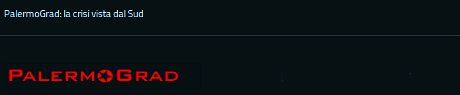Il male oscuro (ma non troppo) del Capitale
di Giovanni Di Benedetto
Prosegue su Palermograd il dibattito avviato dagli interventi di Totò Cavaleri (9 Aprile 2015) e Calogero Lo Piccolo (3 Giugno 2015) su disagio mentale, desiderio, lavoro e nuove forme di schiavitù del godimento. L’intento è quello di tracciare una cartografia in grado di individuare le forme della sofferenza psichica nell’attuale contesto sociale e di provare a legarle all’analisi della società capitalistica, alle forme contemporanee del lavoro e del suo sfruttamento
 Alcuni articoli comparsi negli ultimi mesi su Palermograd hanno provato a sottolineare il nesso strettissimo che lega le condizioni del benessere psicologico soggettivo e l’assetto della sfera dei rapporti sociali e di produzione dell’attuale formazione sociale dominata dal modo di produzione capitalistico. Mi riferisco, nella fattispecie, alle riflessioni di Calogero Lo Piccolo e Totò Cavaleri. Si sottolineava, in particolare, come il campo dell’attuale crisi economica abbia determinato un conseguente incremento di infelicità e malessere, aggravato peraltro dalla percezione di non reversibilità di una tale condizione di naufragio e spaesamento. In una recente intervista, l’economista Emiliano Brancaccio ammoniva chi, in Italia, si è recentemente esaltato per l’andamento dell’economia e dell’occupazione ricordandogli che se alla fine del 2015 l’occupazione, come previsto dalla Commissione Europea, dovesse crescere di 130.000 unità, ci troveremmo comunque con un milione di posti di lavoro in meno rispetto al 2008. Stesso discorso andrebbe fatto per la tanto celebrata economia della Spagna che si ritroverà, alla fine dell’anno, con due milioni e mezzo di occupati in meno in confronto all’anno in cui è esplosa la crisi dei mutui subprime. Il governo greco, alla vigilia del referendum a seguito della rottura delle trattative sul debito, rottura, è bene ricordarlo, voluta dai “creditori” della Troika, ha pubblicato alcune significative informazioni sulla situazione economica del Paese. L’austerità, imposta dalle istituzioni europee, dal Fondo monetario internazionale e dal governo tedesco, ha prodotto i seguenti risultati: tra il 2010 e il 2014 la pressione fiscale è cresciuta di 5 punti percentuali rispetto al Pil, la spesa pubblica è diminuita di un quarto e i salari monetari sono caduti di 20 punti percentuali. Negli stessi anni la crescita della disoccupazione giovanile è passata dal 30% al 55%. Il numero di occupati è diminuito di un milione. I disoccupati sono aumentati da 560.000 a 1.220.000 e il tasso di disoccupazione è balzato al 25,7%. I greci che vivono sotto il livello di povertà sono passati dal 27,6% nel 2010 al 34,6% nel 2013. Non c’è ragione per non correlare questi dati a un aumento dei suicidi, del 35% dal 2010 al 2014, e dei casi di depressione del 270%. Due milioni e mezzo di greci non hanno assicurazione sanitaria con una crescita, dal 2010 al 2014, del 500%. La crisi, almeno in Europa, è lungi dall’essere superata, le ricette della Commissione europea, della Banca centrale europea e del Fondo monetario internazionale, basate sulla dottrina dell’austerità, hanno gonfiato il problema e aumentato a dismisura il disastro economico. Ad ulteriore conferma che non viviamo nel migliore dei mondi possibili.
Alcuni articoli comparsi negli ultimi mesi su Palermograd hanno provato a sottolineare il nesso strettissimo che lega le condizioni del benessere psicologico soggettivo e l’assetto della sfera dei rapporti sociali e di produzione dell’attuale formazione sociale dominata dal modo di produzione capitalistico. Mi riferisco, nella fattispecie, alle riflessioni di Calogero Lo Piccolo e Totò Cavaleri. Si sottolineava, in particolare, come il campo dell’attuale crisi economica abbia determinato un conseguente incremento di infelicità e malessere, aggravato peraltro dalla percezione di non reversibilità di una tale condizione di naufragio e spaesamento. In una recente intervista, l’economista Emiliano Brancaccio ammoniva chi, in Italia, si è recentemente esaltato per l’andamento dell’economia e dell’occupazione ricordandogli che se alla fine del 2015 l’occupazione, come previsto dalla Commissione Europea, dovesse crescere di 130.000 unità, ci troveremmo comunque con un milione di posti di lavoro in meno rispetto al 2008. Stesso discorso andrebbe fatto per la tanto celebrata economia della Spagna che si ritroverà, alla fine dell’anno, con due milioni e mezzo di occupati in meno in confronto all’anno in cui è esplosa la crisi dei mutui subprime. Il governo greco, alla vigilia del referendum a seguito della rottura delle trattative sul debito, rottura, è bene ricordarlo, voluta dai “creditori” della Troika, ha pubblicato alcune significative informazioni sulla situazione economica del Paese. L’austerità, imposta dalle istituzioni europee, dal Fondo monetario internazionale e dal governo tedesco, ha prodotto i seguenti risultati: tra il 2010 e il 2014 la pressione fiscale è cresciuta di 5 punti percentuali rispetto al Pil, la spesa pubblica è diminuita di un quarto e i salari monetari sono caduti di 20 punti percentuali. Negli stessi anni la crescita della disoccupazione giovanile è passata dal 30% al 55%. Il numero di occupati è diminuito di un milione. I disoccupati sono aumentati da 560.000 a 1.220.000 e il tasso di disoccupazione è balzato al 25,7%. I greci che vivono sotto il livello di povertà sono passati dal 27,6% nel 2010 al 34,6% nel 2013. Non c’è ragione per non correlare questi dati a un aumento dei suicidi, del 35% dal 2010 al 2014, e dei casi di depressione del 270%. Due milioni e mezzo di greci non hanno assicurazione sanitaria con una crescita, dal 2010 al 2014, del 500%. La crisi, almeno in Europa, è lungi dall’essere superata, le ricette della Commissione europea, della Banca centrale europea e del Fondo monetario internazionale, basate sulla dottrina dell’austerità, hanno gonfiato il problema e aumentato a dismisura il disastro economico. Ad ulteriore conferma che non viviamo nel migliore dei mondi possibili.
In secondo luogo, mi sembra che nei due testi sopra citati, di Lo Piccolo e Cavaleri, si provasse a ragionare sulla necessità di attivare una soggettività che, oltre i limiti imposti dall’individualismo sfrenato e dalla competizione egoistica, fosse in grado di produrre strategie collettive di resistenza efficaci e produttive. Penso che il merito di queste riflessioni risieda nella capacità di rendere evidente quanto di ideologico vi sia in alcune insistite, e per nulla disinteressate, giaculatorie sull’analisi lacaniana dell’evaporazione del padre, ossia della funzione paterna del definire limiti (castrazione simbolica), facendo emergere la dimensione paradossale di certi moniti da ancien régime che richiamano l’esigenza di un ritorno al principio di autorità. La questione da porre risiede, piuttosto, nella capacità di rendere sociale, e dunque politico, il disagio del singolo, restituendogli, in questo modo, la giusta connotazione di problema collettivo. Del resto, secondo Lacan, il compito del lavoro clinico dell’analista consiste proprio nel rendere il paziente consapevole del suo essere deprivato dei legami sociali per aiutarlo nella ricostruzione di un contesto relazionale gratificante. Se si vuole ancorare la discussione a momento collettivo di riflessione e di crescita, e ad una politica sul che fare, è questa, a mio avviso, la strada che si deve battere. Ecco perché occorre evitare che certe riflessioni evochino il bisogno di un ritorno normalizzatore e di un surplus di controllo sociale.
Ma allora non sarebbe forse il caso di capovolgere il senso delle nostre valutazioni e l’orizzonte delle nostre prospettive? Insomma, non è forse la tracotanza dell’individualismo egoistico, l’illusione di una narcisistica libertà totale e il sogno di un appagamento immediato e esaustivo di ogni desiderio, ad essere di per sé, senza alcuna esigenza di ritorno dell’autorità, il portato di una strategia di normalizzazione e di controllo sociale? C’è da chiedersi se, forse, è la crescente massa di normalizzati e passivizzati a essere non soggetti che scelgono ma il prodotto di una rete di dispositivi di manipolazione ed inganni che fa credere loro di essere liberi. Come se l’istanza al godimento, anche attraverso esperienze esistenziali astratte e intensive, fosse il risultato normalizzatore del discorso del capitalista. In fondo assistiamo al compimento, come scriveva Giovanni Jervis già trent’anni fa, dell’immagine borghese e conservatrice della libertà, cioè della totale libertà del lecito e dell’illecito individuale. Un’immagine che sconfina in una rivendicazione reazionaria, e perfino fascista, che porta allo scoperto un sogno istintivo di violenza, di potere totale e di arbitrarietà senza mediazione alcuna.
Eppure la libertà, come insegnavano Camus e Sartre, può essere una “condanna”, considerato il fatto che in essa si cela un lato oscuro che ci costringe, se analizzata dalla prospettiva della costruzione di sé, a fare i conti con la necessità di rispondere delle nostre scelte, delle nostre azioni e, soprattutto, degli insuccessi delle nostre azioni. Viviamo un tempo in cui l’individuo vive in solitudine il proprio senso di inadeguatezza rispetto al principio di prestazione: Ehrenberg, alcuni anni fa, sottolineava in maniera magistrale come, nel tempo presente, all’origine del disagio mentale vi sia la fatica di essere se stessi, ossia l’incapacità fisiologica, e per ciò tutta umana, di dispiegare le proprie potenzialità all’interno delle logiche del mercato fondate sulla concorrenza e sulla competitività. È, insomma, nell’ambito di una crescente pressione concorrenziale per il salario, di un’accelerazione degli stimoli nervosi nella competitività produttiva e di uno stress costante dell’attenzione per il conseguimento di standard di rendimento sempre più elevati, che si determinano effetti psichici di natura patologica. Non sto qui a ricordare lo slittamento che l’indirizzo suggerito da Ehrenberg imprime alle tradizionali impostazioni di stampo freudiano sul disagio mentale che rimandano alla isteria come risposta ad un contesto nevrotico dominato da repressione e rimozione. Mi pare più importante, per l’economia del nostro discorso, soffermare l’attenzione sull’operazione di svelamento necessaria a mettere in chiaro che è il modo di produzione capitalistico del tempo presente, nelle forme della sussunzione reale alla finanza, a determinare distese di sofferenza spirituale, oltre che fisica, molto più ampie e vaste di quello che si potrebbe solo immaginare.
È a questo livello della discussione che va connesso il tema lacaniano, ripreso da Recalcati, dell’evaporazione del padre, altro che ritorno dell’autorità. È vero, sarebbe troppo semplicistico rintracciare, nella genesi dei disturbi psichici, la produzione diretta del capitalismo: il problema è probabilmente più complesso. Tuttavia, non ci si può sottrarre dal riconoscere che sempre più di frequente le cause del disagio mentale e dei disturbi psichici sono riconducibili non solo a variabili psichiche e culturali ma, insieme, a contraddizioni sociali. Forse se si ricordasse, come scrive Marx, che il capitale è un rapporto sociale di produzione, che in quanto tale si accresce attraverso lo scambio con il lavoro vivente determinando dominio del lavoro accumulato sul lavoro immediato e, conseguentemente, sfruttamento, dissimmetria e sofferenza (un tempo avremmo detto alienazione), si sarebbe nelle condizioni minime per ripristinare le premesse per uno sforzo collettivo nella direzione della lotta per la liberazione e l’emancipazione. È lo stesso Recalcati ad avvalorare quella che lui chiama un’eco marxista quando scrive in Patria senza padri che “oggi una parola chiave dei nostri pazienti è lavoro” intendendo con questa affermazione che il lavoro diventa condizione di possibilità per rifondare la parola desiderio. Certo, sottolinea Recalcati, si tratta di uno spostamento radicale rispetto a quanto si sosteneva negli anni Settanta, quando si considerava la costruzione del desiderio come radicalmente antitetica al lavoro. Tuttavia, c’è tutta una tradizione filosofica che, al centro della modernità, ha ragionato su queste questioni, dalla rousseauiana consapevolezza che l’uomo nasce libero e dappertutto è in catene alla riflessione hegeliana sulla dialettica servo-padrone come dialettica del riconoscimento, per finire ovviamente a Marx. Alla fine degli anni ’20 del secolo scorso Wilhelm Reich attaccò Freud chiedendo che tipo di influenza aveva il sistema capitalista nella genesi della miseria psichica degli operai viennesi. Non si trattava soltanto di analizzare le analogie teoriche che legavano la psicoanalisi di Freud al materialismo storico di Marx, entrambi maestri del sospetto e di un metodo critico in grado di destrutturare le verità evidenti del sintomo psicotico e dello scambio per risalire ad elementi di disagio e di crisi più profondi, ma di funzionalizzare la tecnica psicoanalitica ponendola fattivamente in soccorso della classe operaia.
Certo, occorre subito precisare che tutta la storia della psicoanalisi è stata attraversata dalla pretesa ambigua di distinguere chiaramente fra la dimensione di disciplina normalizzatrice e di recupero e riabilitazione ai valori e ai principi della società borghese, e la natura eversiva di un messaggio dissidente, obliquo e potenzialmente sovvertitore. D’altra parte è anche giusto indicare i rischi di uno sguardo teorico e politico che pretenda di sovrapporre le analisi di un fenomeno storico come il capitalismo, con le sue crisi economiche e i suoi conflitti sociali, e le indagini di natura psicologica, riguardanti prevalentemente la condotta dell’individuo entro un contesto storicamente determinato. In alcuni contributi teorici che in questi ultimi tempi si sono sforzati di cogliere elementi di congiunzione tra politica, psicoanalisi e critica dell’economia, si può manifestare il rischio dell’utilizzo di procedure ermeneutiche di una disciplina per spiegare il funzionamento di un oggetto di studio che con quella disciplina nulla hanno a che fare. Si ha la sensazione che a volte ci si illuda di spiegare con metafore e costruzioni teoriche e linguistiche proprie di una disciplina, la psicoanalisi, dispositivi di funzionamento del modo di produzione; e, viceversa, che si tenti di spiegare il meraviglioso e complesso modo di funzionamento della mente con l’apparato concettuale della scienza economica. Mentre sarebbe bene che i vari livelli del lavoro di indagine, pur dovendo necessariamente cooperare sulla scia di un metodo transdisciplinare, fossero mantenuti distinti. Il rischio che colgo è quello di una certa ambiguità, magari sorretta da una certa spregiudicatezza intellettuale, che poco rafforza, però, la capacità di centrare la natura dei problemi per risolverli. Se c’è un insegnamento preliminare che ho appreso dalla multiforme e a volte policroma corrente culturale dell’ecologia della mente, mi riferisco ai lavori di Watzlawick, Morin e soprattutto di Bateson, è che non si devono mai confondere livelli logici di discorso fra loro differenti.
Il funzionamento del capitalismo è crisi, vive di crisi, convulsioni, conati, incertezze, catastrofi. Il capitalismo è contraddizione. Che tutto questo abbia degli esiti disastrosi per l’equilibrio economico, ma non per l’accumulazione dei profitti, è certo. Come è certo il fatto che il disastro ha degli effetti sulla natura sociale del disagio mentale. C’è una connessione di causa ed effetto tra l’acuirsi della ingiustizia sociale, delle diseguaglianze e della precarietà e la patologia mentale collettiva. Da qui il dovere di tenere insieme lavoro politico, critica dell’economia capitalistica e analisi psicologica. Forse potrebbe essere utile, senza per questo ricadere in semplicistiche forme di riduzionismo economicistico, partire dall’analisi delle trasformazioni del capitalismo contemporaneo. Magari soffermandosi di più sullo studio dei rapporti sociali di produzione, sull’analisi della loro articolazione in una determinata formazione sociale storicamente data, sull’esame dei rapporti geopolitici di potere. Restituendo centralità, lì dove si produce ricchezza, allo sfruttamento sul lavoro nelle svariate forme che questo ha assunto, a partire dal comando monetario e finanziario che ne costituisce il centro propulsivo. Ritornando ad analizzare e denunciare, per esempio, il controllo sul lavoro sempre più stringente, la pressione del comando capitalistico sempre più pervasiva, la frammentazione della classe, sotto il maglio della precarietà e della flessibilità, sempre più forte. O evidenziando, all’interno dello stesso ciclo produttivo, tipologie di contrattualizzazione e inquadramento differenti e molteplici. Il fatto è che va posta come questione fondante la centralità del rapporto di classe e del modo di produzione. Riccardo Bellofiore ha spiegato come “l’esplosione del lavoro dipendente dal capitale cui assistiamo in questa fase (altro che fine del lavoro, e altro che fine del lavoro salariato!) si tramuta in una frantumazione della classe dei lavoratori. La classe operaia certo non scompare, ma viene privata di coscienza e di forza, diviene parte di quel capitale che ne minaccia l’esistenza storica come soggetto autonomo.” Per inciso, anche per queste ragioni vanno rifiutate quelle rappresentazioni dell’economia contemporanea come contrassegnate dal carattere dell‘immaterialità e del cognitariato. È a partire da questa consapevolezza che diventa necessario riattivare forme rinnovate di solidarietà della forza lavoro, strategie di alleanza tra pari nel segno dell’uguaglianza e della libertà.
In conclusione, è certo che il disagio mentale è lì a ricordarci, come il fantasma di Marx, che non tutto funziona per il meglio nel mondo dei normali e dei sani, né tanto meno nel mondo che ha assistito al successo effimero, eppure di portata epocale, del capitalismo. Questa considerazione vale a maggior ragione se ci si rende conto che la sofferenza spirituale e psicologica permea, oggiggiorno pervasivamente, la vita umana e la società. Eppure è terribilmente difficile, nel tempo presente dominato dalle passioni tristi, avere chiaro che il punto non è legare, nella vita lavorativa ma anche in quella affettiva, la nostra condotta e le nostre prestazioni a presunti criteri oggettivi di merito ed efficienza, ma che la posta in gioco consiste nell’acquisizione della consapevolezza dei dispositivi di potere e dello sfruttamento di classe che generano, direi quasi foucaultianamente, in tutti noi, nessuno escluso, subalternità e sentimenti di inadeguatezza ai meccanismi individualistici e competitivi che istigano alla lotta di tutti contro tutti per l’effimero godimento della merce. D’altronde, nel tempo che hanno voluto dipingere come il tempo della fine della storia, e dunque nel tempo della fine del conflitto di classe, lì dove domina incontrastata la logica del lassez faire, ciò che conta è la lotta per la sopravvivenza all’interno del mercato autoregolato: poi, poco importa se l’ideologia economica mainstream, che presuppone condizioni naturali di equilibrio, aggiunga a mò di corollario, al fianco di una ristretta élite di vincenti, l’effetto collaterale di masse sterminate di emarginati, sconfitti, perdenti e umiliati.
È il contesto, produttivo e sociale, di sollecitazione permanente delle nostre energie nervose, nella sfera del mercato del lavoro, e di mobilitazione costante delle nostre solitudini, all’interno dello spazio del consumo, che genera sofferenza psichica nella forma dell’ansia, dell’angoscia e della depressione e che deve essere messo in discussione. Sono da rintracciare qui le radici della condizione di perdita di senso, di smarrimento esistenziale e di precarizzazione permanente delle nostre vite, di quel panorama psichico segnato da una paralisi delle nostre facoltà fisiche e mentali, razionali e irrazionali insieme, che impedisce loro di entrare in connessione empatica con l’altro. E invece sarebbe il caso di sforzarsi per trasfigurare, per dirla con Freud, la libido dell’io narcisistico in una libido oggettuale, aprendosi al contesto di nuovi legami sociali e di nuove alleanze politiche.