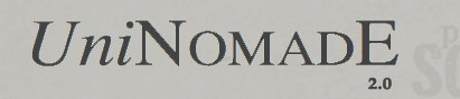
Tra Foucault e Tommaso (Müntzer): una replica ad Asor Rosa
di Marco Assennato
 Alberto Asor Rosa ha dedicato un lungo articolo – sul Il manifesto del 27 aprile – di critica al “Manifesto per un soggetto politico nuovo”, che già aveva suscitato un’accesa discussione sulle pagine dello stesso quotidiano. Franchezza per franchezza: non è tanto sulla valutazione da darsi dell’ipotesi di fondare un nuovo partito – sulla scorta del manifestino dei beni comuni – che trovo interessante porre questioni. Non saprei dire, infatti, se mi preoccupa di più il contenuto di quella proposta politica o il contenuto delle repliche polemiche che ha suscitato. Mi interessa invece, e m’interroga, l’arco di argomentazioni che Asor pone per giustificare la sua critica, poiché mi pare coincidere con altre e sempre più diffuse “pose” argomentative sulla sinistra italiana. La passione dello storico chiama Asor Rosa a rammentarci per intero la raccomandazione di Gramsci sull’ottimismo della volontà e il pessimismo della ragione: un modo per dire che non s’ha bisogno, per trasformare il mondo, di “ridicoli fantasticatori” pronti ad esaltarsi ad ogni sciocchezza o deprimersi di fronte all’orrore, quanto piuttosto “d’uomini sobri, pazienti” capaci d’una analisi realistica dei contesti e d’una azione all’altezza del tempo dato. Ecco. Sempre più spesso (e me ne sfugge la ragione) in Italia si ragiona iniziando così, quando s’affronta il nodo politica istituzionale – movimenti. Penso ad esempio a molti e differenti articoli apparsi su Alfabeta2, insomma all’impostazione complessiva di quel dibattito, come ad alcuni accenti della discussione sul manifesto. Sempre così inizia il ragionamento: vi sarebbe da una parte la nebulosa degli “esaltati”, “sognatori” – a volte definiti persino “saturnini” – e dall’altra quella degli “uomini sobri”, “realistici”, “pragmatici”.
Alberto Asor Rosa ha dedicato un lungo articolo – sul Il manifesto del 27 aprile – di critica al “Manifesto per un soggetto politico nuovo”, che già aveva suscitato un’accesa discussione sulle pagine dello stesso quotidiano. Franchezza per franchezza: non è tanto sulla valutazione da darsi dell’ipotesi di fondare un nuovo partito – sulla scorta del manifestino dei beni comuni – che trovo interessante porre questioni. Non saprei dire, infatti, se mi preoccupa di più il contenuto di quella proposta politica o il contenuto delle repliche polemiche che ha suscitato. Mi interessa invece, e m’interroga, l’arco di argomentazioni che Asor pone per giustificare la sua critica, poiché mi pare coincidere con altre e sempre più diffuse “pose” argomentative sulla sinistra italiana. La passione dello storico chiama Asor Rosa a rammentarci per intero la raccomandazione di Gramsci sull’ottimismo della volontà e il pessimismo della ragione: un modo per dire che non s’ha bisogno, per trasformare il mondo, di “ridicoli fantasticatori” pronti ad esaltarsi ad ogni sciocchezza o deprimersi di fronte all’orrore, quanto piuttosto “d’uomini sobri, pazienti” capaci d’una analisi realistica dei contesti e d’una azione all’altezza del tempo dato. Ecco. Sempre più spesso (e me ne sfugge la ragione) in Italia si ragiona iniziando così, quando s’affronta il nodo politica istituzionale – movimenti. Penso ad esempio a molti e differenti articoli apparsi su Alfabeta2, insomma all’impostazione complessiva di quel dibattito, come ad alcuni accenti della discussione sul manifesto. Sempre così inizia il ragionamento: vi sarebbe da una parte la nebulosa degli “esaltati”, “sognatori” – a volte definiti persino “saturnini” – e dall’altra quella degli “uomini sobri”, “realistici”, “pragmatici”.
D’un lato lo svolazzo ideologico, dall’altro la paziente ricostruzione di fatti e situazioni concrete. Poi, questi due tipi, vengono pian piano lasciati scivolare sino a sovrapporsi da una parte sui “movimentisti” che tutto criticano ma nulla cambiano e d’altro canto su chi si pone – certo realisticamente! – il problema del partito, della rappresentanza e delle elezioni. In modo più o meno esplicito – qui Asor Rosa ha il merito di non nascondersi dietro a un dito e nominare oltre al peccato, anche il peccatore – l’ideologo dei primi sarebbe Toni Negri (insieme a Michael Hardt) e l’ideologia in questione starebbe dentro alla parola “comune”, alla quale viene appiccicata una presunta matrice tomistica o teologico-cristiana. Adesso: su pragmatici e sognatori vorrei muovere qualche perplessità; e sulla coincidenza tra “beni comuni” e “comune” qualche altra, come del resto sulla presenza e sul ruolo effettivi di Toni Negri e Michael Hardt (che potranno certo smentire) alla regia della proposta di costituzione di un nuovo partito politico mossa da Ugo Mattei, Marco Revelli e altri.
Politica, comune e beni comuni
Ma siamo sicuri che il problema del “comune” come dispositivo teorico in grado di pensare il politico “oltre privato e pubblico” – e cioè oltre la modernità – coincida con i “beni comuni” o ancora con il tomismo catechistico del “bene comune”? Certo è vero che Negri e Hardt definiscono, nelle primissime pagine del loro ultimo volume, comune «in primo luogo la ricchezza comune del mondo materiale, l’aria, l’acqua, i frutti della terra e tutti i doni della natura», ma poi continuano scrivendo: «per comune si deve intendere con maggior precisione tutto ciò che si ricava dalla produzione sociale e per la prosecuzione della produzione, come le conoscenze, i linguaggi, i codici, l’informazione, gli affetti e così via». Insomma stiamo qui parlando da una parte della ricchezza sociale già disponibile in natura, ma con più precisione (tanto per non far confusioni sull’ordine e il grado) delle forme nuove della produzione di ricchezza, della composizione sociale e politica di queste forme, della potenza viva sulla quale il capitale cerca d’applicare il suo istinto vampiresco. Determinazione materialissima, questa, che nulla ha a che vedere, o almeno che certo non si risolve né si esaurisce, nelle corrette definizioni di Rodotà a proposito dei “beni comuni”. E non vi si risolve proprio perché attraverso questo concetto viene reintrodotta nella discussione sulla ricostruzione delle forme della politica – e persino sul progetto di nuove forme istituzionali – esattamente la nuovissima dinamica dello sfruttamento e del conflitto tra capitale e lavoro. Più precisamente l’ipotesi sarebbe: dentro comune si trova l’abbozzo della nuova forma della produzione a partire dalla quale va ripensata la politica (e da cos’altro sennò? C’entra in ciò l’operaismo?). Altro che “riappropriazione in funzione apparentemente anticapitalistica di un intero universo concettuale e ideale pre-capitalistico”, qui si tratta piuttosto di ridefinire dopo la crisi del capitalismo dispositivi teorici in grado di pensare le contraddizioni i conflitti e le forme della politica. Dopo la crisi del capitalismo s’intenda: dopo che la razionalizzazione capitalistica ha messo in crisi lo stato-piano e poi e conseguentemente (come in una gabbia d’acciaio) lo stato-nazione, i sistemi pubblici di welfare, i meccanismi della rappresentanza politica e le agenzie di regolazione del conflitto sociale. Situazione storica, di fatti testardi, non d’auspici si tratta qui. Perché di questo stiamo parlando: del fatto che oltre il privato e il pubblico siamo già, e avvedersene –seppure con qualche decennio di ritardo – potrebbe essere un buon viatico per iniziare a risolvere qualche problema.
Sul teologico e il politico
Qui, una piccola digressione: Asor Rosa “rivela” la matrice tomistica della retorica dei “beni comuni” (che spero sia chiaro non coincide con la questione posta da Comune di Negri e Hardt), dalla Summa theologiae I-II, 90, 3 in cui si parla di commune bonum. Ora, fatta salva la differenza tra l’invito ad operare perseguendo il bene comune per una collettività e l’evidenza, tutta contemporanea, che la produzione di ricchezza s’è socializzata – ed allora varrebbe forse la pena di pensare la politica a partire da questa comune potenza produttiva del lavoro cognitivo – mi chiedo: e se anche vi fosse una radice teologica in un concetto politico che possiamo oggi utilizzare, che male vi vedrebbe Asor Rosa? Vuole rivolgere la questione a Mario Tronti o a Massimo Cacciari o ancora riprendere in mano Schmitt o Weber per scoprire quanto si studia in ogni media o buona facoltà d’Europa a proposito della derivazione teologica delle categorie politiche (e ciò indipendentemente dalle propensioni “saturnine”, “movimentiste” degli attori e interpreti di questa vicenda)? Ad ogni modo, se di teologia si deve trattare, suggerirei piuttosto quella di un altro Tommaso: l’omnia sunt communia delle eresie prodotte dalla lezione di Thomas Müntzer all’alba della modernità. E se di storia della filosofia si vuol trattare, a proposito di comune, suggerirei banalmente di riprendere il ragionamento sulla biopolitica aperto da Michel Foucault e che tanto dibattito produce in tutto il mondo filosofico occidentale: da Negri e Hardt a Esposito, da Nancy a Derrida, per dare qualche nome.
Sulle passioni
Anche qui: non voglio diffondermi nell’esegesi del pensiero di Ugo Mattei perché mi pare poco utile all’abbisogna. Eppure che vi sia una relazione tra passioni, sentimenti e politica è cosa che non dovrebbe sfuggire ad un appassionatissimo comunista quale Asor Rosa. Di cos’altro è fatto il lucido pessimismo del Gramsci che apre la questione, altrimenti? E di cosa si compone la spinta collettiva – o per stare in punta di dottrina – “moltitudinaria” se non della gioia che nasce dalla scoperta di non esser soli, ma molti, “nel mondo grande e terribile”? ma lasciamole pure ai poeti, queste passioni, come anche lasciamogli il coraggio di parlar delle rose. Mi resta una domanda, che volgerei in guisa pragmatica: se provassimo a guardar dentro alle parole evocate da Asor Rosa, “popolo”, “classe”, dico oggi e concretamente, cosa vi troveremmo? Chi produce la ricchezza e s’oppone al capitale (la classe)? Dove sta, dove vive, ha una collocazione stabile? Che lingua parla? Che immaginario mobilita? Quello omogeneo della nazione (del popolo), del lavoro? E se questo soggetto – che è quello che la Costituzione Italiana ha per lungo tempo “rappresentato e tutelato” definendone diritti e doveri non entrasse più tra le maglie normative di quella carta? Se così fosse, da dove la passione di Asor Rosa per il “pubblico” e la costituzione nazionale? “Quel che io vedo – scrive Asor – è che il pubblico […] è minacciato, frantumato, reso subalterno da una colossale invasione del privato”. A me pare che questa “minaccia” abbia una lunga storia che data almeno dagli anni settanta, che ha attraversato tutti gli ottanta e si è chiusa a fine degli anni novanta. Se, per converso, si dovesse immaginare la politica oggi come “difesa del carattere pubblico delle istituzioni” mi verrebbe da dire che siamo in ritardo di almeno dieci anni. E proprio “quel che è successo – o più prudentemente “che potrebbe succedere” – in Francia” attorno alla candidatura di Francois Hollande sta lì a raccontare esattamente questo ritardo d’analisi, di lettura e di proposta politica.
Prammatica del comune
Proporrei di sospendere la polemica tra realisti e sognatori per accogliere un approccio analitico e sperimentale alla questione politica. Vi sono momenti nei quali s’è chiamati ad agire all’interno di un sistema che cerca stabilità provvisorie. Altri, più vicini al nostro, nei quali ci si deve attrezzare per pensare al tempo della (o delle) crisi. Altri ancora nei quali ci si deve opporre al vecchio per far sì che il nuovo, ch’ancora non si vede, possa venire alla luce. Allora a me pare che siamo non all’inizio (la “minaccia” del privato sul pubblico) ma alla fine di un lungo processo tecnocratico di spoliticizzazione del politico. Ed in questo passaggio tutti i termini del nostro ragionare vanno ripensati. Direi così: la politica si ridefinisce oggi come forma non consensuale dell’agire collettivo (il riferimento è qui a Jacques Rancière), nella quale il disaccordo produce l’ingresso in scena delle soggettività. Politica è eccezione che si esercita sulle regole cristallizate nel diritto e nella norma: a partire dalla quale si mettono in forma i processi collettivi. La democrazia in tal senso non è né una forma di governo, né uno stile di vita sociale, quanto piuttosto una potenza che attraversa conflittualmente ogni forma di potere, un modo di soggettivazione attraverso cui esistono le soggettività politiche. Per riconcettualizzare il tema, allora, la potenza sociale della democrazia va dissociata dalle forme di potere. Così prende l’abbrivio una vera e propria lotta tra i senza parte nell’organizzazione del comune e le forme di dominio ed espropriazione. Sullo sfondo di questa potenza produttiva comune si tratta di pensare le condizioni di soggettivazione e di crisi delle soggettività che, nel loro confliggere, danno luogo alle forme giuridiche, ai dispositivi di comando, al senso comune, e all’ethos d’una collettività. In tal senso i movimenti hanno un ruolo e una importanza fondamentale. E il livello istituzionale, sul quale certo si può intervenire per determinare il carattere dell’avversario, non è per nulla “indifferente”. Nuovi partiti non ne occorrono (bastano a far danni quelli esistenti) ma nuove pratiche, nuove sperimentazioni e nuove parole, certo sì. Di queste è fatta la prammatica del comune. Da percorrere con “amore” e con “il sorriso sulle labbra”.































Add comment