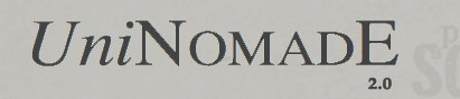
Il disincanto di Ippolita
...e lo sboom di Facebook a Wall Street
di Benedetto Vecchi
 Alla fine Facebook è sbarcata a Wall Street. La prima giornata di vendita delle azioni hanno fatto affluire nelle casse del social network molti miliardi di dollari. Mark Zuckerberg, uno dei fondatori, è diventato un piccolo Paperon de Paperoni; lo stesso è accaduto ad alcuni investitori istituzionali e manager dell’impresa. La divisione della torta ha inoltre previsto piccole porzione anche per i fortunati dipendenti che erano stati premiati con delle stock option nei mesi scorsi. E ieri la Rete ha diffuso un video dove Mark Zuckerberg era attorniato da decine e decine dipendenti che sorridenti festeggiavano l’avvio delle vendita delle azioni. Un video che i compassati New York Times e The Guardian hanno paragonato alle rituali assemblee delle imprese coreane,giapponesi e cinesi, dove i lavoratori inneggiano al logo e ai padroni che li rendono merce. Immagine plastica di quella comunità dei produttori che uno studioso liberal come Richard Sennett prospetta per uscire dalla crisi. I due quotidiani, situati alle due sponde dell’Atlantico, hanno però sottolineato anche un’altra cosa: la prima giornata di Facebook a Wall Street non ha suscitato l’entusiasmo che accompagnò l’Ipo (Initial pubblic offering) di Google. Il giornale newyorkese ha anzi messo in rilevo che gli scambi a Wall Street non sono stati trascinati dall’effetto Facebook. I motivi di ciò sono tanti, ma ciò che emerge dalla lettura dei commenti in Rete sono i dubbi sulla fragilità di Facebook, una società ritenuta niente affatto dinamica e innovativa come invece le relazioni pubbliche del social network hanno sempre tentato di accreditare.
Alla fine Facebook è sbarcata a Wall Street. La prima giornata di vendita delle azioni hanno fatto affluire nelle casse del social network molti miliardi di dollari. Mark Zuckerberg, uno dei fondatori, è diventato un piccolo Paperon de Paperoni; lo stesso è accaduto ad alcuni investitori istituzionali e manager dell’impresa. La divisione della torta ha inoltre previsto piccole porzione anche per i fortunati dipendenti che erano stati premiati con delle stock option nei mesi scorsi. E ieri la Rete ha diffuso un video dove Mark Zuckerberg era attorniato da decine e decine dipendenti che sorridenti festeggiavano l’avvio delle vendita delle azioni. Un video che i compassati New York Times e The Guardian hanno paragonato alle rituali assemblee delle imprese coreane,giapponesi e cinesi, dove i lavoratori inneggiano al logo e ai padroni che li rendono merce. Immagine plastica di quella comunità dei produttori che uno studioso liberal come Richard Sennett prospetta per uscire dalla crisi. I due quotidiani, situati alle due sponde dell’Atlantico, hanno però sottolineato anche un’altra cosa: la prima giornata di Facebook a Wall Street non ha suscitato l’entusiasmo che accompagnò l’Ipo (Initial pubblic offering) di Google. Il giornale newyorkese ha anzi messo in rilevo che gli scambi a Wall Street non sono stati trascinati dall’effetto Facebook. I motivi di ciò sono tanti, ma ciò che emerge dalla lettura dei commenti in Rete sono i dubbi sulla fragilità di Facebook, una società ritenuta niente affatto dinamica e innovativa come invece le relazioni pubbliche del social network hanno sempre tentato di accreditare.
Ma al di là delle analisi che hanno accompagnato il quasi successo (o il quasi flop) di Facebook, il suo arrivo a Wall Street va valutato attentamente, perché è la prima volta che un’impresa che fa le sue fortune organizzando capitalisticamente la comunicazione informale tra i novecento milioni di utenti si candida a diventare un’impresa globale che fa leva su un circolo virtuoso tra finanza e sussunzione reale della cooperazione sociale.
Esistono già altri circoli virtuosi di questo tipo. Google è tra questi; Apple anche, ma è la prima volta che un’impresa si insedia stabilmente a Wall Street per attirare capitali e investitori sul suo core business, cioè le chiacchiere informali scambiate in rete. Per capire le implicazioni della quotazione in borsa occorre tuttavia tornare un po’ indietro nel tempo e indagare a fondo le caratteristiche proprie di questo social network.
Il silicio parlante
La lunga e dorata marcia di Facebook verso la quotazione in borsa è stata sapientemente gestita da Mark Zuckerberg, che ha sempre presentato il social network come un’impresa innovativa che ha saputo interpretare il bisogno di socialità e di comunicazione nell’era del silicio. In un mondo sempre più interconnesso e piccolo, uomini e donne fanno esperienza di una solitudine che lascia attoniti e infelici, proprio quando la Rete dovrebbe consentire relazioni sociali che non conoscono i limiti dello spazio e del tempo. Ma più ci si avvicina alla realizzazione del villaggio globale, più la solitudine è esperienza quotidiana. Facebook, ripete il suo fondatore, fornisce ciò di cui la società ha bisogno: un habitat dove rinverdire vecchie amicizie e coltivarne di amicizie.
Con i suoi quasi novecento milioni di utenti, Facebook è dunque riuscita a compiere un piccolo miracolo: ha reso amichevole la Rete. Inoltre, fornisce gratuitamente i suoi servizi. Basta connettersi, aprire il proprio profilo e cominciare a dialogare con gli “amici”, socializzando stati d’animo, esperienze, gusti musicali, idee politiche, incontrando cioè sul web i propri simili, evitando così la spiacevole prospettiva di chattare con chi la pensa diversamente. L’Altro è bandito dalla propria pagina, ma se mai lo si volesse incontrare basterà chiedere amicizia a chi, nel suo profilo, ha definito un’identità diversa. L’innovazione, dicono alla Facebook, sta nell’aver fornito gratuitamente la possibilità di costruire griglie sociali laddove era impensabile costruirle, la Rete. Certo, la gratuità ha un prezzo, quello di fornire i propri dati, che saranno elaborati e impacchettati per essere venduti a imprese che li useranno per le loro strategie di vendita. Poi ci sono anche i discreti annunci pubblicitari che appaiono sulla destra della pagina, ma viviamo in una società aperta, dove la libertà di scelta è garantita a tutti. Insomma, l’innovazione per Mark Zuckerberg si limita a fornire un habitat favorevole agli incontri con i propri simili, evitando ogni contatto con chi è diverso. Sta in questa standardizzazione dei profili personali la libertà assoluta promessa da Facebook. Gli unici limiti posti sono l’uso di un linguaggio appropriato.
Da molti a molti
Molta acqua è dunque passata sotto i ponti da quando Mark Zuckerberg mise in piedi un social network destinato solo agli studenti di università prestigiose. Il giovane scontroso, irascibile, scaltro, opportunista e molto bravo ad assemblare codici informatici è diventato grande, ricco, ma non ha rinunciato a presentarsi come un «ribelle», ma tollerante verso chi la pensa diversamente. È ovviamente politicamente corretto, ma non rinuncia al suo punto di vista. La leggenda dice che Facebook doveva essere la chiave d’accesso di Zuckerberg nel mondo dorato dell’élite statunitense. Ma se i suoi primi compagni di viaggio, Dustin Moskovitz, Eduardo Severin e Chris Hughes, volevano solo entrare nei circoli e confraternite dell’Ivy League, cioè delle università statunitense più prestigiose, Zuckerberg, anche se era studente ad Harvard, aveva ben altri progetti. In fondo, non ha mai nascosto il suo disprezzo verso un’élite chiusa nelle sue recintate e ben protette torri d’avorio. Per lui, il potere e la ricchezza erano a portata di mano senza dover fare nessun inchino o partecipando ai tristi riti dell’Ivy League. E con feroce determinazione ha fatto fuori tutti i suoi iniziali compagni di viaggio per restare solo al comando.
Il fenomeno Facebook non è però spiegabile attraverso la personalità di Mark Zuckerberg. È infatti un modello di business atipico rispetto agli standard statunitensi. I suoi profitti dipendono da quell’impalpabile, ma fondamentale elemento alla base di quell’animale sociale che è l’essere umano. Bisogno di comunicare la propria esperienza agli altri, senza rinunciare alla sua singolarità. Ci sono ovviamente dei precedenti nel capitalismo di imprese che hanno fatto della comunicazione oggetto di attività imprenditoriali. Ma i media – dai giornali alla televisione – hanno sempre visto una fonte primaria della comunicazione. Il modello era dall’«uno ai molti». La Rete consente invece una comunicazione dai «molti ai molti». Mancava però un habitat dove il singolo potesse esprimere le sue potenzialità, la sua capacità cioè di costruirsi una rete sociale. L’espressione social network evidenzia, d’altronde, proprio la capacità dei singoli di autorganizzare le proprie relazioni sociali. Questo il modello di business di Facebook, al punto che molti analisti e studiosi ne hanno messo in luce le potenzialità politiche vista l’opportunità di funzionare come un produttore just in time di opinione pubbliche, quindi dell’esprimere, in tempo reale, il loro punto di vista senza la mediazione, appunto, dei media.
Destrutturare è bello
È indubbio che il modello di business di Facebook abbia questi elementi alla sua base, ma ce ne sono molti altri da valutare. Per esempio, il cosiddetto data mining, cioè la raccolta, l’elaborazione e la vendita di dati contenuti nei profili degli utenti, nonché la vendita di spazi pubblicitari, così come fa Google. L’aspetto tuttavia più importante, che finora non è stato indagato, è la relazione esistente tra Facebook e quella corrente politico-culturale che negli Stati Uniti è chiamata anarco-capitalista. È a questa relazione che il gruppo Ippolita dedica un saggio intitolato Nell’acquario di Facebook, che può essere acquistato direttamente sul sito www.ippolita.net.
Ippolita è un eterogeneo gruppo di mediattivisti, ricercatori e informatici che da anni analizza i fenomeni emergenti nella Rete e li passa al tritatutto di una critica militante antiautoritaria. Un gruppo che si definisce con orgoglio anarchico o left libertarian. In passato Ippolita ha analizzato il fenomeno del software open source, ritenuto la risposta capitalista alla possibilità di produrre programmi informatici al di fuori delle regole della proprietà intellettuale (Open non è free, Eleuthera) . La stessa tensione «destrutturante» è dietro il volume Luci e ombre di Google (Feltrinelli), dove la società del motore di ricerca è rappresentata come il simbolo di un’impresa che, dietro la retorica della gratuità, ha costituito il primo esempio di data minig nell’era del web 2.0.
Questo saggio non nasconde l’ambizione di destrutturare la visione imprenditoriale non solo di Facebook, ma di tutte le imprese che costruiscono le loro fortune economiche su una concezione «libertaria» delle relazioni sociali. Un progetto di ricerca ammirevole per chi libertario si dichiara. Alla fine del saggio, l’obiettivo di mettere all’angolo il proprio fratello gemello – gli anarco-capitalisti, appunto – è raggiunto. È quindi un testo da leggere con attenzione, perché fornisce molti elementi che aiutano a illuminare il lato oscuro di Facebook e di quel web 2.0 indicato come un luogo di assoluta libertà, considerato invece da Ippolita come un fenomeno di delega tecnocratica della propria socialità.
Gli attivisti da poltrona
La ricognizione parte dalla «distrattenzione», cioè da quella distrazione strutturale che accompagna la vita in Rete. Troppi gli stimoli, troppe le informazioni a cui si ha accesso; da qui la distrazione, che come hanno già verificato i teorici dell’«economia dell’attenzione» pregiudica gli affari. Segue poi la necessità di produrre luoghi dove la distrazione venga gestita e superata attraverso la definizione di profili individuali che attirano attenzione da parte di chi si sente simile. E non è un caso che Facebook sia l’emblema di una «omofilia», cioè della centralità del singolo che entra in relazione con altri individui a colpi di click del mouse, mettendo sulla propria bacheca messaggi tanto insignificanti quanto espressione di una identità immutabile nel tempo e impermeabile a qualsiasi relazione sociale. I post non solo alimentano il chiacchiericcio, la fuffa e il rumore di fondo della Rete, ma sono indice di una pornografia emotiva e relazionale che sicuramente non è sinonimo di libertà. Siamo cioè di fronte a un «automarketing personalizzato di massa» che Facebook trasforma, attraverso la profiliazione, in dati da vendere sul mercato. Non spaventino i neologismi. Il testo di Ippolita è di una chiarezza cristallina. Come non essere d’accordo quando viene analizzato l’attivismo da poltrona, che si esaurisce nel cliccare su «mi piace» di una pagina che invita alla mobilitazione per una causa ovviamente giusta. L’opinione pubblica viene prodotta dentro un dispositivo tecnocratico dove tutti sono spettatori passivi di spettacoli autorizzati dalla policy di Facebook.
L’analisi della «filosofia» anarco-capitalista sottolinea la capacità di una visione antistatalista e a favore del libero mercato di diventare egemone in un contesto, quello high-tech, influenzato dalla controcultura degli anni Sessanta. L’anarco-capitalismo ha una genealogia negli anni Trenta, quando un gruppo di economisti cominciò a sviluppare una teoria incentrata sulla figura dell’individuo proprietario e che ha avuto il suo massimo splendore nel Nobel per l’economia Milton Friedman. Lo stato era il nemico da combattere in nome della libertà individuale. Ogni attività umana doveva essere sottoposta alle leggi della domanda e dell’offerta. Il matrimonio, l’amicizia, il lavoro, la formazione, l’educazione erano beni che potevano essere acquistati o scambiati al mercato. La controrivoluzione reaganiana ha solo posto le basi affinché quella distopia poteva diventare realtà, ma la Rete è un mondo dove i contenuti non devono essere pagati. Ed è proprio in questo contesto che avviene la fusione tra alcuni temi del movement degli anni Sessanta e il credo liberista. Le teorie «libertariane» aggirano così il problema della gratuità e puntano tutto su una trasparenza radicale dove tutto deve essere reso pubblico. Quelle informazioni possono però diventare merce da vendere, lasciando che i contenuti continuino ad essere gratuiti. Anche la proprietà intellettuale non è molta amata. Gli anarco-capitalisti sottolineano allora come la condivisione, il potere della folla possono creare un mondo nuovo, dove l’attitudine individualista può atteggiarsi a paladina di una libertà che ha nel mercato il suo massimo custode.
Liberi perché eguali
Il gruppo di Ippolita ricorda che uno dei primi investitori su Facebook è Peter Thiel, un personaggio inquietante che ha fondato PayPal, chiamata mafia PayPal, un libertariano che chiede l’abolizione della moneta, dello stato, che crede nella competizione come regola aurea delle relazioni sociali. Ma di anarco-capitalisti ce ne sono molti a Silicon Valley. Tutti affermano di aver fatto propria l’attitudine hacker e la conseguente ostilità per i segreti – di stato, delle imprese; e tanti vedono nello Stato il nemico pubblico da combattere per porre le basi di una libertà assoluta. Libertariano è anche Julian Assange, che combatte il segreto di stato in nome di una trasparenza radicale, cioè uno dei fattori base di imprese come Facebook.
Nell’Acquario di Facebook non risparmia, a ragione, nessuno degli idoli della Rete. La sua non è però furia iconoclasta, né un rifiuto o adesione a un luddismo antitecnologico. Più semplicemente, Ippolita ritiene che la tecnologia vada conosciuta per usarla nella costruzione di una società di liberi e eguali che faccia a meno, però, dello Stato. Attitudine saggia, niente da dire, ma questa ricostruzione dell’anarco-capitalismo ne sottolinea sì l’antistatalismo, rimuovendo invece le trasformazione della forma stato che ha accompagnato il capitalismo cosiddetto cognitivo.
In uno dei seminari più citati di Michel Foucault raccolto nel volume Nascita della biopolitica (Feltrinelli), il filosofo francese illustra la genealogia del liberismo, mettendo in rilievo il fatto che più che scomparire lo stato aumenta le sue sfere di intervento. Ma a differenza dell’”era keynesiana”, quando lo stato assumeva il ruolo di imprenditore, nella prospettiva liberista regolamenta attentamente ogni aspetto della vita sociale,svolgendo cioè un ruolo pastorale proprio sugli aspetti della vita sociale che dovrebbero essere distinti da quelli che attengono la produzione della ricchezza. Ma nel capitalismo cosiddetto cognitivo i confini tra vita e lavoro tendono a svanire al punto che nella world factory l’insieme della caratteristiche della natura umana devono sottostare al regime del lavoro salariato. Per questo, lo Stato punta a costruire una società del controllo proprio perché lo sfruttamento della comunicazione, della conoscenza, degli gli affetti è momento costitutivo del capitalismo contemporaneo. La superfetazione degli aspetti normativi delle relazioni sociali deve quindi svolgere una duplice funzione. Da una parte, definire un controllo preventivo dei comportamenti sociali, dall’altra creare le condizioni affinché comunicazione, conoscenza, affetti possano essere sussunti nella produzione di merci. Uno degli esempi che meglio illustrano il ruolo pastorale dello stato nei processi di valorizzazione capitalista è la proprietà intellettuale: da una parte definiscono il lecito e l’illecito per quanto riguarda l’accesso alla conoscenza; dall’altra legittimano l’enclosures di materie prime – conoscenza en general e informazioni – che sono prodotte attraverso la cooperazione sociale. E non è un caso che Facebook abbia sempre stabilito rapporti di collaborazione con gli Stati nazionali. Questo non significa che non ci sia stati conflitti e tensioni con gli stati nazionali attorno alla violazione della privacy, ma sempre all’interno di condivise tecnologie del controllo sociale. L’analisi del gruppo Ippolita restituisce invece una rappresentazione tutto sommato tradizionale della forma stato. Intrattiene sì un corpo a corpo, da gruppo libertario qual è, con il proprio fratello gemello reazionario, ma non riesce ad andare molto in là di una indignazione verso il potere oppressivo dello Stato, cancellando i vincoli, i legami tra l’organizzazione dello stato, le sue forme di governance delle relazioni sociali e il capitalismo.
C’è, infine, un altro aspetto mancante nella critica all’anarco-capitalismo di Ippolita. Si tratta della necessaria critica all’economia politica del capitalismo on-line, cioè di un rapporto sociale di produzione che mette al lavoro alcune caratteristiche della natura umana, a partire da quale socialità e capacità di comunicare che sono i fondamenti di imprese come Amazon, Google, Apple, Facebook e tante altre ancora. Il problema è allora come contrastare questa accumulazione per espropriazione di sapere, conoscenza, socialità. espropriazione che avviene durante il lavoro, ma anche quando si chatta con amici e amiche. Il lavoro e la vita, vale la pena ribadire, sono momenti distinti, anche se i confini sono sempre più labili. E va dunque salvaguardata la privacy, come anche il diritto all’anonimato per non rimanere catturati dalla retorica della trasparenza di cui Facebook si è fatta paladina. Allo stesso tempo però come immaginare una realtà dove non c’è vendita di forza-lavoro se non si assume il fatto che è negli atelier della produzione dove avviene l’espropriazione della propria socialità.
La critica all’economia politica del capitalismo on-line ha dunque due momenti distinti, ma interconnessi. Il primo è lo svelamento del rapporto di sfruttamento del lavoro vivo; l’altro è il ruolo appunto pastorale dello stato nel garantire il controllo sulla produzione di socialità e della comunicazione. Non si vuol qui riproporre una concezione anchilosata e sterile della critica marxista al capitalismo. Piuttosto si tratta di fare i conti con gli attuali atelier della produzione, dove è avvenuta un cambiamento di prospettiva per quanto riguarda ad esempio la proprietà privata e la figura stessa dell’individuo. Il libertario Yochai Benkler, ad esempio, vede nella Rete l’emergere di un capitalismo non più basato sulla proprietà privata, bensì sulla condivisione e sulla cooperazione (La ricchezza della rete, Università Bocconi Editore).
Benkler non è il solo studioso che evidenzia questa tendenza, ma è il solo che evidenzia come la ricchezza delle nazioni non derivi dalla concentrazione della proprietà dei mezzi di produzione nelle mani di una élite, bensì sulla capacità del capitale di espropriare la cooperazione sociale non ponendo limiti sulle sue potenzialità. Da qui la critica del giurista statunitense alla proprietà intellettuale, ritenuta una barriera proprio allo sviluppo della cooperazione sociale. Ci sarebbe molto da obiettare alle tesi di Benkler, ma è indubbio che mettono in evidenza come nella Rete e al di fuori dello schermo è la cooperazione sociale, e il lavoro vivo, a costituire il limite al capitale. Una critica all’ordine costituito non può dunque non assumere come centrale il lavoro vivo come asse su cui misurare le possibilità di costruire una società di liberi e eguali. Senza ripercorrere vecchie dicotomie tra eguaglianza e libertà, che invece emergono in alcune pagine di questo saggio, va quindi detto che la centralità di un conflitto contro i rapporti sociali dominanti di produzione rafforza l’affermazione di una libertà che non coincide con il mercato, ma nella costruzione di una realtà dove uomini e donne cooperano per vivere senza padroni. In fondo, l’animale umano è un individuo sociale. La posta in gioco è dunque il come vivere insieme senza che nessuno sia padrone della vita dell’altro.































Add comment