Lavoro cognitivo e industrializzazione
di Salvatore Cominu
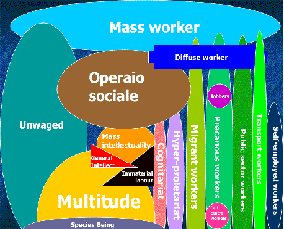
Allo scopo di situare il tema sono necessarie alcune avvertenze preliminari. La prima è di metodo. Il contributo, focalizzato su ciò che continuiamo a chiamare processo di produzione immediato, è consapevolmente parziale, poiché assume questo punto d’osservazione senza preoccuparsi d’inquadrarlo nella molteplicità delle contraddizioni del capitalismo dei giorni nostri, rischiando dunque di restituirne una visione estremamente semplificata. E’ tuttavia questo livello della realtà che s’intende indagare.
In secondo luogo, allo scopo di fugare eventuali ambiguità sull’uso del termine industriale, si premette che nel testo esso sarà utilizzato con due significati differenti. Nel primo paragrafo per indicare una specifica forma dell’accumulazione, la “classica” produzione di beni o servizi venduti sul mercato per la realizzazione di un profitto. Industriale è da questo punto di vista giustapposto ad altre forme di realizzazione del valore (finanziaria, da rendite speculative, ecc.), ma non indica in alcun modo uno specifico settore merceologico; non è contrapposto, in altre parole, a terziario o a servizi. Nei paragrafi successivi, ed è questa seconda accezione che presiede all’ipotesi esplorativa proposta, industriale sarà inteso in senso ancora più ampio, come modalità trasversale diorganizzare la produzione e l’agire umano, anche nella sfera riproduttiva, dei consumi, dell’amministrazione.
Osservazioni preliminari su finanza e industria
Con riferimento alla prima definizione, la riflessione sull’industrialità nel nuovo capitalismo è da porre in tensione con gli approdi recenti di più filoni del pensiero anticapitalista, che individuano nell’accumulazione per spossessamento,[1] in altre parole per appropriazione della ricchezza comune o tramite la messa a valore di attività non direttamente produttive, la forma egemone della valorizzazione nel nuovo capitalismo. Con significati parzialmente diversi, ma anche con numerosi temi comuni, è stata proposta da altri studiosi l’immagine del preminente carattere estrattivo del capitale o delle sue frazioni dominanti nella gerarchia mondiale.[2] Per gli autori che più hanno sottolineato la natura “parassitaria” dell’accumulazione odierna, spossessamento e “pratiche predatorie” sono consustanziali alla storia del capitalismo e non peculiari della stagione successiva alla sua fase organizzata e fordista, e d’altra parte non hanno mai considerato insignificante, per la formulazione di un’alternativa, la “vecchia” contraddizione capitale-lavoro.[3] Del tutto simmetricamente, assumere la parzialità del focus su quest’ultima non significa ignorare l’insieme delle contraddizioni del capitale né, a maggior ragione, la configurazione molteplice del lavoro[4] e la varietà dei regimi di accumulazione compresenti nella mappa spazio-temporale del capitalismo, nonché le gerarchie che strutturano e mettono a valore tali differenze.
L’immagine di un primato dello spossessamento contiene tuttavia il rischio di una sottovalutazione delle articolazioni situate e dinamiche tra le diverse modalità dell’accumulazione, in particolare quando l’analisi si concentra sul ruolo del capitale finanziario. La finanziarizzazione è stata spesso rappresentata attraverso l’enfasi sulla sua autonomia, alimentata da convenzioni e comportamenti mimetici.[5] L’eccezionale concentrazione di denaro e il potere di cui i player finanziari godono nell’allocarlo, sottrarlo o distribuirlo selettivamente fornisce loro un potere smisurato sulla produzione, sul lavoro e (genericamente) sulle vite. E’ da questo livello che si struttura il comando capitalistico globale. Tuttavia, se ci ponessimo la domanda circa la provenienza dei profitti finanziari, vedremmo che la finanza non è del tutto “autonoma”. Una parte significativa dei profitti realizzati in questo campo (derivanti da interessi sui debiti, capital gain, dividendi sulle attività, commissioni, ecc.) richiedono infatti la mobilitazione di aspettative di redditività legate a dei sottostanti; se questi siano mutui ipotecari e quindi immobili (come negli anni Duemila), web companies (come negli anni Novanta), suoli, materie prime o titoli pubblici, dal punto di vista del valore non è più importante di quanto fosse per il capitalista dei tempi di Marx produrre abiti, tè o mobili. Il valore realizzato attraverso la produzione di beni e servizi venduti sul mercato mantiene dunque una perlomeno spettrale (nel senso che è lo spettro del profitto a muovere i mercati finanziari, non la sua realizzazione) consistenza anche nel “finanzcapitalismo”.
“Fabbricanti” di prodotti finanziari, trader, merchant bank, investitori istituzionali, lavorano quotidianamente alla ricerca delle migliori e più remunerative condizioni di atterraggio della liquidità che gestiscono. La partnership che questi player instaurano con i vettori sottostanti è per natura “infedele”, ma negli ultimi decenni ha privilegiato le attività a forte matrice “estrattiva”; il real estate, le assicurazioni, le banche, le imprese che qualcuno ha definito “riscossori di pedaggi”[6] assicurati dal potere politico: telefonia, energia, autostrade, aeroporti, ferrovie, assicurazioni, utilities, ex aziende pubbliche.[7] Tale preferenza non esclude l’esistenza di settori della classe capitalistica globale[8] che da anni spingono per una parziale ricostruzione dei presupposti “sostanziali” del valore;[9] quel “farsi rendita del profitto”[10] con cui si è stilizzato il progressivo disallineamento del capitale dalle sue traiettorie sostanziali, convive dunque oggi con la problematica ricerca di un condizionato “ri-farsi profitto della rendita”[11]. In ciò non vi è alcunché di restaurativo, se non l’embrionale consapevolezza degli effetti prodotti da una finanziarizzazione spintasi troppo oltre che, distruggendo il lavoro e le istituzioni riproduttive, “ha segato il ramo su cui il capitalismo era seduto”[12]. D’altra parte l’eventuale recupero di una base industriale nei paesi a capitalismo maturo passa per la dismissione definitiva dei residui di democrazia sociale imposti dalle lotte di classe del Novecento. L’esperienza della lunga crisi ha costituito un formidabile campo di rieducazione di massa e i tentativi di rilancio dell’occupazione nel “primo mondo” presuppone comunque svalorizzazione del lavoro e delle sue forme sociali.[13]
Ulteriore osservazione, scontata ma non marginale, spossessare è un lavoro. Finanza, real estate, colossi del web, gestori di rete energetiche e infrastrutturali, player estrattivi in senso letterale impiegano decine di milioni di persone in attività di esplorazione, monitoraggio, stoccaggio, standardizzazione e clustering dei segnali che raccolgono, di contatto, vendita, assistenza, di “produzione” dell’offerta, oltre che veri e propri stati maggiori incaricati delle relazioni politiche, delle controversie legali e via di seguito. Aggiungiamo, questo lavoro è sempre più organizzato con criteri industriali e si avvale di sempre più sofisticate (anche se non necessariamente efficaci) tecnologie di monitoraggio, simulazione, comparazione, diagnosi.
Infine, a prescindere da come il capitale incrementi sé stesso, redditi, status e potere sociale della larga maggioranza di coloro le cui esistenze dipendono da un salario continuano a discendere dalla posizione che occupano nella divisione tecnica e sociale del lavoro, che rimane del resto fondamentale (per quanto non esclusivo, ma non lo è mai stato) campo di formazione delle soggettività. Le forme assunte dal dominio sul lavoro, sulle attività lavorizzate o in via di lavorizzazione, e per converso le resistenze e le vie di fuga immaginate ed esperite, continuano – nonostante tutto – ad attrezzare il campo della lotta di classe anche nell’epoca del capitalismo finanziario.
L’ipotesi esplorativa dell’industrializzazione del cognitivo non poggia sul possibile rilancio (che sarebbe comunque condizionato e “sussumibile” nei dispositivi della finanziarizzazione) di alcune basi sostanziali del valore. E’ tuttavia utile rimarcare che il tentativo di ridare impulso al settore produttivo passa per una maggiore produttività (dal punto di vista capitalistico) delle attività e funzioni a maggiore intensità di conoscenza, che diversi osservatori considerano oggi poco “valorizzate” sotto il profilo della gestione e non sufficientemente “valorizzanti” per le imprese. Detto con altre parole, al di là dell’importanza che la produzione di beni e servizi (in cui le attività conoscitive hanno una rilevanza sempre maggiore) occupa nella realizzazione del valore, il lavoro cognitivo è oggi considerato, da imprenditori e manager, troppo poco produttivo.
Capitalismo e lavoro cognitivo
Come si è anticipato, l’ipotesi qui avanzata assume una definizione di industriale come “maniera di agire/lavorare collettiva e organizzata scientificamente, che si basa sul macchinario come base materiale e sull’innovazione e il risparmio progressivo di lavoro/attività e di tempo”.[14] Questa prospettiva, che riprende alcune tesi formulate da Romano Alquati nella fase matura della sua ricerca militante, quando pose al centro dell’analisi quella che definiva “iperindustrialità”, declina dunque l’industria come maniera trasversale di organizzare non soltanto l’occupazione – e ancor meno la sola manifattura – ma l’intero agire umano lavorizzato (sussunto al capitale) o in lavorizzazione. Ricollegandosi al paragrafo precedente, industriale non si contrappone qui a “estrattivo” o a “finanziario”, poiché il termine chiama in causa l’intera trama dei lavori e delle attività che “danno valore”. Anche la politica, l’università, il consumo riproduttivo, l’agire amministrativo, nella visione a suo tempo suggerita da Alquati, sono organizzati (sempre più) con criteri industriali.
Tale visione appare ancora più pertinente oggi, in cui svariati campi di lavoro e attività sono investiti da una evidente (agli occhi di chi scrive) svolta tecnologico-organizzativa, non scevra da elementi ideologici che rasentano il misticismo[15]. Per quanto sia problematico spiegare questa tecno-euforia – i cui riflessi si proiettano sull’intera sfera sociale nella sua accezione “generica” – esclusivamente con l’imperativo del rilancio dei profitti, è evidente che parte dei nuovi paradigmi tecnologi siano orientata al risparmio di i) tempo di lavoro, ii) costi marginali iii) tempi di rotazione del capitale.
Il flusso dell’innovazione, nella rappresentazione mainstream, forma il nucleo centrale della nuova economia fondata sulla conoscenza, che trova riflesso in una divisione del lavoro con al centro le figure produttive in possesso delle qualità generiche e specialistiche motrici del cambiamento e detentrici di sapere potenzialmente convertibile in valore.[16] Di questa popolazione sono state date molte definizioni, dai knowledge worker che Peter Drucker individuava negli anni Ottanta come futura “leading class”, agli analisti simbolici di Robert Reich, dalla meteora della classe creativa di Florida fino alle “nuove geografie del lavoro” di Enrico Moretti. Queste proposte, peraltro tra loro non assimilabili e qui riunite per comodità, non sono – non tutte almeno – liquidabili come rappresentazioni ideologiche. Quasi sempre ideologica è tuttavia la descrizione che forniscono del lavoro cognitivo, con l’inclusione generalizzata dei knowledge worker in una nuova classe media benestante e cosmopolita.
Il programma di ricerca improntato al capitalismo cognitivo ha una genesi articolata ma si può considerare distintivo delle proposte teoriche per brevità accomunabili sotto la definizione di operaismo (o post-operaismo), cui si richiamano gli autori che maggiormente hanno contribuito alla formulazione originaria del concetto e alle sue successive declinazioni e integrazioni.[17] Esplicitamente volto a costruire un paradigma teorico all’altezza del nuovo regime di accumulazione, fornisce della svolta cognitiva dell’economia una visione decisamente distante da quella promulgata dai teorici della knowledge based economy. In questa sede si farà prevalente riferimento, in maniera succinta per ragioni di spazio, al lavoro di Carlo Vercellone, autore che alla sistematizzazione della categoria di capitalismo cognitivo ha fornito uno dei contributi più rilevanti.
Il capitalismo cognitivo ha la sua premessa nella crisi del regime di accumulazione fordista/industriale e si afferma nel progressivo esaurirsi della razionalità economica del capitale, come crisi irreversibile della legge del valore, come crisi del rapporto tra profitto e ricchezza sociale ed infine (è il dato che qui ci interessa) come crisi del controllo sulle condizioni della produzione. Nel capitalismo cognitivo la prescrizione taylorista delle mansioni cede infatti il posto alla prescrizione della soggettività, che “si concretizza in tutta una panoplia di strumenti di valutazione del lavoratore e della sua conformità ai valori dell’impresa, inducendo spesso quelle che in psicologia si chiamano ingiunzioni paradossali”.[18] Questa visione è in aperta contraddizione con l’economia fondata sulla conoscenza, che lo stesso autore antepone logicamente al capitalismo cognitivo, nel senso che la prima (che ha la sua base materiale nella formazione conflittuale di una intellettualità di massa e nei servizi collettivi del welfare oltre le compatibilità capitalistiche) precede e si contrappone all’appropriazione parassitaria, da parte del capitale, delle conoscenze comuni e delle condizioni collettive della produzione. E’ da precisare che sia Carlo Vercellone sia altri autori non hanno mai associato al capitalismo cognitivo l’emergere di un nucleo privilegiato di forza-lavoro con alti skill, ponendo semmai in luce come tale categoria acquisisca efficacia se utilizzata come “filigrana per osservare l’intero spettro delle forme di produzione e di lavoro nella loro compresenza […] e non per individuare uno specifico settore di forza-lavoroo demarcare i lavori creativi daimcjob”.[19]
Questa lettura delle transizioni interne al capitalismo, oltre a costituire un riferimento fondamentale per l’analisi dei nuovi regimi di accumulazione, ha consentito di sottrarre l’analisi all’esaltazione acritica della knowledge based economy. Riteniamo tuttavia, da una parte, che anche queste tesi vadano assunte in modo dinamico, e dall’altra che possano aver dato vita a conclusioni troppo lineari sul tema del governo della forza-lavoro. L’ipotesi, nel passaggio tra fordismo e nuova economia, di un salto nel grado di autonomia della cooperazione sociale rispetto al controllo capitalistico – orientato a prescrivere la soggettività più che a organizzarla, a “catturare” la cooperazione più che ad “orchestrarla” – restituirebbe al lavoro sociale (al lavoratore collettivo) parte del potere sulle condizioni della produzione che nella separazione taylorista tra scienza, tecnica e lavoro, era concentrato nel management. Per quanto la mappa della produzione odierna offra un vasto repertorio di situazioni che danno evidenza empirica a questa lettura, riteniamo che questo approccio[20] possa e debba essere posto in relazione con le precedentemente richiamate tesi di Romano Alquati.
Industrializzazione del cognitivo
In cosa consiste questa industrializzazione? Ad un primo livello, la progressiva lavorizzazione di molteplici ambiti della sfera riproduttiva rimasti relativamente “esterni” al dominio del valore è uno dei passaggi cruciali di questo processo. La definizione di “esterno” è da acquisire in senso relativo. La conquista di spazi sempre nuovi in cui creare le condizioni per instaurare rapporti di produzione capitalistici costituisce infatti una costante del capitalismo, e si potrebbe a ragione affermare che ben poche attività ne siano oggi del tutto fuori. Ciò non significa che non vi siano esterni da piegare agli imperativi del valore. Come molti contributi hanno da tempo posto in luce[21], è il terreno della riproduzione del vivente (o di capacità-umana, per restare al lessico alquatiano) nella sua accezione più estesa (biologica, psichica, conoscitiva, emozionale, ecc.) il bersaglio grosso, “l’esterno” da conquistare alla valorizzazione. Il tema va tuttavia precisato. La sottomissione alla razionalità capitalistica delle funzioni riproduttive, dei mercati, degli apparati burocratici, amministrativi e politici, è infatti un processo che il capitale ha realizzato da tempo. Non è qui al carattere produttivo e funzionale (dato per scontato) della riproduzione sociale, del consumo e della burocrazia che si allude, ma al loro divenire – in forme situate e non lineari – immediati bacini di accumulazione e di valorizzazione diretta del capitale.
Per Alquati, l’affermarsi di una logica industriale nei tre ambiti funzionali che accanto alla produzione di utilità – di merci, beni o servizi in senso classico – individuava come costituitivi del sistema sociale, era un processo dispiegato o comunque in corso già negli anni Settanta e Ottanta.
Il primo di questi ambiti era definito del consumo realizzativo/distruttivo, in altre parole dei consumi indispensabili alla realizzazione del plusvalore, che può oggi essere esteso ad ulteriori sfere di uso esperienziale o edonistico del tempo libero. Difficile non vederne la dimensione valorizzante, ma anche il risvolto “industriale”, se pensiamo al funzionamento delle imprese 2.0 come Facebook, Twitter e molte altre, la cui redditività dipende in larga parte dalla serializzazione e trattabilità delle informazioni sugli utenti (dal loro profiling). O se guardiamo alle pratiche di consumo “collaborativo” che trasformano abitazioni e mezzi di trasporto individuali in ristoranti, alberghi, taxi, e consentono alle merci vendute di rientrare in circolo come valore di scambio, grazie a piattaforme tecnologiche uniformanti e che attraverso il sistema del rating riducono la relazione a feticcio numerico – traducibile in valore. O la proliferazione di protesi digitali indossabili che consentono in teoria di compiere in ciascun istante della giornata un atto di acquisto e quindi in un segnale trattabile dai software che lo registrano. Sempre più “industriali”, inoltre, sono le catene logistiche e distributive che hanno da tempo travalicato il carattere ancillare della produzione per farsi direttamente vettori del valore.
Il secondo ambito, che Alquati definiva del consumo riproduttivo/formativo di capacità umana, è da tempo al centro dei processi di lavorizzazione e molti sub-ambiti (salute, formazione, contenuti culturali, ma in senso più esteso potremmo includere in questo campo altri servizi collettivi) sono già segmenti centrali del mercato capitalistico. L’indebitamento e l’ingiunzione alla compatibilità dei conti di Stati ed Enti Pubblici forniscono inoltre un terreno favorevole per la radicalizzazione dei processi di “mercatizzazione” (non necessariamente privatistica) di queste attività, i cui profitti sono spesso assicurati dai regolatori. Il trasferimento dei costi della riproduzione (o di una loro quota crescente) ai lavoratori medesimi costituisce ad un tempo un risparmio netto per il capitalista collettivo e il terreno di formazione di una nuova imprenditoria che impiega un numero crescente di occupati. Ovviamente tale processo comporta, ad un altro livello, importanti ricadute sulla riproduzione del capitale, poiché qui le condizioni della valorizzazione giocano contro la riproduzione sociale. Come se il capitale, detto rozzamente, cannibalizzasse sé stesso.[22] Questo tema, di fondamentale importanza nella formulazione teorica del capitalismo cognitivo (che proprio per questo carattere distruttivo è contrapposto all’economia della conoscenza e delle “produzioni dell’uomo per l’uomo”), eccede gli obiettivi di questo contributo. Qui interessa sottolineare che in diversi di questi servizi riproduttivi, l’affermarsi di principi di concorrenza (tra imprese in senso stretto o imprese di fatto, come ad esempio le aziende ospedaliere o le Università e sempre più le scuole di ogni grado) e l’esigenza di accrescere la produttività di prestazioni spesso poco standardizzabili, ha favorito svolte tecnologiche e organizzative che si riflettono, secondo i casi, in un crescente assorbimento di funzioni intelligenti entro sofisticati macchinari diagnostici e operativi, piuttosto che nell’introduzione di standard operativi e criteri di valutazione che il personale di ogni livello deve acquisire come schema orientativo delle decisioni.
Anche il lavoro pubblico (che per Alquati costituiva il terzo ambito funzionale, che definiva politico-istituzionale) è con intensità variabile (anche in virtù di resistenze qui più forti) in fase di riorganizzazione in base ai principi del cosiddetto new public management, inteso nel duplice significato di riorganizzazione degli obiettivi e di sviluppo del funzionamento interno alla macchina amministrativa, funzionali sia ad una più esplicita aderenza alla logica della valorizzazione, sia ad incrementarne la produttività sia per ridurre i costi di funzionamento.
Resta infine l’ultimo (o primo) ambito funzionale, che Alquati definiva artefattura, della produzione di merci tangibili e immateriali o servizi venduti sul mercato, manifattura che incorpora crescenti quote di servizi (progettazione, comunicazione, logistica, ecc.) e servizi sempre più organizzati con criteri industriali. Molte pagine sono state spese, a partire dagli anni Ottanta, per analizzare la rottura delle concentrazioni produttive e il contestuale riversarsi sul territorio e nelle metropoli delle filiere di produzione, dunque del contestuale emergere (consensuale ma anche obtorto collo) di una forza-lavoro mobile, flessibile, precarizzata, ma refrattaria a farsi ingabbiare nelle gerarchie delle organizzazioni. La preferenza di ampi strati di lavoratori giovani e meno giovani, tra gli anni Ottanta e Novanta, fino alla coda della fase “espansiva” della globalizzazione, è andata verso impieghi gratificanti, anche se impegnativi sul piano della fatica psichica e del coinvolgimento; era la stagione dei no collar, forse la definizione più efficace per descrivere il mix di etica libertaria e individualismo dei professionisti dei settori high tech della produzione immateriale.[23]
Stupisce la minore attenzione prestata alle gerarchie che, contestualmente alla progressiva trasformazione delle regole d’ingaggio dei nuovi professionals, prendevano forma all’interno della stessa composizione, nonché ai processi speculari al divenire autonomo, basati su nuovi schemi di controllo e eterodirezione: ai livelli inferiori della gerarchia professionale ma anche ai piani alti, come alcune ricerche empiriche rilevano registrando presso molti knowledge worker la diffusa percezione di una intensificazione, di un’accelerazione e di una standardizzazione del lavoro.[24] Nella produzione cognitiva le attività sottoposte al controllo diretto del capitale non sono infatti meno importanti, sul piano meramente quantitativo ma anche dal punto di vista qualitativo, di quelle lasciate in gestione o coordinate in modo endogeno, dentro la cooperazione sociale. La compresenza di più schemi regolativi e di coordinamento rende in realtà problematica l’individuazione di una tendenza modale nelle forme di controllo della produzione cognitiva. Da questo punto di vista, l’ipotesi di una industrializzazione del cognitivo non intende avvalorare una convenzione alternativa a quella dell’autonomia, quanto (nuovamente recuperando una nozione alquatiana, quella di iper-industrialità) un salto organizzativo nella “maniera di organizzare” e sussumere il lavoro e tendenzialmente “l’agire umano in lavorizzazione”. La logica iperindustriale è descrivibile come articolazione e integrazione ad un livello superiore e più astratto di lavori e attività concretamente differenti. Di lavori relativamente proceduralizzati ed eterodiretti e lavori “liberi”, di skill neo-artigianali, di reti cooperanti apparentemente endo-organizzate e finanche di un’ampia gamma di prestazioni extra-salariali (al cui interno occorrerebbe però distinguere tra salariati di fatto,[25] prestazioni remunerate con monete simboliche[26] e attività del tutto desalarizzate che – tuttavia – “danno valore”). Queste diverse modalità sono quasi sempre coordinate secondo schemi razionali di integrazione e spesso con criteri “scientifici” di divisione del lavoro.
Un ruolo abilitante di questa industrializzazione è svolto dalla nuova generazione di IT, in grado di assorbire processi cognitivi ad un livello ancora sconosciuto all’epoca del boom della new economy e che rendono possibile oggi, e promettono di farlo ancor più in futuro, “industrializzare” ambiti e segmenti che fino a ieri si ritenevano al riparo dalla digitalizzazione. Ci siamo sempre opposti ad ogni determinismo tecnologico, ma ciò non implica trascurare l’importanza del tema. Le tecnologie mantengono, accanto ad altre funzioni, quella prioritaria di mezzo per estorcere e assorbire lavoro vivo (o di “agire umano in via di lavorizzazione”), riducendolo a proprio accessorio o comunque organizzandone tempi e schemi operativi. Non di sole piattaforme Web si parla, ma di sistemi gestionali, di “macchine che apprendono”, nuova robotica intelligente, manifattura additiva, oltre che di dispositivi integrabili alle macchine meccaniche ed elettriche (la cosiddetta Internet delle cose); mezzi che potenziano la cooperazione e la produttività, ma impoveriscono e omologano le esperienze cognitive dei lavoratori.
Per quanto nel nostro paese se ne parli meno, è da anni in corso un dibattito sull’impatto sociale di queste tecnologie, comprensibilmente orientato a verificarne gli effetti occupazionali. Lungi dal voler ricostruire in poche righe l’insieme degli argomenti sviluppati da questo filone – i cui obiettivi e preoccupazioni sono molto distanti dai nostri – è opportuno richiamare brevemente alcune ipotesi formulate nei contributi più noti. Tra i più discussi è il lavoro di Frey e Osborne,[27] volto a misurare il grado di “digitalizzabilità” – la probabilità di essere sostituiti da task digitali – degli attuali lavori (restituito attraverso un apposito indice applicato a 702 profili professionali), che arriva a ipotizzare che il 47% degli impieghi odierni è a rischio estinzione. Al di là della discutibile fondatezza di tale previsione, l’elemento di maggiore interesse riguarda il profilo delle professioni “digitalizzabili”: accanto ai lavori manuali finora poco toccati, i due autori includono infatti numerosi profili tecnici nell’industria[28] e nei servizi (si pensi alle ristrutturazioni in corso nelle banche, nelle assicurazioni e più in generale in tutti i servizi che gestiscono grandi quantità di clienti) e diverse figure professionali superiori. Risultati coerenti con quelli proposti da tre economisti della Columbia University in un paper che si confronta con la realtà della “disoccupazione intellettuale” e della dequalificazione degli impieghi dei laureati.[29] Anche secondo questi autori le tecnologie digitali, dopo aver favorito la razionalizzazione e gli incrementi di produttività nel lavoro impiegatizio, starebbero “risalendo le gerarchie”, aggredendo professionalità finora ritenute non automatizzabili. Non dissimili le conclusioni di un saggio particolarmente dibattuto di Brynjolfsson e McAfee.[30] Resterebbero al di fuori del “potere delle macchine” (per ora) le professioni che richiedono skill emozionali, affettivi, relazionali, creativi e le funzioni intellettuali relative a processi diagnostici situati e schemi di problem solving ad oggi difficilmente replicabili.
Il riferimento a questi studi non implica la condivisione degli scenari tratteggiati dai loro autori. Il controllo e la regolazione della forza-lavoro, infatti, non dipendono mai (solo) da variabili tecnologiche. Le ristrutturazioni tecnologiche, nel Novecento, sono sempre state seguite da una nuova dislocazione della forza-lavoro nella divisione tecnica e sociale emergente; l’occupazione veniva distrutta in una fase del ciclo, altra ne veniva creata a monte o a valle. E’ del tutto improbabile, tuttavia, che tale circolarità possa riprodursi. Il grado di sviluppo tecnologico raggiunto, verosimilmente, otterrà l’effetto di gonfiare la già ampia area di eccedenti, soggetti esclusi da qualsivoglia processo sociale produttivo e riproduttivo,[31] e quello correlato di abbattere le aspettative di mobilità sociale di vasti settori di lavoratori scolarizzati.
Nell’economia di questo contributo è più importante però focalizzare lo sguardo sul rapporto tra mezzi freddi e capacità incorporate nel vivente. Qui, ci sembra che la posta in palio riguardi, ad un livello generale, proprio l’autonomia della cooperazione sociale e del lavoro di rete che in qualche misura si rappresentano come estranei al controllo capitalistico. L’industrializzazione del cognitivo, in altre parole, potrebbe anche essere concettualizzata come tendenza (o tentativo di) all’industrializzazione del comune.
Sul versante micro implica viceversa il crescente impoverimento di svariate attività cognitive e capacità umana. Su questo aspetto, quasi del tutto trascurato dalla letteratura sui knowledge worker – dove tra sviluppo dei mezzi tecnici e qualità del lavoro sembra esserci un gioco a somma positiva – e non abbastanza rimarcato anche dai contributi sul capitalismo cognitivo, è opportuno richiamare l’attenzione.
Vi sono infatti più tipi di conoscenza e di prestazioni intellettuali, timiche, comunicative cooperanti nella produzione cognitiva. Quando si parla di conoscenza tutti pensano alla conoscenza generativa, raramente si sottolinea che la stessa produzione cognitiva presuppone molta conoscenza replicativa, oltre che lavoro ”stupido“ tout court.[32] C’è un lavoro produttivo di conoscenza, ne esiste uno di cattura, traduzione e industrializzazione dell’innovazione, ne esistono altri – e sono i più diffusi – di applicazione, trasferimento, circolazione di conoscenze codificate e processi relativamente standard.[33] Proprio l’introduzione di nuovi e potenti mezzi assorbenti capacità umana, attinenti anche alla sfera mentale e psichica, ha tra i suoi effetti una stratificazione verticale del lavoro cognitivo con una crescente concentrazione – questa l’ipotesi – negli strati intermedi e inferiori.
Ovviamente non tutto è macchinizzabile e la maggioranza delle attività non lo è in forma integrale, mentre in tante altre il rapporto tra mezzi e lavoro vivo non si qualifica come semplice deskilling o degradazione à la Braverman, ma piuttosto nella forma di sistemi tecnologici aperti che devono essere attivati e si combinano con funzioni umane non replicabili. Occorre nondimeno considerare che i mezzi della produzione cognitiva non consistono solo in macchine e dispositivi digitali. Sono anche schemi operativi sequenziali, tecniche comportamentali (si pensi a quelle di contatto e vendita, ad esempio), procedure, informazioni codificate, saperi organizzativi, finanche la configurazione degli spazi produttivi. Tutto ciò e molto altro è organizzazione e coordinamento della produzione cognitiva, sistema di mezzi strutturati per potenziare la produttività che vanno concettualizzati come forma di capitale fisso adeguato a cicli produttivi per definizione instabili, in cui i problemi si presentano sempre in forma diversa.
Parlare di industrializzazione del cognitivo non significa dunque ritornare al passato sostituendo l’operaio-massa con il cognitaro-massa; è probabilmente fuorviante la definizione, che pure in alcuni settori appare appropriata, di taylorismo digitale.[34] Nella gran parte dei casi mezzi e tecnologie neo-industriali implicano attivazione, presuppongono il coinvolgimento attivo ed emotivo di chi le usa; come è stato scritto, nel lavoro creativo troviamo una danza dialettica tra autonomia e controllo.[35] E tuttavia, è probabilmente un tema d’importanza fondamentale, industrializzazione non è sinonimo di taylorismo. L’ipotesi esplorativa dell’industrializzazione del cognitivo ha la sua norma nell’eterogeneità delle forme concrete di controllo della produzione,[36] in cui la mobilitazione impressiva[37] di un alto grado di libertà, “orientata” alla generazione di conoscenza convertibile in valore, convive con forme di espropriazione e assorbimento delle conoscenze probabilmente sconosciuti anche ai terzi livelli del contratto dei metalmeccanici delle vecchie linee di montaggio di Mirafiori.[38] Non si fonda però su un compromesso tra autonomia e controllo; piuttosto è un’ipotesi che esplora la tendenza verso un grado più avanzato, dal punto di vista capitalistico, di sussunzione della capacità umana, per tornare al lessico di Alquati, lavorizzata o in lavorizzazione. E’ dunque a questo livello, dentro questa industrialità, che occorre situare e ritrovare le possibilità di un suo contro-uso.
Alcune provvisorie conclusioni
L’ipotesi di una industrializzazione del cognitivo, che non pone in discussione le premesse e alcuni concetti-chiave della categoria di capitalismo cognitivo (crisi del valore, divorzio tra valore e ricchezza sociale), avanza alcune riserve nei confronti dell’argomento della crisi irreversibile del controllo capitalistico diretto (e non solo per prescrizione di soggettività) sul lavoro. Carlo Vercellone, in realtà, non tralascia di dare evidenza al persistere di ambiti ancora organizzati in forma tayloristica, ma l’impressione è che questi siano considerati “residuali”. Si è qui argomentato, viceversa, che considerare il taylorismo come “fase suprema” dell’industrializzazione, e per estensione il fordismo “come apice della sussunzione reale del lavoro al capitale”,[39] rischia di non cogliere il salto di industrialità nella sottomissione dell’insieme delle attività messe a valore nel nuovo capitalismo.
Una conseguenza di questa ipotesi, del tutto evidente, coinvolge il tema della sussunzione.[40] L’industrializzazione del cognitivo evoca una direzione per molti aspetti differente a quella che individua un nuovo primato della sussunzione formale (che ha le sue basi nell’appropriazione parassitaria, da parte del capitale, di quanto prodotto autonomamente da una cooperazione sociale che gli preesiste o che lo eccede), poiché tematizza apertamente l’intervento diretto del capitale nel ri-dare la sua “forma alla produzione”. La crescente difficoltà nell’applicazione delle categorie di sussunzione formale e reale all’insieme delle eterogenee forme della valorizzazione capitalistica contemporanea ha in ogni caso stimolato la ricerca di nuovi approcci esplorativi. Rientrano in questa prospettiva, ad esempio, la categoria di sussunzione vitale, proposta da Andrea Fumagalli,[41] che tematizza (questa riduzione non restituisce ovviamente la complessità della riflessione) il processo di “sfruttamento della vita”, vicino a ciò che in questa sede è stato indicato come lavorizzazione di capacità umana. Il concetto di impressione, proposto da Chicchi, Leonardi e Lucarelli, muove viceversa dall’analisi degli scenari successivi alla “distruzione dell’istituzione del salario”. Lo sfruttamento perimpressione, che nella proposta degli autori intrattiene con la sussunzione un rapporto di compresenza, co-implicazione e riarticolazione reciproca, tematizza la messa al lavoro della soggettività oltre i confini del lavoro subordinato e della compravendita della forza-lavoro, quindi come “strumento di governo delle vite e dispositivo biopolitico volto alla selezione di traiettorie potenzialmente funzionali (dal punto di vista della valorizzazione capitalistica)”.
Detto di una parziale convergenza tra le due proposte, tra loro differenti, quando individuano nella produzione della soggettività il nucleo del comando capitalistico sul lavoro e rinviando ad altre sedi il loro approfondimento, per l’ipotesi di industrializzazione del cognitivo è utile richiamare il passaggio in cui Marx rimarcava che “la sussunzione formale è semprebattistrada” della sottomissione reale “benché questa, più sviluppata, possa a sua volta costituire la base per l’introduzione della prima in nuove branche produttive”.[42] Ci sembra che la formulazione, quando non assunta in senso storicistico (un prima e un dopo cronologico), mantenga la sua valenza esplicativa per rendere conto ad esempio dei processi di lavorizzazione della sfera riproduttiva e dei consumi, o della sequenza a spirale tra innovazione e applicazione industriale nell’ambito produttivo. L’elevata libertà di cui godono i lavoratori cognitivi nelle fasi espansive di nuovi paradigmi produttivi, che mettono a valore forme cooperative e reti relativamente autonome spesso esterne al controllo delle imprese, con l’entrata a regime delle innovazioni è infatti drasticamente ridimensionata e cede spazio a forme più o meno strutturate di organizzazione e divisione tecnica del lavoro.
Ultimo tema, l’ipotesi dell’industrializzazione del cognitivo si propone di contribuire al rilancio del dibattito sulla composizione di classe. E’ nostra convinzione che la verifica della produttività delle categorie proposte debba risiedere anzitutto nella capacità di farsi riconoscere ed entrare in “connessione sentimentale” con alcune frazioni della composizione sociale. L’impressione è che la nostra (in senso lato) elaborazione si sia in questi anni rivolta soprattutto ai segmenti con relativamente alta autonomia, anche se non necessariamente con congrui redditi e spesso esposti anzi a forti livelli di precarietà. E’ una scelta che ha scommesso sulla possibilità di contro-utilizzare l’autonomia e capovolgere la condizione di precarietà. Quali pratiche di emancipazione sarebbero agibili da soggetti espropriati di capacità?[43] E’ però una scommessa con cui, pacatamente, iniziare a fare i conti. L’impressione è che questa prospettiva abbia sopravvalutato la centralità di alcune frazioni (il riferimento è ai segmenti del lavoro culturale, dell’economia sociale, dei creativi) nelle gerarchie della produzione capitalistica. In italia, in specifico, dove non esiste un vero settore della produzione su larga scala di contenuti conoscitivi e creativi, né una vera industria culturale, questi soggetti appaiono spesso inseriti in attività relativamente “periferiche”, circostanza che ne indebolisce la possibilità di dare vita a coalizioni stabili e che, per converso, rafforza i dispositivi impressivi e l’incentivo ad agire conformemente alle ingiunzioni negative (vincoli) e positive (incentivi) che ne orientano l’azione in termini funzionali alla riproduzione del sistema. Non è ovviamente detto che siano “marginali” dal punto di vista dell’organizzazione di un’alternativa. Riconoscere questa possibilità non implica tuttavia acquisire come ambivalenti tutte le pratiche a cui questi soggetti danno vita. Le letture quasi in chiave neo-consiliare di alcune esperienze di economia condivisa e di social innovation, ad esempio, andrebbero chiarite. Tali esperienze potrebbero infatti essere concettualizzate anche come istanze di liberazione dall’industrializzazione del cognitivo, ma assumono tale valenza quando sono agite intenzionalmente con questi fini, non in quanto tali. Nella maggioranza dei casi non ci sembra così e si potrebbe anzi obiettare che spesso in queste sedi siano più facilmente riconoscibili le coordinate simboliche del nuovo capitalismo che non quelle della sua critica. Questo senza disconoscere il valore e il potenziale delle pratiche mutualistiche come possibili spazi di politicizzazione, anzi! Forse però occorrerebbe distinguere maggiormente.
Per contro, è da ritenere che difficilmente possano riconoscersi nell’immagine di autonomia dal controllo delle imprese gli strati inferiori del lavoro cognitivo più esposti ai processi di industrializzazione richiamati e a quelli correlati di declassamento. Possiamo ipotizzare che il disagio e il malessere che periodicamente agita queste componenti (che si esprime quasi solo individualmente, talvolta attraverso il voto), oggi spesso con alta scolarità, derivino almeno in parte dalla concreta esperienza della svalorizzazione delle conoscenze (individuali e sociali) detenute. Parafrasando un celebre articolo sessantottino “contro l’università”, si potrebbe a questo punto affermare che la conoscenza “c’è chi la usa” e “chi ne è usato”. Eppure anche qui si trovano saperi, istanze cooperative e anche qui c’è precarietà. Soprattutto, c’è dismisura tra la qualità delle conoscenze detenute e l’esperienza quotidiana del declassamento. E forse c’è la residua possibilità di dare al malessere forma collettiva. Come c’è scendendo ancora di livello, nelle reti del tutto eterodirette dell’operaietà terziaria che innerva il lavoro riproduttivo delle metropoli, nella produzione di città, nei servizi di cura, nelle catene distributive, nella logistica, nei call center.
Su tutti questi temi, questo l’obiettivo ultimo di questo contributo, sarebbe importante riaprire la riflessione.
___________________________________________________


