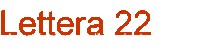La rivoluzione berlusconiana
di Alessandro Leogrande
In questi mesi il governo Pdl-Lega porterà a termine la propria riforma della giustizia, realizzando uno dei capisaldi della “rivoluzione berlusconiana”, elaborato già nella prima metà del decennio passato quando Berlusconi decise di scendere in campo non solo per sbarrare la strada ai “comunisti”, ma anche, via via, alle toghe rosse, a Mani pulite, alla “casta delle procure” che avevano sovvertito e avrebbero continuato a sovvertire la democrazia italiana. Sanare questo tumore, ricondurlo all’ordine, cioè alla posizione che occupava prima di Tangentopoli, è da sempre uno degli obiettivi del berlusconismo. Chi ha pensato negli anni, e ultimamente fino all’approvazione del lodo Alfano, che Berlusconi si occupasse di giustizia solo per regolare e anestetizzare i processi che lo riguardavano, si è mostrato miope.
C’è sicuramente del “personale” in tutto questo, e il Cavaliere ha sempre gridato alla persecuzione giudiziaria, all’accanimento di alcune toghe nei suoi confronti. Ma c’è anche qualcosa di più, molto di più: ridurre l’autonomia della magistratura, farne un ente alle dipendenze dello strapotere governativo risponde a interessi più vasti che si riconoscono nel berlusconismo e da esso si sentono protetti. Tale mossa è in piena sintonia con le pretese del partito degli avvocati, trasversale a tutto il centrodestra, che in questi anni è diventato una potente lobby parlamentare. Non è solo una mossa difensiva, risponde a un preciso impianto ideologico. E qui la parola “ideologia” è usata nel senso più strettamente filosofico: visione del mondo e delle sue cose, ed elaborazione di una teoria politica che sia sulla stessa lunghezza d’onda.
È questo il principale motivo per cui Berlusconi non si accontenta del lodo Alfano, con l’approvazione del quale, nello spazio di un solo pomeriggio, si è imposta l’immunità per le alte cariche dello Stato e per il premier, annullando di fatto il processo Mills che sarebbe da lì a poco giunto a conclusione. Il berlusconismo pretende molto di più: ridimensionamento del ruolo del Csm, separazione delle carriere tra giudici e pm, e soprattutto, per usare le stesse parole di Berlusconi, “indirizzo dell’azione penale superando l’attuale ipocrisia della finta obbligatorietà”. In pratica, l’attuale maggioranza intende sopprimere l’articolo 112 della Costituzione (che così recita: “Il Pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”) e imporre il principio secondo cui è il governo, quindi chi detiene il potere politico, a indicare i reati da perseguire e quelli da lasciar correre, e a stabilire criteri meritocratici per giudicare positivamente i pm che si allineano ai suoi diktat e punire quelli che non lo fanno. È la fine della stagione delle grandi inchieste sul rapporto politica-economia-crimine. E, cosa ancor più grave, è il preludio dell’apartheid giuridico: impunità per chi mi pare, dice il governo, e carcere per i “diversi”, gli “altri”, chiunque non è di mio gradimento...
Con questa riforma siamo al compimento della “rivoluzione berlusconiana”, al suo estendersi su ogni meandro dell’intera società italiana. È come se il berlusconismo (cultura egemone nel paese da molti anni) abbia individuato nella magistratura il solo potere istituzionale ancora non allineato. L’esecutivo è ormai espressione non della dialettica tra partiti, ma delle volontà del premier. Il Parlamento è ormai ridotto a un surrogato della Camera delle Corporazioni: privo di una reale opposizione e popolato da yes-men selezionati dai vertici di partito (il principale partito per giunta, quello del premier, è un non-partito in stile putiniano piuttosto che occidentale, che non ha mai celebrato in quindici anni un solo congresso che possa chiamarsi tale). Il sistema televisivo e informativo è quello che è, e non occorre soffermarsi ulteriormente. Il potere locale, che in altre epoche e altri paesi ha svolto un’importante funzione di contropotere, è invece in larga parte espressione diretta (localistica e alle volte ancora più estremista) della stessa cultura egemone.
Il paradosso tutto italiano è che, in questo scenario, proprio la magistratura (cioè il corpo dello Stato che – forze armate escluse – più tempo ci ha messo per spurgarsi delle scorie del fascismo) sia assurto a spazio politico liberato. E così, con la fine della sinistra, abbiamo assistito al coagularsi di un consenso ambiguo (e spesso reazionario, molto distante dalle posizioni di forze che, come Magistratura democratica, hanno contribuito enormemente alla democratizzazione del proprio campo) intorno al partito dei giudici quale ariete anti-berlusconiano. È questo, più o meno, il programma dell’Italia dei Valori, e dei Grillo, Travaglio eccetera. Rispondere col legalismo, e con tutta una vecchia retorica sulla certezza della pena e delle manette, all’impunità dilagante. In questo scontro tra due destre, la sinistra non può certo limitarsi a scegliere la destra migliore (per quanto lontana anni luce da quella peggiore). Dovrebbe invece ripartire da un altro orizzonte, dalla constatazione delle fratture sociali, dalla critica del fondamento ideologico della nuova ideologia giuridico-securitaria.
Tuttavia il rischio che oggi si corre a sinistra è quello di non capire l’oggettiva portata della “rivoluzione berlusconiana” per paura di apparire giustizialisti. Come se una riflessione necessaria sui modi nuovi del garantismo (riflessione cui dovremmo tutti contribuire) non possa stare insieme alla critica della rottura dell’equilibrio tra poteri dello Stato.
La riduzione dell’autonomia della magistratura pretesa dal governo Berlusconi (e soprattutto da quella lobby degli avvocati che, da Ghedini a Pecorella, alla Buongiorno, ha orientato la bozza presentata dal ministro Alfano) non è una prerogativa della sola destra italiana. A sostenere le stesse cose è una corrente di pensiero molto forte, che ha il suo epicentro nei neocon americani e ha messo le sue radici nei partiti di destra di mezzo mondo. C’è un libro che costituisce il loro principale manifesto: “Coercing virtue: the worldwide rule of judges”. L’ha scritto Robert Bork, avvocato e giudice di Corte d’Appello federale, divenuto famoso a metà anni ottanta quando la sua nomina alla Corte suprema, fortemente voluta da Reagan, fu bloccata da una vasta campagna della associazioni per i diritti civili. In Italia è stato tradotto da una piccola casa editrice di Macerata, Liberilibri, con il titolo “Il giudice sovrano”, e negli ultimi tempi è stato ampiamente citato dagli esponenti della destra italiana, dall’ex-ministro della giustizia leghista Castelli in giù.
Analizzando l’attività della Corte suprema in Stati Uniti, Canada e Israele, Bork sostiene che il potere giudiziario (non eletto dal popolo) ha usurpato i compiti della politica (i cui organi sono invece elettivi) fino al punto di stravolgere la Costituzione e compiere un vero e proprio colpo di Stato. Pur non entrando nel merito delle differenze istituzionali tra paese e paese, conviene citarne per esteso alcuni passaggi, perché spiegano meglio di qualsiasi altra cosa come siamo di fronte a un refrain globale che trascende l’italico berlusconismo.
Scrive Bork: “Le nazioni occidentali hanno temuto a lungo di venire contagiate dalla malattia americana, ovvero dal fenomeno dell’appropriazione, da parte dei giudici, dell’autorità appartenente al popolo e ai suoi rappresentanti eletti. Oggi tali nazioni stanno imparando, forse troppo tardi, che questa forma di imperialismo non è tanto una malattia americana quanto una malattia giudiziaria che non conosce confini.” E ancora: “Se non comprendiamo il deterioramento della funzione giudiziaria a livello mondiale, non potremo capire la portata della rivoluzione politica che sta avvenendo in tutte le nazioni occidentali e che sta portando alla graduale ma incessante sostituzione del governo dei rappresentanti eletti con quello dei giudici nominati.” Pertanto la conclusione non può che essere una: “Le nazioni che non vogliono abdicare alla facoltà di governare se stesse si trovano quindi a dover risolvere un problema cruciale, quello di riuscire a mitigare e arginare le aggressioni antidemocratiche sferrate dalle proprie classi giudiziarie.”
Il principale colpevole del dilagare dell’attivismo giudiziario, dell’internazionalizzazione del diritto, della giuridicizzazione del mondo politico è, manco a dirlo, il ’68. Per Bork, gli ex militanti del movimento studentesco e del movimento per i diritti civili hanno formato una “new class” (una casta formata da “giornalisti, accademici di ogni livello, artisti di Hollywood, esponenti di primo piano di clero e burocrazie ecclesiastiche, di musei e di fondazioni filantropiche, ambientalisti radicali e associazioni attiviste di ogni tipo”) che orienta le classi giudiziarie di ogni ordine e grado. Per cui, ancora una volta, da una parte come dall’altra dell’Atlantico, “abolire il ’68” è il primo passo per la ricostituzione di valori che si ritiene siano andati perduti. O al contrario, ogni battaglia politica reazionaria è vista come un capitolo della madre di tutte le guerre: abolire appunto, quasi per decreto, la stagione degli anni sessanta.
Ho citato a lungo il libro di Bork perché è curioso vedere come, pur non contemplando in alcuna delle sue pagine il caso italiano, le sue dichiarazioni sono in toto sovrapponibili a quelle di giornalisti, intellettuali, ministri e parlamentari alla corte di Berlusconi.
Intendiamoci. La crescita dell’attivismo giudiziario è direttamente proporzionale alla debolezza della politica. Laddove la politica perde la capacità di interpretare e di modificare il reale, laddove risulta incapace di produrre rappresentanza e laddove, su un piano più complesso, la crisi dei legami e delle morali tradizionali non è prontamente sostituita da una nuova morale, la pratica del diritto (nel concreto, il ricorso ai tribunali) tende a riempire il vuoto che si è creato. È quasi un processo fisico, non è – come dicono le destre – il frutto di una usurpazione deliberata. Da questo punto di vista, Tangentopoli costituisce un caso da manuale. Le inchieste e i processi di Milano sono stati una risposta extra-politica all’incapacità, o peggio: all’impossibilità, della politica italiana di riformarsi dal suo interno.
D’altro canto occorre ricordare che il movimento dei diritti civili negli Usa e molti movimenti per i diritti in giro per il mondo, hanno spesso fatto ricorso alla “via giudiziaria” con lo scopo che una determinata sentenza, o un pronunciamento della Corte Suprema, potesse costituire un avanzamento della democrazia sostanziale. Anche in Italia, questa pratica è stata intrapresa da molti soggetti politici, che potremmo definire post-rivoluzionari o riformisti radicali. Molte battaglie femministe, laiche, antimilitariste, antirazziste, antimafia hanno avuto quale loro obiettivo dichiarato l’approdo a un processo civile o penale, con lo scopo che una sentenza favorevole potesse costituire un precedente, un punto fermo, sulla strada per il riconoscimento di determinati diritti; una piccola vittoria all’interno di una lotta più generale.
La sensazione che si ha oggi è che il vento sia davvero girato dall’altra parte. In questo controriformismo giudiziario che prende forma non solo in Italia non c’è – ovviamente – solo l’intento di rimettere le cose a posto, cioè di ricondurre la magistratura ai suoi consueti binari; ma si sta andando oltre. Si risponde alla debolezza della politica con una nuova forma di sovranità. Il governo Berlusconi non sta semplicemente regolando i propri conti con le “toghe rosse”; sta procedendo alla messa in pratica di idee appartenenti a un vasto fronte, che condivide lo stesso humus cultural-politico, senza incontrare opposizione alcuna – cosa che sarebbe impossibile fare in qualsiasi altro paese occidentale. L’anomalia italiana non è in quel novero di idee, è semmai nel fatto che possano davvero realizzarsi, creando un precedente a livello internazionale.
Qui non si tratta solo di autoritarismo, di stravolgimento dei diritti dei lavoratori, di razzismo contro gli stranieri. Siamo a un livello ancora precedente, basilare dal punto di vista della logica politica: siamo alla creazione di una macchina perfetta che racchiude in sé gli altri poteri, in uno stretto e asfittico sistema di dipendenze. Una Bengodi dei neoconservatori in cui la rivendicazione del controllo della politica sulla magistratura diventa il prerequisito fondamentale della piena autonomia di un sovrano post-moderno.
Tuttavia, poiché non esistono età dell’oro che hanno preceduto l’attuale scivolamento, è opportuno ribadire che la Prima Repubblica non è stata proprio il regno delle libertà politiche (e giudiziarie) come oggi troppo spesso si sente dire. Il sistema dei partiti era certo molto più complesso, raffinato, culturalmente più elevato di quello attuale. Ma anche allora, il potere politico era allergico alla pur minima indagine sul proprio operato da parte della magistratura. E quando Pasolini scrisse nel ’75 della necessità di processare i “gerarchi” democristiani era perfettamente consapevole di stare proponendo qualcosa di irrealizzabile, almeno in tempi brevi.
Non solo. Come ricorda Sciascia in “L’affaire Moro”, l’ultimo discorso in Parlamento del leader democristiano, prima di essere sequestrato dalle Br, fu in difesa dell’onorevole Gui, anch’egli democristiano, ministro della Difesa coinvolto nello scandalo Lockheed. Come ricorda Sciascia, di fronte alla richiesta di rinvio a giudizio, Moro disse perentoriamente che la Dc, tutta la Dc, non si sarebbe fatta processare, né in aula, né nelle piazze. Ed evocando, quasi minacciosamente, la solita autonomia del potere politico e il legame diretto con la volontà del popolo, aggiunse: “Noi rispondiamo con la più ferma reazione e con l’appello all’opinione pubblica che non ha riconosciuto in noi una colpa storica e non ha voluto che la nostra forza fosse diminuita.”
Colpa, forza, appello all’opinione pubblica... Cosa sono, queste, tracce di cripto-berlusconismo in Aldo Moro? La domanda da farsi è però un’altra: cosa è cambiato da allora? È cambiato che una riforma radicale della Costituzione (quel testo che le forze della Prima Repubblica non avrebbero mai messo in discussione) può essere conclusa nello spazio di un mese. E che chiunque provi a parlare di diritto, di garanzie del diritto, di azione del diritto, di pratica del diritto, di conoscenza ed emancipazione attraverso il diritto, da una parte sia stritolato dall’armata dei neoconservatori italiani, dall’altra non riesca a capire quali siano i compagni di strada.