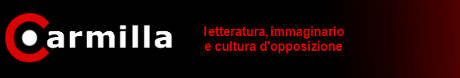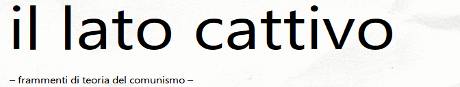- Details
- Hits: 2470
Fine anno, fine della corsa?
di Sandro Moiso
 Quello che infastidisce maggiormente nello spettacolo di Mafia capitale è l’accento posto sull’eccezionalità del caso romano, la sorpresa che tutti i media sembrano mostrare nei confronti di quello che non è altro che un caso (tutt’altro che anomalo) di corruzione amministrativa e politica quotidiana nell’Italia degli scandali legati all’Expo, al Mose e a molti altri ancora. Ma, ormai, il termine Mafia ha preso il posto dell’Uomo Nero, di Freddie Krueger, di Walter White e di qualsiasi altra figura dell’immaginario più diabolico e viene sbandierato ad ogni piè sospinto per dimostrare che ciò che c’è di marcio nella società attuale non dipende dai rapporti di classe e dall’appropriazione privata della ricchezza sociale prodotta, ma da poche figure negative che guastano i sani rapporti sociali basati sui principi del capitalismo e che possono anche arrivare a minacciare gli equilibri politici faticosamente raggiunti.
Quello che infastidisce maggiormente nello spettacolo di Mafia capitale è l’accento posto sull’eccezionalità del caso romano, la sorpresa che tutti i media sembrano mostrare nei confronti di quello che non è altro che un caso (tutt’altro che anomalo) di corruzione amministrativa e politica quotidiana nell’Italia degli scandali legati all’Expo, al Mose e a molti altri ancora. Ma, ormai, il termine Mafia ha preso il posto dell’Uomo Nero, di Freddie Krueger, di Walter White e di qualsiasi altra figura dell’immaginario più diabolico e viene sbandierato ad ogni piè sospinto per dimostrare che ciò che c’è di marcio nella società attuale non dipende dai rapporti di classe e dall’appropriazione privata della ricchezza sociale prodotta, ma da poche figure negative che guastano i sani rapporti sociali basati sui principi del capitalismo e che possono anche arrivare a minacciare gli equilibri politici faticosamente raggiunti.
Da una parte dunque i buoni servitori dello Stato (e del Capitale) e dall’altra i corrotti, le anime perse che non hanno saputo resistere alle seduzioni del Grande Tentatore (di solito un singolo uomo, ex-terrorista di destra oppure capo-bastone di un clan, il solito “grande vecchio” che la sinistra istituzionale ci ha insegnato a vedere dappertutto). Anche se sappiamo tutti che questa narrazione è falsa, come la promessa di Renzi di resistere fino al 2018.
- Details
- Hits: 2783
Il Novecento di Mario Tronti
di Carlo Formenti, Franco Milanesi, Damiano Palano
Questo testo è la trascrizione del dibattito svoltosi presso la Casa della Cultura di Milano il 20 novembre 2014, in occasione della presentazione del libro di Franco Milanesi, Nel Novecento. Storia, teoria, politica nel pensiero di Mario Tronti (Mimesis, Milano 2014).
 Damiano Palano: Il testo di Franco Milanesi, al quale è dedicata la nostra discussione, ha il merito di inquadrare fin dal titolo la centralità del Novecento nell’esperienza e nel pensiero di Tronti, un’esperienza e un pensiero strettamente legati al grande laboratorio del XX secolo e le cui radici affondano, in particolare, nel passaggio cruciale degli anni Venti e Trenta. Al dibattito partecipa naturalmente l’autore del volume, Franco Milanesi, che da sempre affianca la passione politica a un lavoro di riflessione teorica e che in particolare, in alcuni suoi lavori, si è rivolto all’«antropologia» della militanza novecentesca. Il secondo protagonista della nostra discussione è Carlo Formenti, uno studioso molto noto per le sue ricerche sulle implicazioni sociali della rivoluzione digitale (e sugli immaginari cresciuti attorno alle nuove tecnologie). Formenti ha alle spalle un percorso ricco di esperienze eterogenee. Arriva dalla militanza sindacale, nei primi anni Ottanta è stato redattore di «Alfabeta» e in seguito ha lavorato per molti anni al «Corriere della Sera». Senza abbandonare l’attività giornalistica, nell’ultimo quindicennio si è dedicato con maggiore intensità alla ricerca e all’insegnamento, all’Università del Salento. All’interno di un itinerario tanto eterogeneo, è comunque possibile ravvisare una forte coerenza, quantomeno nei temi che Formenti ha collocato al centro della sua riflessione. A partire da La crisi del valore d’uso. Riproduzione, informazione, controllo, un testo pubblicato nel 1980 presso l’editore Feltrinelli (negli «Opuscoli marxisti» diretti in quegli anni da Pier Aldo Rovatti), si possono infatti riconoscere tutti i grandi nodi che tornano quasi costantemente nella ricerca di Formenti: l’interesse per il ruolo delle nuove tecnologie e per l’impatto che esse producono sull’organizzazione del lavoro, un dialogo critico con le diverse posizioni del postmodernismo filosofico e la costante domanda sulle nuove forme di azione politica.
Damiano Palano: Il testo di Franco Milanesi, al quale è dedicata la nostra discussione, ha il merito di inquadrare fin dal titolo la centralità del Novecento nell’esperienza e nel pensiero di Tronti, un’esperienza e un pensiero strettamente legati al grande laboratorio del XX secolo e le cui radici affondano, in particolare, nel passaggio cruciale degli anni Venti e Trenta. Al dibattito partecipa naturalmente l’autore del volume, Franco Milanesi, che da sempre affianca la passione politica a un lavoro di riflessione teorica e che in particolare, in alcuni suoi lavori, si è rivolto all’«antropologia» della militanza novecentesca. Il secondo protagonista della nostra discussione è Carlo Formenti, uno studioso molto noto per le sue ricerche sulle implicazioni sociali della rivoluzione digitale (e sugli immaginari cresciuti attorno alle nuove tecnologie). Formenti ha alle spalle un percorso ricco di esperienze eterogenee. Arriva dalla militanza sindacale, nei primi anni Ottanta è stato redattore di «Alfabeta» e in seguito ha lavorato per molti anni al «Corriere della Sera». Senza abbandonare l’attività giornalistica, nell’ultimo quindicennio si è dedicato con maggiore intensità alla ricerca e all’insegnamento, all’Università del Salento. All’interno di un itinerario tanto eterogeneo, è comunque possibile ravvisare una forte coerenza, quantomeno nei temi che Formenti ha collocato al centro della sua riflessione. A partire da La crisi del valore d’uso. Riproduzione, informazione, controllo, un testo pubblicato nel 1980 presso l’editore Feltrinelli (negli «Opuscoli marxisti» diretti in quegli anni da Pier Aldo Rovatti), si possono infatti riconoscere tutti i grandi nodi che tornano quasi costantemente nella ricerca di Formenti: l’interesse per il ruolo delle nuove tecnologie e per l’impatto che esse producono sull’organizzazione del lavoro, un dialogo critico con le diverse posizioni del postmodernismo filosofico e la costante domanda sulle nuove forme di azione politica.
- Details
- Hits: 5257
Marx e la comune agricola russa: cui prodest?
Il Lato Cattivo
 La crisi attuale del modo di produzione capitalistico è comprensibilmente portatrice di un nuovo interesse per Marx. Nel magma di pubblicazioni – accademiche e non – che escono un po' ovunque, in Europa e negli Stati Uniti ma non solo, non tardano a fare capolino anche lavori di un certo interesse; che però – come spesso accade per ogni studio che sconfini nella «marxologia» – hanno il difetto di voler scoprire e far scoprire il vero Marx, di contro a tutti i falsi Marx di un passato generalmente associato ai brutti ricordi del «socialismo reale». Figlie di una teleologia che vede nella storia l'affrontarsi del Vero e del Falso, simili ambizioni – per quanto possano talvolta risultare feconde – ci dicono molte più cose sui fantasmi degli Autori in questione e sul loro tempo, che non su Marx stesso. Ogni generazione – scriveva molto giustamente Karel Kosik in Dialettica del concreto (Bompiani, Milano 1965) – cerca e scopre nel testo marxiano ciò di cui necessita per esercitare una presa teorica sul proprio presente e, di conseguenza, mette in rilievo certi aspetti di Marx per accantonarne altri; ogni generazione, insomma, si abbevera alla fonte originaria per tradurla (tradirla) una volta di più. Il Marx evoluzionista e progressista della Seconda Internazionale era forse una semplice falsificazione? O era piuttosto la lettura più naturale che di Marx si potesse dare, nelle condizioni della Belle Époque che precedettero la catastrofe della Prima Guerra mondiale? Non scrisse anche Engels che il periodo dei rivolgimenti violenti, almeno per i paesi capitalisticamente più sviluppati, era terminato?
La crisi attuale del modo di produzione capitalistico è comprensibilmente portatrice di un nuovo interesse per Marx. Nel magma di pubblicazioni – accademiche e non – che escono un po' ovunque, in Europa e negli Stati Uniti ma non solo, non tardano a fare capolino anche lavori di un certo interesse; che però – come spesso accade per ogni studio che sconfini nella «marxologia» – hanno il difetto di voler scoprire e far scoprire il vero Marx, di contro a tutti i falsi Marx di un passato generalmente associato ai brutti ricordi del «socialismo reale». Figlie di una teleologia che vede nella storia l'affrontarsi del Vero e del Falso, simili ambizioni – per quanto possano talvolta risultare feconde – ci dicono molte più cose sui fantasmi degli Autori in questione e sul loro tempo, che non su Marx stesso. Ogni generazione – scriveva molto giustamente Karel Kosik in Dialettica del concreto (Bompiani, Milano 1965) – cerca e scopre nel testo marxiano ciò di cui necessita per esercitare una presa teorica sul proprio presente e, di conseguenza, mette in rilievo certi aspetti di Marx per accantonarne altri; ogni generazione, insomma, si abbevera alla fonte originaria per tradurla (tradirla) una volta di più. Il Marx evoluzionista e progressista della Seconda Internazionale era forse una semplice falsificazione? O era piuttosto la lettura più naturale che di Marx si potesse dare, nelle condizioni della Belle Époque che precedettero la catastrofe della Prima Guerra mondiale? Non scrisse anche Engels che il periodo dei rivolgimenti violenti, almeno per i paesi capitalisticamente più sviluppati, era terminato?
- Details
- Hits: 2425
Per smontare la macchina delle panzane sul caso #Marò
Dodici punti
di Matteo Miavaldi
 [Proseguiamo la disamina critica del caso Marò riprendendo da East on line, freschi di pubblicazione, questi dodici punti del giornalista Matteo Miavaldi, autore del libro I due marò. Tutto quello che non vi hanno detto (Alegre, Roma 2013) e di diversi articoli apparsi qui su Giap. Chi vuole lasciare commenti può farlo sotto il post originale. Buona lettura. WM]
[Proseguiamo la disamina critica del caso Marò riprendendo da East on line, freschi di pubblicazione, questi dodici punti del giornalista Matteo Miavaldi, autore del libro I due marò. Tutto quello che non vi hanno detto (Alegre, Roma 2013) e di diversi articoli apparsi qui su Giap. Chi vuole lasciare commenti può farlo sotto il post originale. Buona lettura. WM]
Si preannunciano giorni convulsi, all’insegna della schizofrenia politica, intorno all’annosa questione marò in India. Proviamo a mettere un po’ di punti fermi per orientarci meglio tra le cose che verranno dette e scritte.
Cos’è successo ieri in tribunale?
Gli avvocati di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone avevano intenzione di presentare due istanze separate per prolungare il soggiorno in Italia del primo e far tornare a casa per Natale il secondo.
Latorre è in Italia da metà settembre per proseguire la riabilitazione dopo l’attacco ischemico che ha subìto qui a New Delhi: la Corte suprema ha accordato una licenza in scadenza il prossimo 13 gennaio e il governo indiano – prima che i giudici si pronunciassero – aveva fatto sapere di non aver nulla in contrario al ritorno di Latorre in Italia per motivi medici (occhio che questa cosa è importante, poi la riprendiamo). La richiesta era di poter rimanere in Italia per altri quattro mesi, a fronte anche di un’operazione cardiochirurgica alla quale Latorre potrebbe doversi sottoporre il prossimo 8 gennaio.
- Details
- Hits: 3274
L’impero del consumo
Eduardo Galeano
 La bocca è una delle porte dell’anima, dicevano gli antichi. Ma se da lì passa solo cibo spazzatura, la vita è ridotta a un insieme infinito di acquisti di merci usa e getta. E lo struscio domenicale nel centro delle città è sostituito dal pellegrinaggio negli shopping mall che accerchiano le periferie
La bocca è una delle porte dell’anima, dicevano gli antichi. Ma se da lì passa solo cibo spazzatura, la vita è ridotta a un insieme infinito di acquisti di merci usa e getta. E lo struscio domenicale nel centro delle città è sostituito dal pellegrinaggio negli shopping mall che accerchiano le periferie
L’esplosione del consumo nel mondo di oggi fa più rumore della guerra e più baccano del carnevale. Come dice un antico proverbio turco, chi beve a credito si ubriaca due volte. La bisboccia ottunde e obnubila lo sguardo; e quest’enorme sbronza universale sembra non conoscere limiti di spazio e di tempo. Ma la cultura del consumo risuona molto, come il tamburo, perché è vuota; all’ora della verità, quando gli strepiti si calmano e la festa finisce, l’ubriaco di sveglia solo, con l’unica compagnia della sua ombra e dei piatti rotti che dovrà pagare. L’espandersi della domanda cozza con i limiti imposti dallo stesso sistema che la genera. Il sistema ha bisogno di mercati sempre più aperti e ampi, come i polmoni hanno bisogno dell’aria, e al tempo stesso ha bisogno che si riducano sempre più, come in effetti accade, i prezzi delle materie prime e il costo della forza lavoro umana. Il sistema parla in nome di tutti, a tutti dà l’imperioso ordine di consumare, fra tutti diffonde la febbre degli acquisti; ma niente da fare: per quasi tutti quest’avventura inizia e finisce davanti allo schermo del televisore. La maggioranza, che fa debiti per ottenere delle cose, finisce per avere solo più debiti, contratti per pagare debiti che ne producono altri, e si limita a consumare fantasie che talvolta poi diventano realtà con il ricorso ad attività delittuose.
- Details
- Hits: 2521
Il Titanic Europa e le illusioni di Fassina
di Guido Iodice
 Da alcuni mesi l'ex viceministro dell'economia si è unito al coro degli antieuro, auspicando un “superamento cooperativo” della moneta unica. Ma la vaghezza regna sovrana nella sinistra Pd e la sua analisi rischia di non reggere il confronto con la realtà, mentre rimangono fumosi i contorni della proposta politica.
Da alcuni mesi l'ex viceministro dell'economia si è unito al coro degli antieuro, auspicando un “superamento cooperativo” della moneta unica. Ma la vaghezza regna sovrana nella sinistra Pd e la sua analisi rischia di non reggere il confronto con la realtà, mentre rimangono fumosi i contorni della proposta politica.
Un repentino cambio di fronte
Le critiche di Stefano Fassina all'Europa si sono spinte negli ultimi mesi fino alla messa in discussione della moneta unica. Secondo l'ex viceministro, la situazione dell'eurozona sarebbe insostenibile. Ciò implicherebbe la necessità, da parte del nostro paese, e in particolare da parte della sinistra, di promuovere un “superamento cooperativo” dell'euro. Continuare sulla strada attuale sarebbe iniquo perché “se non si può svalutare la moneta, si svaluta il salario”.
Un concetto (che abbiamo già criticato su Micromega online) ripetuto anche nella direzione Pd alla vigilia del Jobs act. In quella sede, l'ex viceministro aveva spiegato che la cancellazione dell'articolo 18 era un diktat imposto dall'Europa e accettato da Renzi al fine di riequilibrare i differenziali di competitività nella zona euro.
- Details
- Hits: 2310
L’ultima vittoria del lulismo
di Homero Santiago
 Questa analisi del voto brasiliano dello scorso ottobre è eccentrica rispetto a quelle che di solito pubblichiamo su ∫connessioni precarie. A scriverla è un giovane studioso che si è apertamente schierato per la presidente Dilma Roussef. La sua analisi, tuttavia, ha per noi motivi di interesse. In primo luogo può contribuire a sprovincializzare un dibattito di movimento in Italia sempre più segnato dalla convinzione che esista una sorta di delegittimazione preventiva del sistema politico-istituzionale, dipinto costantemente sull’orlo della sua crisi finale in quanto preda della sua corruzione e della sua incapacità di rispondere alle richieste di ampie quote di popolazione. Questa descrizione ha innegabili elementi di realtà. L’analisi che punta sulla progressiva e quasi inarrestabile decomposizione del sistema politico non si riesce tuttavia a spiegare come sia possibile che questo stesso sistema politico riesca costantemente a riprodursi e a ottenere insperate aperture di credito anche da parte di coloro che sembra non rappresentare. Se ci limita alla descrizione della realtà non si spiegano molte cose in Italia e si comprendono anche meno cose che capitano non lontano dall’Italia, per esempio in Grecia con Syriza o in Spagna con Podemos. Il Brasile ha livelli altissimi di corruzione e parte della realtà sociale è letteralmente irrappresentabile dal sistema politico. Eppure, dopo le manifestazioni oceaniche e gli scontri di piazza contro il rincaro dei prezzi dei trasporti pubblici e contro la coppa del mondo di calcio, le elezioni non sono state semplicemente un rituale passaggio di riproduzione del sistema politico.
Questa analisi del voto brasiliano dello scorso ottobre è eccentrica rispetto a quelle che di solito pubblichiamo su ∫connessioni precarie. A scriverla è un giovane studioso che si è apertamente schierato per la presidente Dilma Roussef. La sua analisi, tuttavia, ha per noi motivi di interesse. In primo luogo può contribuire a sprovincializzare un dibattito di movimento in Italia sempre più segnato dalla convinzione che esista una sorta di delegittimazione preventiva del sistema politico-istituzionale, dipinto costantemente sull’orlo della sua crisi finale in quanto preda della sua corruzione e della sua incapacità di rispondere alle richieste di ampie quote di popolazione. Questa descrizione ha innegabili elementi di realtà. L’analisi che punta sulla progressiva e quasi inarrestabile decomposizione del sistema politico non si riesce tuttavia a spiegare come sia possibile che questo stesso sistema politico riesca costantemente a riprodursi e a ottenere insperate aperture di credito anche da parte di coloro che sembra non rappresentare. Se ci limita alla descrizione della realtà non si spiegano molte cose in Italia e si comprendono anche meno cose che capitano non lontano dall’Italia, per esempio in Grecia con Syriza o in Spagna con Podemos. Il Brasile ha livelli altissimi di corruzione e parte della realtà sociale è letteralmente irrappresentabile dal sistema politico. Eppure, dopo le manifestazioni oceaniche e gli scontri di piazza contro il rincaro dei prezzi dei trasporti pubblici e contro la coppa del mondo di calcio, le elezioni non sono state semplicemente un rituale passaggio di riproduzione del sistema politico.
- Details
- Hits: 2056
L’ “Impero per sé”
di Elisabetta Teghil
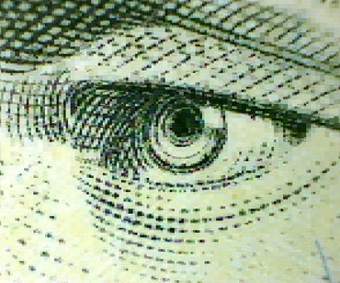 Il capitalismo nel suo processo di espansione è approdato al neoliberismo con i relativi processi di globalizzazione che comportano la ricerca di una nuova strutturazione del modo di produrre e dell’organizzazione capitalistica del lavoro.
Il capitalismo nel suo processo di espansione è approdato al neoliberismo con i relativi processi di globalizzazione che comportano la ricerca di una nuova strutturazione del modo di produrre e dell’organizzazione capitalistica del lavoro.
Gli Stati Uniti, in questo processo, si propongono come “Impero per sé” e pertanto entrano in rotta di collisione con gli imperialismi che pure esistono e sono il risultato più compiuto del principio dello Stato-Nazione.
Gli Usa si presentano e vogliono imporsi come proposta imperiale unilaterale e per questo tendono a superare e a distruggere le sovranità nazionali e a relegare gli imperialismi di vecchia scuola ad un ruolo regionale. Per fare questo possono contare sulle aristocrazie locali, cioè sull’iper-borghesia o borghesia imperialista che non si riconosce più nello stato-nido in cui era nata, ma negli interessi delle multinazionali che sono per lei l’unico valore di riferimento.
In pratica e in definitiva, la diffusione e l’imposizione del modello neoliberista si risolve nella naturalizzazione del modello statunitense.
Da qui le aggressioni militari sempre più ravvicinate e lo spostamento del ruolo della guerra che diventa l’occasione per una ridefinizione della storia. Per questo gli Usa possono contare su di un apparato che è diventato uno strumento che le multinazionali utilizzano per il raggiungimento dei loro obiettivi.
- Details
- Hits: 3112
La democrazia governabile
di Giovanna Cracco
 Di governabilità e democrazia si è iniziato a parlare nei primi anni Settanta. Dopo quasi cinque lustri di crescita economica e relativa pace sociale, le manifestazioni contro la guerra in Vietnam e il movimento afroamericano negli Stati Uniti, il ‘68 studentesco, il ‘69 operaio e la successiva esplosione del conflitto sociale soprattutto in Europa, pongono all’attenzione della classe dirigente politica ed economica dei Paesi occidentali il tema della governabilità della democrazia. Nel ‘71 Nixon decreta la fine degli accordi di Bretton Woods, e due anni dopo la prima crisi del dopoguerra del sistema capitalistico viene accesa dalla miccia del conflitto dello Yom Kippur.
Di governabilità e democrazia si è iniziato a parlare nei primi anni Settanta. Dopo quasi cinque lustri di crescita economica e relativa pace sociale, le manifestazioni contro la guerra in Vietnam e il movimento afroamericano negli Stati Uniti, il ‘68 studentesco, il ‘69 operaio e la successiva esplosione del conflitto sociale soprattutto in Europa, pongono all’attenzione della classe dirigente politica ed economica dei Paesi occidentali il tema della governabilità della democrazia. Nel ‘71 Nixon decreta la fine degli accordi di Bretton Woods, e due anni dopo la prima crisi del dopoguerra del sistema capitalistico viene accesa dalla miccia del conflitto dello Yom Kippur.
Nel maggio 1975 la Trilateral tiene la sua riunione plenaria annuale a Kyoto: Michel Crozier, Samuel P. Huntington e Joji Watanuki presentano il Rapporto sulla governabilità delle democrazie, partendo dal presupposto che si è evidenziata una “crisi della democrazia in termini di ‘governabilità’ del sistema democratico”, come scrive Giovanni Agnelli nella prefazione all’edizione italiana della pubblicazione (1). La riflessione più articolata sulle cause e le possibili soluzioni è quella sviluppata da Huntington, che analizza la realtà degli Stati Uniti.
- Details
- Hits: 2644
La rete non è più un bene comune
di Francesco Paolella
 Vanni Codeluppi oggi insegna sociologia dei processi culturali e comunicativi alla IULM di Milano. Si è occupato a lungo di consumi, televisione, pubblicità. Il suo ultimo libro è I media siamo noi. La società trasformata dai mezzi di comunicazione, pubblicato da Franco Angeli. Parla di come i media abbiano dato vita, negli ultimi anni, “ad un vasto spazio immateriale che affianca quello fisico e nel quale le persone passano una quantità crescente del loro tempo”. Questa invasione dei media sta trasformando profondamente la nostra cultura sociale e il nostro modo vivere la “realtà”.
Vanni Codeluppi oggi insegna sociologia dei processi culturali e comunicativi alla IULM di Milano. Si è occupato a lungo di consumi, televisione, pubblicità. Il suo ultimo libro è I media siamo noi. La società trasformata dai mezzi di comunicazione, pubblicato da Franco Angeli. Parla di come i media abbiano dato vita, negli ultimi anni, “ad un vasto spazio immateriale che affianca quello fisico e nel quale le persone passano una quantità crescente del loro tempo”. Questa invasione dei media sta trasformando profondamente la nostra cultura sociale e il nostro modo vivere la “realtà”.
Lo abbiamo incontrato per discutere di internet, e di Facebook in particolare.
Oggi ha ancora senso parlare di internet come di un “bene comune”?
Vanni Codeluppi: La rete, intesa come bene comune, non esiste più. Così come ormai in ogni ambito della nostra vita sociale, è avvenuta una progressiva privatizzazione degli spazi pubblici – pensiamo ai centri commerciali, che sono solo fintamente pubblici. Sono luoghi privati dove esistono un controllo e una selezione severi e dove non tutti possono entrare. La rete, che era nata da una ideologia in un certo senso anarchica di libertà totale, si è ritrovata ad essere un enorme contenitore di monopoli. Pensiamo ad Apple o ad Amazon: ogni azienda cerca di difendere il proprio territorio, si costruisce attorno un sistema chiuso. E questo è inevitabilmente un grosso problema.
- Details
- Hits: 3161
C'è vita dopo la socialdemocrazia?
Zoltan Zigedy
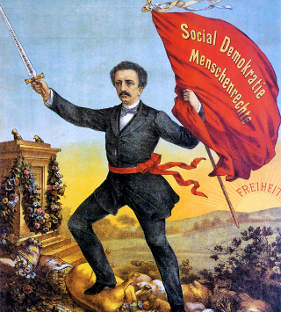 "I problemi del Partito Laburista non sono molto diversi da quelli degli altri partiti socialdemocratici occidentali... In questo senso viviamo oggi non solo una crisi dello stato britannico, ma anche una crisi generale della socialdemocrazia". (Labour Vanishes, Ross McKibbin, London Review of Books, November 20, 2014).
"I problemi del Partito Laburista non sono molto diversi da quelli degli altri partiti socialdemocratici occidentali... In questo senso viviamo oggi non solo una crisi dello stato britannico, ma anche una crisi generale della socialdemocrazia". (Labour Vanishes, Ross McKibbin, London Review of Books, November 20, 2014).
La sintetica valutazione di McKibbin sulla socialdemocrazia è tanto appassionata quanto convincente. La socialdemocrazia, l'espressione politica del riformismo anticomunista del XX secolo, è arrivata a un punto che sfida la sua visione e la sua stessa vitalità politica. Nelle parole di McKibbin: "Nel corso degli ultimi venti o trenta anni, i grandi partiti socialdemocratici di Germania, Austria, Paesi Scandinavi, Australia e Nuova Zelanda (e ora la Francia) hanno vissuto una emorragia di consensi...". Si potrebbe aggiungere tra questi, anche se in modo meno drammatico, l'imitazione di partito socialdemocratico statunitense, il Partito Democratico.
Da un punto di vista sostanziale, la socialdemocrazia trae energia dalla sua posizione di alternativa al comunismo. Per varie ragioni - timore del cambiamento, demonizzazione anticomunista, ignoranza, supposto interesse individuale - molti tra coloro che sono svantaggiati dal capitalismo cercano rifugio nei partiti addomesticati, gradualisti e aggressivamente anticomunisti, che rivendicano spazio a sinistra. Sostenendo un approccio parlamentare piano, cauto, non conflittuale, imbrigliando lo sforzo con la civiltà, i pensatori socialdemocratici credono di poter smussare le asperità del capitalismo con tranquillità e popolarità.
- Details
- Hits: 2524
Pensioni, la manina che ha premiato i ricchi
Maurizio Benetti
Sul Corriere della Sera una denuncia di cui E&L aveva dato conto già nel 2012: Uno degli effetti della legge Fornero ha attribuito vantaggi ad alcune categorie (tra le quali magistrati e docenti universitari) con un costo di 2,5 miliardi in 10 anni. In origine nella legge si specificava che quei vantaggi non sarebbero scattati, ma in Parlamento qualcuno ha cassato proprio quelle righe
 Lo scorso 11 novembre Gian Antonio Stella sul Corriere della sera ha pubblicato un articolo su di un comma “sparito” nella legge Fornero di riforma del sistema pensionistico (L. 214/2011), legge, ricorda Stella, che si riprometteva secondo la Fornero di “togliere ai ricchi per dare ai poveri”. Nel suo articolo Stella sostiene che l’eliminazione di quattro righe dalla formulazione definitiva della legge Fornero ha prodotto un regalo per le pensioni più ricche, in particolare di magistrati, professori universitari, altri burocrati pubblici, che costa alle casse dell’Inps-Inpdap circa 2,5 mld nell’arco di un decennio.
Lo scorso 11 novembre Gian Antonio Stella sul Corriere della sera ha pubblicato un articolo su di un comma “sparito” nella legge Fornero di riforma del sistema pensionistico (L. 214/2011), legge, ricorda Stella, che si riprometteva secondo la Fornero di “togliere ai ricchi per dare ai poveri”. Nel suo articolo Stella sostiene che l’eliminazione di quattro righe dalla formulazione definitiva della legge Fornero ha prodotto un regalo per le pensioni più ricche, in particolare di magistrati, professori universitari, altri burocrati pubblici, che costa alle casse dell’Inps-Inpdap circa 2,5 mld nell’arco di un decennio.
Questo specifico tema era stato rilevato e denunciato da E&L nel marzo del 2012 (Se 51 anni vi sembran pochi) sottolineando che “In definitiva le uniche categorie che possono sentirsi soddisfatte dalla riforma sono professori universitari e magistrati” in contrasto con quelli che Fornero indicava come “i principi ispiratori del provvedimento, l’abbattimento delle posizioni di privilegio e la presenza di clausole derogative soltanto per le fasce più deboli e le categorie dei bisognosi”.
La denuncia di E&L rimase inascoltata anche se portata a conoscenza di sindacati e giornali e temiamo che resterà inascoltata anche la denuncia-rivelazione di Stella, anche se è stato annunciato un emendamento in proposito. Vediamo cause ed effetti macro e micro del problema.
- Details
- Hits: 2111
ILVA: i costi della chiusura e le ragioni per nazionalizzarla
Roberto Polidori e Nadia Garbellini *
 La vicenda di ILVA deve essere l’occasione per discutere le conseguenze economiche e sociali delle politiche Europee. A chi afferma che ILVA non si può nazionalizzare perché i trattati non lo consentono, è possibile opporre numerosi argomenti, tanto politici quanto economici.
La vicenda di ILVA deve essere l’occasione per discutere le conseguenze economiche e sociali delle politiche Europee. A chi afferma che ILVA non si può nazionalizzare perché i trattati non lo consentono, è possibile opporre numerosi argomenti, tanto politici quanto economici.
Come riportato da Luigi Pandolfi, dal 2008 al 2013, mentre ingenti patrimoni privati venivano salvati con centinaia di miliardi di euro pubblici, i PIIGS operavano tagli strutturali a welfare e sanità per 230 miliardi di Euro, un’enorme redistribuzione di ricchezza diretta da Commissione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale.
Questa Europa, come dice Colin Crouch,[1] è il trionfo del liberismo reale, che “produce un’economia politicizzata molto distante da ciò che gli economisti intendono per economia liberale”. Gruppi di interesse privati accentrano capitale attraverso l’attività di lobbying, concentrando la produzione nel centro e distruggendo capacità produttiva “in eccesso” nelle aree periferiche, depredandone le risorse ambientali e creando disoccupazione. Emiliano Brancaccio ha spiegato il processo di germanizzazione dei capitali (o mezzogiornificazione dell’Europa) sottolineando come anche aziende competitive possano essere spazzate via in questo processo di desertificazione industriale.
- Details
- Hits: 5013
Operaismo italiano e realtà del lavoro postfordista
Sergio Bologna
Sergio Bologna, protagonista dell’operaismo e del post-operaismo italiano, racconta l’evoluzione di un pensiero politico, vario e ricco di sfaccettature, che attraversa mezzo secolo di elaborazione teorica e azione militante in Italia, dagli anni Sessanta a oggi. Un pensiero che ancora oggi mostra tutta la sua potenziale ricchezza ed è capace di innervarsi con le energie delle nuove generazioni. Perché l’esercizio del pensiero critico è linfa per la comprensione di ciò che è successo e motore di ciò che verrà
 Il sistema di pensiero che viene riassunto con il nome di “operaismo italiano” non è un sistema organico, racchiuso in un testo fondamentale, in una qualche Bibbia, ma è la somma di diversi contributi teorici provenienti da alcuni intellettuali militanti che hanno fondato le riviste “Quaderni Rossi” e “Classe Operaia”1. Raniero Panzieri, Mario Tronti, Toni Negri e Romano Alquati sono quelli che hanno posto le fondamenta del sistema, altri, come Gaspare De Caro, Guido Bianchini, Ferruccio Gambino, Alberto Magnaghi, hanno portato dei contributi essenziali su tematiche specifiche che completavano l’orizzonte del pensiero operaista e gli davano l’impronta di un “sistema” coerente al suo interno, come la storiografia, l’agricoltura, le migrazioni, il territorio.
Il sistema di pensiero che viene riassunto con il nome di “operaismo italiano” non è un sistema organico, racchiuso in un testo fondamentale, in una qualche Bibbia, ma è la somma di diversi contributi teorici provenienti da alcuni intellettuali militanti che hanno fondato le riviste “Quaderni Rossi” e “Classe Operaia”1. Raniero Panzieri, Mario Tronti, Toni Negri e Romano Alquati sono quelli che hanno posto le fondamenta del sistema, altri, come Gaspare De Caro, Guido Bianchini, Ferruccio Gambino, Alberto Magnaghi, hanno portato dei contributi essenziali su tematiche specifiche che completavano l’orizzonte del pensiero operaista e gli davano l’impronta di un “sistema” coerente al suo interno, come la storiografia, l’agricoltura, le migrazioni, il territorio.
Operaismo e fordismo
L’esperienza dei gruppi operaisti si è sviluppata in un periodo storico nel quale sembrava che nelle società capitaliste non ci fosse un’alternativa alla produzione di massa caratterizzata da grandi imprese in grado di ottenere forti economie di scala.
- Details
- Hits: 4168

Novità a sinistra sull'euro
Sergio Cesaratto interviene sulle novità che emergono nell'area dell'opposizione nel Pd. Di seguito un commento di Mimmo Porcaro su questo intervento.

La sinistra oltre l’euro
di Sergio Cesaratto
Le posizioni che Stefano Fassina ha espresso nelle passate settimane su (a) l’insostenibilità dell’euro a fronte del venir meno delle speranze di un cambiamento delle politiche europee, e (b) il fallimento di una dimensione democratica europea sovranazionale e la necessità di ripristinare una sovranità democratica nazionale, segnano una novità assoluta nel panorama della sinistra italiana. Sinora per ritrovare posizioni simili, la cui elaborazione in questi anni è ascrivibile a una manciata di economisti di sinistra, si doveva andare a cercare nei meandri delle sinistre più estreme, oppure a destra. Esaminiamo i due punti.
- Details
- Hits: 2853
Consumismo etico
di Carlo Augusto Viano
La critica al consumismo sembra in declino nel campo della sinistra, probabilmente a causa della crisi economica. Ma c’è un bene di cui invece sta aumentando il consumo, ed è quello dell’etica. Le vicende del mercato editoriale lo confermano
 Recentemente la rivista Paradoxa ha dedicato un numero, curato da Dino Cofrancesco, alla questione del consumismo nella cultura di sinistra; infatti c’è da domandarsi che fine abbia fatto la polemica contro il consumismo tradizionale nella sinistra. Non intendo discutere del fascicolo di Paradoxa, ma mi pare che il problema sollevato meriti qualche attenzione. La critica del consumismo non sembra molto popolare di questi tempi, nei quali si sentono ogni giorno lamentele sulla caduta dei consumi e si invoca il loro risveglio, come nelle siccità si invoca la pioggia. Forse una delle ragioni per le quali gli ambientalisti non sono oggi molto popolari sta nel fatto che essi sono rappresentati come i più rigorosi anticonsumisti; e giustamente lo sono, perché i consumi comportano uso dell’ambiente.
Recentemente la rivista Paradoxa ha dedicato un numero, curato da Dino Cofrancesco, alla questione del consumismo nella cultura di sinistra; infatti c’è da domandarsi che fine abbia fatto la polemica contro il consumismo tradizionale nella sinistra. Non intendo discutere del fascicolo di Paradoxa, ma mi pare che il problema sollevato meriti qualche attenzione. La critica del consumismo non sembra molto popolare di questi tempi, nei quali si sentono ogni giorno lamentele sulla caduta dei consumi e si invoca il loro risveglio, come nelle siccità si invoca la pioggia. Forse una delle ragioni per le quali gli ambientalisti non sono oggi molto popolari sta nel fatto che essi sono rappresentati come i più rigorosi anticonsumisti; e giustamente lo sono, perché i consumi comportano uso dell’ambiente.
Bisogna pur dire che la polemica contro il consumismo della sinistra tradizionale, soprattutto quella austera condotta dai comunisti, aveva una carta di riserva. Più che ridurre i consumi, si voleva cambiarli, perché quelli offerti dal capitalismo erano banali e pericolosi: prima che emergesse l’ambientalismo, quei consumi, più che minacce alle risorse disponibili, apparivano come armi di corruzione morale, con le quali si voleva distrarre il proletariato, trasformando gli operai in bambini o in ospiti di paradisi artificiali. C’era un vena di tristezza in quella proposta, ben rappresentata da Enrico Berlinguer. Gli ambientalisti, venuti dopo, avrebbero cercato di rimediare, inventando una serena allegria nuova, un po’ faticosa, forse, ma sana, quella del volenteroso ciclista, con lo sguardo sereno, senza i nervosismi di chi è costretto a godere dei piaceri della guida.
- Details
- Hits: 5696
Neo edonismo e coitocrazia
Claudio Valerio Vettraino
 Lo scontro Nappi-Fusaro: due forme della via edonistica al potere
Lo scontro Nappi-Fusaro: due forme della via edonistica al potere
L’apparizione sulle pagine di una rivista nota per la sua vis polemica di alcuni articoli della pornostar napoletana Valentina Nappi e le risposte piccate del filosofo (è lecito definirlo tale?) Diego Fusaro, oltre a testimoniare il degrado a cui siamo giunti, rappresentano – a mio avviso – uno degli snodi attorno cui il potere oggi gioca e cioè quello del rapporto (da sempre forse centrale) tra corpo e “realizzazione”, tra immagine e repressione, visibile ed invisibile, tra ciò che è lecito ed illecito, tra autentica liberazione e falsi miti di emancipazione.
Ma andiamo con ordine: molti sono rimasti un po’ perplessi dal leggere sulle pagine di Micromega alcuni spunti di riflessione, per la verità alquanto discutibili ed opinabili, della giovane pornostar napoletana Valentina Nappi sulla natura del potere odierno e sulla necessità di non impedire lo sviluppo del capitalismo (per meglio dire, dell´ iper capitalismo finanziario contemporaneo) in quanto unica forma di “emancipazione” dai lacci e dai lacciuoli di un fascismo (che vive però solo nella sua testa) ancora in grado di frenarne le spinte progressive, auspicando viceversa il ritorno “salubre” ad un nuovo edonismo tutto da vivere e da conquistare;
- Details
- Hits: 4257
Come non leggere Žižek
Paul Bowman
Notate quanti testi nel presente volume seguono una simile strategia argomentativa. Prima mi imputano una posizione ridicolmente caricaturizzata, poi, quando sono costretti ad ammettere che molti passaggi nel mio lavoro contraddicono chiaramente la posizione descritta, non interpretano tale discrepanza come, prima facie, un segno dell’inadeguatezza della loro lettura, bensì come della mia incoerenza. S. Žižek
Le mie proposizioni illustrano così: colui che mi comprende, infine le riconosce insensate, se è salito per esse – su esse – oltre esse. (Egli deve, per così dire, gettar via la scala dopo che v’è salito).Wittgenstein1
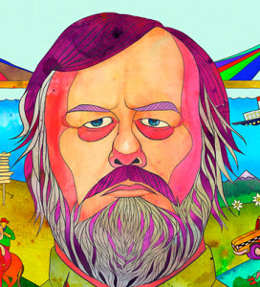 1. Leggere il romanzo
1. Leggere il romanzo
Dal punto di vista teorico, l’opera di Žižek è densa, agile, audace, frenetica. È anche un pensatore che sembra andare in cerca della controversia nei suoi scritti, sembra cercare la provocazione facendo dichiarazioni oltraggiose su ogni genere di argomento, indipendentemente da quanto delicato sia. Nulla sembra essere proibito allo sguardo analitico, diagnostico e polemico di Žižek. Sembra divertire [il suo pubblico] infrangendo tabù accademici. Di certo questa è almeno in parte la ragione per cui è così tanto letto.
Tuttavia, prendere coraggiosamente posizione, rompere eroicamente i tabù (i tabù accademici s’intende, dunque in modo fintamente eroico) e fare diagnosi, esprimere giudizi e condanne in modo sfrontato senza preoccuparsi di offendere delle sensibilità è un problema. Proporre un preciso sistema di valori e delle precise idee politiche è ben altro problema. Questa è la ragione per cui ritengo che la nuova lettura di Žižek da parte di Alan Johnson sia estremamente importante. In effetti, ciò che Johnson dimostra nel suo articolo, «La Teoria della Rivoluzione di Žižek: una critica»2, è che non soltanto le basi della teoria politica di Žižek sono per molti versi fortemente problematiche (molti lo sostengono da un po’ di tempo), bensì anche che, in un certo senso, è uno scandalo che chiunque occupi una qualsiasi posizione nella sinistra politica progressista possa continuare a leggere Žižek come se il suo lavoro si potesse effettivamente collocare da qualche parte nella sinistra politica progressista.
- Details
- Hits: 2560
Guerre mediatiche e trionfo della propaganda
di John Pilger
 Perché così tanto giornalismo si è arreso alla propaganda? Perché censura e distorsione sono diventate consuetudine? Perché la BBC si fa così spesso portavoce di poteri rapaci? Perché il New York Times e il Washington Post ingannano i loro lettori? Perché ai giovani giornalisti non si insegna a capire le finalità dei media e a sfidare le affermazioni eclatanti e le basse intenzioni della falsa imparzialità? E perché non si insegna loro che la sostanza di gran parte di ciò che definiamo media mainstream non è informazione, ma potere?
Perché così tanto giornalismo si è arreso alla propaganda? Perché censura e distorsione sono diventate consuetudine? Perché la BBC si fa così spesso portavoce di poteri rapaci? Perché il New York Times e il Washington Post ingannano i loro lettori? Perché ai giovani giornalisti non si insegna a capire le finalità dei media e a sfidare le affermazioni eclatanti e le basse intenzioni della falsa imparzialità? E perché non si insegna loro che la sostanza di gran parte di ciò che definiamo media mainstream non è informazione, ma potere?
Questi sono problemi urgenti. Il mondo si trova di fronte all'eventualità di una grande guerra, forse addirittura nucleare - con gli Stati Uniti chiaramente determinati ad isolare e provocare prima la Russia e poi la Cina. Questa semplice verità viene capovolta e messa sottosopra dai giornalisti, inclusi quelli che caldeggiarono le bugie che portarono al bagno di sangue in Iraq nel 2003.
I tempi in cui viviamo sono così pericolosi e distorti nella pubblica percezione che la propaganda non è più, come Edward Bernays la definì, un "governo invisibile", ma il governo stesso, che controlla direttamente senza tema di smentita, e il suo scopo principale è di conquistare noi, il nostro senso del mondo, la nostra capacità di separare la verità dalla menzogna.
- Details
- Hits: 1888
Un socialismo del XXI secolo?
Lelio Demichelis
 Forse la sinistra non ha più il vento della storia che soffia nelle sue vele, come dice il titolo dell’ultimo libro di Franco Cassano. Forse davvero la lotta di classe è finita con il crollo del Muro di Berlino, perché la guerra contro il demos e i diritti dell’uomo e del cittadino, la guerra di posizione per la conquista dell’egemonia l’ha vinta il capitalismo. Forse le sinistre si sono illuse di poter creare un socialismo (magari anche un poco anarchico e libertario) via rete, dove invece trionfa l’ideologia della condivisione di tutti con tutti e con il tutto della rete: rete capitalista all’ennesima potenza.
Forse la sinistra non ha più il vento della storia che soffia nelle sue vele, come dice il titolo dell’ultimo libro di Franco Cassano. Forse davvero la lotta di classe è finita con il crollo del Muro di Berlino, perché la guerra contro il demos e i diritti dell’uomo e del cittadino, la guerra di posizione per la conquista dell’egemonia l’ha vinta il capitalismo. Forse le sinistre si sono illuse di poter creare un socialismo (magari anche un poco anarchico e libertario) via rete, dove invece trionfa l’ideologia della condivisione di tutti con tutti e con il tutto della rete: rete capitalista all’ennesima potenza.
Forse l’errore (un errore intellettuale e culturale, prima che politico) di un certo socialismo è stato quello di credere che il capitalismo potesse essere democratizzato, o che bastasse stipulare un soddisfacente matrimonio di interessi tra capitale e lavoro per controllarne gli spiriti animali. Forse l’errore (un altro) della sinistra è stato quello di pensare che si potesse vincere grazie ad una coscienza di classe forte, quando invece il capitalismo ha nella sua logica di funzionamento proprio la dissoluzione, lo scioglimento (attraverso la de-socializzazione, la falsa individualizzazione, i falsi bisogni che continuamente crea, l’industria culturale e del divertimento che incessantemente distrae e diverte) di ogni legame e di ogni coscienza (anche) di classe contraria al proprio funzionamento.
- Details
- Hits: 1820
Economia: il bilancio (molto) magro del governo Renzi
di Paolo Pini e Roberto Romano
 Il bilancio della politica economica del governo Renzi è molto magro. Dopo quasi 10 mesi di governo, tanti annunci, pochi risultati e non pochi errori, l’azione economica del governo non solo non ha fatto cambiare idea a coloro che lo avevano sin dall’inizio contrastato, e questo può essere ovvio benché qualche ripensamento sia sempre da annoverare, ma sta profondamente deludendo anche chi aveva dato ampio credito a Renzi che ha sostituito a febbraio 2014 l’inefficace Letta. Ma oggi vi è chi rimpiange pure quel precedente governo.
Il bilancio della politica economica del governo Renzi è molto magro. Dopo quasi 10 mesi di governo, tanti annunci, pochi risultati e non pochi errori, l’azione economica del governo non solo non ha fatto cambiare idea a coloro che lo avevano sin dall’inizio contrastato, e questo può essere ovvio benché qualche ripensamento sia sempre da annoverare, ma sta profondamente deludendo anche chi aveva dato ampio credito a Renzi che ha sostituito a febbraio 2014 l’inefficace Letta. Ma oggi vi è chi rimpiange pure quel precedente governo.
Prologo. Nell’autunno del 2013, la Legge di Stabilità 2014 elaborata dal Governo Letta era volta unicamente al rispetto dei vincoli previsti dai Trattati europei, e non alla crescita del reddito e dell’occupazione. Ciò nonostante, la Commissione Europea non aveva dato “semaforo verde”, in quanto il rientro dal debito non era garantito nel breve e medio periodo. La proposta governativa non veniva giudicata soddisfacente dai tecnocrati europei perché non coerente con le politiche di rigore e di austerità. Essa però neppure soddisfaceva le parti sociali che chiedevano interventi non simbolici per la riduzione strutturale e selettiva del cuneo fiscale, e quindi per la crescita e l’occupazione. Il governo prevedeva allora una crescita del reddito dell’1,1% per il 2014, ma per conseguire questo risultato non vi era traccia di alcuna politica economica supportata da risorse economiche reali. A dicembre 2013 il Parlamento approvava la Legge di Stabilità, ma il paese nei sondaggi sfiduciava Letta.
Entrata in campo. Ad inizio gennaio Renzi annunciava il suo Jobs Act per la crescita e l’occupazione e chiedeva di cambiare verso, in Italia ed in Europa. Il lavoro veniva posto al centro della nuova azione, e due pilastri dovevano sostenerla: (a) una politica del lavoro per ridurre il dualismo tra i lavoratori protetti e gli esclusi dal lavoro e dal mercato; (b) una politica economica ed industriale per ridare competitività al sistema produttivo ed alle imprese italiane.
- Details
- Hits: 4338
Complessità e sinistra
di Pierluigi Fagan
Parte prima
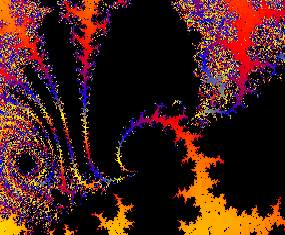 Mi aveva incuriosito il titolo dell’ultimo libro di D. Losurdo “La sinistra assente”1. Ho allora cercato di saperne un po’ di più su Internet e la curiosità è stata rinvigorita da alcuni commenti e da alcune finestre sul testo, tra cui una intervista all’autore. Ho allora scritto un articolo-recensione che poi si allargava a considerazioni personali su quell’assenza denunciata da Losurdo, considerazioni basate anche su un riferimento che l’autore aveva fatto al concetto del vero dell’intero (Hegel) nell’intervista, un concetto a me caro, dal momento che mi occupo di filosofia della complessità. Ero piuttosto soddisfatto dell’articolo e stavo per pubblicarlo quando i guardiani interni dell’etica del discorso mi hanno presentato l’ammonimento: non puoi parlare di ciò che non hai veramente letto. Mi ero cautelato scrivendo che le mie considerazioni prendevano spunto dal testo di Losurdo e non ne erano una diretta conseguenza ma i guardiani non hanno abboccato ed inflessibili mi hanno spedito in libreria a comprare ciò di cui volevo, anche se di rimbalzo, parlare. Ora ho quasi finito il libro, anticipando i capitoli finali che sono poi quelli più direttamente volti a contestare questa assenza ma mi rimane una mancanza.
Mi aveva incuriosito il titolo dell’ultimo libro di D. Losurdo “La sinistra assente”1. Ho allora cercato di saperne un po’ di più su Internet e la curiosità è stata rinvigorita da alcuni commenti e da alcune finestre sul testo, tra cui una intervista all’autore. Ho allora scritto un articolo-recensione che poi si allargava a considerazioni personali su quell’assenza denunciata da Losurdo, considerazioni basate anche su un riferimento che l’autore aveva fatto al concetto del vero dell’intero (Hegel) nell’intervista, un concetto a me caro, dal momento che mi occupo di filosofia della complessità. Ero piuttosto soddisfatto dell’articolo e stavo per pubblicarlo quando i guardiani interni dell’etica del discorso mi hanno presentato l’ammonimento: non puoi parlare di ciò che non hai veramente letto. Mi ero cautelato scrivendo che le mie considerazioni prendevano spunto dal testo di Losurdo e non ne erano una diretta conseguenza ma i guardiani non hanno abboccato ed inflessibili mi hanno spedito in libreria a comprare ciò di cui volevo, anche se di rimbalzo, parlare. Ora ho quasi finito il libro, anticipando i capitoli finali che sono poi quelli più direttamente volti a contestare questa assenza ma mi rimane una mancanza.
La mancanza, che è una assenza, è che sapendo che l’autore è un filosofo, docente (emerito) di filosofia, mi ero immaginato che il titolo completo, il titolo concettuale, in realtà fosse: la sinistra assente, perché? Invece nel libro c’è sicuramente una interessante analisi – denuncia sull’assenza di presenza politica della sinistra su alcuni temi e su una immane confusione percettiva e categoriale, ma non c’è affatto quella interrogazione finale. C’è una indagine sull’effetto, ma non sulle cause di quell’assenza. Debbo quindi ritornare su ciò che avevo pensato di pubblicare per ragionare sull’assenza di quell’assenza poiché forse è proprio l’assenza di quella interrogazione riflessiva che spiega l’assenza principale.
- Details
- Hits: 4012
Un parricidio compiuto. Il confronto finale tra Marx e Freud
Roberto Finelli
In considerazione dei temi e delle sezioni presenti nella rivista, la redazione inserisce nella sezione marxiana l’Introduzione e l’indice del volume di Roberto Finelli, appena pubblicato presso la casa editrice Jaca Book, dal titolo Un parricidio compiuto. Il confronto finale di Marx con Hegel. Pur non rientrando tale inserimento nel piano organico originariamente concepito e realizzato dai curatori del presente numero, non lo si è ritenuto inopportuno e incongruo rispetto alla tematica e alla ispirazione complessiva di «Consecutio temporum».
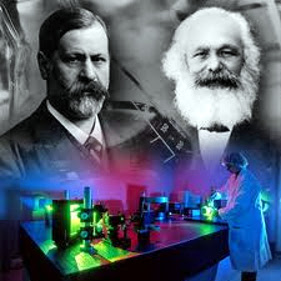 Introduzione: dal bisogno al riconoscimento
Introduzione: dal bisogno al riconoscimento
1. I movimenti della nostra giovinezza, degli anni sessanta e settanta del secolo scorso, a me che sono stato partecipe di quella stagione, appare che abbiano espresso, nelle loro avanguardie piùminoritarie e raffinate, una rivoluzione culturale che si può sintetizzare nel motto, “da un’antropologia della penuria a un’antropologia del riconoscimento”.
La generazione nata nel dopoguerra, e che giungeva nel mezzo degli anni ’60 all’Università, infatti poneva fine, con un accesso di massa alla cultura superiore, ad un’autorappresentazione tradizionale dei ceti subalterni, consegnata al predominio, sul piano del desiderio, ancora della sola bisognosità materiale e all’unico valore dell’eguaglianza, quale criterio etico-politico privilegiato per il soddisfacimento di tale obbligatorietà. Nel tentativo, a muovere dai primi movimenti studenteschi del febbraio del ’68, d’inaugurare un nuovo modello d’umanità possibile, che – al di là, ma non senza l’eguaglianza – rivendicasse, attraverso la celebrazione dell’antiautoritarismo, l’orizzonte ulteriore dell’opportunità, per ciascuno, d’individuarsi e di realizzare nel modo più personale il proprio sé.
Tale allargamento, o, per dir meglio, tale trans-valutazione di valori, costituiva un rivolgimento culturale radicale, perché significava una critica dell’autoritarismo e dell’elitismo che ancora pesantemente caratterizzava gli istituti civili e politici della rinnovata democrazia postbellica, ma, anche e nello stesso tempo, una rottura e un’evasione, per quel che qui maggiormente c’interessa trattare, dalla tradizione della cultura, e dell’antropologia, comunista.
- Details
- Hits: 2601
Guerra del petrolio? Spigolature geopolitiche (2.1)
rk
 Il prezzo del petrolio calato sui mercati globali da più di cento dollari a meno di settanta in quattro-cinque mesi non è proprio poca cosa, e il trend non pare affatto esaurito. Nella sub-provincia italica se ne parla poco e soprattutto male, con interpretazioni preconfezionate - tranne rare eccezioni - che separano la questione dal quadro complessivo delle tensioni geopolitiche globali. Come al solito da queste parti ci si guarda bene dal sollevare questioni politiche che diventano brucianti, se è vero che quelle tensioni stanno subendo in tutta evidenza un crescendo non lontano da possibili punti di precipitazione.
Il prezzo del petrolio calato sui mercati globali da più di cento dollari a meno di settanta in quattro-cinque mesi non è proprio poca cosa, e il trend non pare affatto esaurito. Nella sub-provincia italica se ne parla poco e soprattutto male, con interpretazioni preconfezionate - tranne rare eccezioni - che separano la questione dal quadro complessivo delle tensioni geopolitiche globali. Come al solito da queste parti ci si guarda bene dal sollevare questioni politiche che diventano brucianti, se è vero che quelle tensioni stanno subendo in tutta evidenza un crescendo non lontano da possibili punti di precipitazione.
Altrove girano almeno un paio di interpretazioni. La prima è più strettamente economica e vede questo calo in funzione della diminuita domanda mondiale dovuta alla stagnazione dell’economia occidentale e al rallentamento dei Brics di contro a un’offerta accresciuta anche dall’aumento della produzione statunitense grazie al fracking.
Ora, al meccanismo “puro” domanda-offerta può credere forse qualche economista accademico ma questa lettura tiene poco tanto più per una materia prima cruciale come il petrolio, il cui prezzo legato al dollaro segue da sempre una dinamica finanziaria e geopolitica strettamente intrecciate: vogliamo ricordare il ’73, il ’79, l’’85, il ‘90? Oltre tutto fosse così non si capirebbero il ritmo così accelerato e la tempistica del calo né perché la risposta dell’Opec, leggi: Arabia Saudita, sia stata quella di aumentare la produzione piuttosto che di tagliarla a costo di perdite secche. Certamente il rallentamento complessivo dell’economia mondiale con l’acuita concorrenza che ne segue è lo sfondo che rende possibile quanto sta accadendo al prezzo del petrolio, ma gli strani meccanismi di trasmissione vanno più plausibilmente rintracciati altrove.
- Details
- Hits: 2281
Il jobs act è legge
Dal lavoro precario al lavoro gratuito passando per la destituzione del potere legislativo
di Andrea Fumagalli
 1. Ha ragione Renzi quando afferma che con l’approvazione definitiva del Jobs Act l’Italia volta pagina. L’Italia cambia, e sicuramente in peggio.
1. Ha ragione Renzi quando afferma che con l’approvazione definitiva del Jobs Act l’Italia volta pagina. L’Italia cambia, e sicuramente in peggio.
2. Il Job Act segna la definitiva chiusura del processo di precarizzazione del mercato del lavoro in Italia. Nel momento stesso in cui la precarietà diventa condizione istituzionalizzata di lavoro e di vita e quindi fattispecie “tipica” dei rapporti di lavoro, essa smette di rappresentare un problema. Non essendo più eccezione ma norma si dà per risolta ogni contraddizione a essa correlata.
3. Si apre così un nuovo possibile fronte da sfondare sul mercato del lavoro. L’obiettivo non è più quello della precarizzazione generale ma quello del lavoro gratuito. “Risolto” il primo passaggio grazie alla sua generalizzazione e istituzionalizzazione, la nuova frontiera dei processi di sussunzione, subalternità, sfruttamento dell’essere umano al capitale diventa direttamente il “donarsi” al capitale stesso. Assistiamo a una metamorfosi, impensabile solo qualche anno fa, con il rischio che si ripetano tutti gli errori di incomprensione che hanno caratterizzato per un trentennio lo spostamento del confine della regolazione del rapporto dal lavoro stabile a quello precario.
Page 453 of 612