Schmitt e la guerra
di Maurizio Lazzarato
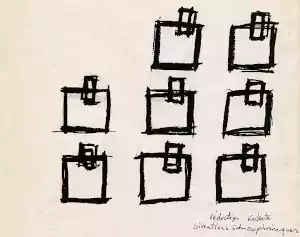 Pubblichiamo l’intervento di Maurizio Lazzarato al convegno «Teologia politica 2022?», svoltosi all’Università Sapienza di Roma alla fine di giugno. Come negli altri articoli su Machina, l’autore approfondisce questioni decisive per analizzare il rapporto tra guerra e capitalismo, soffermandosi in particolare sul pensiero di Carl Schmitt. I temi qui affrontati sono ulteriormente sviluppati e articolati nel libro Guerra o rivoluzione. Perché la pace non è un’alternativa, di imminente pubblicazione nella collana Input di DeriveApprodi.
Pubblichiamo l’intervento di Maurizio Lazzarato al convegno «Teologia politica 2022?», svoltosi all’Università Sapienza di Roma alla fine di giugno. Come negli altri articoli su Machina, l’autore approfondisce questioni decisive per analizzare il rapporto tra guerra e capitalismo, soffermandosi in particolare sul pensiero di Carl Schmitt. I temi qui affrontati sono ulteriormente sviluppati e articolati nel libro Guerra o rivoluzione. Perché la pace non è un’alternativa, di imminente pubblicazione nella collana Input di DeriveApprodi.
* * * *
Non c’era bisogno di essere Lenin per capire che la globalizzazione, i monopoli, gli oligopoli e l’egemonia del capitale finanziario ci avrebbero portato, ancora una volta, all’alternativa tra guerra o rivoluzione, socialismo o barbarie (la guerra è certa, mentre la rivoluzione, date le condizioni dei movimenti politici contemporanei, è altamente improbabile). La stessa situazione si era verificata un secolo fa. Sebbene in modo diverso, il collasso del capitale finanziario contemporaneo, salvato dall’intervento degli Stati, la frammentazione e la balcanizzazione della sua globalizzazione, l’ulteriore concentrazione del potere economico e politico per affrontare le difficoltà della finanza e del mercato globale, hanno prodotto dei risultati analoghi. La guerra rappresenta una «catastrofe» in termini tecnici, ossia un «cambiamento di stato». Non possiamo prevedere cosa accadrà, ma sicuramente il vecchio mondo, quello che abbiamo conosciuto negli ultimi cinquant’anni, sta crollando. In realtà, stava crollando già da diverso tempo.
La guerra in Ucraina affonda le sue radici e le sue ragioni in questi processi e non nell’autocrazia o nella follia di qualche individuo.
Tutto sarà deciso tra grandi macchine statali continentali, diversamente da quanto è accaduto durante la Prima guerra mondiale, in cui la rivoluzione, grazie all’iniziativa dei bolscevichi, irrompeva come attore determinante nel cambiamento dell’ordine mondiale, sconvolgendo i piani degli imperialismi in guerra per spartirsi il mondo. Per i rivoluzionari della prima metà del Ventesimo secolo, il capitalismo era inconcepibile senza guerre tra Stati e senza guerre civili contro il proletariato, senza guerre di conquista. Questo grande realismo politico aveva permesso loro, a differenza dello sgomento e smarrimento del nostro tempo, di non essere sorpresi e impreparati allo scoppio della Grande guerra.
Schmitt può ancora fornirci degli strumenti utili per decifrare il presente, ma non sono, a mio avviso, quelli teologico-politici. Vorrei dunque metterli alla prova nel cercare di comprendere l’attualità più immediata, la guerra o meglio le guerre: guerra di conquista, guerra civile, guerra di liberazione nazionale, guerra coloniale, guerra tra Stati. In particolare, ciò che mi interessa di Schmitt e mi sembra ancora attuale è il principio strategico come strumento per interpretare e leggere le azioni umane e gli eventi storici. Preferisco quindi privilegiare il Carl Schmitt che legge i rapporti di potere sfuggendo alla trappola democratico-liberale, piuttosto che la codificazione che opera di questi stessi rapporti nel teologico-politico, che è sempre il punto di vista dello Stato, dell’ordine e dei vincitori, con i quali si accasa volentieri, anche se nazisti. Si potrebbe anche interpretare il teologico-politico diversamente, cioè come rivoluzione, perché è la Rivoluzione sovietica, dopo e più di quella francese, che mostra che il reale è lotta, conflitto, guerra; è la rivoluzione che rivela «chi» è il sovrano, è la rivoluzione il vero «miracolo», l’eccezione che eccede la forma-Stato e non, come in Schmitt, uno degli strumenti della sua conservazione. Ma allora preferisco affidarmi direttamente al pensiero rivoluzionario. Il problema di Schmitt è infatti frenare, impedire che l’evento irrompa, che faccia secessione, che rompa con la forma-Stato, che era il grande progetto della rivoluzione comunista.
A cavallo tra Diciannovesimo e Ventesimo secolo, la rivoluzione esprime la sua egemonia politica e culturale; farà dire al giurista tedesco «Noi viviamo… sous l’oeil des Russes». Schmitt è costretto alla radicalità concettuale dall’intensità politica della rottura rivoluzionaria che cerca di neutralizzare, restandone comunque affascinato: viviamo «sotto lo sguardo del fratello più radicale che ci costringe a portare fino alla fine la conclusione pratica».
Il grande merito di Schmitt è di darci un’immagine della macchina bicefala Stato-capitale (svilupperò tale concetto più avanti) assolutamente non pacificata, affermando che il problema della guerra non è superato dall’economia, che anzi lo esaspera rendendo la guerra, guerra totale. La polemica con il liberalismo (qui Benjamin Constant) porta precisamente al fatto che «la guerra e la conquista violenta non sarebbero più i mezzi per procurarsi il comfort e i piaceri della vita», l’«impulso selvaggio» all’appropriazione sarebbe stato sostituito dal «calcolo civilizzato». Questo punto di vista mi sembra fondamentale, perché la «pacificazione» della macchina Stato-capitale è l’operazione che le teorie critiche, anche marxiste, hanno messo in opera da cinquant’anni a questa parte, assumendo paradossalmente un punto di vista molto vicino al liberalismo: dove c’è l’economia non c’è la guerra. Se negli anni Sessanta e Settanta la guerra è ancora presente, anche se marginalmente, nelle teorie che sono state elaborate, nei lunghi anni della controrivoluzione la guerra è praticamente scomparsa. Nei testi di Rancière e Badiou, che hanno occupato lo spazio della teoria politica critica degli ultimi vent’anni, così come nel femminismo e nell’ecologia, la guerra e le guerre non sono espressamente tematizzate, se non in maniera congiunturale.
La funzione che lo Stato moderno aveva assunto con successo, controllare il conflitto interno (sedare la guerra civile) e delimitare il conflitto esterno, cioè la guerra tra Stati, salta con l’avvento dell’accumulazione capitalista che introduce un’instabilità permanente, perché la crisi, la successione continua di distruzione/creazione, è la sua natura. Ma ciò che toglie ogni possibilità di stabilizzazione, se non temporanea, non è tanto l’economia, quanto la lotta di classe e, soprattutto, la rivoluzione. L’identificazione di Stato e di politico, possibile perché il primo deteneva il monopolio del secondo, non è più praticabile. «Sorgono nuovi soggetti, non più statali, come classi e razze in lotta, ispirate da nuovi raggruppamenti amico-nemico» che politicizzano altri ambiti sociali, primo tra tutti il capitalismo, l’economia, l’imperialismo. Schmitt individua qui i soggetti che si faranno carico delle rivoluzioni del Ventesimo secolo, la classe operaia e i popoli oppressi, privilegiando a giusto titolo questi ultimi. Schmitt evita di farsi imprigionare dal punto di vista eurocentrico, che sarà la caratteristica di molti marxisti europei.
La politicizzazione dell’economia, iniziata nel Diciannovesimo secolo, si compie nel Ventesimo con la rivoluzione, in cui «il conflitto di classe dapprima motivato solo in senso economico, divenne lotta di classe tra gruppi nemici». È Lenin, secondo Schmitt, che ha spostato il «centro di gravità della guerra sulla politica, cioè sulla distinzione tra amico e nemico». La congiunzione del partigiano di Lenin con Hegel produrrà un «nuovo concetto concreto di nemico, il nemico di classe».
Prendere, dividere, produrre
La prima parte del mio intervento è stata scritta sotto gli auspici del trittico schmittiano «prendere, dividere, produrre». Il ciclo economico comincia con le guerre di conquista e di assoggettamento e finisce con le guerre tra Stati (o con la rivoluzione). Questo è sicuramente vero per il neoliberalismo, ma era vero anche per il liberalismo classico. Il primo doveva superare le contraddizioni del secondo, che hanno condotto alle catastrofi della prima metà del Ventesimo secolo, invece sta pedissequamente seguendo le tracce del suo predecessore, anche nel suscitare diverse modalità di guerra civile interna e di guerra tra imperialismi.
Nel capitalismo, la produzione – sia essa materiale o immateriale, affettiva o desiderante, cognitiva o neuronale – presuppone sempre la produzione extra-economica, extra-affettiva, extra-cognitiva delle classi sociali. Prima di produrre delle merci, è necessario prendere, appropriarsi, espropriare con la forza della violenza e dello Stato, terre, popolazioni, corpi, mezzi di produzione, risorse e dividere ciò che è stato preso. Storicamente, il capitalismo è nato da una triplice conquista: la conquista della terra e dei contadini in Europa, la conquista delle donne (la caccia alle streghe è il segno dell’espropriazione del loro sapere), la conquista delle «terre libere» del Nuovo Mondo, con la sottomissione degli indigeni trasformati in colonizzati e degli africani ridotti in schiavi. Senza queste guerre di conquista dei corpi, che dividono i vincitori e i vinti in proprietari e non proprietari, non può essere avviata alcuna produzione.
In realtà, prendere, dividere e produrre è anche il punto di vista del marxismo rivoluzionario. La rivoluzione, in Marx, ha come condizione «l’espropriazione degli espropriatori», come riconosce Schmitt stesso, cioè il rovesciamento della guerra di conquista e di sottomissione attraverso cui sono state costituite le classi.
L’attuale impotenza politica è la diretta conseguenza dell’esclusione delle guerre dalla teoria politica, che a sua volta è il risultato di un’altra esclusione, quella delle lotte di classe. Ciò accomuna tutti i diversi concetti di «produzione» che dagli anni Sessanta hanno arricchito, ampliato, contestato e cercato di superare la teoria marxista: l’economia libidica (Lyotard), l’economia degli affetti (Klossowki), il discorso del capitalista (Lacan), la produzione desiderante (Deleuze e Guattari), la biopolitica (Foucault). Quest’ultima è esemplare, perché è stata elaborata proprio per sostituire la guerra civile come modello politico. Tutte queste teorie sembrano compiere un passo avanti teorico (poiché il capitalismo funziona anche con i desideri e gli affetti, e proprio i desideri e gli affetti contribuiscono fortemente alla costituzione di rotture rivoluzionarie), mentre politicamente fanno due passi indietro, in quanto hanno contribuito a pacificare il capitalismo, separandolo dalle guerre e dalle lotte di classe.
Le divisioni tra proprietari e non proprietari, il dominio dell’uomo sulla donna, del bianco sul non bianco, non sono il risultato della produzione, ma ciò che essa presuppone. La conquista dei corpi si articola a livello di mercato mondiale e, cosa che Schmitt coglie a differenza dell’eurocentrismo di queste teorie, si produce e si stabilizza in modo differenziale tra Nord e Sud grazie alla conquista dell’America. Nel Nord, il consolidamento del potere dei vincitori mobiliterà il diritto, il salario, il welfare e tutti gli strumenti che le teorie degli anni Sessanta e Settanta hanno elaborato (affetti, desiderio, godimento ecc.) per integrare il corpo e l’anima dei vinti. Al Sud invece, all’istituzionalizzazione del lavoro, all’integrazione attraverso il welfare, all’azione attraverso gli affetti, si predilige la violenza coloniale, la governamentalità attraverso il razzismo e la guerra civile permanente. Questa violenza differenziale tra centro e periferia costituisce la seconda condizione politica che le teorie della produzione, materiale o immateriale, biopolitica o cognitiva, sembrano ignorare perché centrate sull’Europa.
La terza condizione è il «non detto» di queste teorie: le soggettività possono essere mobilitate, le norme di potere interiorizzate, gli affetti implicati efficacemente nell’economia e nella politica, solamente quando la lotta in cui sono coinvolte ha prodotto la separazione tra vincitori e vinti. La governamentalità, che continua con altri mezzi la guerra di conquista, potrà agire sulla soggettività solo dopo che questa sarà stata vinta. Nessuna norma economica, sessuale o razziale può affermarsi in una situazione caratterizzata da un alto livello di lotta di classe (come, ad esempio, in America Latina o nell’Italia degli anni Settanta). È necessario procedere a una normalizzazione preventiva sia politica che soggettiva con un’intensità dell’uso della violenza e della guerra civile che varia a seconda dei rapporti di forza. Solo a queste condizioni le norme e gli affetti trovano la possibilità di agire sugli individui, plasmandoli, costruendoli, assoggettandoli. La norma produttiva, come la norma giuridica, non sono applicabili al «caos», suppongono «una strutturazione normale dei rapporti di vita», dice Schmitt. Questa normalità non è un presupposto esterno che si può ignorare; al contrario, concerne direttamente la sua efficacia immanente.
Queste tre condizioni – vale a dire la divisione binaria in dominanti e dominati, l’articolazione di tali divisioni a livello di mercato mondiale, la normalizzazione attraverso la forza che precede la normalizzazione tramite le norme e gli affetti – si riscontrano all’inizio di ogni ciclo di accumulazione. Il neoliberalismo non sfugge a queste genealogie del capitalismo: guerre civili in America Latina, dove si impianta il suo primo laboratorio, e lotte di classe al Nord, da cui il movimento operaio uscirà sconfitto. Nei due casi, quello che ne risultò fu una soggettività proletaria vinta, costretta a obbedire e disponibile alle sollecitazioni della governamentalità, obbligata ad adattarsi all’innovazione tecnologica, alle nuove forme di produzione, al nuovo mercato del lavoro, alle nuove norme del consumo.
L’estrema semplificazione introdotta dal «discorso del capitalista» di Lacan può essere utile per illustrare la rimozione del concetto di guerra e delle lotte di classe, nonché l’ingenuità con cui viene messo in scena un capitalismo pacificato, consentendoci anche di leggere il ciclo economico da un punto di vista particolare, quello del consumo e del capitale finanziario. Nel mondo descritto dal discorso del capitalista «tutto è possibile», nulla è vietato. L’offerta illimitata di merci sembra produrre un consumo il cui godimento è senza «legge», senza padre, senza il senso di colpa che nei precedenti periodi di sviluppo capitalistico riduceva il lavoro a «sacrificio» e il consumo a frugalità, incitando piuttosto al risparmio. I consumatori, liberati da questi limiti «protestanti», si sarebbero sostituiti ai lavoratori al centro dell’accumulazione. Quel «tutto è possibile» sembra corrispondere all’immagine di un capitale che non conosce limiti e rappresentare la nuova ideologia e la nuova antropologia del soggetto produttivo (performante, intraprendente, spinto continuamente, come il capitale di cui è la maschera – «capitale umano» appunto –, a superare i suoi limiti, che sono solo ostacoli con cui misurarsi per spostarli sempre più in là, all’infinito).
Ma il «discorso del capitalista» sembra non sapere che il godimento non si compra con il salario ma con il credito: vivere a credito è la parola d’ordine del potere. Se si oltrepassano i limiti eurocentrici che condizionano questo «discorso», si può facilmente scoprire che il consumo/godimento è stato immediatamente affiancato, ovunque nel pianeta, dalla coppia sacrificio/distruzione imposta dalle politiche finanziarie del debito. Inizialmente in Africa, in seguito in America Latina e nel Sud-Est asiatico, il credito/debito ha funzionato come un’arma di distruzione di massa, mettendo in ginocchio interi paesi e imponendo, a partire dagli anni Ottanta, l’austerità a tutto il pianeta, prima di approdare in Europa. Nel Nord, nei paesi ricchi, il «discorso del capitalista» è di breve durata, gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, la «belle époque» che si ripete. La congiuntura si inverte rapidamente: le crisi finanziarie si susseguono fino a culminare nel crack finanziario del 2008. Anche in America, origine della crisi, e in Europa, il credito lascia il posto al debito, che costringe i più poveri (chiedetelo ai greci) a sacrificarsi perché colpevoli di essere avidi del consumo e del godimento a cui sono stati spinti.
Dopo la crisi finanziaria, un’enorme creazione monetaria mantiene in vita artificialmente un sistema che, invece di ripartire, si logora. Gli Stati che hanno salvato la macchina del profitto/potere si devono confrontare con enormi squilibri interni tra le classi ed esterni con altri gli Stati. La concorrenza diventa conflitto armato. La guerra, che ha dato inizio al ciclo, lo sta ora concludendo, ma con una violenza moltiplicata dalla produzione e dalla produttività sviluppate lungo la fase di espansione del ciclo stesso.
L’economia desiderante si è trasformata in economia di guerra, il discorso del capitalista si è convertito in un discorso guerrafondaio, l’«intelletto generale» si sta rapidamente militarizzando, la sfera mediatica ha messo l’elmetto (in studio e nei giornali), senza che nessuna delle nuove teorie della produzione sia in grado di rendere conto di questa involuzione, perché le guerre e il loro rapporto con il capitalismo non fanno parte di questi modelli pacificati.
La globalizzazione e il nomos della terra che non c’è
La formazione delle classi tramite la guerra civile è la prima causa della guerra. La seconda è da cercare nell’imperialismo. Il capitale non è un modo di produzione autonomo, ci suggerisce Rosa Luxemburg: è «la prima forma economica incapace di sussistere sola, con il solo aiuto del suo ambiente […] il capitalismo vive delle formazioni e delle strutture non capitaliste, vive più precisamente della rovina di queste strutture». Il capitalismo è quindi indissociabile dalla globalizzazione, cioè dall’imperialismo.
Questa seconda parte è stata scritta sotto il segno de Il nomos della terra e della Teoria del partigiano. Nel primo Schmitt traccia il senso e il significato della prima globalizzazione, dell’imperialismo e dell’ordine mondiale imposto dall’Europa. Nel secondo libro rende conto di come le rivoluzioni del Ventesimo secolo mettano fine a questo nomos globale, cioè a quattro secoli di colonialismo, creando un’instabilità dell’ordine mondiale, che è ancora la causa principale dell’attuale guerra in Ucraina. Le rivoluzioni asiatiche e le loro strategie contro l’imperialismo sono state, senza alcun dubbio, l’evento più importante del Ventesimo secolo, Schmitt lo coglie perfettamente. Dico, en passant, che il teologico-politico è un punto di vista europeo-cristiano poco consono a interpretare queste rivoluzioni che hanno sconvolto l’ordine mondiale.
La divisione dello spazio politico mondiale è contemporanea della costituzione del mercato mondiale, cominciata con la conquista dell’America. Il Nuovo Mondo è sia un fornitore di beni gratuiti, condizione per lo sviluppo del capitalismo industriale, sia la premessa per l’ordine giuridico e politico europeo. Sono infatti «la comparsa di spazi liberi immensi e la conquista territoriale», integrati nelle strategie degli Stati europei, che hanno reso «possibile un nuovo diritto internazionale europeo a struttura interstatale». La macchina mondiale del potere, assolutamente organica alla macchina mondiale della produzione, scava un dentro dove si dispiegano gli Stati europei, la loro costituzione, la loro legge, la loro divisione dei poteri, e un fuori molto più vasto chiamato Nuovo Mondo, dove regna l’anomia, la violenza, l’arbitrio, il razzismo, il sessismo, il genocidio di massa. Questo ordine mondiale comincia a incrinarsi con la Rivoluzione francese e definitivamente con la Rivoluzione sovietica, vedendo a suo capo differenti potenze economico-politiche, l’ultima delle quali sono gli Stati Uniti, che si dovranno drammaticamente confrontare con il problema dell’impossibilità di stabilire un’egemonia, come era avvenuto per secoli.
Dopo la caduta del muro gli americani erano convinti che, avendo vinto la battaglia di «civiltà» del Ventesimo secolo tramite l’economia di mercato e la democrazia, non restasse che capitalizzare la vittoria imponendo il «neoliberalismo» in tutto il mondo. Gli occidentali, concentrati prima sullo scontro Est/Ovest e poi sulla guerra al terrorismo, non hanno compreso che le guerre anticoloniali, in meno di un secolo, avevano profondamente cambiato gli equilibri di potere tra Nord e Sud. La cosa era invece evidente per dei conservatori come Spengler e Schmitt già negli anni Venti del secolo scorso. Il primo, immediatamente dopo la Grande guerra, si esprime con una lucidità che vale la pena di citare: «Non è la Germania ma l’Occidente ad aver perso la guerra mondiale allorché gli è venuto meno il rispetto dei popoli di colore». A vincere è stata la Rivoluzione d’ottobre, che ha gettato via la «maschera “bianca”», per diventare «di nuovo una grande potenza asiatica, “mongolica”», animata da «odio infuocato contro l’Europa». Gli appelli dei sovietici alla sollevazione dei «popoli oppressi» dal colonialismo e alla rivolta dell’«intera popolazione di colore della terra», mirano a costituire «una resistenza comune» e una «lotta contro l’umanità bianca».
Pur avendo abbandonato il progetto comunista o socialista, le rivoluzioni anticoloniali, prima fra tutte la guerra di liberazione nazionale della Cina, sono all’origine della distribuzione contemporanea del potere politico e dello spostamento di centri del capitalismo dal Nord al Sud e all’Est del mondo. La riconfigurazione dell’ordine mondiale non ha avuto luogo principalmente al Nord ma nel Sud del mondo, come ora appare sempre più evidente. Gli Stati Uniti avrebbero dovuto capirlo, loro che avevano condotto un’aspra guerra militare, politica ed economica contro il Sud (all’epoca «Terzo mondo») dopo la Seconda guerra mondiale.
Per Giovanni Arrighi, il cuore dell’antagonismo della seconda metà del Novecento «non è altro che la lotta di potere durante la quale il governo americano cercò di contenere, con l’uso della forza, il doppio fronte della sfida che rappresentavano il comunismo e il nazionalismo nel Terzo mondo». Arrighi dimostra che la controrivoluzione monetaria, iniziata con la dichiarazione di inconvertibilità del dollaro (1971), costituisce una risposta diretta alla più importante guerra anticoloniale dopo la Seconda guerra mondiale, quella che ha dato l’indicazione della mobilitazione generale contro l’imperialismo a tutti i paesi del Sud. «Dobbiamo fare come Dien Ben Phu», proclamava Fanon dall’Algeria ancora sotto l’occupazione francese. Mentre i marxisti europei collegavano la riorganizzazione capitalista esclusivamente alle lotte capitale-lavoro e alla concorrenza tra i capitalisti, Arrighi afferma che le politiche americane a cavallo degli anni Sessanta e Settanta miravano «a strappare ai vincoli monetari la lotta per il dominio che gli Usa conducevano nel Terzo mondo».
Carl Schmitt vede perfettamente l’enorme energia e potenza politica sviluppate dalle guerre anticoloniali che sono riuscite a trasformare, grazie ai comunisti, la «piccola guerra» di Clausewitz in guerra rivoluzionaria, in «guerra partigiana», mentre il suo ammiratore, Mario Tronti, non sembra leggere con la stessa lucidità queste rivoluzioni che definirà, con una certa condiscendenza, «contadine». «L’irregolarità della lotta di classe» organizzata dalla lotta partigiana, articolata alle forme più classiche del combattimento condotto dall’Armata Rossa, «mette in discussione l’intera costruzione dell’ordinamento politico e sociale. […] L’alleanza della filosofia col partigiano, compiuta da Lenin, libererà delle forze nuove ed esplosive» e provocherà «nientemeno che il crollo del vecchio mondo eurocentrico, che Napoleone aveva sperato di salvare e il Congresso di Vienna di restaurare». La guerra partigiana farà crollare anche gli imperi coloniali.
Schmitt segue lo sviluppo della guerra partigiana nella Rivoluzione cinese dove raggiungerà il suo apogeo. «Ma il partigiano del bolscevismo russo è poca cosa – voglio dire nella sua realtà concreta – paragonato al partigiano cinese». La rivoluzione segue l’evoluzione della guerra da limitata a industriale e totale e ha la capacità di batterla nella sua nuova forma: «La guerra limitata» (che è ancora la guerra di Clausewitz), paragonata alla guerra imperialista e alla guerra partigiana scatenata dall’ostilità della rivoluzione, «non è molto di più che un duello tra uomini d’onore».
Ryamond Aron ha espresso lo stesso pregiudizio eurocentrico di Tronti, quando scriveva a Schmitt «che il problema del partigiano era il problema dei popoli poveri» e senza industria, gravati dai ritardi tecnologici e organizzativi, potremmo aggiungere noi. Schmitt, invece, prende molto sul serio la «piccola guerra» dei rivoluzionari e vede tutta la novità strategica che contiene, confrontandola con la configurazione spaziale dei teatri di guerra in mare («spazio liscio») e sulla terra («spazio striato»). «Il combattimento dei partigiani crea un nuovo campo d’azione, uno spazio con una struttura complessa perché il partigiano non si batte su un campo di battaglia aperto […] Al contrario forza il nemico a insabbiarsi in uno spazio nuovo”.
Il partigiano deterritorializza la guerra regolare, rendendo la terra liscia come lo spazio marittimo. Questa capacità di imporre un «nuovo spazio» al nemico, di sparigliare il suo territorio non fissando nessun fronte, creandolo continuamente dove si materializza la guerriglia, è una grande invenzione strategica che conoscerà un grande successo anche quando non ci sono i comunisti a gestirla.
La guerra partigiana è ancora la guerra che, malgrado la loro tecnologia, i loro eserciti, le enormi spese militari, gli enormi investimenti in scienza e tecnologia del Pentagono, gli americani non riescono a vincere. Le guerre iniziate contro il Sud subito dopo il crollo del muro le hanno perse tutte.
Il rifiuto delle sanzioni contro la Russia da parte della maggioranza dei paesi del Sud e il rifiuto di sottomettersi alla volontà egemonica degli Usa hanno le loro radici nella storia delle guerre anticoloniali del Ventesimo secolo, ma anche nell’attualità dell’imperialismo americano e del suo neo-colonialismo monetario e finanziario. Diversamente dalla maggior parte dei paesi del globo, gli Stati Uniti producono meno di quello che consumano, hanno un tenore di vita che non è giustificato dalla loro capacità produttiva, vivono cioè al di sopra dei loro mezzi, con la bilancia dei pagamenti costantemente in passivo. Sono il paese più indebitato del mondo. Le politiche del credito/debito sono state imposte perché erano le sole capaci di garantire che il loro reddito medio fosse sei volte superiore a quello di un cinese, senza che ciò corrispondesse alla realtà produttiva dei due paesi. È l’imposizione del dollaro come moneta internazionale degli scambi che permette alla Fed di finanziare l’«Americain way of life», cioè il più grande spreco nella storia dell’umanità, trovando acquirenti di un debito che continua a crescere.
Sia il dollaro che il debito non sono perciò garantiti dalla capacità produttiva, ma dalla supremazia militare. Il primato del dollaro fonda il primato degli Stati Uniti, e la forza del dollaro è garantita dal primato militare. Qui non si tratta nemmeno più di keynesismo militare, ma di semplice sopruso armato sul resto del mondo. Più cadono bombe, più si trucidano popolazioni, più si costruiscono armi, più il valore del dollaro resta alto o sale, e più possono emettere dollari in grande quantità e attirare capitali che sottraggono ai paesi poveri e in via di sviluppo. Le carneficine interne sono la legittimazione di questa logica assassina.
La guerra e l’armamento sono un elemento vitale per gli Stati Uniti non solo per l’egemonia mondiale ma anche per conservare standard di consumo e di produzione. È per questo che il loro imperialismo è molto più pericoloso di quello della Cina e della Russia, che non dispongono ancora dei dispositivi di predazione mondiale degli americani. Quando qualche paese del Sud, produttore di materie prime, decide di scambiarle con una moneta diversa dal dollaro, gli Stati Uniti intervengono immediatamente (vedi la fine di Saddam Hussein e di Gheddafi).
La cosa straordinaria dei governi e dell’amministrazione americana è che, nonostante questa «tassa» imposta al mondo intero, sono riusciti – creando delle enormi differenze di reddito e di patrimonio – a scatenare una guerra civile interna. Il che li rende doppiamente pericolosi. In realtà gli Stati Uniti sono ancora più pericolosi, perché le politiche del credito/debito utilizzate per sopperire al loro declino, sono all’origine della crisi finanziaria che è stata l’anticamera della guerra.
I paesi del Sud hanno tutte le ragioni del mondo per non appoggiare la coalizione anglo-americana in Ucraina, è ciò che dovrebbe fare anche l’Europa, se avesse un minimo di forza politica, perché si sta suicidando per la seconda volta.
Stato e capitale
La terza causa della guerra è da cercarsi nell’integrarsi dello Stato e del capitale in una macchina in cui produzione e distruzione tendono a identificarsi. La successione di eventi che ci ha portato alla guerra in Ucraina si era già prodotta, in maniera simile, nella grande globalizzazione precedente, determinando le condizioni della guerra e delle rivoluzioni. La finanziarizzazione che crea squilibri mostruosi tra le classi ma anche tra gli Stati, la mondializzazione che si sgretola, la guerra tra gli imperialismi che esplode, devono spingere a porci la domanda: perché il capitale non può diventare mercato mondiale compiuto e conduce invece con stupefacente regolarità alla guerra tra Stati? Com’è possibile che dopo tanto parlare di crisi dello Stato, di superamento delle frontiere, di reti mondiali economiche, finanziarie e commerciali, ci si trovi di fronte a una guerra tra imperialismi condotta da grandi Stati continentali, ma pur sempre e comunque da Stati?
Il problema di fondo mi sembra questo: non è possibile parlare di «ritorno dello Stato» perché non è possibile opporre il capitale e lo Stato, separare la potenza immanente del primo dal potere trascendente del secondo, dividere la forza deterritorializzante del capitale da quella territorializzante dello Stato, perché insieme costituiscono una macchina, che però non può mai diventare Impero o una sola macchina da guerra. Rosa Luxemburg lo aveva anche scritto un secolo fa: il capitale, «avendo la tendenza a diventare una forma mondiale, si spezza contro la propria incapacità a essere questa forma mondiale della produzione». Il capitale non può globalizzarsi senza lo Stato e quest’ultimo ha bisogno del capitale per vivere nella globalizzazione. Senza capitale la sua sovranità è vuota, senza salari e reddito, senza impiego e welfare la sua legittimità è debole, la sua forza interna ed esterna dipende dalla produzione. Senza lo Stato il capitale non può far fronte alla sua estensione produttiva, che deve coinvolgere l’intera società e l’intero mondo.
L’integrazione tra capitale e Stato si attua gradualmente senza mai fondersi in un tutto organico, con un’accelerazione a partire dalla Prima guerra mondiale. Dalle nozze dello Stato e del capitale celebrate tra il 1914 e il 1918, dopo un fidanzamento durato qualche secolo, nasce una macchina da guerra che riorganizza sia lo Stato che il capitale. Lo Stato vede modificarsi la sovranità, l’indipendenza, l’autonomia che aveva detenuto fino alla Rivoluzione francese. Lo Stato non più «stare», non può più frenare i movimenti che minano l’ordine, è impossibilitato a essere una forza katechontica, ma deve diventare esso stesso attore del cambiamento che deve anticipare e produrre, mentre il capitale non è più la potenza immanente e autonoma descritta da Marx. Non è più vero che «nel segreto laboratorio della produzione sta scritto: No admittance except on business», perché lo Stato ci entra di prepotenza per cercare di sedare la lotta di classe che il capitalismo ha suscitato ma non riesce a contenere.
Negli anni Trenta Schmitt definisce questo Stato come totale o economico perché «dispone di un esteso diritto del lavoro, d’una fissazione dei prezzi e d’un arbitraggio dei poteri pubblici in caso di conflitto sui salari attraverso il quale esercita un’influenza determinante sui salari; assicura delle sovvenzioni gigantesche ai diversi settori dell’economia; è uno Stato del benessere e della previdenza, uno Stato fiscale e che spende». Tutti i settori della società sono implicati in questo processo: già nel 1928, dice Schmitt, il 53% del reddito nazionale è controllato dai poteri pubblici. Lo Stato interviene in una materia che era precedentemente definita non politica e la produzione si politicizza perché luogo privilegiato della lotta di classe.
Questa perdita relativa di autonomia di entrambi è largamente compensata dall’acquisizione, tramite il loro integrarsi, di una forza di produzione/distruzione inaudita, che contiene tutte le catastrofi a venire.
Non c’è mai stata «fobia dello Stato», contrariamente a ciò che afferma Foucault, né da parte degli ordoliberali, né da parte dei neoliberali. La sola fobia che insieme hanno avuto è quella della «rivolta delle masse», che con la lotta strappano allo Stato conquiste di ogni tipo, obbligandolo al compromesso, riducendolo a un «mercato del bestiame» (diceva un ordoliberale) e a perdere parte della sua sovranità. Il progetto di Schmitt, così come degli ordoliberali negli anni Trenta («Economia libera, Stato forte» diceva Rüstow nel 1932, facendo eco a un testo precedente di Schmitt, Stato forte, economia sana) e dei neoliberali contemporanei, non è mai stato quello di uno Stato debole bensì di uno Stato forte, capace di neutralizzare tutte le «domande» operaie e proletarie che lo assalgono e di investire invece tutta la sua forza e le sue funzioni nello sviluppo della macchina Stato-capitale.
Il già citato Rüstow, uno dei fondatori negli anni Trenta del neoliberalismo, annuncia a suo modo il progetto di una macchina Stato-capitale capace di integrare le loro differenze: «uno Stato forte nell’interesse di una politica economica liberale e una politica economica liberale nell’interesse di uno Stato forte – perché le due esigenze si condizionano mutualmente». L’integrazione di Stato e capitale è spinta al suo limite quando gli ordoliberali domandano di scrivere i principi che regolano la produzione del profitto nella costituzione (cosa fatta in Europa durante l’ultima crisi del debito).
Questa integrazione senza identificazione produce un «capitalismo politico» in cui la burocrazia amministrativa, militare e politica non si distingue in niente dai capitalisti: insieme costituiscono la soggettivazione della macchina economico-politica. Burocrati e capitalisti occupano funzioni diverse all’interno della stessa macchina politico-economica-militare, costituendone il punto di vista soggettivo che instaura e regola il rapporto tra guerra di conquista e produzione, tra violenza della colonizzazione e ordinamento democratico, organizzazione scientifica del lavoro (astratto) e saccheggio della nature umana e non umana.
La guerra in Ucraina ci mostra una realtà che struttura da sempre la globalizzazione: Stato, guerra e capitale sono strettamente intrecciati, ma in macchine da guerra diverse che si oppongono strategicamente. Il capitalismo si è imposto su tutto il pianeta, ma il rapporto economia/politica non è uguale in ogni nazione. Anche gli obiettivi e i mezzi che si danno per raggiungerli non sono gli stessi. Abbiamo quindi a che fare con una molteplicità di centri di potere politico-economico che con l’acutizzarsi delle crisi e delle catastrofi ecologiche, sanitarie ed economiche scatenate dalle politiche neoliberali, si battono come un secolo fa per appropriarsi di mercati, risorse materiali e umane, per imporre le proprie regole e la propria moneta.
Insomma, abbiamo ancora a cha fare con gli imperialismi, anche se si tratta di grandi spazi, di Stati continentali, che si stanno scontrando con le armi, con l’economia, con la comunicazione, con la logistica, con la cultura, dunque con la guerra «totale». Ma totale era già il conflitto del 1914-18, anzi è ancora esso che costituisce la matrice di ciò che sta succedendo.
Un’ultima cosa non meno importante: l’industria bellica e il militarismo sono degli elementi costitutivi del capitalismo. Stato, capitale, militarismo costituiscono un circolo virtuoso: il militarismo favorisce lo sviluppo del capitale e dello Stato da sempre, e questi ultimi, a loro volta, finanziano lo sviluppo del militarismo. Dopo la Prima guerra mondiale, l’industria bellica costituisce un investimento imprescindibile per l’accumulazione. Ha la stessa funzione di stimolo degli investimenti produttivi (keynesismo di guerra) e assorbe l’aumento della produzione in modo che non vada al «consumo». In ciò l’industria bellica è un regolatore del ciclo economico, ma soprattutto del «ciclo politico». L’economia di guerra in cui siamo entrati aumenterà ancora la parte della ricchezza prodotta che andrà all’armamento e ridurrà ulteriormente il consumo. Al Sud non si tratterà soltanto di una contrazione del potere di acquisto, ma di carestie, esplosione del debito per molti di questi paesi, default per altri, miseria per tutti, irrigidimento delle gerarchie (sessuali, razziali, di classe), chiusura di ogni spazio politico.
Lenin diceva, forse saggiamente, «cercare di impedire la guerra in ogni modo», ma se arriva, «rovesciare» i signori della morte. Se non ci si riesce, si rimane comunque schiacciati dalla distruzione generale operata dalla guerra.
































Add comment