Domenico Losurdo legge Nietzsche
di Leo Essen
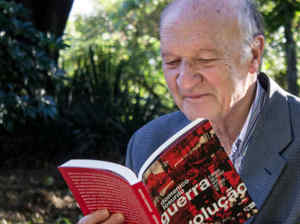 Losurdo dice di Nietzsche che è il più grande pensatore tra i reazionari e il più grande reazionario tra i pensatori. E chiude la faccenda. Centra i tre temi del suo pensiero (Innocenza dell’avvenire, Eterno ritorno, Volontà di potenza), ma li liscia tutti e tre, fornendo un’interpretazione banale e ingenerosa.
Losurdo dice di Nietzsche che è il più grande pensatore tra i reazionari e il più grande reazionario tra i pensatori. E chiude la faccenda. Centra i tre temi del suo pensiero (Innocenza dell’avvenire, Eterno ritorno, Volontà di potenza), ma li liscia tutti e tre, fornendo un’interpretazione banale e ingenerosa.
Dell’eterno ritorno dice che viene usato per liquidare la tradizione (messianica) ebraico-cristiana.
La critica del messianesimo e di ogni forma di teologia o filosofia della storia, dice, va a sfociare nella critica della speranza socialista nell’avvento di un mondo nuovo – un mondo nuovo per gli schiavi.
Lasciate ogni speranza, abbandonate ogni messianesimo, per voi la schiavitù sarà sempre e solo schiavitù, ora e per sempre, in un eterno ritorno, in un eterno presente.
Nietzsche, dice Losurdo, liquida la fiduciosa attesa, mediante la contrapposizione alla visione unilineare del tempo, propria della tradizione ebraico-cristiana, della tesi, mutuata dall’antichità classica, dell’eterno ritorno dell’identico. E così Nietzsche sembra voler ritornare al punto di partenza.
Il sentimento della speranza e la visione unilineare del tempo su cui esso si fonda, dice Losurdo, viene messa definitivamente fuori causa con la tesi o con il mito dell’eterno ritorno
dell’identico.
L’Eterno ritorno viene connesso da Losurdo al tema dell’Innocenza dell’avvenire.
Non fatevi illusione, non attendetevi niente. Tutto ciò che sarà è già stato, e ciò che è già stato lo avete davanti agli occhi, è la vostra schiavitù. Non abbiate speranza nell’avvenire. Non c’è avvenire, non c’è messia. Non c’è nessun piano, nessun progetto, nessuna filosofia della storia. C’è solo questo presente che gira intorno al suo asse.
Innocenza del divenire per Losurdo significa: fine della speranza. Fine di ogni autentica possibilità. Chiusura della storia, eternità dello status quo.
La fuga di Nietzsche, dice Losurdo (Nietzsche e la critica della modernità), la fuga a ritroso di Nietzsche dalla catastrofe della modernità e dalla notte che incombe sulla civiltà (catastrofe che Nietzsche vede con lucidità) mette infine capo alla riscoperta del meriggio pagano dell’innocenza del divenire e dell’eterno ritorno: prive di ogni senso appaiono per Nietzsche le rivendicazioni avanzate in nome della morale e di pretesi valori universali; non c’è più posto per le speranze di redenzione o di mutamento delle classi subalterne ovvero degli schiavi incatenati o da incatenare al carro della civiltà.
Innocenza dell’avvenire – lo ripeto – per Losurdo vuol dire niente possibilità. Questa fine del possibile (chiusura della storia, fine della storia) è legata all’interpretazione dell’Eterno ritorno. Niente possibilità perché il tempo si piega su se stesso in un circolo. Se sei uno schiavo ti risveglierai schiavo in questa e in altre vite, per sempre. Tu sarai uno schiavo, tuo figlio sarà uno schivo, tuo nipote sarà uno schiavo. Come pianta o animale ti rinnoverai, ma questo rinnovamento non contemplerà alcun progresso, alcun avanzamento, tornerai sempre alla casella basa, al punto di partenza, la penitenza ricomincerà sempre e per sempre daccapo.
Per Nietzsche, la filosofia della storia (la teleologia) pone nell’aldilà (nel futuro) un fine, insozza l’aldiqua. Insozzando l’aldiqua e contrapponendo ad esso un aldilà o comunque un fine, un «mondo vero» che svaluta il presente e il terreno, il movimento che dal cristianesimo conduce al socialismo sfocia inevitabilmente nel nichilismo.
Questa lettura di Losurdo è corretta – ma non si applica a Nietzsche.
Nietzsche ha di mira la teleologia hegeliana – ha di mira l’idealismo. Ciò che Losurdo contesta a Nietzsche, ovvero di aver levato dalla storia la speranza, Nietzsche lo contesta a Hegel (e, a questo punto, a Losurdo, fedele seguace di Hegel).
II
Non è il caso che governa le cose umane – dice Hegel (Introduzione alla storia della filosofia). La storia è determinata solo dall’idea. Per lo spirito il suo essere è il suo agire.
E com’è questo agire?
La natura è come è, dice Hegel. I suoi mutamenti sono soltanto ripetizioni, il suo movimento è solo circolare. Io sono immediatamente, dice Hegel. Ma in tal maniera sono solo come organismo vivente. Come animale e pianta. La natura, dice Hegel, non progredisce. Nelle infinite variazioni delle sue manifestazioni e funzioni, rimane sempre ferma nelle sue leggi originali, non compie alcun progresso.
Perché alla Cina deve essere vietato progredire? Perché i cinesi non devono conoscere i vantaggi dell’industrializzazione? Perché al Terzo Mondo deve essere vietata la civilizzazione, l’universalismo alla francese, la produttività inglese, il pragmatismo americano, etc?
Perché sono piante, perché l’Asia è immobile, foresta di bambù. Perché sono animali, si ammucchiano e si riproducono come conigli, ma non migliorano, non conoscono la Civilizzazione, la cultura, il progresso, etc.
È questo tabù imposto al Terzo Mondo che Losurdo contesta.
Nel Novecento, per una strana ironia della storia, proprio l’Europa occidentale, nella sua rinuncia all’eurocentrismo, bolla come antiquato ogni progressismo, compreso il progressismo possibile di chi ha conosciuto il progresso, ma solo per sentito dire.
Insomma, dice Losurdo, l’Occidente nega al Terzo Mondo la possibilità, la possibilità in quanto piano, la possibilità in quanto dynamis.
La possibilità che in Occidente è diventata attività industriale e capitalismo, nel Terzo Mondo deve rimanere congelata nel momento del desiderio, dall’aspirazione peccaminosa. Non deve cadere e cedere all’azione, non deve diventare processo e progresso, non deve conoscere le gioie e le pene del capitalismo, perché il capitalismo, perlomeno in Occidente, è stato bollato come il male. E però, obietta Losurdo, l’unica maniera per ottenere il progresso, l’unico e solo modo per avanzare verso uno stadio superiore, è passare per il negativo. Non è ammissibile che l’Occidente sia passato per la negazione determinata e abbia conosciuto le gioie della civilizzazione e, invece, il Terzo Mondo debba limitarsi a una negazione astratta, ad una negazione che si risolve in nulla. Al Terzo Mondo deve esser concesso di passare all’azione.
Il passaggio all’azione non si risolve nello zero. Il passaggio si risolve in un progresso. Non c’è progresso senza passaggio all’azione. Solo la negazione fa diventare vera l’aspirazione all’universale. Non c’è uguaglianza effettiva senza il passaggio all’azione.
La negatività è creatrice, radice del movimento. Il vasaio, prima di portare il vaso all’esistenza, lo porta nella mente in quanto vaso meramente possibile, non spendibile. Quando, dalla mente, il «vaso in genere» cade nel mondo e dà forma alla creta, l’esemplare è pronto e spendibile. Finché non viene speso, rimane fisso e inutile nella sua determinazione. Bisogna che sia tolto, affinché consegni nelle mani del vasaio la generalità di una domanda effettiva – soldi – con la quale il vasaio potrà domandare ogni cosa, ogni altra merce disponibile sul mercato.
Questa possibilità, la possibilità di poter scambiare il proprio lavoro con ogni altro lavoro, alle persone del Terzo Mondo deve essere preclusa, e lo deve essere perché nel momento in cui la possibilità passa all’azione e si fissa nella cosa, si esternalizza, questa esternalità negativa si ritorce contro la fonte inquinandola – alienazione.
Il Terzo Mondo deve rimanere intatto nella sua purezza astratta, non deve passare all’azione, non deve passare per l’esternalizzazione, non deve azzardarsi a mettere in scena alcun animismo, alcun feticismo, eccetera.
La cosa – il vaso – deve rimanere muta, pietra. Non deve parlare alle altre merci, non deve negarsi in quanto questo vaso particolare qui, e pensarsi in quanto un’altra merce qualsiasi. Non deve credere di poter valere tanto quanto un’altra merce qualsiasi, non deve pensarsi in quanto denaro – poiché il denaro è lo sterco del demonio. Non deve poter annullare (annichilire) la sua unicità lanciandosi nell’equivalenza con altre merci.
Nei soldi si ritrova l’idea del vaso, ma più arricchita e determinata. Il terzo termine della serie – i soldi – si ritorcono verso il primo – il vaso possibile -, negando il secondo – il vaso effettivo, negando la negazione. Del secondo termine della serie i soldi mantengono l’effettività, la determinazione, del primo termine mantengono la possibilità generica di fissarsi in ogni cosa: potere di acquisto generico.
Ecco la metamorfosi dell’idea: da possibilità generica, transitata per il vaso effettivo, ritorna ad essere possibilità generica, ma effettiva.
Ciò che è tolto, dice Hegel (Logica), non perciò diventa nulla. Nulla è l’immediato. Ciò che risulta dal togliere ha ancora la determinazione da cui proviene. La parola togliere (aufheben, superare togliendo), ha il doppio senso di conservare e togliere.
Questo circolo che dal vaso generico transita per il vaso effettivo per tornare a una possibilità generica, possibilità che, del passaggio terreno conserva la determinazione, termina appunto da dove ha iniziato. La genericità ideale – il vaso che il vasaio ha in testa – si nutre del mondo, lo lavora, lo divora, lo fa scomparire. Il lavoro produce il vaso effettivo, fa diventare vero il vaso possibile. Il passaggio all’azione è anche un passaggio di verifica. La verità non è il riflesso del mondo. La verità è produzione, produzione del mondo, costruzione sistematica del contenuto. Impedendo al Terzo Mondo il passaggio alla produzione gli si nega l’accesso alla verità.
In principio c’è la potenzialità dell’idea, che esce da sé, trasforma la creta, lavora il vaso. L’idea si divide, diventa altro e produce la dialettica. Senza il servizio della produzione l’avvento della verità è precluso.
Poi, ancora, il vaso deve essere tolto. Bisogna infine emanciparsi dal corpo e dalla materia e tornare alla possibilità generica.
L’hegelismo, scrive Lefebvre (Il materialismo dialettico), ha voluto mettere fine al divenire con una visione del divenire conchiuso in un cerchio tranquillo. Ma il cerchio tranquillo, il riposo del pensiero in sé, il soddisfacimento pieno dello Spirito, non sono che illusioni. L’hegelismo ha voluto risolvere tutte le contraddizioni del mondo, ma la contraddizione, e anche l’inconseguenza, sono rimaste nell’intimo del sistema. Cosa risponde Hegel alle esigenze, alle urgenti domande degli individui impegnati nella vita che vorrebbero avere un avvenire aperto davanti a sé?
Il mondo si giustifica solo se è opera «mia», opera di ciò che di più alto vi è in me, dell’umano e dello Spirito. Hegel si impegna a dimostrare a me, uomo qualsiasi, che anche quello che io subisco è prodotto dell’attività umana e spirituale che è in me, si impegna a giustificare il passato, e il presente, e i problemi del presente. Ma io non mi riconosco nel dramma fittizio dell’idea che si lascia andare a creare il mondo, si aliena e si ritrova nel sistema hegeliano.
III
Per Losurdo l’hegelismo è progressismo. Non è fissità e ritorno di ciò che c’era all’inizio nell’idea. L’hegelismo è un’avventura umana – è un’esperienza umana. Non è l’andare e venire della natura.
Con parole di oggi si potrebbe dire che la natura esegue l’algoritmo, processa l’informazione impressa nel DNA. Le generazioni non aggiungono nulla, tutta l’esperienza si perde nella rigenerazione.
Anche lo spirito esegue il suo codice. L’idea deve diventare ciò che essa è. Da cosa possibile (potenzialmente tale – dynamis), in sé, deve diventare cosa effettuale, attuale, per sé (energheia), deve mettersi all’opera, deve agire nel lavoro e manipolare la materia.
Per esempio, dice Hegel, l’uomo possiede ragione, intelletto, fantasia, eccetera, sin dalla nascita, anzi, già nel grembo della madre. Ma, il bambino è uomo solo in potenza, possiede solo l’attitudine e la possibilità della ragione, è come se non avesse ragione: la ragione non esiste ancora in lui, poiché non può ancora compiere nulla di ragionevole. Solo quando l’uomo diventa per sé, acquista al riguardo un’autentica realtà, è realmente razionale. Ciò che è in sé, dice Hegel, deve diventare oggetto per l’uomo, deve giungere alla sua coscienza, diventare per sé. Soltanto attraverso il processo, mediante il quale l’uomo diventa suo oggetto, l’uomo diventa per sé, si sdoppia, pur rimanendo se stesso e non diventando un altro.
Un vasaio dà alla creta la forma (impronta – stampo) di una brocca. La formazione – la messa in forma – avviene seguendo il filo conduttore di un’immagine (idea), di un modello preformato. L’aspetto della cosa che deve essere formata è anticipato in quanto possibile nell’ideazione. L’aspetto della cosa anticipata, scorta preliminarmente, è ciò che i Greci chiamano eidos e idea. La cosa che prende forma secondo un modello si configura come copia di questo modello.
L’idea e la forma sono compresi a partire da un atteggiamento produttivo, dice Heidegger (I Problemi fondamentali della fenomenologia). La produzione fa avvenire (avverare) l’idea, offre la cosa in ciò che essa, prima della sua effettuazione (energheia – attualità – azione) già era ed è (essenza). Ciò che è – l’aldiqua – è un inveramento, una incarnazione di ciò che già era nell’aldilà. Ciò che la cosa già era prima del suo attuarsi, l’aspetto a cui si commisura la produzione, è anche ciò da cui ha veramente origine la cosa che riceve l’impronta. L’eidos, ciò che una cosa già era preliminarmente, indica la stirpe della cosa, la sua origine, il suo genos – il genere (Heidegger).
L’in sé, dice Hegel, quando entra nell’esistenza, passa attraverso la variazione, ma rimane uno e lo stesso perché è esso che regola l’intero processo. Può sembrare che l’uomo, passando dal possibile all’azione non sia progredito affatto, dal momento che non è aggiunto alcun contenuto nuovo. In quanto anche l’uomo esegue il codice pre-marcato nell’idea. E invece l’in sé, quando entra nell’esistenza, passa bensì attraverso la variazione, ma rimane tuttavia uno e lo stesso perché è esso che regola l’intero processo.
L’algoritmo è codificato nel DNA e tenuto nel seme che cade a Terra, varia, ma non si perde o disperde, si semina ma non si dissemina.
La pianta, dice Hegel, non si perde in una variazione infinita. Ciò si vede sin dal suo germe: in esso non si discerne ancora nulla, ma è presente l’impulso a svilupparsi, giacché esso non può tollerare di essere soltanto in sé. Questo impulso infatti contiene una contraddizione, poiché è soltanto in sé e non deve esserlo. Così l’impulso si estrinseca nell’esistenza. In tal modo viene fuori una molteplicità, che però era già interamente contenuta nel germe, se non in modo sviluppato, tuttavia implicitamente e idealmente, mentre si compie questo estrinsecarsi, esso si pone uno scopo. La sua più alta perfezione e il fine preordinato è infatti il frutto, cioè la produzione del seme, il ritorno allo stato primitivo. Il seme vuol soltanto estrinsecare se stesso e tornare a sé. Esso esplica ciò che è in lui e poi ritorna nuovamente in se stesso e si raccoglie di nuovo nell’unità, da cui era sorto. È vero però che nell’ambito della natura si verifica che il soggetto che ha cominciato e l’esistenza finale (il seme e il frutto) sono due individualità separate; lo sdoppiamento ha il risultato apparente di scindersi in due individui, che però sono la stesa cosa quanto al loro contenuto. Così nella vita animale, genitore e figlio sono individui diversi, per quanto siano della stessa natura.
IV
Secondo Aristotele le cose mondane (fisiche, naturali) sono state di volta in volta viste secondo la necessità (causae efficientes) e secondo la finalità (causae finales)
La causa efficiente – o necessità esteriore – si identifica con il caso. Si ammette che i fatti della natura vengono determinati esteriormente da cause naturali.
La causa finale si identifica con la teleologia. La finalità può essere interna o esterna. Quest’ultima, dice Hegel (Lezioni sulla storia della filosofia), ha dominato a lungo la cultura moderna. E così, dice, si brancola alla ricerca di cause esterne, e ci si trastulla con la forma della teleologia esteriore che pone il fine aldilà della natura.
Aristotele, dice Hegel, ha conosciuto queste distinzioni, e la sua concezione della natura è superiore a quella moderna, e lo è in quanto la sua fisica contiene ancora un po’ di metafisica. I fisici moderni (empiristi), invece, hanno tenuto a distanza la metafisica, convinti che la schietta verità possa passare dalle mani della natura nelle loro mani e nei loro occhi.
Il fatto è che, dice Hegel, essi non si possono liberare del concetto. Con un tacito sottinteso continuano a servirsi di certi concetti, come Consistere di parti, Le Forze ecc., e li adoperano senza sapere affatto se questi concetti hanno una verità e in quale modo hanno la verità. Mentre Aristotele, come d’altronde gli antichi, non manca di interrogarsi sugli universali, ovvero sui principi.
Per Aristotele ciò che più importa nella natura è determinare il fine come interiore determinazione della stessa cosa naturale. A questo proposito, dice Hegel, egli ha inteso la natura come vita, ovvero come ciò che – scopo in sé e unità con sé – non trapassa in altro, ma grazie a questo principio dell’attività determina i mutamenti in maniera conforme al suo particolare contenuto, e così si conserva in essi.
In questa formula, dice Hegel, Aristotele ha in vista la finalità interna o immanente. Determina la natura come la causa finale, che si deve distinguere da ciò che è fortuna e caso.
Nella Fisica di Aristotele il concetto di finalità si presenta come momento ideale della sostanza. Si comincia (Fisica II, 8) con l’affermare che il naturale è ciò che si conserva, e che ogni verità, dice Hegel, sta proprio nel capire questa cosa.
Emerge anzitutto il dubbio, si legge nella Fisica, su cosa impedisca alla natura di operare non secondo uno scopo e secondo ciò che è meglio, ma di comportarsi piuttosto così, dice, come Zeus manda la pioggia, non perché i cereali crescano, ma per necessità, ovvero per la conseguenza, per così dire meccanica e casuale di forze e di resistenze. Il vapore, dice, spinto in alto si raffredda, e l’acqua raffreddata precipita in pioggia. Ed è un caso che, dice, in tal modo prosperino le messi. Parimenti, dice, allorché a qualcuno si infracidiscono le colture, non piove già perché avvenga questo danno – non c’è un progetto, uno scopo che determina il danno – la cosa avviene a caso. Cioè, commenta Hegel, vi è un nesso di necessità, ma esso è un rapporto estrinseco. In ciò sta appunto l’accidentalità della causa come dell’effetto. Che la siccità sia accaduta adesso, e che adesso le piante abbiano bisogno di acqua, è fortuito, non era scritto da nessuna parte e in nessun progetto che le piante dovessero vivere o morire – sono morte (o vissute) per niente, senza motivo, senza scopo, senza indirizzo.
A questo punto, si domanda Aristotele, cosa impedisce che le parti – per esempio le parti di un animale – non possano secondo natura comportarsi a caso? Che, per esempio, i denti anteriori siano acuminati e adatti a lacerare, e invece i molari siano larghi e buoni a triturare il cibo, può dunque avvenire a caso, senza che questi denti siano necessariamente così fatti a quel fine. La stessa cosa può dirsi per le altre parti del corpo – gli occhi, le orecchie, le gambe, etc. – nelle quali sembra esserci implicito uno scopo: in quell’ambito, in cui tutte le realtà si direbbero generate in vista di uno scopo, queste si sono levate casualmente connettendosi le une alle altre nella maniera adatta.
L’argomento secondo cui la natura ha messo insieme a casaccio le composizioni più strambe e a sopravvivere siano stati i più adatti è stata formulata da Empedocle a proposito dei buoi dal volto umano. E noi stessi, aggiunge Hegel, senza pensare ai favolosi mostri degli antichi, conosciamo una quantità di specie animali, che sono scomparse, perché non potevano sopravvivere. Le prime produzioni naturali, dice, erano dei tentativi, fra i quali non potevano sopravvivere quelli che non si mostravano rispondenti a un fine, quelli che non erano adatti.
La risposata all’argomento di Empedocle è la seguente. Questo modo di vedere, dice Aristotele, non regge. Tutte le cose naturali si ripetono sempre o per lo più allo stesso modo. Un ulivo ritorna sempre identico nelle generazioni, così una mucca, la pioggia, le onde, il sole, il giorno, la notte, eccetera. Mentre ciò non avviene per gli eventi dovuti al caso o alla fortuna. Se una mucca si rigenera in quanto mucca, ciò vuol dire che la sua fine – ciò che essa diventa in quanto mucca – è guidata dal suo inizio. Ciò in cui c’è uno scopo (télos), è fatto in conformità a questo stesso scopo, sia in ciò che precede, sia in ciò che segue. Dunque, dice, in tutto quello che è o che si genera nel mondo della natura è presente una finalità: ogni cosa è fatta secondo la sua natura.
Natura, commenta Hegel, significa appunto che una cosa diviene ciò che era già in lei sin dal principio: è questa interna universalità e finalità che si realizza. Sicché, dice, causa ed effetto sono identici, in quanto tutti i singoli membri sono relativi all’unità di un fine.
Operiamo in vista di qualcosa? – si chiede Aristotele.
Ebbene, risponde, in vista di qualcosa si verifica pure la generazione naturale.
Per esempio, dice, se una casa fosse un prodotto naturale, si costruirebbe esattamente come è ora che è prodotta dalla tecnica. E gli esseri che ora sono per natura fossero non solo per natura, ma anche prodotti d’arte si formerebbero né più né meno di come sono formati per natura.
Questo finalismo è particolarmente evidente negli altri viventi che non agiscono ispirandosi a un’arte, né compiendo una ricerca, né a seguito di una decisione meditata.
Sono per natura quelle realtà che, mosse da un principio intrinseco, giungono per movimento continuo a un certo fine.
In questa affermazione di Aristotele, dice Hegel, c’è tutto il vero e profondo concetto del vivente, che deve considerarsi come fine autonomo in sé: un che di identico a sé, che si stacca da se stesso, e nel suo estrinsecarsi rimane identico col suo concetto – in una parola, dice Hegel, l’idea che realizza se stessa. Così foglie, gemme, radici producono la pianta e tornano a lei. E ciò che esse producono preesiste già, il seme, da cui esse anche sono nate.
Nella concezione moderna di concepire la natura, dice Hegel, questo approccio di Aristotele è andato smarrito o a opera di una filosofia meccanicistica o a opera di una fisica teologica.
Il meccanicismo mette a fondamento la pressione, l’urto, i rapporti chimici, le forze, in ogni caso sempre le relazioni esteriori e in generale tutte quelle cose che sono immanenti alla natura, ma non sembrano scaturire dalla natura del corpo, ma sono un dato a esso esteriore, tutt’al più un’appendice, come il colore di un liquido.
Per la fisica teologica, dice Hegel, le cause originarie sono pensieri di una mente extra-mondana.
Se i cinesi sono uomini come gli europei, e gli africani sono uomini come gli europei, e i russi, i papuani, i bruzi, i patagonici, gli eschimesi, sono uomini, in sé sono uomini (uomini in potenza), perché a essi non è dato passare all’azione (actus), passare dalla possibilità all’attualità? Questo è il busillis di Losurdo. Perché i papuani non possono fare esperienza del capitalismo? Perché devono contemplare attivamente le loro possibilità – perdersi guardandosi l’ombelico – e non passare per il negativo, per l’azione, l’incarnazione, la caduta, la sofferenza, il travaglio, il lavoro, la semina, la fioritura, la rinascita, l’assunzione?
V
Heidegger lega il pensiero dell’eterno ritorno al pensiero dell’innocenza dell’avvenire. In primo luogo, dice Heidegger, Nietzsche accosta il tema dell’eterno ritorno al tema del tragico (Nietzsche). In Gaia scienza, dove per la prima volta compare il tema, Nietzsche parla di tragedia. Secondo Nietzsche, dice Heidegger, la grandezza e l’altezza fanno tutt’uno con la profondità e il terribile. L’affermazione della co-appartenenza di questi opposti è conoscenza tragica: muovere incontro alla propria suprema sofferenza e alla propria suprema speranza contemporaneamente. Il «contemporaneamente» è qui l’elemento decisivo. Non il mettere fuorigioco l’uno con l’altro, e ancor meno il prescindere da entrambi.
Perché il pensiero dell’eterno ritorno è la suprema affermazione?
Perché afferma persino il no estremo, l’annientamento e il dolore come appartenenti all’ente. Pertanto, dice Heidegger, con questo pensiero lo spirito tragico entra per la prima volta in modo originario e integrale nell’ente. Il supremo si, all’estremo no. Il doppio si: si al bene, si al male. Il futuro è innocente, è aperto, dalla porticina può entrare il messia, ma può entrare anche l’anticristo.
Chi entrerà?
L’enigma, risponde Heidegger, diviene manifesto indovinando. E si indovina perché si danno le spalle al futuro. Dare le spalle al futuro significa questo: contaminare le cose buone con le cose cattive.
Indovinare è diverso da calcolare.
Nel caso del calcolo si segue un filo conduttore già dato, si scopre progressivamente, partendo dal noto, qualcosa di ignoto. Nell’indovinare, invece, è insito un salto senza filo conduttore e senza pioli di una scala che chiunque può in ogni momento scalare. Il cogliere l’enigma è un salto, tanto più, dice Heidegger, se indovinare l’enigma è un arrischiare la verità.
Perché ciò che viene non può essere calcolato, e, al contrario, deve essere indovinato?
Il calcolo è teleologico. Parte da una premessa e progredisce verso una conclusione. La conclusione è già compresa nella premessa. Come nella logica esemplare: che è una logica circolare. La ricerca dell’esempio presuppone già ciò che l’esempio dovrà esemplificare.
L’indovinare si affida al caso.
È evidente – ma su questo punto non voglio dilungarmi – che l’indovinare non ha, e non può avere, dietro di sé un indovino. Nessun indovino, dunque nessun uomo. L’indovinare non è in mano all’indovino, così come il calcolare è in mano dello scienziato. Lo scienziato, per operare, cioè per calcolare, ha bisogno di un tempo vuoto che lui riempie con gli oggetti della sua ricerca. Un tempo rispetto al quale rimane sempre fuori, rimane sempre come un osservatore. Lo scienziato non è nel tempo, è fuori dal tempo. Lo scienziato si pone come un Dio, fuori dal tempo – pone il tempo con un apriori, come in Kant.
Eppure deve esserci qualcosa ad attendere, non un orizzonte di attesa, ma, perlomeno, un attendente, in una attesa che non attende più nulla.
Da una parte, dice Heidegger, abbiamo la mancanza di un fine – tema della disantropomorfizzazione, della negazione della teleologia – tema del nichilismo.
Dall’altra parte abbiamo la collocazione in un angolo, l’essere sempre situato.
“Tutto è indifferente, nulla vale la pena, il sapere strangola”[VI, i, 267] – fine delle ideologie, fine dei grandi racconti – un secolo prima della fine delle ideologie.
Come si supera il nichilismo?
Il nichilismo, dice Heidegger, non può essere superato dall’esterno, tentando di strapparlo e di cacciarlo via, ponendo semplicemente al posto del Dio cristiano un altro ideale, la ragione, il progresso, il socialismo economico-sociale, la mera democrazia. Volendo togliere in questo modo il nichilismo esso si attacca sempre più.
Non si può certo togliere il nichilismo con il sapere, con la conoscenza, con il ragionamento, eccetera. Perché il ragionamento stesso è nichilismo. Tutto ciò che ha a che fare con premesse – di qualsiasi tipo – ricaccia nel nichilismo.
Il nichilismo si supera con una «crisi». L’Eterno Ritorno, dice Heidegger, è pertanto il punto critico, il punto della scissione [critica κρίνω = scissione].
La scissione non è un dividere che stacca una cosa in due parti contrapposte – passato e futuro. L’andare in crisi non è un dividere, è piuttosto un dividersi, ma un dividersi che sa cosa lascia indietro, cosa eredita dal passato, ma non conosce la cosa verso cui si slancia – si tratta sempre di un lancio nel vuoto. Prima dello slancio e della crisi l’attimo non è pensato. Se l’attimo è la porta carraia che divide l’eterno-passato dall’eterno-futuro, e prima del salto l’attimo non si dà, ciò vuol dire che prima del salto non si danno un eterno-passato e un eterno-futuro, non si dà il tempo. Il tempo dipende dal salto, e il salto dalla decisione. Dalla scelta. Si sceglie, e nello stesso attimo il tempo si mette in moto, e tutto ritorna, compreso l’attimo. Se il tutto non ritornasse nell’attimo, nemmeno l’attimo si affermerebbe.
Indovinare significa: decisione e scelta. La decisione è legata all’attimo. Indovinare coincide con l’attimo, in quanto indovinare non dipende né dalla conoscenza del passato – eterno-passato -, né da una previsione-calcolo del futuro – eterno-futuro -, ma deriva da un azzardo, da una decisione, da una scelta libera da condizionamenti, libera dall’antropomorfismo. Arrischiare la verità. La via che conduce alla verità è la stessa via che può condurre all’errore – tema dell’apertura dell’avvenire. Se non ci fosse possibilità di errore, l’avvenire non sarebbe aperto. Se non ci fosse la possibilità del male – di sbagliare, di errare, di scegliere la cattiva strada – non ci sarebbe nemmeno la possibilità di scegliere il bene, di far accadere il bene, di volere il bene. Non si può aprire la porta carraia solo al bene – la parta deve essere aperta per tutti e tutto. Se la porta fosse selettiva non arriverebbe nulla, perché si selezionerebbe il noto, e l’ignoto verrebbe sempre e irrevocabilmente rimbalzato.
La spaccatura minima, dice Heidegger, l’apparente ponte rappresentato dal detto «tutto è uguale» nasconde l’assolutamente diverso: «tutto è indifferente» e «nulla è indifferente».
Bisogna attendere che tutto diventi niente, bisogna attendere che nella “vita”, nella “storia”, nell’ente nel suo insieme si faccia largo il niente – il nichilismo. Solo quando si è pronti, quando il nichilismo ha fatto il suo corso, quando non c’è più nulla da attendere, perché tutto è uguale, proprio quando, in virtù del fatto che tutto è uguale e non vale la pensa, allora l’avvenire si apre, quando non ci si attende più nulla in termini di previsione e di calcolo, di attesa politica eccetera, solo allora qualcos’altro, l’inatteso e l’inaspettato, il nuovo (la rivoluzione?) può venire.
Pensare l’eterno ritorno, dice Heidegger, richiede due condizioni:
1) Il pensare partendo dall’attimo. Ciò significa: il trasporsi nella temporalità dell’agire da sé e del decidere in base alla prospettiva di ciò che è dato come compito e alla retrospettiva di ciò che è dato in dote.
2) Il pensare il pensiero come superamento del nichilismo. Ciò significa: il trasporsi nella necessità della situazione che emerge con il nichilismo; questa costringe a una meditazione su ciò che è dato come compito. La situazione di necessità stessa altro non è che ciò che il trasporsi nell’attimo apre.
Pensare l’ET, dice Heidegger, esige il confronto con il «tutto è uguale», con il «non vale la pena», con il nichilismo.
Heidegger chiarisce bene il rapporto dell’eterno ritorno con l’Innocenza dell’avvenire. Tutte le possibilità che sono in carico al calcolo devono essere azzerate. Deve essere tolta al piano ogni pretesa sull’avvenire. Deve essere disarmata ogni previsione. La macchina calcolatrice deve girare a vuoto. Ma anche se girasse, e di fatto gira sempre, la calcolatrice non ha alcun potere sull’incalcolabile – sull’avvenire. L’avvenire rimane, di diritto, innocente, ovvero sciolto da ogni tipo di relazione con il presente e con il passato. Non si calcolo – s’indovina.
Ebbene, come viene e me questo avvenire del quale non ho alcuna anticipazione?
VI
L’eterno ritorno è strettamente legato all’innocenza dell’avvenire. Se il futuro facesse parte di un programma o di un piano non ci sarebbe bisogno di Eterno ritorno. Se il futuro fosse una possibilità conosciuta che si tratta solo di attualizzare non ci sarebbe bisogno di eterno ritorno. Perché già l’avvento di questo futuro programmato sarebbe una forma di ritorno, quella forma di ritorno circolare che Losurdo contesta a Nietzsche.
Se il futuro è imprevedibile, è incalcolabile, se non c’è nulla nella storia passata che possa farne presagire la venuta, come possiamo riconoscere ciò che viene? Ecco, qui si inserisce il tema dell’Eterno Ritorno. Per venire, un avvenire assolutamente incalcolabile, deve essere, almeno una volta, già venuto. Deve anticipare la sua venuta. Deve essere già, almeno una volta, venuto, tale che il suo arrivo vero e proprio sarà nientemeno che un ritornare sui propri passi.
Il tema ricorrente della danza in Nietzsche chiarisce questo movimento in cui il tempo segue un andamento a scatti, avanza e arretra, danzando, avanza di un passo e arretra di due, poi avanza di tre, eccetera.
Il ritmo del verso usato dai greci, dice Nietzsche, doveva esercitare una costrizione. Doveva costringere gli dei alla profezia. Doveva farsi esprimere delle profezie – originariamente significa (secondo l’etimo per me probabile della parola greca): farsi destinare qualcosa; si crede di costringere il futuro.
Far venire qualcosa dal futuro significa farlo ripetere, farlo accadere due volte. Eterno ritorno: non è ripetersi del passato, ma ripetersi del futuro. Eterno ritorno significa: Rendere possibile l’azione, la danza, la poesia, il passo aldilà.
Si crede di costringere il futuro, dice Nietzsche, col conquistarsi Apollo: lui che secondo la rappresentazione più antica è molto più di un dio preveggente. Non appena la formula viene pronunciata, letteralmente e ritmicamente, essa vincola il futuro.
Visto tutto ciò, continua Nietzsche, ci fu in generale per l’antico e superstizioso genere umano qualcosa di più utile del ritmo? Con esso si poteva tutto: dare magnificamente incremento a un lavoro; predisporsi il futuro secondo i propri voleri [Matematica]; sgravarsi l’anima di qualsivoglia eccesso (di paura, follia, di pietà, di spirito vendicativo) e non soltanto l’anima propria, ma anche quella del peggiore demone – senza il verso non si era nulla, col verso si diventava quasi un dio.
Bisognerebbe porre tutta questa discussione tra virgolette. E Nietzsche prontamente lo fa. Dice (Gaia, 109. Stiamo allerta!): guardiamoci bene dal dire che tutto ciò proviene dal caso. Perché soltanto accanto a un mondo di scopi la parola «caso» ha un senso. Guardiamoci dal dire che morte sarebbe quel che si contrappone alla vita. Il vivente è soltanto una varietà dell’inanimato e una varietà alquanto rara. Guardiamoci dal dire che il mondo crei qualcosa di eternamente nuovo. Non esistono sostanze eternamente durature: la materia è un errore.
Bisogna stare in allerta. Quand’anche si dicesse, e lo si deve dire, che tutto viene dal caso e dall’arbitrio, che la mano non è fatta per afferrare, ma è fatta a caso, e l’occhio non è fatto per vedere, perché se fosse fatto allo scopo di vedere, bisognerebbe subito introdurre un creatore (un Dio, un artigiano, un artista, un lavoratore) che ha pensato questo scopo nella sua testa e poi lo ha realizzato nella materia; bisognerebbe introdurre, insieme allo scopo, l’idea, la materia, il bene, eccetera; insomma, bisognerebbe trascinare nell’arena tutta la metafisica.
Quando la finiremo di essere circospetti! aggiunge Nietzsche. Quando sarà che tutte queste ombre di Dio non ci offuscheranno più? Quando avremo del tutto sdivinizzato la natura! Quando potremo iniziare a naturalizzare noi uomini insieme alla pura natura nuovamente ritrovata, nuovamente redenta!
VII
Queste precauzioni di Nietzsche servono a metter in guardia quelli che volessero pensare la Volontà di potenza – fra essi c’è sicuramente Losurdo – come decisione e piano, come progetto e indirizzo consapevole. La volontà di potenza è spinta che avanza e arretra, è danza e canto, in attesa che innocentemente l’avvenire si affacci.
Un pensiero – scrive in Aldilà, 17 – viene quando è «lui» a volerlo. [E non quando lo vuole un «io penso», in quanto soggetto, sostrato, sostanza].
Un pensiero viene quando è «lui» a volerlo e non quando «io» lo voglio; cosicché è una falsificazione dello stato dei fatti dire: il soggetto «io» è la condizione del predicato «penso». [Le virgolette e i corsivi sono di Nietzsche, e hanno il loro peso, evidenziano la raffinata precauzione di Nietzsche].
Esso pensa [in corsivo. Nemmeno il flebile «esso», l’impersonale «esso» va bene, perché mira sempre a una sostanza, dunque anche «esso» è una falsificazione dello stato dei fatti.]
Come cavarsi fuori da questo pasticcio se anche «Esso» rimanda ad una sostanza, falsificando lo stato dei fatti?
[Non ci si cava fuori dall’impaccio in alcun modo, se non segnalando che «Esso» è una falsificazione, e che non si può fare a meno delle falsificazioni se si vuol denunciare la falsificazione, etc – bisogna assumersi la responsabilità, dice Nietzsche, di questa falsificazione. Bisogna imporre il concetto. La Legge morale, dice (Umano I, 40), è una menzogna necessaria per non essere sbranati].
Già con questo «esso pensa» si è fatto anche troppo – scrive: già questo «esso» contiene un’interpretazione» del processo stesso. [Questo «esso pensa» contiene un’interpretazione, ovvero appartiene ai sintomi – è successivo, si apre a partire da qualcosa che lo precede.]
Si conclude a questo punto, secondo la consuetudine grammaticale: «Pensare è un’attività, a ogni attività compete qualcuno che sia attivo, di conseguenza…». Pressappoco secondo uno schema analogo il più antico atomismo cercava, oltre alla «forza» che agisce, anche quel piccolo conglomerato di materia in cui essa risiede, da cui promana la sua azione, l’atomo; cervelli più rigorosi impararono infine a trarsi d’impaccio senza questo «residuo terrestre» e forse un bel giorno ci si abituerà ancora, anche da parte dei logici, a cavarsela senza quel piccolo «esso» (nel quale si è volatilizzato l’onesto, vecchio io).
Pensare non è nemmeno un’attività – attività intesa in questo caso come attività di qualcuno – di una sostanza. A questo livello non ci sono attività e passività. Non ci sono forze e controforze. Le opposizioni – le Differenze – di ogni tipo, sono interpretazioni, sono concetti, anche quando puntano a un residuo terrestre.
Questo qualcosa a cui allude Nietzsche – che non è né una cosa, né un nulla – precede i Differenti o la Differenza. Non c’è «opposizione» tra positivi prima di questa cosa. L’opposizione è un’interpretazione – un sintomo di questa cosa inconscia. Di questo pensiero inconscio.
Qui Nietzsche è più sottile di Freud – e ne anticipa tutto il quadro che si trova, per esempio, in Aldilà del principio di Piacere.
Prendiamo la Volontà. Il Volere, scrive Nietzsche (Aldilà, 19), mi sembra soprattutto qualcosa di complicato, qualcosa che soltanto come parola rappresenta un’unità, – e appunto nell’uso di un’unica parola si nasconde il pregiudizio del volgo, che ha prevalso sulla cautela dei filosofi, in ogni tempo esigua.
La volontà, quando la si consideri come spinta (Trieb), come pulsione o istinto, non è mai un atomo, una sostanza. L’inconscio non è una sostanza – non è l’inconscio di qualcosa o di qualcuno. Qualcosa e qualcuno – i Differenti – sono sintomi dell’inconscio.
La volontà è qualcosa di complicato – dice Nietzsche. Complicato qui non vuol dire intricato, oscuro, enigmatico, da decifrare. La volizione – l’inconscio – è innocente. Ha innocenza dell’avvenire. È un sapere che non sa – una sorta di sapere-no. Per riferirsi a questo inconscio, che precede i Differenti, e precede anche la Volontà come sostanza, Nietzsche parla di enigma e di segreto.
Il segreto non è ciò che, una volta decifrato, rivela un qualcosa, un «che cosa». Segreto è ciò che è piatto, alla luce del sole, positivo, chiaro. È ciò che non ha nulla da nascondere. L’Enigma è che non ci può essere enigma là dove non c’è segreto. E dove non c’è segreto non c’è inconscio, inconscio da decifrare o interpretare. L’interpretazione dell’Inconscio è un sintomo di questo inconscio che è l’inconscio di nessuno, inconscio alla luce del sole, senza segreto. Se ne accorse Freud quando, cercando un linguaggio per decodificare l’inconscio, si rese conto che questo linguaggio doveva essere, di diritto, inconscio.
Non c’è segreto dove non ci sono i Differenti. Ci sono i Differenti dove c’è segreto. Non è una contraddizione. Ci sono due tipi di segreto. Come ci sono due tipi di differenza. Una «precede» l’altra – metto «precedere» tra virgolette, perché non ha alcun senso, in questo caso, parlare di precedenza: la precedenza è prospettica, allude sempre a un prima e a un dopo, dunque a una coppia di Differenti.
In ogni volere (in ogni spinta volitiva) – dice Nietzsche – c’è in primo luogo una molteplicità di sensazioni, vale a dire la sensazione dello stato da cui ci si vorrebbe allontanare, la sensazione dello stato a cui ci si vorrebbe avvicinare, la sensazione di questo stesso «allontanarsi» e «tendere», quindi anche una concomitante sensazione muscolare, la quale, pur senza che si metta in movimento «braccia e gambe», comincia il suo gioco mercé una specie di abitudine, non appena noi «vogliamo».
Ma non siamo noi a Volere. Non c’è alcun Volere. Nessuna meta cui tendere, nessuno scopo. Non c’è Voglia di… Non c’è sensismo che tenga. Il sensismo si dispiega a cose fatte, a partire da un pensiero della Differenza. Anche qui i corsivi e le virgolette sottolineano l’inadeguatezza del linguaggio nel descrivere il segreto e l’inconscio. Non c’è allontanarsi, avvicinarsi, non ci sono braccia e gambe se non a partire dai Differenti, ma qui siamo in un stadio che anticipa (o forse segue) i Differenti, che comunque non ha nulla a che vedere con essi.
In Gaia Scienza (360) Nietzsche aveva già precisato che c’è un quantum di energia accumulata, e che questo quantum può essere attivato attraverso uno scopo, all’interno di un ordine della Differenza. Oppure può essere attivato da qualcosa di interamente irrilevante, se commisurato a questo quantum di energia, perlopiù, dice Nietzsche, una piccola circostanza fortuita, conformemente alla quale quel quantum alla fine si «sprigiona» in un’unica determinata maniera: il fiammifero in rapporto al barile di polvere.
Le virgolette intorno a «sprigionare» sottolineano l’inadeguatezza di ogni linguaggio – linguaggio che si trascina dietro tutta la metafisica – inadeguatezza a descrive questo stato enigmatico chiamato qui quantum energetico.
Il fiammifero non è in mano allo scopo, è in mano al caso. Il quantum energetico è la differenza che precede ogni Differenza. C’è uno stadio della Differenza, in cui accendo il fuoco per una ragione, e c’è uno stadio della differenza dove è il fuoco ad accendere me.
Tra queste piccole circostanze fortuite e tra i fiammiferi, continua Nietzsche, annovero tutti i cosiddetti «scopi», così pure le ancor più cosiddette «vocazioni di vita»: essi sono relativamente gratuiti, arbitrari, quasi indifferenti in rapporto all’enorme quantum di energia che fa pressione per essere in qualche modo consumato.
D’ordinario, dice, [secondo una impostazione teo-teleo-logica] si considera tutto questo diversamente: secondo un secolare errore si è abituati a vedere proprio nell’obiettivo (scopo, vocazione, ecc.) la forza propulsiva – ma esso è soltanto l’energia direttiva, si è scambiato a questo riguardo il pilota della nave col vapore. E nemmeno sempre il pilota, l’energia direttiva… L’«obiettivo», lo «scopo», non sono molto spesso nient’altro che un sotterfugio per mascherare, un auto-accecamento a posteriori della vanità, riluttante ad ammettere che la nave segue la corrente in cui è incappata per caso? Che «vuole» andare verso quel punto, perché è verso quel punto che – deve andare? Che ha sì una direzione, ma – nient’affatto un pilota?
Tutti i corsivi sogno degli allert!, degli avvisi. Attenzione: la grammatica si trascina dietro la metafisica, ogni nome richiama una sostanza, ogni nome è un sostantivo, ogni verbo rimanda a un agente. Ma qui non c’è nessun agente. C’è una necessità, ma non c’è uno scopo.
La destinazione, si legge in Umano I (Prefazione, 7), dispone di noi, anche se non la conosciamo ancora; è il futuro che dà la regola al nostro oggi. C’è una forza che ci trascina verso una destinazione e questa forza non siamo noi. Non c’è Differenza a questo livello. E, a rigore, non si potrebbe parlare né di segreto, né di enigma, né di inconscio. Perché tutti e tre questi termini sono sostantivi e si trascinano dietro la metafisica, dunque la logica binaria che la sostiene.
Non c’è volontà nella volontà di potenza. C’è spinta e c’è danza. C’è marca e rimarca. Ma non c’è niente di ciò che ci vede Losurdo.
VIII
Dunque, innocenza, spinta e ri-marca.
Invece, nella vita dello spirito, le cose vanno in modo diverso. Lo spirito, dice Hegel, è coscienza, libertà, perché in lui coincidono il principio e la fine. È bensì vero che anche lo spirito, come il germe nella natura, dopo essersi fatto un altro, si raccoglie nuovamente a unità; ma in esso ciò che è in sé diventa per lo spirito ed egli diventa così per sé. Invece il frutto e il nuovo seme contenuto in esso non diventano per il germe primitivo, bensì soltanto per noi.
Lo svolgimento dello spirito risiede dunque nel fatto che egli, mentre si estrinseca e si scinde, contemporaneamente torna a se stesso.
Questa conciliazione con sé dello spirito, dice Hegel, questo suo tornare a se stesso può essere considerato come il suo scopo supremo e assoluto. Lo spirito è sdoppiamento, alienazione, ma solo al fine di poter trovare se stesso e di poter ritornare a sé. Per trovarsi ci vuole l’alienazione, il dolore, la pazienza e il travaglio del negativo (essendo il negativo appunto l’alienazione, il passaggio all’azione, il passaggio nel mondo, la cosificazione). Questa è l’autentica libertà. Lo spirito che si pone da sé e si fa da sé. Giacché è libero solo ciò che non si riferisce ad altro, né dipende da altro. E lo spirito, mentre torna a se stesso, ottiene appunto di esser libero.
Il circolo descritto da Hegel è il circolo che Losurdo appioppa a Nietzsche. Nel circolo di Hegel alla fine si ritrova ciò che c’era all’inizio – gravato dell’esperienza mondana.
In Nietzsche il ritorno è un gettarsi oltre, è uno spingersi aldilà, con le spalle rivolte al futuro, bendati, con la speranza che dalla porticina possa passare la rivoluzione, l’incalcolabile, l’imprevedibile, eccetera. Nel circolo di Hegel le spalle sono rivolte al passato e ciò che si ha in vista è il futuro programmato e calcolato, ovvero il progressismo, il passato ingegnerizzato.
IX
Pentitevi dunque e cambiate vita, dicono gli Atti degli apostoli (3,19-21), perché siano cancellati i vostri peccati e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore ed egli mandi quello che vi aveva destinato come Messia.
Pentitevi dunque, e tutto sarà restaurato. Tutto tornerà com’era già stato e durerà per l’eternità, la storia avrà fine, la storia della sofferenza avrà fine.
Nietzsche cancella ogni traccia di messianesimo. Il futuro non è chiuso, la storia non è finita. L’innocenza dell’avvenire significa che non c’è messianesimo, non c’è messia, non c’è sol dell’avvenire.
Anche Losurdo avversa il messianesimo. Dice che esso si innesta nel marxismo già nel 1879, con August Bebel, esponente di primissimo piano del partito socialista tedesco e assiduo interlocutore di Engels.
Nella società ventura e post-capitalista non ci sarà più lo Stato, non ci saranno i parlamenti, le dogane, i delitti. Spariranno gli avvocati, i tribunali, i pubblici ministeri, le prigioni, la stessa norma giuridica, i delitti. I codici e le raccolte giurisprudenziali andranno al macero. Spariranno i sentimenti di odio e di vendetta – dice Bebel.
Persino in Marx, dice Losurdo, si trova questa forma di messianesimo. Poi, rinnovato, il messianismo ritorna in Bloch, alla fine della prima guerra mondiale. Subito dopo la rivoluzione d’ottobre.
Nella prima edizione di Spirito dell’utopia, Bloch chiama i Soviet a metter fine non solo a ogni economia privata ma anche a ogni economia del denaro e, con essa, alla morale mercantile che consacra tutto quello che di più malvagio vi è nell’uomo. Dal comunismo, chiosa Losurdo, ci si attendeva la trasformazione del potere in amore.
La guerra, la crisi economica del 1929, la disoccupazione e la miseria minano l’idea di progresso. Sono la dimostrazione, dice Losurdo, che il progresso tecnologico è lontano dall’essere sinonimo di emancipazione. Anche Simone Weil, nel 1934, dice che il regime attuale della produzione, cioè la grande industria, riduce l’operaio a nient’altro che a un ingranaggio della fabbrica, a un semplice strumento nelle mani di coloro che lo dirigono; vane e fuorvianti sono le speranze nel progresso tecnico. Otto anni dopo, dice Losurdo, gli fa eco Horkheimer.
Le macchine, dice Horkheimer, sono diventate mezzi di distruzione non solo in senso letterale, com’è avvenuto nel corso della prima guerra mondiale, in luogo del lavoro hanno reso superflui gli operai, come avviene in seguito alla crisi scoppiata nel 1929.
Il Marxismo, dice Losurdo viene deviato verso l’anarchismo. Questi temi anti-illuministi, contrari allo Stato e alla legge, alla scienza e alla tecnica, contrari al progresso, si trovano già in Bakunin e, prim’ancora, in Stirner.
Nel complesso, dice Losurdo, tra le due guerre fa il suo ritorno in Occidente un motivo caro all’anarchismo. Nel 1869 Bakunin diceva che le ferrovie e i telegrafi, utilizzati dalla strategia militare, decuplicano la potenza difensiva e offensiva degli Stati; i telegrafi che trasformando ogni governo in un Briareo con cento, mille braccia, fornendogli la possibilità d’essere presente, di agire e di colpire ovunque, creano la centralizzazione politica più formidabile che mai sia esistita al mondo.
Agli occhi del leader anarchico, dice Losurdo, non solo sui campi di battaglia, ma anche in fabbrica scienza e tecnologia si rivelano sinonimo di dominio e di oppressione. Ci basti fare l’esempio delle macchine, diceva Bakunin, perché ogni operaio e ogni sincero fautore dell’emancipazione del lavoro ci dia ragione. Pertanto la scienza borghese va rifiutata e combattuta allo stesso modo della ricchezza borghese, tanto più che i moderni progressi della scienza e delle arti sono causa dell’aggravarsi della schiavitù intellettuale, oltre che di quella materiale. Che cosa costituisce oggi, principalmente, la potenza degli Stati? È la scienza, la scienza militare soprattutto, con tutte le sue armi perfezionate e quei formidabili strumenti di distruzione che fanno meraviglie; scienza del genio, che ha creato le navi a vapore, le ferrovie e i telegrafi: le ferrovie che utilizzate dalla strategia militare decuplicano la potenza difensiva e offensiva degli Stati, fornendogli la possibilità di essere presente, di agire e di colpire ovunque, creano la centralizzazione politica più formidabile che sia mai esistita al mondo.
Tra le due guerre fa il suo ingresso nel marxismo il tema del totalitarismo, della società del controllo, dello Stato come strumento di disciplina e repressione. L’ordine totalitario, dicono Adorno e Horkheimer nel 1944, insedia completamente nei suoi diritti il pensiero calcolante, e si attiene alla scienza come tale. Il suo canone è la propria cruenta efficienza. La scienza e la tecnologia affettano totalmente la scienza dello Stato. Lo Stato diventa Stato totalitario. Per il nuovo Leviatano sono parti integranti la scienza e la tecnica, utilizzate al fine sia di accrescere il profitto spremuto alla forza-lavoro salariata sia di approntare la «macchina tecnica» e la «macchina di morte» con cui affrontare la lotta per l’egemonia mondiale.
In Occidente, ribadisce Losurdo, la Grande Guerra, la Grande Depressione, l’avvento del fascismo e del nazismo e il secondo conflitto mondiale ridanno spazio e credibilità ai temi anarchici. Persino un autore come Lukács, dice Losurdo, nei suoi anni giovanili e nel periodo in cui l’orrore e l’indignazione per la guerra non hanno ancora trovato un’articolata risposta politica, sembra essere influenzato dal clima sopra descritto. Marianne Weber lo vede animato da «speranze escatologiche» e teso verso l’«obiettivo finale» della «redenzione del mondo» da conseguire grazie a una «lotta finale tra Dio e Lucifero».
Il vero campione del messianesimo è sicuramente Benjamin. Nelle Tesi di filosofia della storia, critica il «tempo omogeneo e vuoto», il tempo di Kant e della scienza, il tempo dell’evoluzionismo e di ogni progressismo. Il tempo lineare, dice Benjamin, non è in grado di dare ragione del salto che può dare la salvezza. Solo il tempo messianico della tradizione ebraica è in grado di allinearsi con la speranza operaia. In questo tempo, dice Benjamin, ogni secondo è la piccola porta dalla quale può entrare il Messia. Non c’è, e non può esserci, alcuna continuità tra il tempo storico e il tempo messianico. Tra i due c’è una frattura, nessun orizzonte di anticipazione, nessun calcolo, nessuna previsione, nessuna scienza, nessuno Stato ha la forza o la volontà di far entrare dalla porticina il Messia.
Come si vede il tema del messianesimo in Benjamin è molto vicino al tema dell’Innocenza dell’avvenire di Nietzsche.
Il torto di Benjamin è di aver depotenziato lo Stato, il partito, la classe, di aver portato discredito alla causa del Comunismo. Perché il comunismo, così come lo intende Losurdo, è hegelismo, è filosofia della storia. È progressismo. È emancipazione.
Il messianesimo è letto da Losurdo come un nuovo anarchismo. Per gli anarchici lo Stato, la Scienza, la tecnica, il calcolo, la statistica (soprattutto la scienza statistica), devono essere distrutti in quanto sono gli strumenti di un totalitarismo che deve essere tolto per giungere finalmente nel regno della felicità, del senza legge, senza delitto, senza sofferenza, senza questo e senza quello.
Siccome lo Stato, invece, serve, e serve soprattutto ai deboli per difendersi dai forti e prepotenti, Losurdo avversa fortemente questa concezione anarcoide e messianica.
Losurdo lega – e ci sono sufficienti motivi per farlo – lega l’anarchismo all’antiscienza, l’anarchismo all’anti-legge – lega Stirner a Nietzsche.
È noto che Nietzsche amasse Stirner.
Sull’altro fronte, Losurdo avversa anche il cosiddetto anti-umanismo che deriva direttamente da Nietzsche, e che trova espressione in particolare nello strutturalismo, nella persona di Althusser. In quanto anti-umanista Althusser nega la legge e l’universale, e li nega proprio a quei disgraziati e ultimi della terra ai quali non resta altro che la protezione della legge, dei diritti dell’uomo e del cittadino.
Anti-umanismo e Messianismo ritornano ancora negli anni Sessanta, a rinvigorire il mito fricchettone e borghese di una società senza Stato, senza Potere, senza Tetto e Legge, free, libera, edenica. Ancora negli anni ’60 del Novecento, scrive Losurdo, l’ideale (caro a Herbert Marcuse) di una società fondata su una sostanziale liberazione dal lavoro e sul trionfo definitivo dell’eros su ogni forma di dominio (e forse anche di potere) conosce una diffusione di massa e a tratti anche una radicalizzazione. A chiamare esplicitamente a «sopprimere il lavoro» è il principale esponente dell’«operaismo» italiano, e cioè Mario Tronti, che alcuni decenni dopo proclama la sua orgogliosa consonanza con le «eresie millenariste» degli «operai del Novecento».
Chi sono questi rivoltosi anarchici? – chiede Losurdo. Chi sono, se non i figli dei capitalisti, i quali invitano studenti e operai a costruire barricate in piazza per conto della borghesia. Chi sono, se non gli eredi di quei capi della Prima Internazionale, dei suoi führer borghesi (Bakunin, Stato e Anarchia), eredi di quella specie di triumvirato investito di poteri dittatoriali dei signori Marx e Engels e, dietro di loro e ai loro ordini, i signori Bebel e Liebknecht e alcuni ebrei amanti dello scrivere?
X
È evidente oltre ogni dubbio, e solo Losurdo non se ne accorge, che il messianesimo di Bebel e di Bloch condivide la stessa matrice del suo progressismo. Il motore di entrambi è la teleologia. L’idea, cioè, che la vita è una penitenza – un’esperienza – attraverso la quale il figlio ritorna dal padre, si eleva (aufhebung), si emancipa, si stacca dalla terra, si disincarna, si libera da ciò che lo tiene alla materia e nella materia e lo fa soffrire.
La semina contempla la possibilità (la possibilità) della disseminazione, del peccato. Tramite il sacrificio – la morte – si risorge. È per questa ragione che Losurdo giustifica tutto, e tutto, del Novecento: lo Stato, la scienza, la tecnica, la guerra. Tutto, persino la guerra. Perché tutto ha uno scopo, tutto ha un fine, tutto conduce alla redenzione.
La parusia per Losurdo si chiama umanesimo. E l’umanesimo passa per la libertà. Ogni uomo nato da uomo aspira alla libertà, ovvero aspira a non dipendere da un altro uomo. Questa libertà non si fonda sul contrattualismo o sul giusnaturalismo. Non ci sono contratti o leggi di natura che tengano. Io sono libero se mi libero da te (di te). Non c’è padrone (sovrano) che possa dirsi tale se, per il suo sostentamento, dovesse dipendere da un servo, da uno schiavo, da un proletario. Con la liberazione del servo si libera anche il padrone. A sostegno di questo tema Losurdo chiama direttamente Hegel (Enciclopedia § 431): «Sono realmente libero solo quando anche l’altro è libero ed è da me riconosciuto come libero». Finché rimango nelle spire del negativo (determinatio negatio est) non posso dirmi libero (sovrano, assoluto etc.). L’umanismo di Losurdo deriva direttamente dall’assolutismo hegeliano. Solo quando avrò finito con te sarò libero.
































Add comment