Da Keynes a Gramsci
Il filo della pace impossibile nell'internazionalismo dei mercati
di Quarantotto
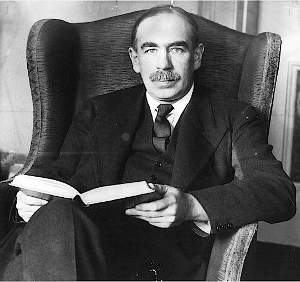 Nozioni elementari, un tempo note e oggi del tutto dimenticate (nell'insegnamento scolastico e specialmente nelle Università):
Nozioni elementari, un tempo note e oggi del tutto dimenticate (nell'insegnamento scolastico e specialmente nelle Università):
1. C'è un articolo di Keynes assurto ormai a rinnovata fama, almeno nel recente, e non casuale, dibattito attuale legato a globalizzazione e federalismo liberoscambista imperniato sull'euro: "National Self-Sufficiency", originato da una conferenza tenutasi all'Università di Dublino il 19 aprile 1933, e pubblicato in varie riviste economiche anglosassoni e anche italiane (in Italia, nel 1933 e nel 1936, con il titolo "aggiustato" di "Autarchia economica", non si sa se dovuto al traduttore o alla "diplomazia" dello stesso Keynes; cfr; la ripubblicazione dell'articolo stesso nel libro J.M.Keynes "Come uscire dalla crisi", raccolta di scritti a cura di Pierluigi Sabbatini, pagg.93 e seguenti; sul punto del titolo italianizzato, v.nota * alla stessa pag.93).
L'articolo non risulta disponibile in rete nella sua versione integrale e per la citazione di vari ulteriori brani rinviamo, ex multis, a questa fonte.
2. Il pensiero di Keynes, al tempo largamente anticipatorio, è particolarmente ricco di spunti non solo ricostruttivi delle differenze del capitalismo (primo)novecentesco rispetto a quello del secolo precedente, ma anche di indicazioni ancora attualissime sugli elevati "costi" del liberoscambismo internazionale in termini di convenienza socio-
 economica e di pace nell'ordine internazionale, e sulle soluzioni che si potrebbero adottare con politiche di adeguamento della "struttura della capacità produttiva alla struttura della domanda" (per usare la, non casuale, formula di Caffè) all'interno degli Stati nazionali (il punto è a lungo trattato, in termini generali alla pag.98 dell'op. cit., ma con varie delicate, anche col senno di poi, implicazioni relative a paesi come l'Italia, la Germania e la Russia).
economica e di pace nell'ordine internazionale, e sulle soluzioni che si potrebbero adottare con politiche di adeguamento della "struttura della capacità produttiva alla struttura della domanda" (per usare la, non casuale, formula di Caffè) all'interno degli Stati nazionali (il punto è a lungo trattato, in termini generali alla pag.98 dell'op. cit., ma con varie delicate, anche col senno di poi, implicazioni relative a paesi come l'Italia, la Germania e la Russia).
Per porre nella giusta prospettiva i vari, e spesso illuminanti, passaggi di Keynes, occorre però, a nostro parere, farne precedere l'esposizione da alcune informazioni storico-economiche e storico-politiche.
3. Sul piano storico-economico perché Keynes non poteva logicamente disporre, nel 1933, di dati comparativi tra la "crescita" che si supponeva fosse stata promossa dal liberoscambismo che vide come primario protagonista lo stesso Impero britannico e quella legata al periodo successivo alla seconda guerra mondiale, nel trentennio d'oro di (sia pur faticosa) applicazione del sistema di Bretton Woods. O meglio: dell'applicazione, tendenzialmente diffusa a livello mondiale, delle teorie politico-economico originate dal suo pensiero.
Per altro verso, sul piano storico-politico, l'integrazione delle informazioni, poi, va fatta, anzitutto, per via della premessa che egli stesso compie con grande onestà, già nell'incipit dell'articolo: "Come la maggior parte degli inglesi, sono stato allevato nel rispetto del libero commercio, considerato non soltanto come una dottrina economica, che una persona razionale ed istruita non poteva mettere in dubbio, ma anche come parte della legge morale" (pag.93, op. cit.). Un certo riflesso di questo atteggiamento lo riproduce nel corso dell'esposizione, pur dopo aver iniziato a manifestare la sua critica verso il liberoscambio; ad es. a già a pag.94: "Cosa credevano di fare i liberoscambisti del XIX secolo, che erano i più idealisti e disinteressati tra gli uomini?".
A questa prospettiva di intellettuale, anzi, a rigore, di aristocratico inglese, in quanto tale difficile da abbandonare del tutto, sul piano psicologico personale, mediante un imparziale distacco (che egli in fondo non reclama come suo), va aggiunto anche il fattore storico: egli, nel 1933, non poteva sapere quali sviluppi avrebbe avuto il conflitto, che già allora si preannunciava, tra le potenze europee e mondiali (in particolare il Giappone, pressocchè l'unico Stato asiatico non assoggettato a una qualche forma di controllo coloniale) "escluse" dall'accesso ai mercati mondiali delle materie prime e gli imperi colonialisti e (vetero)liberoscambisti. Liberoscambisti quantomeno all'interno delle loro sfere di influenza territorial-militare, serbando un simmetrico protezionismo, cioè una preferenza di accesso e di sfruttamento, rispetto a tali altre potenze, considerate avversarie senza alcuna possibilità di mediazione: almeno nel corso della cruciale prima parte del '900, quando appunto, il protezionismo "conflittuale", guerrafondaio, è quello ascrivibile agli imperi coloniali e, per riflesso, ai grandi Stati europei loro "contendenti" sul piano globale, e non certo quello dei minori Stati nazionali, europei in particolare.
4. Sul primo aspetto, storico-economico, richiamiamo i dati sulla crescita mondiale già riportati in un precedente post:
Al riguardo, ci basterà rammentare i dati, nudi e crudi, che si offre Ha-Joon Chang, in "Bad Samaritans" (capitolo 1, "The real history of globalization", pagg.6-14).
Ebbene, già al tempo dei "misfatti" dell'Impero inglese, - che pur ammessi non portano gli storici ad ammettere altrettanto la realtà economica conseguente e induce anzi a continuare a lodare gli effetti positivi "per tutti i paesi coinvolti" della globalizzazione "imperialista" dell'800-, l'Asia, che prima dei trattati aveva paesi al vertice dei PIL mondiali (tipicamente la Cina nella prima parte del secolo) crebbe solamente dello 0,4% all'anno tra il 1870 e il 1913. L'Africa, il più vantato esempio di civilizzazione e progresso free-trade colonialista, crebbe, nello stesso periodo, dello 0,6%. Europa e USA crebbero invece, rispettivamente, dell'1,3 e dell1,8% in media negli stessi anni. Notare che i paesi dell'America Latina, che nello stesso periodo recuperarono autonomia tariffaria e di politica economica, crebbero allo stesso livello degli USA!(Tralasciamo gli eventi susseguenti alla crisi del '29, quando i free-traders dominanti, abbandonarono il gold-standard e aumentarono sensibilmente le tariffe alle importazioni, prima nei settori dell'agricoltura e poi in generale nell'industria manifatturiera).
Che accadde nel dopoguerra del 1945, quando si verificò il progressivo smantellamento del colonialismo e l'adozione degli Stati interventisti praticamente in tutto il mondo, sviluppato (e in ricostruzione) o in "via di sviluppo " (col tanto deprecato neo-protezionismo, da incentivazione pubblica all'industria nazionale e alla ricerca)? Riassuntivamente: nei deprecati anni del protezionismo, rigettato come Satana dai vari governatori di tutte le banche centrali del mondo divenute indipendenti, in specie negli anni '60 e '70, i paesi in via di sviluppo che adottarono le "politiche "sbagliate" del protezionismo, crebbero del 3% in media all'anno: questo dato, sottolinea Chang, è il migliore che, tutt'ora, abbiano mai accumulato. Ma gli stessi "paesi sviluppati" crebbero, negli stessi decenni, al ritmo di 3,2% medio all'anno.
Poi intervengono le liberalizzazioni alla circolazione dei capitali e gli accordi tariffari: i paesi sviluppati, già negli anni '80 vedono la crescita media annuale abbattersi al 2,1%. Anche questi facevano le riforme, e infatti gli effetti di deflazione e rallentamento della crescita si vedono (finanziarizzazione e redistribuzione verso l'alto del reddito crescono a scapito delle invecchiate democrazie sociali). Ma le riforme più intense, sono imposte proprio ai paesi in via di sviluppo, tramite il solito FMI: è qui che si registra il calo della crescita più marcato.
I paesi emergenti, infatti, debitamente "riformati" e "aperti" nelle loro economie, vedono la crescita praticamente dimezzarsi dal 3% a circa la metà, negli anni '80-'90, cioè all'1,7 medio annuo.
Ma attenzione: la decrescita "infelice", cioè l'impoverimento neo-colonizzatore, sarebbero ancora più marcati se si escludessero Cina e India. Infatti, nota Chang, questi paesi si imposero progressivamente alla crescita, realizzando un 30% del prodotto globale dei paesi in via di sviluppo già nel 2000 (dal 12% degli anni '80): ma India e Cina rifiutarono il Washington Consensus e le "riforme" stile "golden straitjacket" tanto propugnate dal noto Thomas Friedman (che abbiamo già incontrato in questo specifico post).
5. Questi dati, lungi dallo smentire Keynes, rafforzano la sua critica ai liberoscambisti, relativa al fatto che pensassero, almeno quelli del XIX secolo, "di essere persone perfettamente ragionevoli", che "credevano di risolvere il problema della povertà, e di risolverlo in tutto il mondo, utilizzando al meglio, come una buona massaia, le risorse e le capacità presenti sulla Terra".
L'ironia di Keynes, col riferimento alla "buona massaia", appare a posteriori una critica troppo tiepida, almeno in quanto, in tutto lo scritto, si tende a non negare una certa qual buona fede nelle intenzioni ("Essi pensavano inoltre di garantire non solamente la sopravvivenza di ciò che è più opportuno dal punto di vista economico ma, battendosi contro le forze del privilegio, del monopolio e dell'arretratezza, ritenevano anche di servire la grande causa della libertà, libertà dell'iniziativa e del talento individuale, nonché la causa della creatività artistica...Erano convinti infine di essere gli amici e i garanti della pace, della concordia internazionale, della giustizia economica tra le nazioni e i propagatori dei benefici del progresso"; pag.95).
6. E qui possiamo andare invece ai dati storico-politici, che consentono una diversa visione una volta che, fuoriuscendo nella stessa limitazione che auto-indica Keynes (cioè quella di un inglese "allevato nel rispetto del libero commercio"), si veda la questione dal punto di vista culturale dei paesi che subirono il liberoscambismo imperialista.
Sappiamo infatti che, proprio sul piano delle intenzioni e della supposta buona fede, i liberoscambisti del XIX secolo, non potessero certo dirsi esenti dal ricercare i privilegi e il monopolio, secondo una convenienza che era giustificata dall'utile individuale e, quindi dalla superiore razionalità della "mano invisibile" (delle leggi del mercato), senza alcuna preoccupazione morale sul conservare e, anzi, determinare la povertà e l'immiserimento dei popoli interessati.
Ne abbiamo una, non l'unica, delle riprove, in quello che fu il più grande affare di arricchimento colonialista, apertamente teorizzato come liberoscambista, del XIX secolo: il traffico dell'oppio (vicende analoghe, si svolsero, sempre in chiave di libero mercato che non doveva trovare ostacoli nei "confini" all'affermazione delle sue leggi naturali di "benessere", rispetto ai business del legno di tek o alla coltivazione intensiva dell'albero della gomma).
7. Il traffico dell'oppio, comunque lo si voglia contestualizzare, coinvolse, in diverse forme e fasi di aggressione politico-territoriale, e quindi militare, i più grandi paesi di quella e della nostra stessa epoca, Cina e India:
"La Compagnia (britannica) delle Indie Orientali (ne esistettero anche una francese e una olandese, che ebbero la peggio nello scontro, per il dominio colonial-mercantilista, con la prima), aveva stabilito che la coltivazione dell'oppio in India, e in particolare nel Bengala (ma non solo), dovesse divenire il suo "core business".
[ADDE: e questo, si noti, in regime produttivo, e di vendita all'ingrosso, caratterizzato da monopolio: il processo di distribuzione e commercializzazione "a valle", peraltro, risultò poi liberoscambista "guerrafondaio", nel senso che non si ammise neppure un'eccezione normativa alla importazione, da parte della Cina, fondata su fondamentali interessi pubblici sanitari, nemmeno applicando la reciprocità di diritto internazionale, cioè riconoscendo ai cinesi di poter introdurre lo stesso standard normativo di divieto praticato sul territorio dell'Impero britannico.
In ultima analisi, così come oggi, il liberoscambismo tende ad affermare, tramite quella che, come vedremo, Keyens definisce la "specializzazione internazionale", cioè gli effetti dei c.d. "vantaggi comparati", delle gerarchie che, - in qualsiasi regime politico sia esso propugnato, incluso il federalismo (unificatore sul piano "politico", cioè l'UE), ovvero il super-trattato per grandi aree politiche congiunte, (il TTIP)- sono gerarchie tra comunità umane, che vengono plasmate e ricondotte a diversi gradi strutturali di benessere e di prospettive di sviluppo. Chi viene posto in condizione recessiva, nella graduazione delle produzioni meno convenienti, dovrà rimanervi per sempre. La sanzione morale per qualsiasi tipo di resistenza a questo asservimento e impoverimento "relativo" (sia alla condizione precedente, sia rispetto ai paesi dominanti nella gerarchia) è oggi l'accusa di nazionalismo e populismo che "mette in pericolo la pace".
Dell'instaurarsi di tali gerarchie, considerate inevitabili e, anzi, auspicabili, i fautori dell'euro e del TTIP, (che tendenzialmente coincidono, trattandosi dell'allargamento di un unico paradigma politico-economico), non parlano mai: si tratta di un problema che i media orwelliani non trattano, se non in modo del tutto indiretto: cioè, per colpevolizzare i vari popoli circa la loro inadeguatezza "competitiva" che sarebbe la soluzione per crescere fondandosi (solo) sulla domanda estera, celando pervicacemente che, in realtà, si mira solo a imporre riforme strutturali, del mercato del lavoro, che favoriranno, inevitabilmente, i futuri controllori esteri dell'economia degradata, all'interno della gerarchia perseguita ].
L'Inghilterra, infatti, si trovava nella scomoda posizione di essere in costante deficit degli scambi con la Cina, che produceva merci pregiate che erano effettivamente molto, troppo, richieste nel resto dei territori dell'Impero britannico.
Per non depauperare le proprie risorse finanziarie, dato che, adottando il gold standard, non poteva permettersi un costante saldo negativo (equivalente a un'emorragia di oro verso il paese creditore commerciale) con la più importante economia mondiale del tempo (appunto la Cina), stabilì di incrementare al massimo possibile la coltivazione e la lavorazione dell'oppio. Con conseguenze socio-economiche distruttive per i territori indiani sotto il loro dominio.
Tra queste conseguenze, la sistematica deportazione (oggi diremmo "arrivo di migranti"), a Sri-Lanka e nelle Mauritius - e servendosi delle navi già utilizzate per il traffico degli schiavi-, della manodopera agricola divenuta eccedente, una volta instaurata una monocultura con obbligo di una produttività "minima". Infatti, accadeva che, ove non fosse raggiunta la quantità di prodotto prestabilita, e pagata a prezzi irrisori, all'agricoltore indiano venisse sottratta la proprietà del terreno, mediante una rapida escussione della garanzia del debito contratto forzatamente con la Compagnia.
L'esecuzione forzata era assicurata sotto il controllo di giudici inglesi, che erano sostanzialmente dei dipendenti della Compagnia delle Indie, (dato che esercitava anche le funzioni sovrane di amministrazione di giustizia e ordine pubblico sui territori indiani).
La Compagnia in tal modo estendeva notevolmente la diretta proprietà dei terreni utili e dediti alla coltivazione e, agendo da monopolista, tendeva a ridurre i salari e la stessa capacità di sopravvivenza dei contadini bengalesi (già resa critica dall'esistenza di una monocultura forzata). Da cui l'ulteriore ampliamento dell'ondata di deportazioni, ben controllata dal funzionamento strutturale dell'economia nel paese di partenza, e che doveva apparire come un evento quasi meteorologico nelle terre di arrivo...
L'oppio raccolto dai produttori veniva quindi raffinato nei giganteschi stabilimenti di proprietà della Compagnia e poi venduto in apposite aste a "liberi mercanti" inglesi, americani, olandesi e anche indiani; in particolare appartenenti all'etnia "parsi" (antichi mercanti persiani, ancora seguaci del culto di Zoroastro, trasferitisi, tra l'altro, nei territori indiani, in particolare nella zona di Calcutta)
I liberi mercanti erano anche armatori di navi che arrivavano principalmente a Canton (unico approdo ove era consentito il commercio in entrata dalle autorità imperiali cinesi e, tradizionalmente, un polo commerciale con "l'occidente" sviluppatosi per millenni)".
8. Ritornando all'articolo di Keynes, egli si interroga sulla efficacia dell'internazionalismo economico relativamente all'ottenimento della pace (sempre nei limiti di contesto, punto di osservazione, e di momento storico, fin qui tratteggiati; cfr; pagg.95-98):
"...al momento attuale non sembra logico che la salvaguardia e la garanzia della pace internazionale siano rappresentate da una grande concentrazione degli sforzi nazionali per conquistare i mercati esteri, dalla penetrazione, da parte delle risorse e dell'influenza di capitali stranieri, nella struttura economica di un paese e dalla stretta dipendenza della nostra vita economica dalle fluttuazioni delle politiche economiche di paesi stranieri.
Alla luce dell'esperienza e della prudenza, è più facile arguire proprio il contrario.
La protezione degli attuali interessi stranieri di un paese, la conquista di nuovi mercati, il progresso dell'imperialismo economico, sono una parte difficilmente evitabile di un sistema che punta al massimo di specializzazione internazionale e di diffusione geografica del capitale, a prescindere dalla residenza del suo proprietario.
...Ma quando lo stesso principio (ndr; di scissione tra proprietà "azionaria" del capitale e gestione dell'impresa multinazionale, cioè che investe all'estero) è applicato su scala internazionale, esso è, in periodi di difficoltà, intollerabile: io non sono responsabile di ciò che posseggo e coloro che gestiscono non sono responsabili verso la mia proprietà non sono responsabili nei miei confronti. Vi può essere qualche calcolo finanziario che mostra i vantaggi di investire i miei risparmi in qualche parte della Terra, mettendo in evidenza la più elevata efficienza marginale del capitale o il più elevato daggio d'interesse ch eposso ricavare. Ma l'esperienza dimostra sempre di più che quando si considerino le relazioni tra gli uomini, il distacco tra proprietà e gestione è un male, e che esso quasi sicuramente, nel lungo periodo, provocherà tensioni e antagonismi, facendo fallire il calcolo finanziario."
9. Sulla scorta di questa premessa previsionale, relativa a "tensioni e antagonismi" che, col senno di poi, paiono un understatement rispetto agli eventi che si produrrano sulla scena mondiale, Keynes azzarda una ricetta, applicando la quale per tempo si sarebbe potuto evitare il disastro.
I paesi colonizzati, in questo schema, avrebbero avuto un necessario grado di autonomia politica per poter sviluppare, con un ragionevole protezionismo (qui, p.6), l'infant capitalism (ben prima della fase del trentennio d'oro), i mostri del nazi-fascismo sarebbero stati (forse) in gran parte ridimensionati, sul piano delle stesse motivazioni sovrastrutturali che li animavano, dalla riapertura dei giochi (specie sulle materie prime,) e delle conseguenti "gerarchie" che erano la giustificazione per la conservazione degli imperi coloniali europei; la stessa tendenza al gold-strandard e alle politiche di bilancio austere in caso di crisi, incentrate sul riequilibrio naturale dei prezzi e dei salari, avulse dalla politica delle bilance di pagamento in attivo (o del loro equilibrio raggiunto a scapito della permanente dipendenza economica delle aree coloniali), avrebbero perso gran parte della loro implicita ragione politica (molto più forte, già allora, di quella economico-scientifica, essendo in corso già le conseguenze della crisi del '29).
10. In conclusione, a complemento del discorso svolto da Keynes, ci pare opportuno riportare l'analisi di Gramsci (citata da Francesco), che con la sua consueta nitidezza, tratteggia, in raccordo alle stesse intuizioni keynesiane, una cornice storico-economica che, oggi, risulta più che mai attuale; la visione gramsciana, infatti, appare capace di descrivere le analoghe tensioni a cui sono esposte, sempre a causa dell'ordine internazionale dei mercati come paradigma che si deve affermare a qualsiasi costo, la pace e il democratico benessere dei popoli:
"Lontani anni luce da Gramsci che non si era fatto attrarre da tali sirene, consapevole della vocazione globale del capitalismo mercataro e del falso mito dell’internazionalismo: “Tutta la tradizione liberale è contro lo Stato. [...] La concorrenza è la nemica più accerrima dello stato. La stessa idea dell'Internazionale è di origine liberale; Marx la assunse dalla scuola di Cobden e dalla propaganda per il libero scambio, ma criticamente” (A. Gramsci, L'Ordine nuovo, 1919-1920, Torino, 1954, 380).
E sulla “globalizzazione”, diversamente da rapporti inter-nazionali tra Stati sovrani come concepita, già allora scriveva: “Il mito della guerra - l'unità del mondo nella Società delle Nazioni - si è realizzato nei modi e nella forma che poteva realizzarsi in regime di proprietà privata e nazionale: nel monopolio del globo esercitato e sfruttato dagli anglosassoni. La vita economica e politica degli Stati è controllata strettamente dal capitalismo angloamericano. [...] Lo Stato nazionale è morto, diventando una sfera di influenza, un monopolio in mano a stranieri. Il mondo è "unificato" nel senso che si è creata una gerarchia mondiale che tutto il mondo disciplina e controlla autoritariamente; è avvenuta la concentrazione massima della proprietà privata, tutto il mondo è un trust in mano di qualche decina di banchieri, armatori e industriali anglosassoni” (A. Gramsci, L'Ordine nuovo, cit. 227-28).
Le conseguenze sono quelle descritte nel post, ovvero: “L'Italia è diventata un mercato di sfruttamento coloniale, una sfera di influenza, un dominion, una terra di capitolazioni, tutto fuorchè uno stato indipendente e sovrano. [...] Quanto più la CLASSE DIRIGENTE ha precipitato in basso la nazione italiana, tanto più aspro sacrificio deve sostenere il proletariato per ricreare alla nazione UNA PERSONALITA' STORICA INDIPENDENTE” (A. Gramsci, L'Ordine nuovo, cit., 262-263).


