Chi salvò il liberalismo da se stesso
Una lettura di Ordoliberalismo di Adelino Zanini
di Lauso Zagato
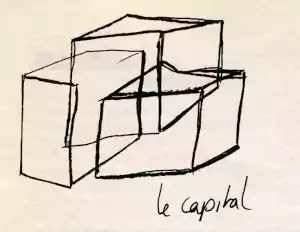 Ordoliberalismo ed economia sociale di mercato sono concetti politici ed economici che tendono a essere sovrapposti, oppure relegati a una fase specifica del Novecento. In realtà, come ci spiega Adelino Zanini nel suo Ordoliberalismo. Costituzione e critica dei concetti (1933-1973) (Il Mulino, 2022), si tratta di sviluppi teorici e pratici distinti che arrivano fino alla crisi degli anni Settanta e continuano a essere importanti per comprendere e dunque poter analizzare criticamente – anche ponendo nella giusta luce taluni passaggi politico/giuridici rilevanti – quel processo di costruzione europea, avviluppato oggi in una crisi profonda. In questa attenta e approfondita lettura del volume, Lauso Zagato ci consente di analizzare genealogia e attualità di questi concetti, prima di Foucault e oltre Foucault.
Ordoliberalismo ed economia sociale di mercato sono concetti politici ed economici che tendono a essere sovrapposti, oppure relegati a una fase specifica del Novecento. In realtà, come ci spiega Adelino Zanini nel suo Ordoliberalismo. Costituzione e critica dei concetti (1933-1973) (Il Mulino, 2022), si tratta di sviluppi teorici e pratici distinti che arrivano fino alla crisi degli anni Settanta e continuano a essere importanti per comprendere e dunque poter analizzare criticamente – anche ponendo nella giusta luce taluni passaggi politico/giuridici rilevanti – quel processo di costruzione europea, avviluppato oggi in una crisi profonda. In questa attenta e approfondita lettura del volume, Lauso Zagato ci consente di analizzare genealogia e attualità di questi concetti, prima di Foucault e oltre Foucault.
* * * *
La nuova avventura scientifica di Adelino Zanini, cui l’Autore lavorava da tempo, pone prima facie problemi di non facile soluzione al lettore, quand’anche di formazione operaista, che non risulti sufficientemente qualificato sotto il profilo disciplinare di riferimento (la teoria economica). Forse, cresciuto nel solco dell’incontro/scontro con Keynes, egli avrà ignorato l’esistenza di un neoliberismo diverso da quello classico; ciò, almeno, fino al drammatico impatto con l’anarco-liberismo americano trionfante degli ultimi decenni. Esempio tra i tanti, chi scrive è tra costoro, e confessa di aver letto la parola ordoliberalismo per la prima volta in relazione alla formazione teorica (seconda formazione, provenendo l’interessata dalla ex Germania dell’Est e quindi essendosi inizialmente formata nel delirio del diamat) della allora cancelliera Merkel. Il riferimento costituiva una apparente giustificazione della riluttanza di costei nell’assumersi i compiti «interventisti» in materia economica che la crisi del 2008 richiedeva alla Ue e in primis al suo Stato-guida.
A ben vedere, era dunque un richiamo irridente: l’ordoliberalismo è stato raccontato in via incidentale, quale teoria di nicchia, insieme stranezza da archivi storici e oggetto legittimo di disprezzo, anche alla luce dell’ambiguo rapporto dei protagonisti con il nazismo trionfante. Il punto è che la vicenda intellettuale/politica di costoro risulta ben più attuale di quanto si creda, anche da parte della dottrina qualificata. Già nel guidarci per mano a questa, inattesa per più versi, conclusione, il volume e il suo Autore acquistano solidi titoli di merito (Adelino Zanini, Ordoliberalismo. Costituzione e critica dei concetti (1933-1973), Il Mulino, Studi e Ricerche, Bologna 2022).
È evidente peraltro come lo scrivente, studioso certo di formazione operaista ma cimentatosi nei decenni con e su altri rami disciplinari, fosse (e sia) il meno indicato a intervenire sul volume, ciò per il motivo, in ipotesi decisivo, che gliene mancano i riferimenti scientifici adeguati. Quando ha spiegato all’Autore questo semplice dato di fatto, è purtroppo andato troppo in là, accennando in via aneddotica a un singolare effetto della lettura. Invero, completato il primo capitolo, si è reso conto di avere finalmente la chiave per comprendere il ciclo di lezioni della primavera del ’79 di Foucault [1]. Confessava allora di essersi messo di buona lena a ri-leggere quei capitoli centrali del filosofo francese, dedicati agli ordoliberalisti e massimamente a Eucken, che alla prima lettura gli erano risultati inintelligibili, nel mentre proseguiva e portava a termine la lettura del volume di cui qui si parla. Ciò parve divertire l’Autore, che non volle più accettare ragioni di rifiuto. Nel frattempo, la situazione si era evoluta: completata la lettura del lavoro di Zanini, emergeva come l’ordoliberalismo si proietti con forza nell’attualità politica, facendo per giunta irrituale irruzione nello specifico campo di saperi (anche disciplinari) dello scrivente. Era dunque giocoforza rimanere sul pezzo. Come a dire: l’uomo sbagliato, capitato nella postazione sbagliata, nel momento sbagliato.
Una nuova costituzione economica
Il volume è strutturato in tre capitoli, i primi due dedicati ai maestri/fondatori del filone (Eucken e, rispettivamente, Böhm), operanti nel periodo tra la tarda Weimar, l’ascesa e la fine del nazismo, l’immediato dopoguerra. Si tratta di personaggi non particolarmente gradevoli di proprio, anche per le ambiguità accennate e su cui si tornerà. L’Autore sembra talora latitare, assentarsi; quasi scegliesse di farli parlare liberamente per portarli a invischiarsi nelle proprie contraddizioni insanabili; talora invece riappare, quasi a gettar loro una provvisoria ancora di salvataggio. È una tecnica che non prevede complicità «piaciona» con chi legge. Zanini ci va duro, e l’insistito ricorso a termini tedeschi non agevola. E tuttavia, è innegabile come la lettura, comunque mai banale, acquisti in itinere vieppiù interesse, e anche fascino.
Subito all’inizio incontriamo una questione metodologica posta da Eucken che lascia perplesso l’internazionalista, che in certe situazioni ha a disposizione e si avvale di strumenti di lavoro ben più saldi quale il principio di effettività (ma di ciò un’altra volta). Per Eucken le costruzioni evoluzionistico-storicistiche riferite alla realtà economica sono prive di valore. Egli rifiuta l’approccio concettualistico così come quello empirico, ricorrendo piuttosto alla costruzione di alcuni «tipi ideali». La sua ricerca è volta ad astrarre «forme economiche pure, elementari» – astrazioni isolatrici, le chiama – dalle cui molteplici combinazioni diventerebbe possibile trarre un incalcolabile numero di sistemi economici possibili (p. 36). Le forme pure sarebbero per un verso l’economia centralmente regolata, per l’altro verso quella fondata sullo scambio. La prima comprenderebbe a sua volta tre varianti: la totalitaria, senza scambio, quella con libertà di scambio dei beni di consumo; la terza, comprendente una certa libertà di scelta dei consumi stessi. L’economia di scambio vedrebbe invece contrapposte una forma aperta, comprendente monopolio, monopolio parziale, concorrenza, oligopolio parziale, monopolio collettivo, e una forma chiusa (in particolare a causa di disposizioni di diritto pubblico). Eucken, va da sé, non riscontra in nessun caso l’esistenza nella realtà di tali forme pure, ma sostiene che le molte varianti delle situazioni reali richiedono da parte dello scienziato il ricorso ad astrazioni isolatrici per funzionare, consentendo il rapporto tra realtà economica individuale (fattuale) e teoria economica generale. Cacciata dalla porta, la storia economica rientra così dalla finestra, perché solo essa, in questo schema di ragionamento, consente di stabilire verità e attualità di una teoria. Ciò porta l’Autore, richiamando svariate critiche formulate in dottrina, a chiedersi se alla fine non sia proprio l’economista tedesco a «doversi riparare sotto l’ala protettiva dello storico economico».
Questo singolare personaggio appare terrorizzato dall’idea che l’industrializzazione si sia spinta troppo avanti. Lo sviluppo di una economia tecnicizzata, industrializzata e basata sulla divisione del lavoro avrebbe creato una situazione che l’uomo non è più in grado di controllare. In un mondo che non assomiglia più a quello in cui operavano Sismondi e Marx (l’accostamento insensato meriterebbe di per sé un commento irridente), un mondo caratterizzato dalla sproporzione tra prestazioni offerte da scienza e tecnica da un lato, insufficienza degli ordinamenti (economici e giuridici) dall’altro lato, si genera una domanda sociale che pare legittimare il prevalere di forme di economia centralizzata come unico mezzo per dare lavoro a tutti. Tali politiche economiche, in realtà, sarebbero portatrici «di un impossibile compromesso tra sicurezza e libertà» (p. 65). L’insicurezza provocata dalla disoccupazione di massa provoca – Eucken scrive dopo la grande crisi, e l’ascesa del nazismo, ma rifiuta caparbiamente di vedere in questo altro che una variante del sistema economico centralmente regolato – la creazione di una società piramidale. Non, quindi, l’utopica società senza classi edificata dal basso, sognata dai teorici rivoluzionari dell’Ottocento, ma una società controllata invece oculatamente dall’alto. Lo Stato cade progressivamente nelle mani di gruppi di potere che ne influenzano in modo decisivo le manifestazioni di volontà, e al tempo stesso gli sottraggono settori importanti di attività precedentemente controllate dallo Stato stesso (p. 67).
E qui Zanini ci accompagna al cuore del ragionamento teorico di Eucken. Questi sviluppa una sequenza elementare (binaria) di fasi storiche: all’epoca del laissez-faire avrebbe fatto seguito l’«epoca degli esperimenti economici», caratterizzata per un verso dalle diverse forme di centralizzazione economica anticipate, per l’altro verso da una mediazione tra conduzione centralizzata e rispetto delle libertà individuali: Weimar, e poi tutto ciò che si richiama al keynesismo. A proposito del laissez-faire, Eucken, e tutti gli ordoliberalisti dopo di lui, ne denunciano gli errori: monopoli e lotte monopolistiche (tra settori industriali, tra imprenditori all’interno dei settori, tra gruppi di imprenditori e sindacati) nel corso in particolare della seconda parte del Diciannovesimo secolo avrebbero impedito la piena realizzazione dello Stato di diritto. Semplificando, avremmo una situazione di «pubblicizzazione impropria di contratti tra privati» (p. 74). Lungi dal difendere una autonomia totale dell’ordinamento economico dunque, Eucken, conscio della debolezza di fondo del laissez-faire, sostiene che il diritto dello Stato debba costituire sempre e comunque il punto di riferimento fondamentale. Ciò non significa però l’intervento diretto dello Stato nella gestione dell’economia, quanto la «garanzia giuridica che le condizioni stabilite dalla legislazione statale al fine di assicurare un attento equilibrio di interessi non mutassero a seconda delle mutate circostanze economiche», se non per impellenti ragioni. Sarebbe proprio l’esistenza di corpi di interesse economico privato (cartelli industriali e unioni sindacali) ad aver impedito l’instaurarsi di quello Stato di diritto che avrebbe dovuto accompagnare il liberalismo economico. L’età del laissez-faire precedente ha dimostrato come l’ordinamento economico, lasciato a se stesso, non può combattere l’indebolirsi e quindi il venir meno della libera concorrenza, unico autentico fondamento dello Stato liberale. In altre parole, la libertà economica pura e semplice (il laissez-faire) non può realizzare il giusto ordinamento economico. Come osserverà acutamente, parecchi anni dopo (1973), il sodale Böhm, se l’economia di una nazione è retta non dal governo ma dal sistema dei prezzi di mercato (frutto di un saldo regime di concorrenza), non saremmo in presenza di una capitolazione della politica a favore della natura, quanto di una «eminente decisione politica».
In termini foucaultiani, chiosa Zanini, si potrebbe dire che è la libertà di mercato a essere posta quale principio fondatore dello Stato (p. 84). Donde l’originalità del momento fondante del pensiero euckeniano: non vi sono da un lato il libero mercato e dall’altro lo Stato interventista, perché il regime di concorrenza ha bisogno, per non essere travolto dal potere dei gruppi di potere economici, di una protezione giuridica forte (governamentalità attiva, dice Eucken). Insomma, è necessaria una sovrapponibilità totale tra meccanismi di mercato (regolati dalla concorrenza) e politica economica governativa. Confrontandosi con le varie forme di centralizzazione dell’economia, Eucken tralascia l’esempio sovietico: proprietà collettiva con un organo esecutivo in veste di pianificatore centralizzato, significa per lui sovrapposizione puntuale di totale assenza di libertà e di inefficienza economica. Diverso sarebbe il caso del regime nazista, in quanto – continuando a vigere la proprietà privata – sarebbe rimasto presente il salvifico sistema dei prezzi. Peraltro, il controllo del processo economico essendo nelle mani delle strutture pubbliche, fortemente influenzate da gruppi privati di potere economico; ne sarebbero inevitabilmente conseguiti lo stravolgimento dello Stato di diritto e la perdita delle libertà individuali, di pensiero e di formazione. Una progressiva atrofizzazione dello Stato di diritto Eucken vedrà anche, in termini non molto diversi, nelle misure prese dalla Gran Bretagna dopo l’ascesa dei laboristi nel 1945 per sostenere l’occupazione [2]. L’oggetto privilegiato della sua polemica è, apertamente, Keynes: l’espansione creditizia a sostegno della piena occupazione, sostenuta da questi, sosterrà Eucken nelle lezioni alla London School of Economics nel 1950, distruggeva «la funzione guida esercitata dai prezzi e agevolava il formarsi di monopoli» (p. 96) La disoccupazione di massa non era inevitabile risultato dello sviluppo del capitalismo, ma conseguenza dell’esistenza di forme di mercato intrinsecamente instabili; il laissez-faire del vecchio liberalismo così come la politica di piena occupazione sarebbero egualmente incapaci di raggiungere l’equilibrio del mercato. Eucken, puntualizza Zanini (p. 97), è decisamente oltre l’ortodossia neo-classica, il punto di vista ordoliberalista richiede un impianto giuridico funzionante che è altro dalle mitizzate «leggi del mercato» autoriproducentisi. Resta da vedere come lo studioso tedesco risponda alle due domande: cosa è la Wettbewerbsordnung, il sistema di regole di concorrenza (competitive order), espressione di una azione creatrice di diritto da parte dello Stato? E chi ne può essere il custode?
Egli individua una serie di principi costitutivi e, rispettivamente, regolativi. Tra i primi: sistema di prezzi efficiente (che assurge a vero e proprio principio fondamentale di ordine economico-giuridico-costituzionale), politica finanziaria stabilizzatrice (critica radicale della espansione creditizia con finalità di piena occupazione, anticamera della pianificazione economica e generatrice di effetti inflazionistici); mercato aperto (donde la necessità di combattere il divieto d’importazione e le tariffe troppo elevate, così come il monopolio del commercio estero e il divieto d’investimento). Interessante come la polemica euckeniana contro i mercati chiusi porti con sé una critica in anticipo sui tempi del sistema brevettuale, idoneo, in assenza di una attenta strumentazione giuridica, a favorire i monopoli impedendo il sorgere di gruppi concorrenti. Proprietà privata, libertà di contratto, principio della responsabilità civile sono gli altri principi costitutivi. L’ultimo e significativo è il principio della costanza della politica economica, che riapre la polemica contro la soluzione keynesiana alla diminuzione della spinta a investire (politica economica attiva supportata dallo Stato). Nell’insieme, a parere dell’Autore, siamo davanti all’enunciazione di una vera e propria costituzione economica, donde la centralità della contemporanea presenza di alcuni principi regolativi, capaci di salvaguardare l’ordine concorrenziale e con esso il sistema della stabilità dei prezzi. Tra questi la creazione di un ufficio di sorveglianza (dei monopoli) indipendente e vincolato alla sola legge; una politica dei redditi (anche attraverso una forma tenue, non punitiva, di politica di tassazione progressiva); un sistema dei prezzi di concorrenza come via verso un conto economico rigoroso. Ancora, un forte controllo del l’offerta anomala sul mercato del lavoro, dietro la quale Eucken vede la piaga del lavoro minorile.
Ma come può lo Stato, questo Stato della prima metà del Ventesimo secolo, aggredito e strumentalizzato dai diversi gruppi di potere, divenire custode di un sistema fondato sul permanere di un competitive order? Come, se l’economia è lotta, spesso molto dura, «nella quale ciascuno impiega le ideologie che gli sembrano utili» (scrive questo nel 1938)? Il movimento anticapitalistico (p. 129) del tempo di Marx aveva come obiettivo una «società socialista senza Stato» (veramente questo sarebbe il comunismo, ma si può soprassedere…); l’anticapitalismo contemporaneo invece «vuole andare oltre il capitalismo attraverso uno Stato totale autarchico» capace di racchiudere al suo interno l’intera economia. La trasformazione dello Stato liberale in Stato interventista/dirigista ha portato all’indebolimento dello Stato, condizionato dall’agire dei gruppi economici. Nei vari casi di economia centralmente amministrata le decisioni dei pianificatori vengono influenzate da corporazioni e grandi imprese. La riformulazione anche terminologica della politica di concorrenza e dei cartelli avvenuta nella Germania nazista tra il 1934 e l’estate ’36 allontana risolutamente lo Stato da una situazione «sia pur imperfettamente concorrenziale» (p. 132, sic!). Colpisce la… ondivaga lucidità della posizione euckeniana. Egli ha ben presente l’esistenza nell’economia del tempo di un potente insieme di misure private e pubbliche volte a indebolire o annullare la tendenza alla libertà di concorrenza. Ciò perché «il potere privato prospera all’ombra del potere dello Stato» (p. 133). La presenza di diverse aggregazioni di interessi nella moderna società appare ai suoi occhi come l’emergere di una situazione neofeudale. E quindi? L’unica soluzione sta nel coordinamento intelligente tra politica economica e politica del diritto. Quello che Eucken vuole è uno Stato forte (starker Staat) capace nel contempo di garantire libertà di mercato e di imporsi anche duramente sugli interessi dei diversi gruppi. Uno Stato forte, ma capace di autolimitarsi: questo è lo Stato di diritto, custode dell’ordinamento concorrenziale.
Eucken richiama anche la necessità di misure specifiche, quali il rilancio dell’azionariato diffuso e il tetto massimo alle concentrazioni di capitale, ma il principio guida che deve animare lo Stato è quello dello smantellamento dei gruppi economici di potere. Il secondo principio è che l’attività economica dello Stato risulti diretta alla «creazione delle forme ordinamentali dell’economia» (p. 145), non alla direzione del processo economico. Lo avevamo già approssimato: non attività economica centralmente amministrata, ma imposizione da parte dello Stato delle regole giuridiche (e loro imposizione sui soggetti sociali). Dietro tale pensiero si nasconde una idea di ordo, nel senso di connessione del molteplice in un tutto, che per certi versi ricondurrebbe secondo l’Autore a Sant’Agostino, per altri versi è debitrice del pensiero paterno (il padre di Eucken fu un qualificato esponente dell’idealismo tedesco). Così egli parla di ricerca dell’ordinamento che, «a differenza degli ordinamenti dati, corrisponde alla ragione e alla natura degli uomini e delle cose» (p. 149).
In conclusione del primo capitolo, Zanini pone in luce la circolarità del ragionamento euckeniano, azionata da un riferimento non alla concorrenza perfetta (Walras) ma alla cosiddetta concorrenza piena, categoria vaga e indefinibile, con la conseguenza che, inevitabilmente, alla fine l’ordine economico è garantito dall’ordine politico. Secondo Zanini – non particolarmente toccato dal giudizio di Foucault, per il quale «l’analisi ordoliberale non è più inscrivibile nella linea della teoria economica della concorrenza e della storia dell’economia […] ma piuttosto all’interno di una linea di teoria del diritto» (p. 154) – la circolarità di cui il ragionamento dà prova nasce da una visione che non riesce a liberarsi dei 1presupposti teorici neoclassici che tale staticità imponevano» (p. 155). L’Autore fa un interessante passo oltre, interrogandosi sulle ipotetiche condizioni di funzionamento pratico del discorso di Eucken, trovandole nella cosiddetta crescita lenta. In ultima analisi, sia i principi costitutivi che quelli regolativi proposti da Eucken fanno riferimento a uno stato stazionario, o quantomeno a una evoluzione rallentata, che conosce crescita ma non la «creazione distruttrice» propria dello sviluppo. Solo una crescita lenta può portare al modello sociale popolato di piccoli produttori, e soprattutto determinarne il rimanere nel gioco. Crescita lenta come sorta di ri-territorializzazione di un nuovo capitalismo, allora? Vi si tornerà.
La visione guerresca del comportamento monopolistico
L’altro capitolo di cui è costituita la parte prima del libro è dedicata al giurista Franz Böhm, e cerca di delineare i tratti giuridici del sistema economico ordoliberalista, e la loro centralità. I pilastri portanti del suo pensiero convergono con quelli di Eucken; anche se l’evoluzione negli anni della vecchiaia richiederà forse maggiore attenzione. Ciò che separa in partenza i due, è che Böhm ha una esperienza giovanile presso il Ministero dell’economia di Weimar, e quindi la sua analisi dei monopoli e del loro ruolo presenta maggiore solidità. Il nodo decisivo per Böhm è impedire che il comportamento dei concorrenti sul mercato sia tale da influenzare il sistema dei prezzi. Quello che egli teme è che interessi di gruppi privati possano assurgere a dominare lo Stato, indebolendolo. Centrale nella sua riflessione è insomma il problema del contenimento del potere privato, in particolare tramite la politica di concorrenza. La mancanza di concorrenza «è sinonimo di potere e il potere nelle mani di un soggetto di diritto privato equivale alla dipendenza di altri soggetti di diritto privato da quel potere» (p. 176). Tipica di questo studioso è una visione guerresca, per così dire, del comportamento monopolistico, considerato «un attacco rivoluzionario organizzato al principio ordinativo centrale della stessa libera economia di scambio» (p. 189). Böhm afferma il carattere pubblicistico dell’istituto della concorrenza, pur se la tutela giuridica delle parti rispetto alla concorrenza illecita è lasciata al diritto privato: la concorrenza «rappresenta un processo che il diritto non solo istituisce ma anche regola» (p. 197). E ancora: «compito dell’ordinamento giuridico è quello di salvaguardare la lotta, non l’armonia». In altre parole, «impedire che il regolato gioco di forze sconfini in un conflitto di potere privo di confini». Ciò perché «una evoluzione giuridica che affidi al moderno imprenditore privato un addizionale potere di mercato e di monopolio non può trasformare il sistema economico in un sistema auto-amministrantesi di stampo politico liberale» (p. 213). Al contrario incrementerà una versione individuale ed egoistica della libertà, a scapito del vantaggio della collettività.
La soluzione giuridica indicata da Böhm, e che traduce in norma l’imperativo astratto euckeniano, è che l’instaurazione di una vera libertà economica fondata su un ordinamento competitivo, nel senso fin qua ricordato, deve essere oggetto di una deliberazione politico-costituzionale (avere quindi natura pubblicistica) intesa a dotare la vita economica di una costituzione di lotta non soggetta a dominio (p. 233). In altre parole, lo Stato deve essere il duro, spietato se occorre, garante che la vita economica del Paese avvenga all’insegna di una guerra di tutti contro tutti nei limiti concessi dall’ordinamento. Una visione certo priva delle «fumisterie» di derivazione idealista proprie del fondatore, ma decisamente cupa, del mondo (non solo quello esistente, qui cupo è soprattutto il mondo auspicato dallo studioso), pur nobilitata da uscite fulminanti, come quella per cui il monopolista si sente un autocrate nei confronti del mercato, nel mentre pretende di essere semplice cittadino privato di fronte allo Stato (pp. 246-247).
Il Böhm del dopoguerra si presenta come agguerrito combattente ordoliberalista, condottiero sul fronte giuridico con la durezza che gli è propria. Egli mette a confronto il programma economico dei partiti borghesi e del socialista, non ha difficoltà ad accettare la fine dell’antinomia laissez-faire/sovietismo, ma solo per stabilire che il mix tra democrazia politica e socialismo economico – nel suo linguaggio è socialismo qualsiasi misura dello Stato in economia diversa dalle regole di ferreo controllo antimonopolistico – non è realizzabile, poiché non può esistere mix tra economia centralmente amministrata ed economia di scambio, la prima portando di necessità alla fine delle libertà. Una economia centralmente amministrata consta di due atti: lo stabilirsi (il piano, per capirci), atto eminentemente governativo, e la sua realizzazione. Il secondo livello, il piano, necessariamente assorbe l’intera vita lavorativa di tutti i cittadini: questi non potranno dunque scegliere liberamente (e cambiare) il posto di lavoro. Se vi è un piano economico, anche la forma più leggera di piano, ogni cittadino sarà sottoposto «al giogo» del potere centrale dalla fanciullezza alla tarda età. In una economia di scambio, dominando la legge del mercato, avremo invece niente di meno che una democrazia plebiscitaria esercitata quotidianamente tramite i prezzi concorrenziali; Böhm oppone coscientemente lo Stato liberale in quanto unica forma possibile di Stato di diritto allo Stato sociale. La polemica contro le misure volte ad assicurare la piena occupazione riecheggiano quelle già viste. Piuttosto, nel dopoguerra, Böhm ingaggia una dura battaglia contro il programma di cogestione dei socialdemocratici. Tale programma in certa misura deriva da un progetto del tempo di Weimar, meno criticabile nella logica ordoliberalista in quanto riferito a una cogestione di tipo politico, non economico. Il tema si colloca anche quale punto di apertura dello scontro con la nuova generazione di ordoliberalisti, come l’Autore anticipa. La posizione di Böhm non è comunque identificabile con quella delle ali più conservatrici dei cristiano-democratici nella Germania ovest del dopoguerra; ciò che egli teme di più è proprio l’alleanza tra produttori (imprenditori e maestranze) a scapito dei consumatori. Dalla istituzionalizzazione del conflitto di classe tra soggetti della produzione sorgerebbe (sarebbe sorto?) un dualismo di potere ai danni della grande maggioranza dei cittadini. Il ragionamento non è banale, fondandosi sulla modificata costituzione dell’impresa introdotta dalla cogestione. Mentre la maggior parte delle funzioni imprenditoriali sarebbe rimasta nelle mani di chi aveva gestito l’impresa in quanto imprenditore, con le rispettive prerogative (in particolare rappresentanza con l’esterno e responsabilità giuridica), all’interno dell’impresa il potere sarebbe stato condiviso con i rappresentanti dei lavoratori, il nuovo organismo di gestione essendo caratterizzato non dall’autonomia propria del diritto privato, ma «dalla norma inerente al lato pubblicistico» della works constitution law (p. 287). Da questo dualismo di potere sarebbe sorta una falsa democrazia, la socializzazione, che Böhm definisce «espressione delfico-oracolare», quale negazione dell’autonomia del privato e della sua libera decisione.
A conclusione di questa prima parte, Zanini richiama il passaggio in cui Foucault individua nell’atteggiamento verso il monopolio la differenza strutturale tra vetero-liberali e neoliberali. I primi non si liberavano dal paradosso per cui il monopolio sarebbe un fenomeno degenerativo della concorrenza: si sarebbe allora dovuto intervenire sui meccanismi economici per salvare la concorrenza dai propri effetti. Per i neoliberali invece i monopoli sono fenomeni «d’intervento di tipo arcaico, di processi di rifeudalizzazione legati all’esistenza di strutture giuridiche residuali che tali processi avrebbero permesso o facilitato» (p. 307). Zanini sembra trovare il limite del ragionamento foucaultiano proprio nel non aver fatto riferimento specifico alla lucida battaglia di Böhm, volta a privilegiare la lotta contro l’opacità che domina gli ordinamenti misti (tra concorrenza pura e monopolio assoluto), cioè la quasi totalità degli ordinamenti economici esistenti. Ciò che distinguerebbe Böhm sarebbe la necessità di farla finita con l’opacità, rompendo una tolleranza strisciante tramite una espressa volontà di decisione in termini politici (politico-costituzionali). Lo stesso Zanini concorda peraltro sul fatto che proprio Foucault ha in ultima analisi dimostrato in cosa consista la distinzione dell’ordoliberalismo con i vetero-liberisti da un lato, con l’anarco-liberismo americano dall’altro. E questo sta, indubitabilmente, nella centralità per i primi dell’intervento politico. Orbene, per Böhm, come abbiamo visto, il sistema dei prezzi avrebbe dovuto costituire un «istituto economico politico di carattere pubblicistico».
Una osservazione (provvisoriamente) conclusiva su questo studioso. La sua è, come accennato, una costruzione epico-eroica, quanto fosca del mondo che vorrebbe costruire: la guerra eterna di tutti contro tutti nel quadro di una politica di concorrenza rispettata – con le buone o con le cattive – da ciascuno. Non vi è spazio per comunità di valori, per non parlare delle comunità patrimoniali dei nostri giorni: la parola comunità è riferita solo alla società civile nel suo complesso, in relazione allo Stato. Una è la comunità, uno lo Stato, uno il diritto, uno il regolamento del meccanismo di competizione. Prima facie, questa visione riscatterebbe in parte l’ambiguo sentire di Böhm (e dello stesso Eucken) verso i nazisti. Questi ultimi fin dall’inizio intendevano dividere il contesto sociale in una serie di comunità rigidamente distinte (su base etnica, sessuale, politica…) la quasi totalità delle quali – diciamo così – non recuperabili all’interno dello Stato: ci ritorneremo.
Il paesaggio intellettuale-politico di riferimento della seconda parte del volume (corrispondente al terzo capitolo) si modifica profondamente, spostandosi alla Germania del dopoguerra. È qui che il sistema economico ideato dai maestri dell’ordoliberalismo viene messo alla prova, conoscendo insieme una significativa espansione ma anche una correzione di rotta. A differenza di quanto ha fatto con Eucken e Böhm, Zanini nel paragrafo iniziale discute con le diverse scuole di pensiero che si sono misurate con l’ordoliberalismo, orientandosi nel senso che non è mai stato in discussione il sostanziale continuismo teorico-politico all’interno di tale filone; quanto piuttosto la dimensione delle modifiche che ne accompagnano il ridefinirsi quale «economia sociale di mercato», destinata a grande fortuna nel circolo magico costruito dal ministro dell’economia (e futuro cancelliere) Erhard, il comitato scientifico consultivo. Né vi può essere dubbio sulla profondità delle modifiche che intervengono, ove si rifletta sul fatto che il caposcuola, Eucken, oltre a non utilizzare mai l’espressione «economia sociale di mercato», ne abbia anche preso le distanze, affermando che tale concetto per lui «rappresentava un andare alla deriva» (p. 322 in nota, dal testo di una lettera di Eicken a Von Beckerath del 3 febbraio 1950, riportata da Oswalt).
Venendo ai due primi esponenti considerati, Röpke e Rüstow, Zanini constata una forte accentuazione sociologica dell’utilizzo del termine «sociale» da parte di entrambi, particolarmente evidente rispetto alla connotazione giuridica che l’espressione ha in Eucken e (soprattutto) in Böhm. Il loro intento è quello «di de-proletarizzare la società tramite una politica di ri-ruralizzazione della popolazione, di de-radicazione nel senso proprio del termine» (p. 325), e in generale di definizione di una nuova cornice politico-morale istituzionale. Röpke in particolare inserisce la propria assoluta convinzione nella libertà di mercato sorretta dall’interventismo dello Stato in un quadro pessimistico sugli effetti dell’esasperata divisione del lavoro e della massificazione tecnologico-organizzativa della grande fabbrica. Critica radicale del collettivismo e allo stesso tempo del laissez faire, propri degli ordoliberalisti in genere, si mischiano in lui ai timori per la decadenza della famiglia e, soprattutto per la crisi dei valori cristiani più autentici. La soluzione possibile sta nella ricerca di un autentico liberalismo costruttivo. Le conseguenze che egli ne trae sono pesanti: a parte la durezza con cui attacca esponenti dell’intelligentia (Thomas Mann) e teologi (Teilhard de Chardin) per il loro sottrarsi alla generale chiamata alla lotta contro il comunismo, Röpke cavalca il volto più truce della tradizione reazionaria europea, esprimendosi con fortissimo accento razzista, dimostrando anzi aperta simpatia per il regime dell’apartheid sudafricano (Zanini cita Slobodian, «a racialized worldview was at the heart of Röpke’s postwar philosophy of society and economy», p. 331). Né va dimenticato come nel suo progetto di ri-ruralizzazione giochi un ruolo importante l’elasticità dei salari (verso il basso, si intende). Non è il caso di soffermarsi oltre su un personaggio tanto inquietante, autodefinitosi conservatore liberale, ma che attacca frontalmente il principio della sovranità popolare veicolato dal giacobinismo, che avrebbe origine in una idea (agli occhi di questo studioso mostruosa) di democrazia fondata sul principio dell’eguaglianza invece che della libertà. È peraltro quanto consente di leggere in Röpke una effettiva differenza di tono rispetto ad altri ordoliberalisti. Se la critica all’economia di mercato idealizzata dai vecchi liberali è tratto comune della scuola di pensiero in analisi, tale critica assume profili radicali in Röpke. In particolare la concorrenza, pur in sé elemento «d’odine e di moderazione nel ristretto ambito di una economia di mercato» (p. 341), può tuttavia, in determinati contesti, risultare più un elemento destabilizzante più che di unificazione. Per controbilanciare la mancanza di potere di integrazione della concorrenza propone un interventismo liberale di ampio respiro (anche sul piano delle misure materiali: parla di imporre un principio obbligatorio di assicurazione privata).
L’Autore ci propone di vedere nelle posizioni di questo studioso una derivazione dalla Redemptio proletariorm di papa Pio XI, che ne costituirebbe la direttrice spirituale. Lo scrivente confessa qualche dubbio. Non che le pagine della Redemptio siano proprio inni di libertà, anzi, ma stiamo comunque misurandoci con chi, nella Germania del dopoguerra, attacca con accenti scandalizzati il suffragio universale, in particolare se legato al voto proporzionale; sostenendo che la collettività deve essere organizzata secondo una «scala gerarchica naturale» (p. 344, sic!). E ancora (sulle rovine fumanti lasciate della distopia nazista) attacca Keynes con toni isterici, definendolo uno dei massimi «geisteger Ruinerer» (diciamo cattivi, cattivissimi maestri) della storia del genere umano (p. 347). Insomma…
La riflessione di Rüstov scorre parallela, distinguendosi solo per specifici profili. Rüstow condivide con Röpke non solo le idee base degli ordoliberalisti in genere, ma il particolare approccio sociologico, nel senso di necessità della costruzione di un discorso etico-politico che sostenga la libertà di mercato, non bastando a ciò, certo, le regole di concorrenza. Egli parla di Vitalpolitik, «intendendo con ciò la demolizione di qualsiasi istanza centralizzatrice», per porre al centro la famiglia/impresa, quindi i valori di solidarietà e gerarchia, e più in generale le istanze del ceto medio. Mirando a costruire una «griglia antropologica politica», Rüstow attacca a fondo i vetero-liberali, veri responsabili di ogni catastrofe successiva (della Germania, dell’Europa). Costoro «non hanno colto la necessità sociologica di inquadrare il mercato attraverso un diverso modo di integrazione, controbilanciando così la mancanza di potere d’integrazione della concorrenza. A volte, sono persino giunti a proclamare la concorrenza quale principio universale, anche per ambiti di vita al di fuori dell’economia» (p. 357). Alla loro «sub-teologica superstizione incondizionata era riconducibile l’avanzata del collettivismo antiliberale e radicale”. Vi è in lui una attenzione per le misure che il potere pubblico deve prendere in favore del ceto medio (e più in generale della famiglia e dell’autoimprenditorialità) che ne fa forse il più deciso interventista nell’ambito dell’ordoliberalismo, prima di Müller-Armack. L’Autore sottolinea peraltro come prevalga in questo studioso il legame con il liberalismo politico-culturale propugnato da Röpke; in comune i due avrebbero anche la nostalgia di un mondo rurale antico che non è mai esistito, e che ha fatto spendere a qualcuno il paragone, in realtà fuori luogo, con Ruskin.
Le radici teoriche dell’economia sociale di mercato
L’ultima parte del lavoro di Zanini, che assume rilievo decisamente attuale, porta in primo piano la figura del più giovane tra gli ordoliberalisti, Alfred Müller-Armack. Si tratta di un personaggio di notevole impatto politico nella Germania del dopoguerra, il cui lascito ha respiro europeo; personaggio che rimane tuttavia il più enigmatico, anche in virtù del rapporto giovanile, più evidente che negli altri, con l’ideologia nazista. L’Autore sceglie di dedicare corpose pagine iniziale a delineare lo sviluppo dell’antropologia filosofica müller-armackiana a partire dagli anni Trenta. Esula da questa riflessione, e più in generale dagli orizzonti teorici dello scrivente, la Spannung (tensione) tra immanentismo e trascendentalismo; peggio, detta antropologia filosofica sviluppa un discorso sul rapporto tra uomo e ambiente, nella relazione in particolare con gli altri animali, affatto irricevibile, fondata come è su una piatta contrapposizione tra unicità umana e resto del vivente (considerato quale unità indifferenziata). Non c’è neppure bisogno di richiamare, polemicamente, l’amato compost harawayano. Alla larga, semplicemente.
Piuttosto, risulta dalle considerazioni svolte dall’Autore, come già negli anni Trenta Müller-Armack operi una lettura del capitalismo come fattore essenzialmente dinamico, ma allo stesso tempo remoto da ogni determinismo storicistico. In altre parole, Müller-Armack condivide nella loro interezza i tratti salienti della costruzione euckeniana, ma presenta fin dall’entrata in scena una sua specificità di accento. La sua diventa, con il dopoguerra, la ricerca di una soluzione costruttiva alle contraddizioni che attraversano la compagine ordoliberalista, una soluzione che vada, per così dire, in direzione della riduzione degli attriti sociali. Al cuore della erigenda costruzione, Müller-Armack individua l’«economia sociale di mercato», perché inclusiva del principio di libertà e allo stesso tempo al servizio della sicurezza sociale. Dunque, scrive nel ’45, se l’individualismo impolitico e il collettivismo impolitico sono entrambi figli della secolarizzazione: il loro superamento richiede ne venga negato il presupposto comune, rappresentato da «relativismo di valori e edificazione di idoli» (p. 408); la sua ricerca di un realismo adeguato, lo conduce all’individuazione di alcuni possibili capisaldi del discorso politico che legittimamente si possono definire irenistici. Si tratta di operare per una riconciliazione che prenda come un dato di fatto la divergenza, ma non sacrifichi a essa il possibile sforzo «per un’unità comune» (p. 411). Lo sforzo irenistico richiede di avvalersi, nella situazione tedesca del dopoguerra, del meglio offerto da tradizioni diverse: la volontà morale del socialismo, l’idea cattolica di ordo, la fraterna disponibilità all’aiuto del protestantesimo, tutte, possono rivelarsi utili «nel concorrere a forgiare un nuovo liberalismo». Di qua nasce il programma teorico dell’economia sociale di mercato, che, come principale consigliere di Erhard, Müller-Armack contribuirà a trasformare in progetto politico. Nel fare ciò, ne fosse o meno cosciente all’inizio, viene portato a misurarsi con il tema dell’ordine sociale europeo, la questione degli anni Cinquanta.
E già nello scorcio finale dei Quaranta comunque Müller-Armack, nel dar prova di doti sincretiche non indifferenti, dimostra anche di saper mantenere saldi i principi euckeniani: libertà di concorrenza (e lotta ai monopoli) e centralità del sistema dei prezzi di mercato. Seguiamo la sua diagnosi del ’47: il processo di troppo lenta dissoluzione della precedente economia di comando (modo alquanto tortuoso di significare: «nazismo») impedisce il pieno dispiegarsi dell’economia di mercato. Nella crisi economica tedesca del dopoguerra sarebbero puntualmente all’opera i residui di quel dirigismo economico che si mescolano peraltro con quelli del precedente liberismo corrotto (Weimar), il tutto sotto il peso della crisi monetaria in atto. La soluzione non può che essere una economia libera e socialmente orientata – sintesi di mercato e ineludibili domande sociali – cui doveva peraltro unirsi un forte impegno spirituale. La realizzazione dell’economia sociale di mercato in Germania richiede dunque il contemporaneo realizzarsi di «formazione di prezzi naturali fondati su solide condizioni concorrenziali, libertà di sviluppo dei poteri creativi degli agenti economici (imprenditori e lavoratori), salvaguardia della giustizia sociale». Un tale modello può davvero vincere la battaglia rispetto al contrapposto modello della pianificazione-centralizzazione, ma solo «in presenza di una cornice spirituale, politica e giuridica, ben definita e salda» (p. 417). Osserva Zanini (p. 319): «nei termini teorici compendiati da Müller-Armack l’economia di mercato rappresentava un ordinamento ovviamente privo di una prefissata regolamentazione dei processi economici, ma non di un ben stabilito ordine razionale». La critica al liberismo tradizionale non è più limitata alla passività di questo a fronte della necessità di «perequazione reddituale», ma anche dal suo essere confinata alla ristrettezza della visione economica. Müller-Armack intende liquidare così l’alternativa, ormai in via di esaurimento, tra vecchio liberalismo e dirigismo economico. L’economia di mercato è destinata a essere la struttura portante dell’ordinamento economico futuro; dovrà però trattarsi di una economia di mercato «consapevole e socialmente guidata» (p, 422).
Come accennato, il discorso sull’economia sociale di mercato è destinato dal 1948, opportunamente rielaborato, a trasformarsi in programma politico sotto la guida di Erhard. Müller-Armack ne diventerà uno dei più stretti collaboratori. È il caso di seguirlo – nella presentazione che ne fa Zanini – con attenzione.
Centrale da subito nel progetto è, per lo studioso fattosi consigliere politico/economico, l’elaborazione di una autentica politica di concorrenza. Il punto decisivo è costituito dalle misure legislative: il debito verso Böhm si fa qui, par di capire, più netto. Andando oltre la vulgata neoliberista, Müller-Armack richiama la necessità di combattere il costante riproporsi di forme oligo-monopolistiche, risultando a tal fine indifferibile la «revisione della teoria dei costi espressa dalla teoria economica ortodossa» (p. 427). Rimane ben viva in lui, sia chiaro, la diffidenza di tutti gli ordoliberalisti verso gli interventi di politica sociale che si prefiggano di intervenire direttamente sul sistema dei prezzi. Piuttosto, pensa a «una compensazione diretta tra redditi alti e bassi tramite la diretta diversione del reddito» (p. 430). Insomma, una forma di tassazione che consenta di trarre i mezzi per sussidi per l’infanzia e politiche abitative senza mettere a repentaglio i criteri del calcolo economico. Per quanto riguarda le politiche abitative egli, andando ben oltre tutti gli altri ordoliberalisti, sostiene la necessità di legare tra loro un piano generale (che comprenda criteri estetico-funzionali, igienici, economici, sociali) e iniziativa individuale. Non si poteva lasciare solo a quest’ultima la definizione di un paesaggio urbano della ricostruzione che avrebbe guidato per decenni la vita delle persone! Per quanto riguarda l’altro tema centrale, la struttura dell’impresa, terminato lo stantio dibattito sulla grande impresa pubblica o privata (con il senno del poi, l’affermazione risulta alquanto audace…), il tema decisivo diventa quello della tutela pubblica della piccola e media impresa «accompagnato da una sempre minore disponibilità ad affidarsi alla discutibile superiorità economica della grande impresa» (p. 432). Affrontando il problema della politica creditizia e monetaria, afferma poi la liceità del ricorso, quando necessario, a strumenti congiunturali che non vadano contro il quadro dell’economia sociale di mercato. Rompe, insomma, almeno tendenzialmente, il tabù comune al neoliberalismo di ogni forma e latitudine. L’economia di mercato non sarebbe una forma già stabilita una volta per tutte dalla tradizione liberale, «bensì un principio organizzativo aperto a una vasta gamma di cambiamenti» (p. 434).
Con l’uscita nel gennaio ’48 del primo numero della rivista «Ordo», la messa a punto teorica del programma è completata. Il problema che lo ossessiona è quello del come sfuggire al rischio di una politica sociale solo apparente, che ruoti attorno al doppio monopolio costituito dalle organizzazioni di massa imprenditoriale e sindacali e dell’enorme potere manipolatorio di cui queste dispongono.
L’Autore (che sottolinea la centralità del rapporto di Müller-Armack con Rüstow e la sua Vitalpolitik, oltre che con Böhm) sofferma la propria attenzione su un discorso pronunciato da Müller-Armack a Colonia alla fine del decennio della ricostruzione (1959). Qui egli, nel mentre confermava l’appartenenza del proprio pensiero (e della prassi da questo ispirata) alla tradizione ordoliberalista, rivendicava nel contempo alcuni momenti di distinzione. «Mentre la teoria neoliberale si impernia soprattutto sulla tecnica della politica di concorrenza, il principio dell’economia sociale di mercato è una esauriente idea di stile, che trova applicazione non solo nell’ambito della concorrenza, ma anche nello spazio complessivo della vita sociale, nella politica economica e del pari nello Stato» (p. 439). Egli insomma rivendica il fatto che la politica sociale di mercato si sia appropriata di un contenuto sociale di per sé estraneo all’orizzonte della originaria riflessione euckeniana, e in ciò vede la causa principale della vittoria della ricostruzione tedesca. Egli detta anche le necessità per il nuovo decennio: investire in capitale intellettuale, garantire la stabilità monetaria, legittimità dell’intervento congiunturale, tematica ambientale (vivere comune, questione edilizia in primis). Il Müller-Armack del 1959 arriva a parlare di cogestione di fatto, ben oltre quindi l’avventuroso compromesso proposto nel dopoguerra. Rivendica in altre parole l’economia sociale di mercato come «idea strategica all’interno del conflitto tra diverse finalità», ovvero «formula d’integrazione per garantire una adeguata cooperazione e superare le situazioni di attrito» riconoscendone nel contempo la legittimità (pp. 443-444). Certo, l’argomentazione non sfugge alla dura critica – e Zanini vi dà il giusto rilievo – di chi (Ulrich, 2009) osserva come nella riflessione di questo studioso sarebbe assente fin dall’inizio un’idea della problematicità del rapporto tra economia di mercato e società democratica, un rapporto qui confinato a una mera politica sociale redistributiva, a conferma di una ambiguità che richiama gli altri ordoliberalisti (e altri prima di loro peraltro se lo scrivente ricorda ancora qualcosa della buona, vecchia, cara Critica del programma di Gotha…). In ogni caso ne risultano piste o comunque suggestioni di ricerca critica ulteriori, e promettenti, su cui non ci si può ora soffermare.
La politica economica è prima di tutto politica
Va sottolineata la forza del discorso, la consapevolezza orgogliosa (e sprezzante) del maitre à penser del programma erhardiano che lo porterà a definire negli anni Sessanta l’economia sociale di mercato come il miglior ordinamento economico non solo sul piano della riuscita pratica (a suo dire ciò sarebbe inconfutabile) ma anche, e «altrettanto inconfutabilmente» (?), sul piano scientifico, in polemica aperta con il concetto di tardo-capitalismo della nuova sinistra.
Müller-Armack è più polemico che mai anche quando, con il finire degli anni Sessanta e poi con il nuovo decennio, appaiono i limiti del «suo» modello, ed emergono posizioni critiche radicali. Con i giovani dell’ultrasinistra (che chiama beffardamente Ȕberwinder, nel senso di coloro che vanno oltre) è sprezzante, anche se ne riconosce l’opposizione al comunismo totalitario. Resta che l’unica alternativa (all’economia sociale di mercato) essendo l’economia centralizzata, inevitabilmente essi cadrebbero nel dirigismo economico, socialista o comunista. Quanto al secondo nemico, i Dirigisten, il suo attacco è spietato. Dal punto di vista di chi scrive, colpisce, nella ripetizione di vari argomenti comuni a tutti gli ordoliberalisti, quello molto soggettivo secondo cui costoro non sanno riflettere sui disastri di cento anni di storia tedesca; i disastri della storia tedesca del Novecento come frutto dell’irresponsabilità dei socialdemocratici, insomma…
Ma siamo nei primi anni Settanta, si profila ormai il terzo nemico, rappresentato dai cosiddetti Futuristen. Costoro utilizzerebbero il crescere di importanza delle tematiche ambientali, e delle angosce che il tema ispira nell’opinione pubblica, per riproporre, dietro le quinte, il dirigismo economico. La differenza con i Dirigisten starebbe nel fatto che alla superficiale irresponsabilità dei socialdemocratici (il socialismo è prima di tutto inettitudine, per gli ordoliberalisti), si sostituirebbe qui una visione macabra del futuro. Insomma, quasi fosse un politico italiano, Müller-Armack sembra trattare da… iettatori quanti anticipano il disastro ambientale incombente. La durezza dei suoi toni è invero inusuale, non rispettando egli né il club di Roma, né il vertice della Commissione Ce (rappresentato all’inizio di quel decennio dall’olandese Sicco Mansholt, personaggio certo di non grande rilievo nella storia dell’apparato burocratico Ce, ma su cui gli odierni ambientalisti, talora alla ricerca di padri improbabili e fasulli, farebbero bene invece a puntare l’attenzione).
In termini generali, se Müller-Armack ben comprende come, anche a seguito dello sviluppo del dopoguerra, nuove forze sociali e intellettuali si vengano manifestando, e ragiona sul come riportarle entro il quadro dell’economia sociale di mercato, di fronte alle tematiche ambientali si presenta invece con atteggiamento di chiusura rigida, forse perché indifeso è il suo pensiero su tale versante. L’uomo che aveva saputo liberare l’ordoliberalismo dalle più grette strettoie economicistiche, teorizzando la necessità di inquadrare il discorso economico nell’ambiente umano in senso ampio, non sa esprimere altro che fastidio di fronte alle prime uscite di nuove sensibilità ecologiche.
Il richiamo a Mansholt introduce il ruolo giocato da Müller-Armack come sottosegretario di Stato agli affari europei della Germania ovest tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Il punto è che siamo in presenza di un padre, sia pure poco noto, della costruzione europea. Non si può dubitarne: l’obiettivo a lungo termine di Müller-Armack è quello dell’unione politica dell’Europa sulla base dell’economia sociale di mercato o, comunque, della mediazione economico-politica a questa più vicina. Certo, egli riprende nel suo tragitto alcune posizioni sulla superiorità non solo del cristianesimo sulle altre religioni, quanto proprio del cristianesimo occidentale sugli altri cristianesimi, che vanno in scia con il sociologismo rustow-ropkiano; è quanto però lo guida non solo nella convinzione dell’esistenza di una grande comunità destinale dei popoli europei (occidentali), ma anche – e ciò nello stallo presente è rilevante – nella certezza del nesso inestricabile tra costruzione economica e costruzione politica europea, escludendo da quest’ultima le mega costruzioni super-statalistiche care a certo dirigismo europeista, ma anche sottolineando la decisività del superare le pulsioni sovraniste. Il suo continuo ribadire che il problema europeo non può essere meramente rappresentato a livello economico, e che la questione europea è primariamente politica, meritano apprezzamento ancora (o forse soprattutto) oggi. Müller-Armack muove con risolutezza, a partire dagli anni Cinquanta, verso l’idea una progressiva unione doganale, ma considerando il Trattato di Roma del ’56 come un punto di passaggio. Soprattutto è per lui fondamentale la fissazione di una politica congiunturale europea, per far fronte alle fluttuazioni del ciclo economico. Per questo, a parte e oltre la politica commerciale comune, egli punta sulla centralità del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, e quindi sul loro rafforzamento. «Rispetto alle minacce insite negli squilibri della crescita tra i diversi paesi, sarebbe stato fondamentale anticipare soluzioni efficaci e comuni. Qualora non si fosse seguita tale strada, un indesiderabile quanto inevitabile contraccolpo si sarebbe prima o poi imposto. I differenti tassi d’inflazione dei singoli paesi avrebbero finito con l’esigere una correzione dei tassi di cambio, in contrato con la logica del mercato comune, di per sé necessitante di parità fisse” (pp. 460-461). Sono parole dense di futuro, come a ciascuno è evidente. Aveva insomma la consapevolezza che la politica economica era prima di tutto politica, e che quindi la pur indispensabile costruzione economica rappresentava per l’Europa un passaggio di politicità indiretta, dice Zanini, osservando poi come Müller-Armack ragionasse, certo, in termini prima economici e poi politici. Tutto ciò, peraltro, in modo tale che «un’autonomia tra essi fosse impensabile», dal momento che «le maggiori ed essenziali domande politiche ed economiche entrano in gioco contemporaneamente» (pp. 464-465).
La crisi degli anni Sessanta, concretizzatasi nella politica della sedia vuota francese, e il rapporto bloccato con i Paesi dell’Efta, lo portarono alle dimissioni da sottosegretario di Stato; rientrate queste una prima volta, con il cambio di governo verso la fine degli anni Sessanta egli lasciò definitivamente la carica, anche se rimase impegnato a fondo nella Bei. Le sue critiche e le sue posizioni dei primi anni Settanta anticipano in parte quello che sarà il nuovo passo dell’Europa alla fine delle due crisi energetiche degli anni Settanta.
Non meno dell’uomo in generale, anche il politico è difficile da valutare: abilità tattica e capacità anticipatorie sono in lui evidenti; d’altro canto, Müller-Armack è vissuto e morto nella piena e assoluta certezza (comune agli altro ordoliberalisti), che in ultima analisi fossero i Dirigisten socialdemocratici con le loro politiche di piena occupazione e conseguente crisi inflazionistica il pericolo unico per l’economia sociale di mercato, in Germania e in prospettiva in Europa. Chissà le facce, se qualcuno avesse anticipato loro che sarebbe stato l’anarco-liberismo americano a irrompere nel continente per ri-avviare – con altre concause, ovviamente, ma sempre collegate – l’Europa verso la catastrofe. E agli anarco-liberalisti di oggi, vi è da scommetterlo, Böhm quanto meno apparirebbe un pericoloso bolscevico déguisé…!
Il soffio ordoliberale nel presente
Nelle Conclusioni, di cui si raccomanda la lettura, Zanini non perde tempo nel tornare a riassumere quanto ha scritto; piuttosto, fornisce direttamente un esempio di come si possa utilizzare il volume ai fini del dibattito politico attuale: in altre parole per analizzare la situazione generale ed europea in cui siamo calati. È suo diritto, anzi faremo bene a seguire il suo esempio. Lo scrivente, per quanto lo riguarda, quando avrà agio di riflettere su presente e futuro del continente in modo organico, lo farà utilizzando – anche se in parte criticamente – le opinioni espresse dall’Autore nelle Conclusioni.
Per intanto egli fissa alcuni appunti: tra questi, la necessità di trovare il modo di leggere Böhm, in italiano se possibile, altrimenti in inglese. Lo scrivente dovrà inoltre tornare, dal punto di vista della storia e del (-la storia del) diritto della allora Cee, su quell’inizio degli anni Settanta che vede nel contempo la fine della sedia vuota francese, ma anche il caso Mansholt, all’epoca trattato come marginale; il tutto nel quadro della fine di Bretton Woods, di cui i contemporanei – maestri dell’operaismo a parte, questo dobbiamo concederlo ai nostri maggiori – non capirono sostanzialmente nulla… Molto invitante è anche il discorso dell’Autore sulla crescita lenta, su quello stato stazionario vigente nell’universo euckeniano, che conoscerebbe sì una evoluzione rallentata, ma non la creatività distruttiva dello sviluppo. A parte che l’evoluzione tecnica gradualistica, incrementale, costituisce il tratto distintivo dell’artigianato tradizionale e artistico più che della piccola impresa, fondandosi proprio sul radicamento, trovare questo spunto di ri-territorializzazione del capitalismo nella lettura finale di Eucken data dall’autore, è intrigante, e lascia spazio a riflessioni. Non è il caso di andare oltre in questa sede, altrimenti dovremmo finire per riconoscere una attenzione alla sostenibilità economica in capo agli ordoliberalisti e questo, «forse», sarebbe un po’ troppo…
E per concludere il punto dolente. Più volte si è accennato alle ombre sui rapporti di costoro con il nazismo. I due fondatori sono, per usare l’espressione di Canfora parlando della Atene successiva alla sconfitta nella guerra del Peloponneso, nel novero di «coloro che erano rimasti in città»[3], mentre Röpke e Rüstow erano emigrati (Röpke in particolare insegnò in Turchia e in Svizzera) tenendo comunque un profilo basso. A fine guerra e oltre vi fu chi intese difendere Eucken e Böhm sostenendo trattarsi di «esuli interni», nozione invero di difficile decifrazione, di cui per giunta sfugge la necessità, dal momento che la Germania del dopoguerra non conobbe una seria rea dei conti interna, al contrario. Peraltro, il coinvolgimento più grave era stato quello del giovane Müller-Armach: nella sua prima monografia giovanile, edita nel 1933, anno dell’ascesa al potere di Hitler, ma frutto del lavoro del biennio precedente, egli non solo cita con puntualità il Mein Kampf, ma lo richiama come fonte di autorità etico-politica, senza se e senza ma, frutto evidente di una vicinanza diciamo così spirituale (!) alla Nsdap al momento dell’ascesa al potere di questa. Va insomma ribadita la sensazione iniziale: non siamo davanti a filosofi ed economisti fuori dal mondo, che non hanno idea precisa di cosa avviene attorno a loro. Nessuno di costoro, a quanto ci racconta l’Autore, nomina mai in sede scientifica, la parola nazismo, anche a distanza di svariati anni. Vengono sempre usate espressioni sfuggenti, che richiamano «la precedente gestione dell’economia centralizzata», e si è visto come per Eucken, addirittura, siano le riforme economiche del ’36 a rappresentare la fine delle libertà: allo studioso erano sfuggiti, va preso atto, i primi tre anni di potere hitleriano.
Tutto ciò è oltremodo sgradevole, come lo sono di massima le persone in questione. L’aspetto centrale che va rimarcato è tuttavia la totale assenza di ogni riferimento alla questione migratoria, volontaria o coatta. Consideriamo che negli anni Trenta funzionava già a pieno regime, dall’altra parte dell’Atlantico, il modello fordista dell’organizzazione per linee etniche alla catena di montaggio [4]. Di lì a qualche anno la struttura e l’assetto produttivo della fabbrica nazista, per sostenere lo sforzo bellico, sarà organizzata attorno a una variante militarizzata dello stesso modello, e d’altro canto cosa sono i «campi» dove il passare della forza lavoro in via di consumazione in tempo reale è scandita dai triangolini colorati di stoffa, che distinguono per etnia, sangue, sesso, tendenze sessuali, tendenze politiche? Dopo la guerra sarà la forza-lavoro italiana sparsa per i paesi dell’Europa occidentale a fornire la mano d’opera per la ricostruzione, e insieme il tessuto connettivo per l’avviamento dell’esperimento comunitario. Quando, con il Regolamento 1/68 sarà stabilita una (graduale) libertà di circolazione dei lavoratori, con la conseguente trasformazione degli italiani residenti negli altri Stati Cee in cittadini (bè, più o meno), l’effetto sarà la marginalizzazione dell’emigrazione italiana, ormai sempre meno discriminabile a discrezione, a favore del reclutamento in un volgere brevissimo di tempo di masse provenienti dalla Turchia (in Germania), dal Portogallo (nei paesi del Benelux soprattutto). Possibile che costoro nell’arco di quaranta anni non si siano mai accorti di nulla? Quanto poi al Sudafrica dell’apartheid tanto caro a Röpke, sulla variante del modello fordista (più simile al campo nazista) messa in atto in quel paese si sono scritte enciclopedie.
La totale assenza di ogni richiamo ai sommovimenti umani dell’Europa della ricostruzione e della stabilizzazione, lontana anticipazione di un fenomeno intensificatosi a cavallo del nuovo millennio, parrebbe affatto fuori dai radar degli ordoliberalisti. E tuttavia, a dimostrazione della quantità e qualità degli stimoli che la lettura genera, vi sono suggestioni che vanno in senso diverso.
In fondo il venir meno (certo previsto dal Trattato di Roma, ma in tempi imprecisati) del trattamento discriminatorio dei lavoratori migranti italiani (e comunque, il Reg.1/68 da cui un processo molto graduale avrà inizio, è della fine del ’68, ben dodici anni dopo la nascita della Cee) – in Europa, potrebbe collocarsi nel solco di quella «economia sociale di mercato» che nelle parole del suo profeta è legata alla comunanza ultima di destini degli abitanti dell’Europa cristiana (cattolica e protestante). Senza andare al disastro presente (ma bisognerà farlo, quando vorremo rendere attiva e fruttuosa la complessa lettura), la seconda globalizzazione (quella di fine millennio) vedrà la Ue impegnata nel sostituire, al modello di rigida gerarchizzazione della forza lavoro per linee etniche, nel controllo della forza lavoro migrante, «la giuridicizzazione del controllo, fondata […] su una accentuata procedimentalizzazione», quel fenomeno cioè che si è a suo tempo provato a definire come cittadinanza a geometria variabile [5]. Vi è quantomeno la suggestione che qualcosa, del lascito di Böhm e di Müller-Armack, abbia continuato a lungo a soffiare nell’apparato Cee/Ue…
































Comments