
Un programma di governo non si improvvisa
Riccardo Bellofiore, Joseph Halevi
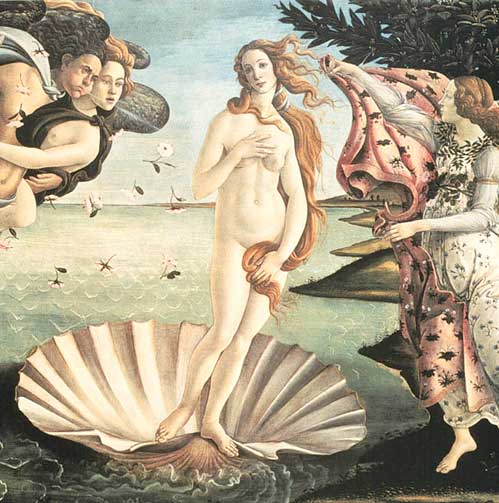 Rossanda ci chiede: come è possibile andare al di là di un «punto di vista» sull'economia, sul lavoro, sul welfare? Come far vivere, nella concretezza degli attuali rapporti di forza, un programma praticabile? Realfonzo replica perentoriamente: gli economisti della Rive Gauche hanno un accesso «scientifico» alle cose tangibili del mondo. L'unica alternativa credibile alla posizione dominante è l'appello per la stabilizzazione del debito pubblico. Ma i politici non ascoltano e i giornali di sinistra non sostengono a sufficienza la battaglia mediatica.
Rossanda ci chiede: come è possibile andare al di là di un «punto di vista» sull'economia, sul lavoro, sul welfare? Come far vivere, nella concretezza degli attuali rapporti di forza, un programma praticabile? Realfonzo replica perentoriamente: gli economisti della Rive Gauche hanno un accesso «scientifico» alle cose tangibili del mondo. L'unica alternativa credibile alla posizione dominante è l'appello per la stabilizzazione del debito pubblico. Ma i politici non ascoltano e i giornali di sinistra non sostengono a sufficienza la battaglia mediatica.
Dissentiamo. C'è davvero sulle pagine del manifesto un punto di vista serio sul capitalismo che vada oltre genericità e cortocircuiti? Senza, invocare il programma è aria fritta. Per dire, il programma dell'Unione, che la sinistra richiama come ultima trincea, in 282 pagine contiene tutto e il suo contrario: nulla però contro il Patto di stabilità. Si contava che il conflitto sociale, e la contrattazione nel governo, avrebbero spostato a sinistra gli equilibri, sull'onda dei movimenti. Si è visto come è finita. Si erano scambiati i desideri con la realtà. Un corteo di successo, ma difensivo, non cambia da solo lo stato delle cose.
Non si parte dalla, ma si arriva alla, politica economica. Si inizia da una analisi di classe del capitale, dalle macrodinamiche globali. Al convegno, se non fosse stato per un social-liberista come Messori o per due fuori dal coro come noi, dei caratteri nuovi del capitalismo contemporaneo non se ne sarebbe quasi sentito parlare, se non per il «capitalismo cognitivo» di Fumagalli (posizione smontata un anno fa in un dibattito sul manifesto).
La crisi dei mutui non parla anche a noi? Non parla di precarietà e di welfare? Non incide su crescita e esportazioni? Dal 1995 il capitalismo vive sempre più su un asse Stati Uniti-Cina, dove la domanda effettiva è garantita, anche all'Europa, dalla esplosione del debito delle famiglie e dalle bolle speculative (azionaria e immobiliare), regolate politicamente. E' questo modello che, sul mercato del lavoro e con i fondi pensione, si vuole importare. Non solo dai neo-liberisti (indifferenti al monopolio e ai disavanzi pubblici), anche dai social-liberisti (preoccupati delle rendite e della finanza sana). Un modello instabile e insostenibile: ma non crollerà. Il possibile impatto sull'Asia della frenata Usa amplificherebbe la flessione della Germania e dell'Europa, grave per noi perché doppiamente dipendenti dal neomercantilismo altrui. E' in questo contesto che vanno inquadrate le difficoltà strutturali dell'economia italiana e il peggioramento della bilancia commerciale.
Realfonzo scrive che la precarietà ostacola l'occupazione. La precarietà spalma l'occupazione data su più figure a tempo parziale o «atipiche». Ma si pensa davvero che un capitalismo pieno di working poor non sia un cambiamento di grande portata, che basti «demistificarlo»? Scrive che la precarietà abbatte i salari e viene usata per riequilibrare i conti con l'estero. Siamo lieti che ci si sia accorti almeno ora del degrado strutturale dell'economia italiana. Se è vero che il disavanzo commerciale verrà brandito per approfondire l'assalto al lavoro, tutto è questo meno che un riequilibrio: perché la precarietà abbatte ulteriormente la produttività, e incancrenisce la nostra debolezza competitiva. Né ha senso ragionare di salario in generale: le varie aree del paese prendono velocità diverse, e così i salari, su base aziendale o territoriale. Se poi ci si squaderna davanti lo spettro del 1992, si parla non di difficoltà della bilancia dei pagamenti, ma di uscita dall'euro. Ne dubitiamo: l'Italia fa più comodo come paese debole dentro l'area che come battitore libero fuori.
Si dovrebbe poi essere meno vaghi sulle politiche «industriali» (ovvero: il «cosa» e «come» produrre). Siamo lieti che un altro tema al centro del nostro intervento di due anni fa abbia fatto strada. Ma queste politiche conseguono «automaticamente» alla stabilizzazione? Possono essere confuse con una difesa del «paese» Italia? Il capitalismo attuale si articola per catene transnazionali di valorizzazione, il centro e la periferia sono dappertutto, le imprese «avanzate» scaricano bassi salari e precarietà lungo la filiera. Una politica economica alternativa procede all'inverso. Non parte da formule contabili sul debito, ma dal contenuto di una spesa pubblica diversa. Da lì risale al disavanzo. Per aumentare il prodotto domani occorre investire e indebitarsi oggi: è il «paradosso della produttività». Una posizione forte, che ribalta sugli interlocutori il problema di rispondere nel merito di un intervento strutturale, di dove eventualmente reperire le risorse per non sforare i «parametri» della finanza pubblica. E' proprio sul terreno del cosa e come produrre che si fa vivere la centralità delle questioni della natura e del genere: se no, si invitano Cini e Ravaioli a fare colore.
Abbandonato l'hegelo-keynesismo (cambiate le idee, cambierà la realtà!), si può andare oltre il punto di vista e arrivare al programma. Ma solo come risultato di un lavoro: di anni, e non si improvvisa. I nodi della precarietà e della spesa pubblica erano noti non uno, ma molti anni fa. Si sapeva che si sarebbe arrivati a queste strette, che occorreva un lavoro collettivo. Come quello su cui si era impegnata la rivista del manifesto, o doveva impegnarsi la sinistra una volta di alternativa. Non ci sono scorciatoie. Non si inventa in un convegno, non si concentra in un appello dal presunto «successo comunicativo». La vera domanda antipatica è piuttosto: dove sta il manifesto in questo lavoro? Inutile cadere dalle nuvole. Partiamo da noi.

