We shall live again: i fantasmi, la violenza, l’utopia
A proposito dei fantasmi di Avery Gordon
di Stefania Consigliere
Avery Gordon, Cose di fantasmi. Haunting e immaginazione sociologica, DeriveApprodi, Roma 2022,291 pp., 20,00€
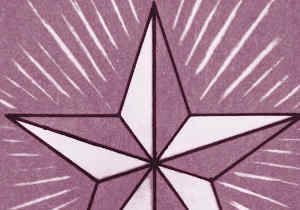 La proposta teorica è magnifica e sconvolgente: il fantasma è la traccia di una violenza. Una traccia ben presente e attiva, anche se invisibile. Qualcosa in cui si può andare a sbattere, senza preavviso, perché esiste nel mondo, al di fuori di noi, come segno di un passato che non può passare perché nessuno ancora gli ha dato ciò che gli spetta.
La proposta teorica è magnifica e sconvolgente: il fantasma è la traccia di una violenza. Una traccia ben presente e attiva, anche se invisibile. Qualcosa in cui si può andare a sbattere, senza preavviso, perché esiste nel mondo, al di fuori di noi, come segno di un passato che non può passare perché nessuno ancora gli ha dato ciò che gli spetta.
Qualcosa è successo – proprio qui, nel punto dove si affollano i turisti, nella terra di nessuno fra gli ultimi palazzoni e la spiaggia, dietro una malandata fermata di autobus – che ha segnato il luogo con il dolore, il dominio e l’orrore. La ferita non è mai stata curata: forse perché, quando la violenza ha colpito, non si è potuto far altro che fuggire; o forse perché, nel tentativo di sopravvivere a molta altra violenza subentrante, è stata dimenticata. Il tempo è passato e nessuno ha rimediato a quel gesto brutale. Ma potrebbe anche trattarsi di una violenza del presente, quella che incessantemente deve ripetersi, giorno dopo giorno, perché la macchina letale del capitalismo possa continuare a macinare plusvalore. La violenza strutturale, incarnata nel modo stesso in cui “le cose funzionano” è proprio questo: la continua produzione di disumanizzazione, dolore, oppressione, gerarchie; un continuo sparger sale su ferite già aperte; un’infinita produzione di spettri muti e dolenti.
Chi vede i fantasmi della violenza, chi si ostina a pensare che la modernità abbia troppi punti ciechi, chi non riesce mai a ritrovarsi nei resoconti ufficiali troverà in Cose di fantasmi. Haunting e immaginazione sociologica di Avery Gordon, appena uscito per DeriveApprodi, un vero e proprio manuale di sopravvivenza etica ed epistemologica.
Diario di traduzione
Ho incrociato Ghostly matters per la prima volta nel 2015, nella bibliografia di un articolo di Roberto Beneduce. A diciassette anni dalla sua prima uscita, dunque, ma ero già scesa a patti con la mia distrazione culturale e quindi non ci sono rimasta troppo male. L’ho scaricato e letto immediatamente, in preda all’entusiasmo che mi piglia nell’incontro con i libri-chiave, quelli che modificano per sempre il tuo modo di vedere. Come succede in questi casi, ne ho parlato con tutti e, per un certo periodo, non ho parlato d’altro. Ne ho ordinato una copia “vera”, su cui ho diligentemente riportato le sottolineature e le note della versione elettronica. Da allora ci sono tornata ogni volta che ne ho avuto bisogno. Nella primavera del 2021, durante l’occupazione del nostro dipartimento, Federico Rahola mi ha proposto di tradurlo insieme in italiano: era già in amicizia con l’autrice, l’editore era ovvio e le cose sono andate avanti senza problemi, ma con tutta la lentezza e le risacche a cui questi anni di diluvio ci hanno abituati.
Da quel momento, non so più quante volte ho letto e riletto le pagine, i paragrafi, le singole frasi: in inglese, in italiano e a cavallo fra le due lingue, cercando di restituire la prosa flessibile e felice dell’autrice, il suo modo amorevole di parlare a ciò che non dovrebbe esserci, ma c’è. Ci sono stata appiccicata lungo tutta l’estate e l’autunno del 2021, poi nella primavera di quest’anno e di nuovo nell’autunno, in full immersion, per la correzione delle bozze. Dovrei conoscerlo a memoria, o almeno muovermi senza sorpresa fra immagini e capoversi, al riparo da batticuori, spaventi, illuminazioni profane e reazioni emotive.
E invece no. Piango tutte le sante volte.
Il capitolo sui desaparecidos argentini – su cosa significhi vivere all’insegna di «Dio, patria e famiglia» in un regime di colonnelli fascisti – mi porta, ogni volta, lo stesso dolore provato da bambina quando la rai mandò in onda uno sceneggiato (oggi: serie tv) intitolato Olocausto. Era la fine degli anni Settanta e la prima generazione di storici nati dopo gli eventi, e quindi relativamente immuni dalle ferite biografiche, stava cominciando a riaprire i dossier. A lungo in Germania dei campi non si è parlato; la generazione nata dopo la guerra ha dovuto scoprirli da sé, sull’onda del clima rivoluzionario del “decennio Sessantotto”, inseguendo il non detto e gli invisibili della vita sociale. Inseguendo i fantasmi, dunque.
Non vorrei suonare melodrammatica, ma sospetto che i mesi in cui ho tradotto Cose di fantasmi abbiano una parte sostanziale nella mia risposta emotiva al testo. La violenza produce fantasmi, amnesie, scissioni e terrore: in formato mignon, lo vedevo avvenire intorno a me. Il lockdown come dispositivo di rieducazione, la militarizzazione dei territori, l’induzione del terrore come strumento di controllo, il blocco epistemologico, il silenziamento dei saperi critici, la criminalizzazione di ogni forma di dissenso, la caccia alle streghe, la propaganda di guerra, uomini armate alle fermate dei bus per controllare il green pass dei ragazzini, Dostoevskij proibito, la follia sociale che per tre anni abbiamo respirato a pieni polmoni. Tutto quello che oggi cerchiamo disperatamente di rimuovere, a costo di non ricordare più niente della nostra vita recente, e che ci lascia feriti, risentiti, scissi, disperati. Le magnifiche pagine che Avery Gordon aveva scritto un quarto di secolo prima entravano in costellazione con il presente fino a produrre un shock, un arresto.
Will the circle be unbroken?
Le domande giuste
A (ri)leggere oggi i testi prodotti negli ultimi trent’anni del secolo scorso, si avvertono una ricchezza teorica e una generosità che nei decenni seguenti – dopo “Genova”, dopo le torri gemelle, nella prima ondata di guerra al terrore – avrebbero preso un andamento più carsico, vie più lunghe. Apparso per la prima volta nel 1997, Cose di fantasmi naviga in quelle acque, ben sondate dalla bibliografia, dove, oltre ai nomi classici, s’incrociano i nomi di Raymond Williams, Michael Taussig, Cedric Robinson e quelli delle autrici intorno a cui il testo s’intesse: Sabina Spielrein, Luisa Valenzuela, Toni Morrison.
Più ancora delle risposte – che tanto ciascuno deve trovare da sé nel luogo e nel tempo che gli sono toccati in sorte – contano le domande. Una cattiva domanda porta fuori strada rinforzando la disvisione del mondo, la continua rimozione che dobbiamo operare perché l’assurdo di una società in cui perfino l’annientamento degli umani produce plusvalore non disturbi la nostra sopravvivenza quotidiana. La buona domanda rivela ciò che siamo tenuti a non sapere, dà voce all’imparlabile: la si riconosce dallo spavento elettrizzato che si prova quando una domanda coglie nel segno.
Sabina Spielrein non era presente al congresso psicoanalitico di Weimar nel 1911 perché era una giovane donna, perché prima di diventare psicoanalista era stata paziente, o per via della doppia clandestinità della relazione con Jung? Quali connessioni pulsionali hanno legato la classe media argentina e il regime dei colonnelli che la proteggeva dai suoi stessi figli? Quanta fame – di dolci, di umanità, di amore – hanno i fantasmi della tratta atlantica e dello schiavismo su cui la modernità si è edificata? Più vicino a noi: quale rapporto lega le spiagge dei bagnanti estivi alla rotta libica e ai lutti senza cadavere che funestano i villaggi del Magreb? Quanti lavoratori morti giacciono sotto le mura delle città, gli stadi, le vie ad alto scorrimento? Quali parti di noi – ridotte al silenzio da un mix di shot tossici, cinismo e pornografia – ci aspettano all’angolo della solita strada?
Il fantasma sta dalla parte di chi sente il mondo in modo diverso da come esso viene descritto. Qualcosa è successo che dà ragione della dissonanza: non eravamo matti o ipersensibili o paranoici a pensare che quell’angolo di strada fosse inquieto; a sentire odore di cimitero in certi appartamenti di lusso; a vedere zombie nei grattacieli della city. Il fantasma libera dall’oppressione di dover aderire a una verità pubblica che fa a pugni con quel che sentiamo.
Non solo. Proprio perché segnala che qualcosa è andato storto, il fantasma porta con sé la certezza che le cose potevano anche andare altrimenti. Ci dice che è stata la violenza (e non il caso, o la natura) a sbarrare l’accesso a un futuro desiderabile. E ci dice anche che queste possibilità mancate non sono perdute per sempre: come il fantasma, i nostri futuri perduti e felici attendono di essere visti e rivendicati, che qualcuno li accolga e li porti con sé nei futuri che i morti avrebbero voluto – e noi con loro.
Alcuni storceranno il naso: i fantasmi non esistono. Le foreste non parlano. Lari, penati e ninfe dei boschi erano vecchie superstizioni. Il terrore non uccide. I mattatoi non sono luoghi d’orrore. Le danze, le rose e l’incanto sono solo per donne e bambini. E via dicendo. Qui il movimento rivoluzionario ha commesso il suo errore più catastrofico e ancora fa fatica ad avvedersene: l’adesione al disincanto rende solidali a quello stesso sistema di dominio che, sul fronte economico e politico, vorremmo superare. Se c’è qualcosa che dobbiamo togliere rapidamente dalle mani dei nostri avversari (e sono tanti) è il monopolio dell’immaginario: la zona del possibile, del non-ancora, del rimosso, dell’utopico, dell’inaffrontabile; le parole dei fantasmi; il nostro desiderio di una vita decente.
Spettri di Genova
Una donna olandese inseguita dalla polizia. Un salto dal molo sulle pietre che proteggono la caletta. Il rumore di un bacino che si spezza nell’impatto. Quel rumore. Bisogna soccorrerla, non si può lasciar per strada qualcuno col bacino spezzato. Una mano ti afferra e ti porta via perché, se resti, la prossima cosa che si spezzerà sarà il tuo cranio. Un bacino si spezza, bisogna soccorrere, devi andartene. Quel rumore non smetterà più di farsi sentire. Il tuo andartene non ti porterà mai più via da quella spiaggia.
Un pomeriggio di metà agosto, con lo stesso caldo di allora e la città abbastanza vuota, ho accompagnato una reduce del G8 sui luoghi dei nostri fantasmi generazionali: lo stadio Carlini, Boccadasse, corso Italia, piazzale Kennedy. Lei non tornava a Genova da ventun anni, io non l’ho mai davvero lasciata. Insieme ad altri compagni, erano arrivati a Genova nella notte, dagli Appennini, per evitare i posti di blocco autostradali; poi erano ripartiti in ordine sparso e forse, prima di separarsi, erano passati per la Diaz imbrattata di sangue – nessuno di loro, oggi, ne è più sicuro. Nell’autunno di quell’anno, quando mi capitava di passarci, sovrimpresse su piazzale Kennedy vedevo scorrere le immagini dei tre giorni di luglio: la polizia in assetto antisommossa; i banchetti di accoglienza; le montagne di bottiglie d’acqua; gli attivisti di Attac! immobili davanti ai manganelli; l’onda dei manifestanti che bruscamente piega e s’incunea su per la scalinata; il fragore incessante dell’elicottero; il sangue. Mentre camminavo con un compagno dei Paesi Baschi, a un certo punto lui mi ha messo una mano sulla spalla e mi ha dolcemente spostata mezzo metro in là per evitarmi di calpestare una chiazza di sangue. Camminare sul sangue, le ossa spezzate dei morti. Di chi era quel sangue?
Abbiamo cercato il posto dove la donna olandese è caduta sugli scogli, dove la polizia ha inseguito un bacino fino a spezzarlo, dove non si è potuto prestare soccorso. Alla fine, dopo molti sopralluoghi, non siamo certe di averlo trovato: forse in due decenni la città è troppo cambiata o forse la ricostruzione oggettiva è impossibile. Michael Taussig ha indagato gli spazi del terrore, e cioè i luoghi dove l’uso sistematico e intenzionale della violenza arriva a creare un contesto allucinatorio. Come in quell’iniziazione multigenerazionale alla violenza di stato: lo sgomento nel riconoscere il suono di un osso che si spezza senza averlo mai sentito prima; la consapevolezza stordita di esser finiti in un teatro dell’orrore; la confusione. Il suono delle ossa sulla pietra non ha segnato le mie orecchie, è il fantasma di altri: della compagna che me lo racconta, di quelli che erano con lei. Ma è anche un fantasma mio, uno dei tanti che da allora si affollano, nell’indistinzione perdurante fra ciò che si è vissuto e ciò che è stato raccontato, fra ciò che si è visto e ciò che si è temuto, nella nebbia cognitiva che gli spazi del terrore invariabilmente inducono e che si alza, appena un po’, solo accettando di parlare alle ombre che vi si muovono.
Da sola non avrei mai fatto questa ghost dance. Pigrizia, timore; o forse non mi sarebbe venuto in mente. Cercare quei fantasmi non mi ha dato nessuna risposta, nessuna certezza. Mi ha permesso di sputar fuori un po’ del fango accumulato. E soprattutto, mi ha riconnessa con il senso di quelle lotte, con la parte perduta della storia mia e di tutti, con i futuri abitabili distrutti sotto i miei occhi dalla violenza del capitale. E mi ha mostrato, una volta di più, l’intelligenza dei collettivi che danzano la ghost dance, dove i fantasmi cantano, insieme ai vivi, we shall live again.
































Comments
L'anno scorso mi scervellavo su questo ricordo, oggi leggo questo articolo e mi salta all'occhio il riferimento a 'Olocausto'. Può essere la risposta al mio dubbio? Sarò grato a chiunque possa aiutarmi - e in ogni caso all'autrice, che mi sorprende ogni volta per le affinità dei riferimenti culturali (qualcuno ha detto Prigionieri delle Pietre? ^__^;;;).
F.
Credo anche sia necessario sul piano lessicale dare più forza alla parola "potere" ed ha questo come viene usato proprio in forza del ruolo che svolge a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale. La mia opinione politica dopo oltre 50 anni di lotte espresse nelle diverse forme e fortunatamente in un contesto politico in cui viviamo : le norme e le regole democratiche, con le dovute eccezioni, vengono praticate, è che c'è un uso improprio del termine capitale, a mio parere, invece di quello di "potere". L'esercizio del potere ed il suo uso andrebbero meglio analizzati per consentire al singolo e alle forme in cui esso si mette insieme con gli altri per poterlo esercitare, che assume il valore politico e che come questo dovrebbe essere attuato. Le forme le conosciamo tutte, ma sul piano dell'azione politica necessaria per un "Governo" funzionale a garantire pari diritti e pari opportunità ed appropriate redistribuzione della ricchezza prodotta, ci si logora nel ricercare il sistema più adatto a cambiare il sistema capitalistico, più che a ricercare il sistema di "governance" più funzionale a perseguire l'obiettivo prima indicato. Il partito di lotta e di governo in un sistema veramente democratico e quello a cui la Sinistra che c'è dovrebbe lavorare più che continuare a frammentarsi, come stiamo facendo da 50 anni a questa parte.
forse un niente che è tutto.."
Eugenio Montale
Grazie Signora Stefania.