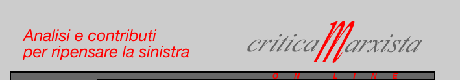
L’EREDITÀ DEL PCI
Guido Liguori
 I recenti libri di Giuseppe Chiarante e Lucio Magri sulla storia e sulla fine del Partito comunista italiano. Un lascito che non è stato raccolto e portato avanti da alcuna forza politica, ma senza vivificare il quale sarà difficile per i comunisti e per la sinistra italiani tornare a esercitare un ruolo di primo piano.
I recenti libri di Giuseppe Chiarante e Lucio Magri sulla storia e sulla fine del Partito comunista italiano. Un lascito che non è stato raccolto e portato avanti da alcuna forza politica, ma senza vivificare il quale sarà difficile per i comunisti e per la sinistra italiani tornare a esercitare un ruolo di primo piano.
Sono giunti in libreria quasi contemporaneamente, a metà settembre, due libri importanti sulla storia del Pci e sulla sua fine. Sono stati scritti da Giuseppe Chiarante (La fine del Pci. Dall’alternativa democratica all’ultimo Congresso 1979-1991, Roma, Carocci, pp. 211) e da Lucio Magri (Il sarto di Ulm. Una possibile storia del Pci (Milano, il Saggiatore, pp. 453).
Entrambi dirigenti comunisti, due vite a tratti intrecciate, sul piano degli ideali e su quello della militanza politica: in comune, oltre a un’amicizia lunga decenni, la provenienza dal movimento giovanile democristiano e la scelta di entrare nel Partito comunista italiano, alla fine degli anni ’50, controcorrente; e la vicinanza con la sinistra comunista negli anni ’60.
Poi il divaricarsi delle strade, dal 1969 all’inizio degli anni ’80: tra i fondatori e dirigenti della rivista il manifesto (poi divenuto gruppo politico) Magri, e per questo fuori dal Pci insieme a Castellina, Parlato, Pintor, Rossanda e altri; rimasto nel partito, sia pure con alcune perplessità, Chiarante. Infine, riavvicinati dalla «terza via» del secondo Berlinguer,a fianco del quale Chiarante interpretò anche un ruolo importante e sulla scia della quale Magri rientrò nel Pci. Infine, entrambi tra i protagonisti dell’ultima battaglia nel partito, contro lo scioglimento deciso da Occhetto. E poi tra le voci più autorevoli della sinistra, voci autorevoli ma sempre più isolate, negli ultimi anni, punti di riferimento soprattutto intellettuali e morali nella lunga stagione (gli ultimi tre-quattro lustri) della diaspora, della divisione e della sconfitta dei comunisti italiani,in qualunque partito finissero per militare. O, ben presto, nella loro maggioranza, fuori da ogni partito.
Se l’argomento e anche i percorsi degli autori portano inevitabilmente ad accostare i due libri, diversi motivi concorrono però a distinguerli. In primo luogo, parzialmente diverso è l’arco temporale considerato: il libro di Magri ricostruisce tutta la storia del comunismo italiano dopo il fascismo, senza tralasciare di gettare interessanti sonde interpretative anche sul movimento comunista nazionale e internazionale precedente; quello di Chiarante è il terzo volume1 di una autobiografia politica che ha preso le mosse dagli anni ’50 fino ad arrivare – nel volume uscito da poco – all’89, alla fine del partito comunista e oltre. Parzialmente diverso è pure il taglio: quella di Chiarante è dichiaratamente un’autobiografia politica, anche se sostanziata da ricerche e documentazione tali da farne un contributo storiografico che va ben al di là di semplici memorie; il libro di Magri vuole essere una storia, per di più sospettosa verso la memorialistica e l’autobiografismo, anche se alcune delle pagine più interessanti sono legate al ruolo svolto dall’autore e si nutrono dei suoi ricordi.
Nonostante alcune differenze, i due libri si leggono bene insieme, anzi si arricchiscono e si completano. Anche perché dove il racconto di Magri si fa più veloce (la «svolta» occhettiana e la fine del Pci) la messa a fuoco di questo terzo volume di Chiarante si sofferma maggiormente, nel raccontare e spiegare l’epilogo della storia. In entrambi i casi, è la riflessione sugli anni ’80 a richiamare oggi soprattutto l’attenzione, poiché è in quel passaggio, nei suoi vuoti e nelle sue carenze, come nella mancata prosecuzione di alcune delle linee di ricerca dell’ultimo Berlinguer, che vengono individuati giustamente i preliminari della fine del Pci
Il sarto di Ulm
Ulm è una poesia di Bertold Brecht. Essa racconta della sfida che un artigiano lancia negli ultimi anni del Cinquecento al vescovo della sua città: egli vuole dimostrare che l’uomo può volare. L’«assalto al cielo» fallisce, il sarto muore, il vescovo (il senso comune) afferma perentorio che l’umanità non è fatta per volare. Ma, ha chiosato Pietro Ingrao cogliendo il senso dell’apologo brechtiano, qualche secolo dopo l’umanità riuscì effettivamente ad alzarsi dal suolo.
La metafora è trasparente: il comunismo è fallito nel suo novecentesco «assalto al cielo», ma è stato solo il primo tentativo; altri ne seguiranno: nulla vieta di pensare, sperare e lavorare perché un giorno si riesca a giungere a una società contrassegnata da principi di cooperazione e solidarietà, al posto dell’attuale fondata sulla «legge della giungla». Ma – viene da chiedersi – vi è un legame tra le ali del «sarto di Ulm» e il moderno aereo a reazione? Imparare a volare è stato possibile – e la cosa avrebbe fatto piacere al vecchio Marx – solo grazie a un enorme sviluppo della scienza e della tecnologia, che se ben usate possono aprire all’umanità nuove strade di libertà. Ma anche – e questo rende l’apologo meno tranquillizzante – imparare a volare ha seguito modalità e strade completamente diverse da quelle immaginate dal «sarto». Insomma, il parallelo con l’avventura dell’umanità verso il volo sembra dirci soprattutto che quanto è stato fatto fino a ora non è servito a niente, se non a indicare una vaga aspirazione. Ma è davvero così?
Magri è lontano dal crederlo. In primo luogo, egli non è fra quanti considerano la storia dell’Unione Sovietica solo come un enorme cumulo di errori e orrori. Vi è nel suo libro – sia pure non in primissimo piano – una consapevolezza di quella storia, delle scelte sbagliate e di quelle obbligate, ma anche del passo positivo che essa ha costituito nella storia del Novecento, in relazione alla liberazione di una gran parte dell’umanità dai gioghi del colonialismo e delle forme di sfruttamento medievali; alla sconfitta del nazismo; al miglioramento deciso (sia pure «di rimbalzo») delle condizioni di vita dei lavoratori in Occidente. Senza dimenticare gli «orrori» che tutti sanno, ma senza ridurre tutto a tali «orrori». È partendo da questa convinzione, mi sembra, che l’autore ragiona sulla storia del comunismo e sulle speranze del comunismo.
Soprattutto della storia dei comunisti italiani parla il libro di Magri, non a caso, e non solo per motivi autobiografici. La storia dei comunisti italiani è ritenuta la punta più avanzata del tentativo di contrastare il capitalismo «in Occidente», come avrebbe detto Gramsci – un tentativo visto con un’ottica che non nega i limiti e gli errori, ma non trae da ciò conclusioni da «fine della storia», da insuperabilità della società capitalistica, purtroppo oggi diffuse anche nella sinistra, non solo italiana.
Il discorso interpretativo di Magri mi sembra a grandi linee il seguente: grazie al «genoma Gramsci» e alle capacità togliattiane, il Partito comunista italiano fu sì parte organica del movimento comunista internazionale nato dall’Ottobre, ma seppe anche coltivare e preservare una crescente diversità rispetto alla strada intrapresa «in Oriente» e via via declinata in modo peggiorativo. Se fino a un certo punto era inevitabile stare «da una parte della barricata», negli anni ’60 si sarebbero potuti praticare maggiori margini di autonomia. Il prevalere – con l’XI Congresso – del compromesso tra il «centro» del partito e la «destra» provocò la perdita di una occasione storica, quella offerta dal ’68-’69, per attuare una concreta politica alternativa al sistema vigente, quella stessa politica di cui Togliatti, pur con molti limiti, aveva indicato alcune linee strategiche e che aveva in Gramsci un arsenale di idee e suggerimenti ancora in parte non utilizzati. Il secondo Berlinguer seppe riprendersi dagli errori catastrofici degli anni del «compromesso storico», rilanciando e rinnovando almeno in parte l’identità di un partito comunista in bilico tra omologazione e alternativa. Ma Berlinguer morì nel bel mezzo di tale incompiuto sforzo di ridefinizione e di rilancio di una moderna identità comunista – un’opera, la sua, certo insufficiente, ma comunque conditio sine qua non per rilanciare il Pci all’altezza dell’evoluzione della società italiana. Il suo partito non solo non seppe proseguirne la politica e il modo d’essere, ma rapidamente fece prevalere tutti quei motivi che, come Berlinguer aveva ben visto, lo avrebbero portato rapidamente a chiudere una esperienza storica durata settant’anni.
Nelle pieghe di questa interpretazione–chea me pare nella sostanza condivisibile–vi sono naturalmente singole pagine da discutere e approfondire. Il metodo che Magri usa – una sorta di storia controfattuale, con l’indicazione reiterata di cosa sarebbe stato possibile e auspicabile fare di contro a ciò che fu invece fatto – è sicuramente legittimo (e tutti lo usano, implicitamente, nel momento in cui ravvisano nel passato un limite), ma a volte rischia a mio avviso di condurre a una semplificazione eccessiva del discorso. Anche se – va precisato – Magri svolge la sua riflessione, oltre che con competenza e intelligenza, sempre dall’interno, con una dimensione di ricerca in cui il discorso è sempre più autocritico che critico, persino per gli anni nei quali egli fu fuori dal partito.
La difficoltà di una storia controfattuale usata in modo tanto esteso sta nel fatto che numerosissime sono le varianti storiche che determinano una «situazione concreta», per cui il rischio appare sempre quello di alternative possibili alle scelte compiute che non si sa se fossero poi realmente possibili: si rischia di ragionare su una data politica senza retrocedere a esaminare tutte le scelte che effettivamente stanno alle sue spalle e la surdeterminano. Ad esempio, sarebbe stato possibile all’Urss staliniana reagire in modo diverso alla «guerra fredda» scatenata dall’Occidente, rifiutare l’arroccamento territoriale e la formazione di un proprio «campo»? Per Magri sì2. Ed è una ipotesi suggestiva. Si potrebbe però obbiettare che le scelte relative erano già state fatte – addirittura decenni prima. Se vi era stato un momento in cui davvero l’Unione Sovietica sarebbe potuta forse divenire altro e scegliere una strada diversa era quello della fine degli anni ’20, della sconfitta della linea di Bucharin, della scelta di rompere l’alleanza con le campagne e la gradualità della Nep, del puntare sull’industria pesante, ecc. Lì era stato costruito un socialismo fortemente territorializzato, come «fortezza assediata», di cui le scelte del dopoguerra a me paiono conseguenze logiche. È probabilmente vero ciò che Magri dice–cioè che sono gli anni peggiori di Stalin anche dal punto di vista delle scelte politiche (ad esempio: l’esperienza disastrosa del Cominform, alla quale non a caso Togliatti si sottrasse). Ma dubito – come Magri afferma, a partire dal riconoscimento delle responsabilità guerrafondaie dell’«Occidente» – che sia vero che «ogni guerra si fa in due»: arrivati a quel punto era possibile probabilmente una conduzione diversa del confronto-scontro con gli Stati Uniti, ma non il sottrarsi veramente al proprio ruolo di grande «antagonista» nella «guerra fredda». Le scelte dirimenti erano probabilmente alle spalle.
Quella che voglio indicare è la difficoltà di una «storia ipotetica». Anche se tante considerazioni di Magri sulle alternative possibili sono di grandissimo interesse, esse lo sono soprattutto perché aiutano a imparare dal passato e a cercare di ragionare su cosa oggi comunque i comunisti non dovrebbero più essere e non dovrebbero più fare o volere, non perché fosse realmente possibile allora fare ciò che oggi si reputa fosse possibile.
E ancora: dalla ricostruzione di Magri scaturisce una valutazione positiva della figura di Togliatti e della sua opera di costruzione del «partito nuovo». Di cui l’autore non sottovaluta i limiti. Ma che comunque sembra considerare – come dargli torto? – l’unico tentativo sia pure embrionale di articolare un discorso all’altezza della «rivoluzione in Occidente», del passaggio dalla «guerra manovrata» alla inevitabile «guerra di posizione». Tuttavia, non sarebbe stato possibile anticipare al ’56 il discorso poi tentato nel ’62-’64? Se le proposte contenute nel Memoriale di Yalta fossero stato elaborate nel ’56, pur senza rotture con l’Urss, sarebbe stato possibile contribuire a un diverso indirizzo del «blocco socialista»? Anche qui è difficile rispondere. Ma l’esperimento mentale resta interessante.
Sugli anni ’70-’80 le pagine sono tra le più importanti del libro. Anzi, il processo che avrebbe condotto alla fine del Pci può essere in parte individuato nelle scelte fatte subito dopo la morte di Togliatti, quando negli anni ’60 prevalse una lettura «di destra» della società italiana. Una osservazione mi sembra di grande interesse, anche se avrebbe bisogno di approfondimenti: Amendola non si oppose alla nomina di Berlinguer (un centrista più incline a sinistra, e per questo come è noto anche «retrocesso» dopo l’XI Congresso) a vice-segretario e poi segretario del partito, a svantaggio del suo «delfino» Giorgio Napolitano, ma chiese e ottenne in cambio dal «centro» politico del Pci un gruppo dirigente sbilanciato verso le sue posizioni, che imbrigliò e condizionò a lungo il nuovo segretario succeduto a Longo3. Da qui – più che dai fatti del Cile (come anche Chiarante ineccepibilmente documenta) – nasceranno «compromesso storico» e «solidarietà nazionale». Ma prima ancora la grande occasione persa dopo il ’68-’69, quando il partito non seppe interpretare fino in fondo quel ruolo di alfiere del cambiamento di cui la società, o la gran parte di essa, lo aveva investito.
Molti altri esempi di osservazioni e ragionamenti utili per la riflessione sono contenuti in un libro come quello di Magri, così vasto e denso: per il lettore una riflessione impegnativa,ma sicuramente stimolante e utile.
La fine del Pci
E venne la sconfitta della politica berlingueriana degli anni ’70. E poi il tentativo disperato del secondo Berlinguer e quindi la lenta agonia e la «fine del Pci». Siamo ormai a vent’anni dalla Bolognina, ed è ben studiata la scelta di Chiarante di concludere la sua biografica politica in tre volumi proprio in coincidenza con questo ventennale che vede la sinistra e i comunisti in Italia ridotti ai minimi termini.
Mi sembra si possa dire che le linee di fondo della ricostruzione di Chiarante e Magri nella sostanza non divergano per quel che concerne gli anni ’80 e l’ultimo capitolo, occhettiano, del più grande partito comunista d’Occidente. La (parziale) differenza sta forse nel rapporto fra il «primo» e il «secondo» Berlinguer. Chiarante sottolinea maggiormente i momenti di continuità, sia pure nella diversità, nel rovesciamento persino, della linea politica. Scrive infatti l’autore (in coerenza anche con la sua «piena adesione già nei primi anni ’80 alla linea del secondo Berlinguer») che «è essenziale considerare anche gli elementi di continuità che attraversano la prima come la seconda fase della sua azione di segretario»4. Tra essi Chiarante indica, un po’ sorprendentemente, l’«acuta sensibilità» berlingueriana proprio per «le nuove questioni che erano poste dai movimenti e dalle lotte del ’68»5. Non ho elementi per contestare l’ipotesi che personalmente Berlinguer abbia sempre sentito tali suggestioni e abbia sempre nutrito tale interesse. Pub-blicamemente, però, cioè politicamente, se tale sensibilità è manifesta dal 1979 in poi, appare ben nascosta negli anni ’70, quando è vero che il Pci si avvalse elettoralmente della grande spinta al cambiamento manifestatasi nel «secondo biennio rosso», ma in fin dei conti la deluse profondamente proprio perché non fu sensibile ad alcuni grandi temi di «riforma intellettuale e morale» ri-lanciati dal movimento operaio, dal movimento studentesco e dal nascente movimento delle donne già nel «secondo biennio rosso» e all’inizio del decennio successivo.
Sarà forse perché intorno al segretario, nel gruppo dirigente del Pci, era maggioritaria una lettura e una tendenza di destra, come si è detto quella guidata da Amendola, che subito aveva contestato i tentativi di dialogo con gli studenti messi in cantiere da un Longo ormai malato e nell’impossibilità di esercitare a lungo il suo ruolo di segretario? È probabile. Resta il fatto che il numero uno del Pci dalla fine degli anni ’60 era di fatto Berlinguer ed egli avallò e promosse in prima persona una politica che andava in direzione diversa da quella domanda di forte ricambio politico che saliva dalla società.
Chiarante ha probabilmente ragione nell’indi-viduare una influenza e una eredità del ’68 nel celebre discorso «sull’austerità», che però giunge solo nel 1977, quando cioè la linea della «solidarietà nazionale» e della rinuncia a un ruolo antagonista rispetto al sistema democristiano e più in generale capitalistico aveva alienato al Pci già molte simpatie e offerto il terreno più favorevole per fraintendere, anche volontariamente e strumentalmente, il discorso sull’«austerità».
Dove appare evidente la continuità di ispirazione di Berlinguer è invece nella politica internazionale – dalla presa di distanze dall’Urss in occasione dell’invasione di Praga in poi. Chiarante mette molto bene in luce il filo rosso che collega questo nuovo posizionamento con la proposta dell’eurocomunismo e poi anche con le alleanze con alcuni leader socialdemocratici di sinistra in relazione al tema dei rapporti tra Nord e Sud del mondo. Purtroppo per creare un polo eurocomunista le forze non furono sufficienti, ma a quelle posizioni si guardò con grande interesse da tutto il mondo e lì – nella posizione originale di un comunismo democratico – affondano le radici anche del secondo Berlinguer.
Sia Chiarante che Magri sottolineano a ragione come – a fronte delle novità strutturali e politiche degli anni ’80, e in considerazione dei limiti mostrati dal Pci soprattutto dopo la morte di Berlinguer – non sarebbe stato possibile continuare semplicemente a difenderne la storia e la tradizione: il destino del Pcf mostra chiaramente a quale fine si sarebbe andati incontro. Infatti sia l’ultimo Berlinguer che coloro che – anche richiamandosi alla sua eredità – si opposero alla Bolognina sostennero la necessità di un adeguamento delle analisi e della pratica politica. Le forze che condussero l’ultima battaglia per il Pci non seppero però – dopo la fine del partito, decretata a maggioranza – mantenere la loro unità (dentro o fuori il nuovo partito che nacque a Rimini, ma comunque tutti insieme), dando vita a loro volta a una diaspora e a una frammentazione che contribuì a far sì che l’eredità della migliore tradizione del comunismo italiano andasse dissolta. Il compito del resto non era agevole: si trattava non di una coesa e coerente posizione politico-culturale, ma di un fronte molto diversificato di posizioni, unite dal rifiuto di una decisione avventata e suicida. Era però forse l’unico modo per non disperdere un patrimonio di forze ancora considerevole (un terzo del vecchio partito, che contava un milione e mezzo di iscritti e raccoglieva nel 1989 ancora 9.600.000 voti) e iniziare da lì una riflessione anche autocritica e un rinnovamento necessari.
L’eredità del Pci
Sarà un caso che a venti anni di distanza dalla Bolognina, dall’inizio della fine del Pci, solo i protagonisti che furono critici dell’iniziativa occhettiana prendano ormai la parola per scriverne diffusamente? E che pure le ricostruzioni di chi non fu allora tra i protagonisti dell’ultima battaglia che si accese sui destini del più grande partito comunista d’Occidente siano anch’esse più che critiche verso quell’esito6? Certo, se si guarda non solo all’oggi, ma a tutta la vicenda complessiva della sinistra italiana degli ultimi venti anni, si può facilmente vedere come quella occhettiana sia stata un’operazione a perdere. Scrive Chiarante: «Uno dei motivi animatori della svolta della Bologni-na – il convincimento che potesse bastare voltar pagina, ripudiando il nome, l’ideologia, la stessa peculiare esperienza del comunismo italiano, per dar vita a una nuova e più ampia formazione della sinistra, e aprirsi così la strada per l’accesso al governo del paese – si è rivelato soltanto un’illusione»7. Fin dalle prime prove elettorali successive al Congresso di Rimini l’esito fu disastroso e «in occasione delle elezioni politiche del 1992 il Pds raggiunse solo il 16,1 per cento dei voti, contro il 26,6 che il Pci aveva ottenuto nel 1987 nelle elezioni politiche e il 27,6 per cento nelle europee del 1989»8.
A soli otto anni dal suo apogeo elettorale, il Pci cessava di esistere, dilaniato dall’accentuarsi delle divaricazioni tra le sue varie anime interne e soprattutto dalla nuova egemonia liberal che si affermò rapidamente nella sinistra a livello mondiale, travolgendo, dopo il crollo del «socialismo reale», anche la cultura socialdemocratica. Non vi è stata nessuna forza politica in Italia che ne abbia saputo davvero valorizzare il lascito, l’eredità, che pure ancora appare cospicua: un partito comunista fortemente radicato nella realtà nazionale, sia pure con una vocazione e una presenza internazionale e internazionalista; una politica delle alleanze che non dimenticò mai di metterne al centro il mondo del lavoro e le lavoratrici e i lavoratori; una capacità di aprirsi alle nuove culture e ai nuovi movimenti senza però fare andare persa la propria originaria ispirazione e la propria ragion d’essere più profonda. Insomma, la ricerca costante di una dimensione di massa, su cui graduare obiettivi e pratica politica.
Sembra difficile pensare a una nuova e non minoritaria presenza dei comunisti, delle comuniste e della sinistra nel nostro Paese che non tenga conto del grande patrimonio teorico e politico lasciato dal Pci, pur tra ritardi e scelte sbagliate. La fine del Partito comunista italiano non era scritta o inevitabile, fu frutto di errori gravi, sia pure in una ardua contingenza storica. Certo ora ricominciare è enormemente più difficile.































Add comment