Pensare con il martello
di Gigi Roggero
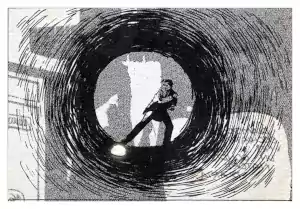 È fresco di stampa La rivoluzione in esilio. Scritti su Mario Tronti, a cura di Andrea Cerutti e Giulia Dettori (Quodlibet). Il volume è costituito da una raccolta di saggi da parte di figure di differente formazione che analizzano degli aspetti particolari dello straordinario percorso teorico-politico dell’autore di Operai e capitale. Proponiamo qui lo scritto di Gigi Roggero, dall’esemplificativo titolo Pensare con il martello, e dall’esemplificativa conclusione: «Abbiamo l’impressione di non vederla, eppure la tigre è lì, sempre pronta a balzare. Non in un imprecisato futuro, ma contro un presente determinato. Scommettiamo su una profezia, la forza di vedere quello che gli altri non vedono, la volontà di dire quello che gli altri rifiutano di ascoltare, il progetto di scomporre il tutto del capitale per ricomporre e dunque trasformare radicalmente i frammenti della nostra parte. In questa notte apparentemente senza stelle, il nostro noi si forma riconquistando la capacità di afferrare le tracce dell’aurora».
È fresco di stampa La rivoluzione in esilio. Scritti su Mario Tronti, a cura di Andrea Cerutti e Giulia Dettori (Quodlibet). Il volume è costituito da una raccolta di saggi da parte di figure di differente formazione che analizzano degli aspetti particolari dello straordinario percorso teorico-politico dell’autore di Operai e capitale. Proponiamo qui lo scritto di Gigi Roggero, dall’esemplificativo titolo Pensare con il martello, e dall’esemplificativa conclusione: «Abbiamo l’impressione di non vederla, eppure la tigre è lì, sempre pronta a balzare. Non in un imprecisato futuro, ma contro un presente determinato. Scommettiamo su una profezia, la forza di vedere quello che gli altri non vedono, la volontà di dire quello che gli altri rifiutano di ascoltare, il progetto di scomporre il tutto del capitale per ricomporre e dunque trasformare radicalmente i frammenti della nostra parte. In questa notte apparentemente senza stelle, il nostro noi si forma riconquistando la capacità di afferrare le tracce dell’aurora».
* * * *
«As a first objection, we might ask who said that human civilisation is indeed capital’s dearest concern». Tradurre significa tradire, si dice. Questo non è un tradimento linguistico per rendere comprensibile il pensiero. Questo è un tradimento del pensiero per rendere malleabile il linguaggio. Invece no, il pensiero è proprio quello: «Ma prima di tutto, chi vi dice che ci sta a cuore la civiltà dell’uomo?». La liquidazione definitiva del lessico umanitario universalista viene qui ritradotta in quel lessico. Per essere chiari: la responsabilità non è del lavoratore che ha tradotto Operai e capitale. La responsabilità è dell’industria che quel lavoro comanda. Quando Lenin arriva in Inghilterra, l’Inghilterra tenta di edulcorare Lenin, di depoliticizzarlo, di svuotarlo. Il pensiero debole è sempre uno strumento al servizio del pensiero dominante.
L’umanitarismo e l’universalismo sono infatti il linguaggio della macchina capitalistica. L’algoritmo, se preferite. Chi parla quella lingua si colloca nel campo del nemico: è magari l’ala sinistra di quel campo, ovvero chi permette alla squadra nemica di fare gol e vincere. Invadere il terreno di gioco, interrompere la partita, cambiare campo: ecco il nostro problema. Finché ci crogioliamo nei riconoscimenti e nelle gratificazioni che in quello stadio riceviamo, non penseremo la rivoluzione. E senza pensiero, senza pensiero forte, non c’è rivoluzione. Possiamo pertanto chiedere al nemico di essere politicamente corretto, accetterà molto volentieri. Perché la politica è nelle sue mani, dunque più è corretta e più resterà nelle sue mani. Possiamo perfino infervorarci nella critica del nemico e chiedergli che rispetti il diritto a esprimere le nostre opinioni. Certamente, risponderà: perché nelle sue mani sono il diritto e l’opinione, perciò nelle sue mani è quella critica. Potete dire tutto quello che volete, nella misura in cui tutto quello che dite sviluppa e innova il gioco. Basta che continuiate a giocare.
Vediamo attorno a noi confusione più che sbigottimento, disinteresse più che scandalo. Soprattutto in fasi come questa, è necessario un machiavelliano ritorno ai princìpi. Non per contemplare il passato, ma per avanzare contro il presente. «La tradizione è la salvaguardia del fuoco, non l’adorazione delle ceneri» sentenzia il Mahler dello spirito libero. Allora, ricordiamo per procedere: l’interesse generale è sempre l’interesse del capitale. L’interesse generale è il punto di vista di parte borghese. Fare del punto di vista di parte borghese l’interesse generale, ecco l’ideologia. È la mistificazione in senso marxiano: non come sinonimo di menzogna, bensì occultamento degli interessi di parte. È un velo opaco che copre la contrapposizione tra le classi, una contrapposizione che nelle fasi normali è potenziale o confusa, implicita, in fasi eccezionali è reale e aperta, esplicita. Avere accettato l’ideologia universalista e umanitaria è stato l’errore di base del marxismo. Ha significato velare la lotta di classe, negarne la possibilità di rottura, ovvero ridurla a puro gioco di aggiustamento nelle relazioni del diritto borghese. Per questo bisognava ripartire da Marx e da Lenin per affermare che solo dalla parte si può afferrare il tutto, rovesciarlo, spezzarlo. Il punto di vista è irriducibilmente parziale e unilaterale, oppure non è punto di vista.
E quindi? Per spezzare quella macchina, bisogna innanzitutto spezzare quel linguaggio. Con la forza. «Il sociologo comincia a leggere il Capitale dalla fine del III libro e interrompe la lettura quando si interrompe il capitolo sulle classi. Poi, da Renner a Dahrendorf, ogni tanto qualcuno si diverte a completare ciò che è rimasto incompiuto: ne viene fuori una diffamazione di Marx, che andrebbe come minimo perseguita con la violenza fisica». Chi quella macchina non la vuole spezzare, da quella macchina trae giovamento e benefici. Chi vuole difendere l’umanità, in quell’umanità occupa una posizione privilegiata. Chi si innamora della cultura si innamora di se stesso. E chi si innamora di se stesso, si innamora del capitale che ci portiamo dentro. Solo odiando quel maledetto capitale che ci fa parlare così, cioè solo arrivando a odiare noi stessi possiamo conquistare il pensiero rivoluzionario. Conosce veramente chi veramente odia: non è un slogan, è un presupposto.
Dalla parte di chi si sbaglia
Sgombriamo subito il campo da un equivoco che non è più nemmeno tragico, ma farsesco. Chi è questo noi a partire da cui parliamo? Non lo sappiamo ancora. Potremmo dire in senso generico che è il noi di chi vuole abolire lo stato di cose presente. È il noi non degli sfruttati, bensì di chi lotta contro lo sfruttamento. Ancora troppo generico, appunto. Incarnare quel noi, definirlo concretamente, è il primo compito politico, teorico e pratico. Però possiamo dire con precisione scientifica, di una scienza di parte tutta da ipotizzare, cosa questo noi non è. Non è il noi della sinistra. Anzi, è un noi contro la sinistra. Non ci perderemo in inutili distinguo tra la sinistra costruita o quella da costruire, la sinistra reale o quella ideale. Parliamo della sinistra sans phrase. Perché non è diventata questa. È ab origine stata questa: umanitaria, universalista, progressista, sviluppista, ovvero per l’umanità, l’universalismo, il progresso e lo sviluppo della civiltà capitalistica. Piange sulle vittime affinché restino tali. Odia la forza e l’autonomia di classe perché dove ci sono queste, non c’è più lei.
Dobbiamo allora ritornare all’operaismo per ripetere la rottura con la sinistra, così come gli operaisti erano ritornati a Marx e Lenin contro il marxismo e il leninismo, e la loro dogmatica congiunzione con quel trattino storicistico. «Altri, tutti, avevano trovato lì dentro quello che, secondo noi, non si deve nemmeno cercare: un nuovo processo intellettuale del mondo, che è poi un altro indirizzo per i propri studi; una nuova scienza della vita, e cioè tranquillità per se stessi nello scegliersi un posto nella società; una nuova coscienza della storia, la cosa peggiore di tutte e la più pericolosa, perché porta a firmare in bianco l’atto notarile di riconsegna nelle mani dell’operaio della sua essenza umana smarrita, eredità concessa dal padrone che muore e non a caso rifiutata, disprezzata, dal lavoro vivente». Non un tranquillizzante trattino, bensì una produttiva tensione va posta tra i due. Lenin ha strappato il materialismo di Marx al determinismo e all’oggettivismo, e l’ha aperto alla contingenza e alla soggettività. Ha spaccato la logica ferrea del Moro, quella inevitabile consequenzialità di passaggi che disegna il circolo vizioso del capitale. Marx ha interpretato la catena del dominio capitalistico, Lenin si è posto il problema di spezzarla. Non dove il capitale è più debole, ma dove la classe operaia è più forte. L’XI Tesi su Feuerbach è stata trasformata nelle Tesi di aprile.
Contingenza e processo, processo e contingenza. Il partito si costruisce dentro questo rapporto. Non pensare mai i due termini separatamente, non pensarli mai linearmente. La contingenza del conflitto va agita contro il processo capitalistico, il processo di organizzazione va sviluppato per la contingenza della rottura. Qui, in questo rapporto, Alquati completa Tronti. Conricerca, ricomposizione, controsoggettività significano questo: tenere insieme politico e soggetto, impedirne la reciproca autonomizzazione, organizzarne il rapporto dentro e contro il processo, dirigerli verso la rottura.
La rottura con cosa? La rottura con la Storia, senza cui non c’è possibilità di rivoluzione. Il marxismo ha pensato di poter raccogliere le bandiere che la borghesia aveva lasciato cadere nel fango, quelle della linearità dello sviluppo, della Storia appunto. Si è collocato su quella supposta freccia, per portarla avanti. Senza rendersi conto che, così facendo, si è condannato a percorrere forzatamente le tappe che conducono al telos della civiltà capitalistica. Un telos che non sarà mai pienamente raggiunto, e proprio per questo viene continuamente riprodotto. Più che lo stalinismo, è questa la tragedia. O meglio, lo stalinismo è stato questo, al pari della socialdemocrazia. Quella freccia andava spezzata, quella storia interrotta, un’altra storia cominciata. Il 1917 andava agito contro il 1789, non in continuità con esso.
E oggi? Oggi ricominciamo da qui. Perché i militanti rivoluzionari ricominciano sempre. E ai filistei che ci accusano di essere rumorose minoranze, rispondiamo che il problema è il loro essere maggioranze silenziose. Contro quella fredda logica della ragione priva dell’odio di classe è già detto tutto lì, nei nostri princìpi: «Quando da una parte troviamo quelli che dicono: domani scoppia tutto e il vecchio mondo crollerà, e dall’altra parte quelli che dicono: per cinquant’anni non si muoverà niente, e i primi sono smentiti dai fatti e i secondi hanno ragione dai fatti, – noi qui stiamo con i primi, noi qui dobbiamo stare con quelli che si sbagliano». Solo dalla parte di chi si sbaglia possiamo mandare gambe all’aria il mondo di chi ha ragione.
Indifferenti, già le sentiamo le solite voci: siete primitivisti, nostalgici, o rossobruni, per usare l’ultima etichetta creata dalla doxa di sinistra. I caricaturali tifosi di una potenza mitologica ci fanno altrettanta pena dei tifosi di una debolezza reale. Abbandoniamoli, definitivamente, davanti alla pay tv della loro sinistra insignificanza. Parafrasiamo Operai e capitale: siamo contrari alla società presente, all’ideologia nuovista e accelerazionista che la impregna, non per questo siamo favorevoli al mondo del passato; siamo contro lo sviluppo del capitale, perché siamo per lo sviluppo della forza comunista; siamo contro la sinistra, perché il contrario di destra è rivoluzione. Per dire no al nuovo di oggi, non è necessario dire sì al vecchio di ieri. Siete voi che non riuscite a uscire dalle coordinate imposte dal nemico, a ragionare al di fuori dello schema di posizionamento nell’assemblea nazionale francese: sinistra o destra, progresso o reazione, democrazia o fascismo, innovazione o conservazione, illuminismo o barbarie. Per continuare a marciare sulla testa dei re, decapitiamo definitivamente Rousseau e Voltaire. Rompere la geometria della Storia borghese è la scoperta, tutta da compiere, della nostra geometria non euclidea.
Terra e mare
Di recente Tronti ha riformulato in termini schmittiani il rapporto antagonistico fondamentale: la classe operaia sta al capitale come la terra sta al mare. La modernità liquida, per usare un gergo sociologico di successo, è la prosecuzione della modernità capitalistica con altri mezzi. È una modernità che è riuscita – temporaneamente – a sradicare la lotta e deterrestrizzare la classe. E, come sappiamo, senza lotta non c’è classe. Tanti si sono entusiasmati nel riempirsi la bocca del lessico deleuziano della territorializzazione e della deterritorializzazione, senza rendersi conto che esso descrive esattamente il movimento del capitale, e specificamente della sua finanziarizzazione. Il mare che avvolge e travolge gli attori produttivi, sciogliendone la volontà di contrapposizione e la possibilità di aggregazione, ha continuamente bisogno dei rubinetti terricoli in cui il valore si condensa.
Già a suo tempo il Carl senza K ci aveva spiegato che la metamorfosi sostanziale è avvenuta quando il Leviatano, da grande pesce che era, si trasformò in macchina. Macchina di dominio. Macchina capitalistica. «Tra l’elemento del mare e l’esistenza dell’uomo si frappose un dispositivo meccanico»: è il sistema automatico di macchine di cui ci parla l’altro Carl, quello con la K, il sistema in cui la soggettività operaia viene innervata dai dispositivi del dominio. Il capitale non ci comanda dall’esterno, ce lo portiamo dentro: ci fa muovere il suo sistema, pensa con la nostra testa, siamo parlati da lui. La macchina liquida è la fase suprema del capitalismo, perché il dominio che ha forma molle è il peggiore che esista. Ingarbuglia maledettamente la questione leniniana: dove colpire? Quando si tentò senza riuscirci di portare Lenin in Inghilterra, significava anche questo: la forza terrestre operaia contro la macchina liquida del mostruoso pesce.
Ora, ritornando a quel brano da cui siamo partiti, capiamo perché si tenti di sciogliere l’acciaio del pensiero operaista nel mare acido del Leviatano anglosassone. Un mostro che non si presenta con il volto feroce dell’assolutismo, ma con la faccia suadente della democrazia. Una è la condizione in cui quasi nessuno può parlare e però, potenzialmente, tanti desiderano ascoltare; l’altra è la condizione in cui tanti possono parlare e però, concretamente, quasi nessuno desidera ascoltare. La democrazia è la prosecuzione dell’ideologia umanitaria con gli stessi mezzi. Dunque la democrazia è borghese e non può essere altrimenti. Aver lasciato la critica radicale della democrazia nelle mani dei reazionari è l’errore imperdonabile. Non è stato un arretramento tattico, ma una sconfitta strategica. Ritorniamo ad affermare: siamo contro la democrazia, perché siamo per la libertà. Ricerca della libertà comunista o accettazione della libertà liberale, affermazione del pensiero libero oppure conformazione alla libertà di pensiero: questo resta il problema, da qui passa la scelta di vita del militante, ecco il nodo gordiano da tagliare. Con una certezza, oggi ancora più acuta: non c’è possibilità di mediazione. O si sta da una parte, o si lavora per l’altra. O si agisce per esasperare le contraddizioni del capitale, o si compatisce l’umanità per risolvergliele. Amico oppure nemico.
Per affrontare questo enorme compito di ricerca, teorica e pratica, dobbiamo ripercorrere e far nostra, per piegarla e rovesciarla, per strapparla dalle mani dei reazionari, un’intera genealogia della modernità, chiamiamola provvisoriamente antropologia negativa. Da Machiavelli a Schmitt, da Musil a Gehlen a Jünger poggiando sull’architrave Nietzsche, si è accumulato un arsenale da cui attingere per spezzare la dialettica tra fede nella bontà dell’uomo e inevitabilità dell’autodistruzione, tra progresso e conservazione. Per contendere con la forza Marx a una lettura teleologica, per sottrarlo aggressivamente alle sue sinistre ambiguità, per piegarlo in una direzione anti-illuministica. La ripercorriamo per arrivare a dire che l’uomo non è buono, e proprio per questo il comunismo è possibile.
Per un simile compito meglio ripartire da Hobbes, non da Spinoza. Il mostro di Malmesbury è terrorizzato dal mostro della lotta di classe, ovvero della guerra civile. Che poi, a un certo grado di intensità, sono la stessa cosa. Per questo vuole uno Stato assoluto, per sconfiggere la potenza assoluta della libertà e dell’eguaglianza. L’ordine geometrico di Spinoza è l’ordine dello Stato liberale: al suo centro vi è l’individuo, è suo il corpo che – dentro gli immutabili confini di quell’ordine costituito necessario – può tutto. In tale condizione deterministica e oggettiva, da cui non si sfugge, in cui non c’è spazio per l’azione della soggettività, l’unico correttivo è la tolleranza. Noi non chiederemo mai al padrone di essere buono, solo il servo lo chiede. Nel momento in cui il servo non riconosce più il padrone, lì si apre la possibilità della lotta di classe. La storia, la nostra storia, ci ha insegnato che gli unici momenti in cui il capitale è sceso a patti con il proprio nemico è stato quando gli è stata puntata una pistola alla testa, oppure quando ha comprato i militanti della controparte. Noi possiamo utilizzare una tregua, solo a patto che sia armata, soltanto per guadagnare una posizione più avanzata nel rilancio in avanti del conflitto. Non rifiutiamo affatto la tattica, perché il politico – in quanto azione volta a trasformare e sovvertire la realtà dei rapporti di forza – è fatto anche di tattica. Il punto è che soltanto a partire dalla rigidità della strategia si può agire la flessibilità tattica. Se manca quella rigidità, questa flessibilità si chiama opportunismo.
La democrazia assoluta – sempre che questo concetto si debba a Spinoza e non ai suoi pappagalleschi follower – è l’assoluto dominio del capitale. Un dominio mistificato, laddove Hobbes per controbattere alla paura del mostro proletario non ha timore di esibire la paurosità del mostro borghese. Presentiva quello che Operai e capitale avrebbe esplicitato qualche secolo dopo: quando la classe operaia rifiuta politicamente di farsi popolo, a quel punto si apre la via più diretta per la rivoluzione. Il bellum omnium contra omnes diviene, può divenire, guerra di una parte contro l’altra parte. Qui Hobbes va corretto non nella sua antropologia pessimistica, come vorrebbero gli atterriti sinistri illuminati, ma al contrario laddove rischia di sdrucciolare sul versante liberale: il politico non è il patto tra individui, ma il conflitto tra le parti. Da Machiavelli a Schmitt, possiamo così rimettere il realismo sui piedi dello scontro collettivo tra amico e nemico.
Non è questione di teologia della trascendenza o teleologia dell’immanenza. Non c’è alcun ordine geometrico a cui dobbiamo sottostare, non c’è intervento divino che ci salverà. La nostra sostanza, quindi, non è Dio e non è oggettivamente presente nelle cose – quella sostanza qui non è altro che il progresso del capitale. La potenza infatti non ci appartiene per necessità divina, ma per volontà materiale. E non appartiene mai all’individuo, che in sé è solo e debole; appartiene sempre a una parte collettiva da costruire. Il problema perciò non è adeguare i soggetti all’ordine naturale, ma organizzarli contro quell’ordine: sovvertire attraverso la processualità dell’iniziativa il meccanicismo dello sviluppo. Insomma, l’unica sostanza per noi è la lotta di classe: è sempre possibile ed è sempre contingente. Il nostro panteismo si chiama materialismo rivoluzionario.
Tutto ciò potrà far sobbalzare le anime belle, peggio per loro. Sappiano che la libertà non è necessaria, ma possibile. La libertà non è un diritto, bensì una conquista. È l’odio per i nostri nemici che ci porta ad amare i nostri amici. L’affermazione rivoluzionaria parte sempre dalla negazione dell’esistente. Chi oggi rifiuta l’odio e parla delle passioni liete, è perché ama ed è amato da un sistema che produce tristezza. Allora ripartiamo da Hobbes contro di lui: far paura ai nostri disumani nemici, non far compassione ai nostri filantropici amici. Più guadagniamo simpatia nello spazio dell’opinione pubblica, più ci diventa antipatica la lotta di classe. Finché il terreno dell’opinione pubblica è occupato dal nemico bisogna spararci sopra, senza lacrime per la libertà di espressione.
Elogio del demone
Continua, devi arrivare a tot caratteri. E poi, metti la citazione, spiega, fai riferimenti scientifici. E invece no, ci fermiamo qui. Prendere o lasciare. Perché il nostro maestro ci ha insegnato, in via definitiva, che la scrittura è sempre una cattiva azione. Bisogna compierla, con la consapevolezza di non avere altra scelta che usare le armi del nemico, con il pericolo mortale di innamorarci delle nostre cattive azioni. E non perdiamo tempo a parlare della scrittura accademica, quella appunto delle citazioni, delle spiegazioni, dei riferimenti scientifici: lì non c’è possibilità di contro-utilizzo, lì c’è solo il grottesco linguaggio della mistificazione borghese. Non c’è peer review che tenga, perché i nostri pari non stanno nelle grigie sale delle conferenze universitarie, dove si compete sulla performance, in quelle infami macchine di depoliticizzazione del pensiero e della vita, dove la durezza della prassi rivoluzionaria viene tradotta nella liquidità dell’opinione e del consumo, dove il sapere materiale delle lotte è catturato e svuotato nel sapere astratto del valore, in cui puoi dire tutto quello che vuoi perché tutto quello che dici non ha alcuna traduzione concreta. Vade retro.
Ci fermiamo qui perché non c’è più altro da aggiungere su questo livello. C’è tutto da aggiungere su un altro livello: quello su cui – per dirla con il Moro di Treviri che rispondeva alle petulanti preoccupazioni di Vera Zasulič – non si tratta più di un problema teorico da risolvere, si tratta di un nemico da abbattere. O, restando al tema del testo: «Ricominciare a camminare vuol dire immobilizzare l’avversario per poterlo meglio colpire». Per affrontare un simile compito bando ai distinguo, al timore di essere fraintesi, al politicamente corretto, ché al solo sentirlo nominare istintivamente la mano corre alla fondina. Sempre, e in tempi come questi soprattutto, bisogna impugnare l’accetta. Per immobilizzare il nemico democratico, serve una scrittura anti-democratica. Operai e capitale ne costituisce l’incarnazione: non ammette possibilità di contraddizione verbale, ma solo di messa a verifica reale. Il linguaggio è uno strumento di offesa, «tutti insieme dobbiamo arrivare ad usare quella che chiamano cultura come si usa un martello e un chiodo per appiccare il quadro». Ancor di più e ancor prima di scrivere: solo se pensiamo con il martello, non ci faremo mai catturare dai dispositivi della macchina capitalistica.
È noto che «La linea di condotta» si apre con il rifiuto del discorso sul metodo, cioè il metodo della scienza borghese. E tuttavia, dell’operaismo a noi resta innanzitutto un metodo, un metodo contro la scienza borghese. O, per usare le sue parole successive, uno stile. Quando lo possiedi, o forse potremmo dire quando ne sei posseduto, non riesci più guardare il mondo in altro modo. Non riesci più a smettere di odiare questo mondo, e questa umanità. Perché questo mondo e questa umanità basta guardarli per odiarli. E odiare noi stessi che ne facciamo parte. Sottolineiamo il verbo possedere, in forma al contempo attiva e passiva. Perché lo stile operaista è come un demone dostoevskijano. È l’ossessione che con terrore e malcelata ammirazione osservava il reazionario Solženicyn nella mente inquietantemente indemoniata di Lenin a Zurigo. Questo stile non ci viene trasmesso in eredità, non ci sono testamenti che valgano. Questo stile va conquistato reinventandolo continuamente, senza rispetto filologico, senza timori reverenziali. Altrimenti diventa una litania, una chiesa, una scuola: tutto ciò che l’operaismo non è stato, tutto ciò che l’operaismo ha rifiutato e con cui ha da principio rotto, tutto ciò che è facilmente catturabile dal nostro nemico.
Per imparare o reimparare questa lingua, cioè questo stile, dobbiamo sempre tenere a mente l’insegnamento de Il 18 brumaio: «il principiante che ha imparato una lingua nuova la ritraduce continuamente nella sua lingua materna ma non riesce a possederne lo spirito e ad esprimersi liberamente se non quando si muove in essa senza reminiscenze, e dimenticando in essa la propria lingua d’origine». Ciò ha ancora più importanza nell’odierno contesto di crisi della soggettività politica. Questa crisi non è per noi il disperante problema, da qui si apre la possibilità della soluzione. Abbandoniamo al loro destino chi vuole rifugiarsi nei porti sicuri offerti dal mare del capitale, dimentichiamo la sua sinistra lingua, liberiamoci dalle sue reminiscenze. Noi ci rimettiamo a navigare alla ricerca di una terra della forza, di una forza di terra. Una forza oggi mistificata e usata dal padrone. Per strappare quella forza dalle sue mani, per rovesciarla contro il capitale.
Quando la nostra bussola impazzisce vuol dire che la rotta della nave nemica è salda. Forgiare nuove bussole per una vecchia rotta, ecco perché rileggere Operai e capitale. Non per crogiolarci nella nostalgia, bensì per riarmare il pensiero. E poi andiamo avanti: non facendoci trascinare nel post, ma conquistando l’oltre. Non stiamo parlando di utopia, no. Stiamo parlando del sogno rivoluzionario, quello che sogna solo chi organizza il che fare. Un sogno che poggia saldamente i suoi piedi e le sue mani nell’ambiguità del reale per condurre l’unilateralità della testa verso una tendenza possibile. Una tendenza di minoranza, che si apre laddove la tendenza maggioritaria si spacca.
Abbiamo l’impressione di non vederla, eppure la tigre è lì, sempre pronta a balzare. Non in un imprecisato futuro, ma contro un presente determinato. Scommettiamo su una profezia, la forza di vedere quello che gli altri non vedono, la volontà di dire quello che gli altri rifiutano di ascoltare, il progetto di scomporre il tutto del capitale per ricomporre e dunque trasformare radicalmente i frammenti della nostra parte. In questa notte apparentemente senza stelle, il nostro noi si forma riconquistando la capacità di afferrare le tracce dell’aurora.
































Add comment