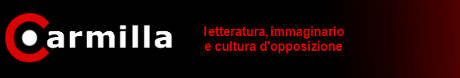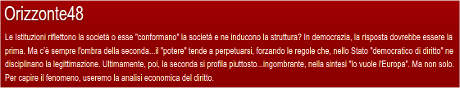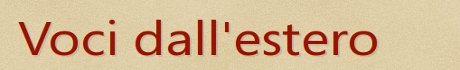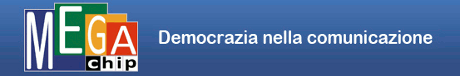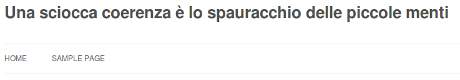- Details
- Hits: 2635
Partecipate pubbliche e miti privati: una visione d'insieme
Giacomo Gabbuti
 È ripartita, come prevedibile, la crociata contro le imprese partecipate dallo Stato – quelle imprese, cioè, “normali”, o “private” da un punto di vista del diritto, ma tra i cui azionisti figura lo Stato in una delle sue declinazioni a livello locale (quando è l’azionista prevalente, dovrebbero dirsi “controllate”). Del resto, per garantire coperture impossibili alle sue goffe misure di politica economica, il governo dimostra tutta la sua scarsa originalità e innovazione promettendo ancora una volta di eliminare la “spesa pubblica improduttiva”. Nel tentativo di dare un volto a questa creatura mitologica (forse Renzi pensava di trovare nel bilancio dello Stato la voce “spesa improduttiva”, da tagliare sic et simpliciter), torna buona la bestia delle partecipate. Non solo – ci tiene a dirci Repubblica – esse sono tutte in perdita:ma la perdita sarebbe addirittura proporzionale alla presenza dello Stato! Del resto, l’equazione è da prima elementare: se pubblico = brutto, allora + pubblico = + brutto. Talmente vero che entra in 140 caratteri, e se la metti su una slide lascia tanto spazio per le foto.
È ripartita, come prevedibile, la crociata contro le imprese partecipate dallo Stato – quelle imprese, cioè, “normali”, o “private” da un punto di vista del diritto, ma tra i cui azionisti figura lo Stato in una delle sue declinazioni a livello locale (quando è l’azionista prevalente, dovrebbero dirsi “controllate”). Del resto, per garantire coperture impossibili alle sue goffe misure di politica economica, il governo dimostra tutta la sua scarsa originalità e innovazione promettendo ancora una volta di eliminare la “spesa pubblica improduttiva”. Nel tentativo di dare un volto a questa creatura mitologica (forse Renzi pensava di trovare nel bilancio dello Stato la voce “spesa improduttiva”, da tagliare sic et simpliciter), torna buona la bestia delle partecipate. Non solo – ci tiene a dirci Repubblica – esse sono tutte in perdita:ma la perdita sarebbe addirittura proporzionale alla presenza dello Stato! Del resto, l’equazione è da prima elementare: se pubblico = brutto, allora + pubblico = + brutto. Talmente vero che entra in 140 caratteri, e se la metti su una slide lascia tanto spazio per le foto.
A prescindere dalla serietà di un governo che promette di coprire spese certe con tagli tutti da definire, sembra necessario provare a decostruire questa continua narrazione. Difficilmente otterremo l’ascolto del governo, ma speriamo almeno di aiutare i lettori di Repubblica a capire se dar retta o meno alla nuova editorialista, l’economista italo-americana Mariana Mazzucato, che proprio dalle colonne di quel giornale tenta di sostenere opinioni ben diverse.
- Details
- Hits: 2943
Sbadigliare, vomitare o mozzare teste?
Sebastiano Isaia
One thing I can tell you is you’ve got to be free (Come Together, Beatles).
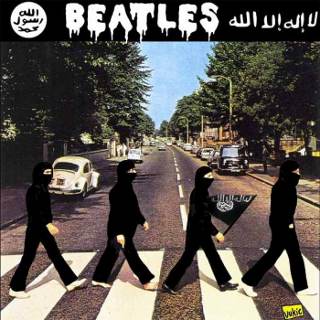 Secondo il filosofo, e opinionista assai popolare in Inghilterra, Roger Scruton «L’assassino di James Foley è il prodotto del multiculturalismo inglese. Tutto quello che il multiculturalismo ha ottenuto è distruggere una cultura pubblica condivisa, e al suo posto ci ha messo un vuoto che fa sbadigliare». E qui, vittima del noto contagio, devo un attimo interrompere la citazione, per sbadigliare appunto. Fatto! Continuo: «Il più grande bisogno umano non è la libertà, come pensano i liberal, ma l’obbedienza, come hanno capito i musulmani» (Sgozzati dal multiculturalismo, Il foglio, 26 agosto 2014). Una volta Kant formulò – l’apparente – paradosso che segue: «Ragionate quanto volete e su ciò che volete, ma ubbidite!». È su questo “paradosso” che intendo dire qualcosa.
Secondo il filosofo, e opinionista assai popolare in Inghilterra, Roger Scruton «L’assassino di James Foley è il prodotto del multiculturalismo inglese. Tutto quello che il multiculturalismo ha ottenuto è distruggere una cultura pubblica condivisa, e al suo posto ci ha messo un vuoto che fa sbadigliare». E qui, vittima del noto contagio, devo un attimo interrompere la citazione, per sbadigliare appunto. Fatto! Continuo: «Il più grande bisogno umano non è la libertà, come pensano i liberal, ma l’obbedienza, come hanno capito i musulmani» (Sgozzati dal multiculturalismo, Il foglio, 26 agosto 2014). Una volta Kant formulò – l’apparente – paradosso che segue: «Ragionate quanto volete e su ciò che volete, ma ubbidite!». È su questo “paradosso” che intendo dire qualcosa.
Per un verso Scruton affonda il coltello nella burrosa, e sempre più screditata (nonché stucchevole), ideologia multiculturalista, la quale ama celare i reali contrasti e antagonismi sociali (d’ogni tipo: di classe, di genere, di razza, di religione) dietro una tolleranza, anch’essa ridotta a mera finzione ideologica*, che sempre più mostra la sua vera natura di strumento al servizio dello status quo sociale. Per altro verso egli, suo malgrado, tocca un nodo fondamentale della condizione disumana nell’epoca del dominio totalitario e planetario degli interessi economici (capitalistici): la reale mancanza di libertà di tutti gli individui. Oggi la «libera scelta» non solo è un inganno, un’ipocrisia (soprattutto quando si presenta in guisa elettoralistica), ma è anche un’odiosa arma di oppressione psicologica di massa: «Nessuno ti ha obbligato a scegliere quel lavoro, quella merce, quella persona, quel partito. Guarda il ben di Dio che ti offre il mercato (delle merci, della politica, delle idee, delle religioni, delle amicizie, dei desideri)! Oggi la società ti offre perfino la libertà di scegliere il sesso che meglio aderisce alla tua più intima personalità. Anziché lamentarti, impara dunque a usare meglio il tuo libero arbitrio».
- Details
- Hits: 2724
L’alternativa radicale alla globalizzazione
Guido Viale
«Riterritorializzare» i processi economici. Se è stata la globalizzazione a spalancare le porte alla competitività universale, noi dobbiamo pensare e praticare alternative che valorizzino i benefici dell’unificazione del pianeta in un’unica rete di rapporti di interdipendenza e di connettività
 Molte delle minacce che incombono sul nostro pianeta – e di cui poco si parla – sono già fatti. Innanzitutto la data che renderà irreversibile un cambiamento climatico radicale e devastante si avvicina. A questo vanno aggiunte tutte le altre forme di inquinamento e di devastazione, sia a livello globale che locale, che lasceranno a figli e nipoti un debito ambientale ben più gravoso dei debiti pubblici su cui politici ed economisti si stracciano le vesti.
Molte delle minacce che incombono sul nostro pianeta – e di cui poco si parla – sono già fatti. Innanzitutto la data che renderà irreversibile un cambiamento climatico radicale e devastante si avvicina. A questo vanno aggiunte tutte le altre forme di inquinamento e di devastazione, sia a livello globale che locale, che lasceranno a figli e nipoti un debito ambientale ben più gravoso dei debiti pubblici su cui politici ed economisti si stracciano le vesti.
Governi e manager hanno per lo più cancellato il problema dalla loro agenda: la green economy promossa a quei livelli non è un’alternativa al trend in atto, ma una serie scollegata di misure, spesso dannose, che ne occupano gli interstizi. L’Italia, che ha una strategia energetica (Sen) recepita dal governo Renzi, ne è un esempio: ha impegnato cifre astronomiche nelle fonti rinnovabili a beneficio quasi solo di grandi speculazioni che devastano il territorio, ma dentro un piano energetico incentrato su trivellazioni e trasporto di metano in conto terzi. È una visione miope che distrugge, insieme all’ambiente, anche l’agognata competitività, e chiude gli occhi di fronte al futuro.
Viviamo ormai da tempo in stato di guerra: l’Italia – ma non è certo un’eccezione – è già impegnata con diverse modalità, tutte contrabbandate come «missioni di pace», su una decina di fronti.
- Details
- Hits: 2884
Marx contro il “marxismo”
di Sandro Moiso
Ettore Cinnella, L’altro Marx, Della Porta Editori, Pisa – Cagliari 2014, pp.182, € 15,00
 Già negli ultimi anni della sua vita Karl Marx dovette prendere le distanze da ciò che già allora si definiva come “marxismo”. Lo testimonia proprio il suo amico e sodale Friedrich Engels in una lettera a Eduard Bernstein del 2-3 novembre 1882, in cui afferma: “Ora, ciò che in Francia va sotto il nome di “marxismo” è in effetti un prodotto del tutto particolare, tanto che una volta Marx ha detto a Lafargue: “ce qu’il y a de certain c’est que moi, je ne suis pas marxiste”.
Già negli ultimi anni della sua vita Karl Marx dovette prendere le distanze da ciò che già allora si definiva come “marxismo”. Lo testimonia proprio il suo amico e sodale Friedrich Engels in una lettera a Eduard Bernstein del 2-3 novembre 1882, in cui afferma: “Ora, ciò che in Francia va sotto il nome di “marxismo” è in effetti un prodotto del tutto particolare, tanto che una volta Marx ha detto a Lafargue: “ce qu’il y a de certain c’est que moi, je ne suis pas marxiste”.
Anche se, in ultima istanza, sarà proprio Engels a codificare il “marxismo” nello sforzo di salvaguardare il lascito teorico del comunista di Treviri dopo la sua scomparsa, ancora nel 1890, in una lettera a J.Bloch si vedrà costretto a chiarire che:
“secondo la concezione materialistica della storia la produzione e riproduzione della vita reale è nella storia il momento in ultima istanza determinante. Di più né io né Marx abbiamo mai affermato. Se ora qualcuno distorce quell’affermazione in modo che il momento economico risulti essere l’unico determinante, trasforma quel principio in una frase fatta insignificante, astratta e assurda. La situazione economica è la base, ma i diversi momenti della sovrastruttura – le forme politiche della lotta di classe e i risultati di questa – costituzioni stabilite dalla classe vittoriosa dopo una battaglia vinta, ecc. – le forme giuridiche, anzi persino i riflessi di tutte queste lotte reali nel cervello di coloro che vi prendono parte, le teorie politiche, giuridiche, filosofiche, le visioni religiose ed il loro successivo sviluppo in sistemi dogmatici, esercitano altresì la loro influenza sul decorso delle lotte storiche e in molti casi ne determinano in modo preponderante la forma.
- Details
- Hits: 2083
Uniamo il pensiero ribelle!
Piotr Zygulski intervista Antonello Cresti
 Per iniziare, si presenti.
Per iniziare, si presenti.
Come recitano le mie biografie standard sono un saggista e compositore, più in generale un appassionato di idee, creazioni ed ambientazioni “nascoste”. Le mie assolute passioni sono la cultura tradizionale britannica, la controcultura e la musica underground, e utilizzo questo bagaglio di conoscenze non propriamente “mainstream” per approcciare da un punto di vista eccentrico anche altre problematiche. Ho pubblicato CD, libri, ho fatto programmi radiofonici, ho organizzato festival … Le vie della comunicazione culturale, insomma, mi intrigano tutte allo stesso modo!
Lo scorso anno ha lanciato il progetto “Idee In/Oltre”. Per quale motivo si è lanciato in questa avventura?
Idee In/Oltre nasce soprattutto dall’esigenza di coagulare un po’ di forze attorno ad un progetto di informazione/divulgazione non massificato. Usando facebook e i social network ci si rende conto che vi sono intelletti e spiriti liberi, ma che è difficile riunirli sotto un’unica sigla. Il blog che ho creato è un tentativo in questo senso, ed è anche un esperimento per capire quanto impatto possa avere un articolo (anche a mia firma) senza il supporto della testata di riferimento.
Devo dire che in periodo ancora invernale qualche piccolo “miracolo” è accaduto, con punte di svariate migliaia di lettori per singolo articolo. Conto quindi di continuare nel tentativo di affiancare mie collaborazioni esterne (da Il Manifesto a Aam teranuova, a Rockerilla etc…) a questo progetto più organico. E pluribus unum, insomma!
- Details
- Hits: 2393
Per il Papa siamo alla Terza Guerra Mondiale. Ha davvero ragione?
di Alfonso Gianni
Di fronte agli scenari bellici in Medio Oriente e Ucraina Bergoglio ha preso parola sostituendosi anche alla classica sinistra laica e pacifista. Ma forse sbaglia: si tratta piuttosto di una guerra civile prolungata senza frontiere, ove entrano in gioco una molteplicità di soggetti dai contorni imprecisi. Per un nuovo equilibrio mondiale
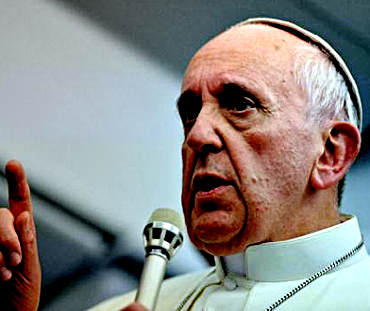 Papa Bergoglio sta godendo di un lungo momento di grazia nell’opinione pubblica mondiale. Ogni cosa che dice diventa di riferimento anche in ambito non confessionale. Ne sia esempio la sua recente dichiarazione sull’esistenza nel mondo contemporaneo di una terza guerra mondiale “a pezzetti”. Il Papa non è un analista politico e quindi non si può pretendere da lui l’esattezza della definizione, ma è un fatto che essa ha sfondato anche nel campo della sinistra laica che pensa di interpretare così le varie guerre guerreggiate sanguinosamente in corso, dall’Ucraina al Medio Oriente. D’altro canto, vista la mancanza di profondità nella ricerca analitica e di pensieri lunghi nel campo della sinistra non deve stupire né infastidire questa supplenza pontificia.
Papa Bergoglio sta godendo di un lungo momento di grazia nell’opinione pubblica mondiale. Ogni cosa che dice diventa di riferimento anche in ambito non confessionale. Ne sia esempio la sua recente dichiarazione sull’esistenza nel mondo contemporaneo di una terza guerra mondiale “a pezzetti”. Il Papa non è un analista politico e quindi non si può pretendere da lui l’esattezza della definizione, ma è un fatto che essa ha sfondato anche nel campo della sinistra laica che pensa di interpretare così le varie guerre guerreggiate sanguinosamente in corso, dall’Ucraina al Medio Oriente. D’altro canto, vista la mancanza di profondità nella ricerca analitica e di pensieri lunghi nel campo della sinistra non deve stupire né infastidire questa supplenza pontificia.
Resta da domandarsi se le cose stanno proprio così. Se il papa ci ha preso oppure no. Propenderei, con tutto il rispetto e – perché no – anche ammirazione per la figura di papa Francesco, per il no.
Per quanto molteplici siano i conflitti in corso, non credo che si possa parlare di una terza guerra mondiale seppure a macchia di leopardo e a bassa intensità. Siamo piuttosto di fronte – ma ogni definizione è per necessità, come diceva il grande filosofo, una limitazione – ad una guerra civile prolungata senza frontiere, ove entrano in gioco una molteplicità di soggetti dai contorni imprecisi.
- Details
- Hits: 5899
Il referendum contro l’austerità è un regalo alla Germania? Ma anche no
Keynesblog
Ovvero: perché chi non guarda contemporaneamente anche al lato dell’offerta rischia di prendere lucciole per lanterne, fischi per fiaschi e il keynesismo per la croce keynesiana; e ancora: perché la domanda è un vincolo esterno quanto il tasso di cambio fisso
 Sui social network ogni tanto (per fortuna piuttosto raramente) spuntano commenti di questo tipo a proposito del referendum contro l’austerità:
Sui social network ogni tanto (per fortuna piuttosto raramente) spuntano commenti di questo tipo a proposito del referendum contro l’austerità:
Commentatore-che-sa-tutto-lui-1:
In un regime di cambi fissi…e l’euro e’ esattamente quello, allentare l’ austerita’ servira’ a far ripartire l’export della Germania. Lo capirete quando sarete morti e sepolti dalla Troika.
Commentatore-che-sa-tutto-lui-2-ancor-più-educato-del-1:
ma neanche per il c***. scusate il francesismo, ma dire queste cose significa non averci capito una mazza. possiamo fare tutte le politiche keynesiane di sto mondo ma con l’euro andremmo sempre più a fondo. a cosa servirebbe espandere la spesa se la bdp va a picco per i deficit di parte corrente e per l’ingresso di capitali a bassa inflazione? a un cavolo di nulla se non a portarci ad una agonia senza fine.quindi basta che sta balla che la colpa è dell’austerità. la colpa è della moneta euro. punto.
Qualcosa ci dice che gli autori di queste perle sono lettori accaniti di altri blog. Lasciamo perdere le polemiche (che taluni condiscono con accuse di “collaborazionismo” e “tradimento”). Stiamo al merito. Hanno ragione o hanno torto questi due commentatori?
Hanno torto non una ma due volte, perché gli argomenti sono in realtà due, entrambi erronei. Vediamoli.
- Details
- Hits: 2017
Le "due crisi" e il nodo della sovranità
Draghi al telefono con Merkel
Quarantotto
 "Il Cancelliere tedesco Angela Merkel avrebbe chiesto chiarimenti al presidente della Bce, lamentando il fatto che Draghi avrebbe posto maggior accento sull’opportunità di riforme strutturali piuttosto che sulla necessità di mantenere l’austerità di bilancio, per rafforzare la crescita in Europa. Lo rivela il Der Spiegel. Ma la Bce smentisce: «È inesatto il fatto che la Merkel abbia chiamato Draghi per contestare le frasi dette a Jackson Hole», afferma il portavoce della Bce, senza fornire i dettagli ma confermando implicitamente che ci sia stata la telefonata. «Il contenuto della conversazione - aggiunge il portavoce - non lo commentiamo e non lo riveliamo».
"Il Cancelliere tedesco Angela Merkel avrebbe chiesto chiarimenti al presidente della Bce, lamentando il fatto che Draghi avrebbe posto maggior accento sull’opportunità di riforme strutturali piuttosto che sulla necessità di mantenere l’austerità di bilancio, per rafforzare la crescita in Europa. Lo rivela il Der Spiegel. Ma la Bce smentisce: «È inesatto il fatto che la Merkel abbia chiamato Draghi per contestare le frasi dette a Jackson Hole», afferma il portavoce della Bce, senza fornire i dettagli ma confermando implicitamente che ci sia stata la telefonata. «Il contenuto della conversazione - aggiunge il portavoce - non lo commentiamo e non lo riveliamo».
Senza citare fonti, la testata tedesca ha riferito che sia la Merkel sia il Ministro delle finanze Wolfgang Schaeuble avrebbero telefonato al numero uno dell’Eurotower, la scorsa settimana, per chiedergli chiarimenti riguardo il suo intervento fatto a Jackson Hole la scorsa settimana.
In quell’occasione Draghi aveva sostenuto che sarebbe «utile» che la politica monetaria della Bce fosse fiancheggiata anche da «un ruolo maggiore della politica fiscale» nel quadro di importanti riforme strutturali. In particolare, Draghi aveva detto: «Nessuna quantità di aggiustamenti fiscali o monetari può sostituire le necessarie riforme strutturali: la disoccupazione strutturale era già molto alta nella zona euro prima della crisi e le riforme strutturali nazionali per affrontare questo problema non possono più essere ritardate».
- Details
- Hits: 2667
Il declino del lavoro standard
di Maurizio Fontana
 Come attestano i dati più recenti sulle tipologie occupazionali, il processo di frammentazione del lavoro dentro la crisi ha subito nel nostro paese un’accelerazione, favorita dai provvedimenti legislativi assunti da tutti i governi succedutisi dall’inizio della crisi, che non ha eguali in Europa. Per quanto la crescente precarizzazione del lavoro sia una tendenza di fondo omogenea a livello continentale, come conferma lo studio Accessor reso pubblico lo scorso autunno (studio che peraltro ha anche evidenziato la connessa contrazione del welfare previdenziale collegato alle prestazioni lavorative atipiche), in Italia il decreto legge del duo Renzi-Poletti (34/2014), con l’introduzione della a-causalità totale nel rapporto di lavoro a termine, ha aggiunto all’ordinamento l’ennesima nuova fattispecie di contratto non standard che rende il lavoro a tempo pieno e indeterminato sempre più residuale, favorendo ulteriormente una tendenza che vede già da due anni le assunzioni a tempo pieno e indeterminato attestarsi intorno al 20% del totale dei rapporti di lavoro avviati. Secondo i dati, aggiornati all’inizio del 2013, forniti dai sindacati europei lo scorso autunno (vedi tabella), l’Italia si colloca un punto sotto la media dell’Unione Europea a 27 paesi per quanto riguarda le due principali tipologie di contratti atipici: il part-time (introdotto in Italia dalla legge 86 del 1984) e il contratto a tempo determinato (rilanciato dalla legge 56 del 1987).
Come attestano i dati più recenti sulle tipologie occupazionali, il processo di frammentazione del lavoro dentro la crisi ha subito nel nostro paese un’accelerazione, favorita dai provvedimenti legislativi assunti da tutti i governi succedutisi dall’inizio della crisi, che non ha eguali in Europa. Per quanto la crescente precarizzazione del lavoro sia una tendenza di fondo omogenea a livello continentale, come conferma lo studio Accessor reso pubblico lo scorso autunno (studio che peraltro ha anche evidenziato la connessa contrazione del welfare previdenziale collegato alle prestazioni lavorative atipiche), in Italia il decreto legge del duo Renzi-Poletti (34/2014), con l’introduzione della a-causalità totale nel rapporto di lavoro a termine, ha aggiunto all’ordinamento l’ennesima nuova fattispecie di contratto non standard che rende il lavoro a tempo pieno e indeterminato sempre più residuale, favorendo ulteriormente una tendenza che vede già da due anni le assunzioni a tempo pieno e indeterminato attestarsi intorno al 20% del totale dei rapporti di lavoro avviati. Secondo i dati, aggiornati all’inizio del 2013, forniti dai sindacati europei lo scorso autunno (vedi tabella), l’Italia si colloca un punto sotto la media dell’Unione Europea a 27 paesi per quanto riguarda le due principali tipologie di contratti atipici: il part-time (introdotto in Italia dalla legge 86 del 1984) e il contratto a tempo determinato (rilanciato dalla legge 56 del 1987).
- Details
- Hits: 3033
Attualità di Lacan
Federico Chicchi
 Ogni lettore che si rispetti lo sa bene: ci sono libri che si limitano ad aggiungere semplici didascalie e libri che producono concatenamenti, aprendo nuovi e imprevedibili orizzonti di ricerca. Questo secondo è certamente il caso di Attualità di Lacan (a cura di Alex Pagliardini e Rocco Ronchi per Textus edizioni, 2014), un libro imperdibile per chi non sia allergico a quella fondamentale passione dell’essere che lo psicoanalista francese definiva ignoranza.
Ogni lettore che si rispetti lo sa bene: ci sono libri che si limitano ad aggiungere semplici didascalie e libri che producono concatenamenti, aprendo nuovi e imprevedibili orizzonti di ricerca. Questo secondo è certamente il caso di Attualità di Lacan (a cura di Alex Pagliardini e Rocco Ronchi per Textus edizioni, 2014), un libro imperdibile per chi non sia allergico a quella fondamentale passione dell’essere che lo psicoanalista francese definiva ignoranza.
L’ignoranza è, non a caso rispetto a ciò che ci interessa sottolineare, quella passione che secondo il Lacan del Seminario I si situa sulla linea di giunzione del simbolico con il reale e che, in quanto terzo che introduce un’asimmetria tra amore e odio, fonda l’atto analitico. D’altronde, quando si prova a ricercare la verità in quanto tale, come negli intenti di questo volume, è, statene certi, perché ci si situa per intero nella dimensione appassionata dell’ignoranza (del desiderio di sapere), cioè proprio dove simbolico e reale confondono i loro confini.
Attualità è una parola che si declina al singolare o al plurale? In questo caso, nel caso di questo testo, direi al plurale. Ci sono infatti delle specularità, dei giochi allo specchio tra i diversi, tutti eccellenti, contributi, perché qui vengono supposte e proposte diverse attualità di Lacan. Alcune differenti argomentazioni che rivendicano una per una un’attualità dell’insegnamento lacaniano. I saggi che vengono presentati non sono infatti tutti interni alla stessa prospettiva “etica”.
Non si traccia qui una sola etica della psicoanalisi.
- Details
- Hits: 2383
“La nuova ragione del mondo” di Pierre Dardot e Christian Laval
Andrea Baldazzini
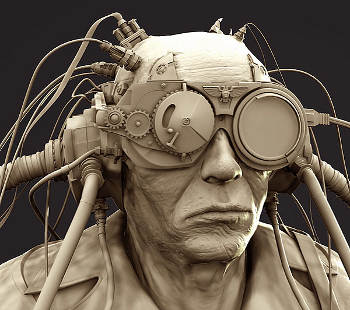 Partirò con un’apparente banalità: l’oggetto del presente studio, portato avanti a quattro mani da Laval e Dardot (sociologo il primo, professore di filosofia il secondo), non rappresenta solo il tema filosofico per eccellenza, ma costituisce anche il principio fondante, l’atto costitutivo, dell’intera società occidentale moderna, ovverosia la Ragione. Una Ragione che si è guadagnata la maiuscola conquistando la quasi totalità degli aspetti dell’esistenza individuale e collettiva, per usare un lessico habermasiano, colonizzando tanto la dimensione del ‘sistema’ quanto quella del ‘mondo della vita’ (Lebenswelt). Ma cosa si intende precisamente qui con ‘Ragione del mondo’ e in particolare con l’espressione ‘razionalità neoliberista’? Scopo di questa breve recensione vorrà essere da una parte la chiarificazione del significato di tali termini impiegati in riferimento ad un ambito che solo superficialmente è di carattere economico, dall’altra la messa in evidenza di alcune intuizioni chiave, che permettono una più ampia presa di consapevolezza sulla reale portata, per usare le parole degli autori, della disciplina neoliberista. Difatti, il merito più grande dell’opera è quello di porre la questione del neoliberismo in termini radicali, in termini cioè antropologici. Questo libro non è una scontata critica al capitalismo considerato come ideologia o come semplice sistema economico produttore di disuguaglianza, esso è qui «assunto nel suo essere una realtà sgombra da riferimenti arcaizzati e nel suo essere una matura costruzione storica»1.
Partirò con un’apparente banalità: l’oggetto del presente studio, portato avanti a quattro mani da Laval e Dardot (sociologo il primo, professore di filosofia il secondo), non rappresenta solo il tema filosofico per eccellenza, ma costituisce anche il principio fondante, l’atto costitutivo, dell’intera società occidentale moderna, ovverosia la Ragione. Una Ragione che si è guadagnata la maiuscola conquistando la quasi totalità degli aspetti dell’esistenza individuale e collettiva, per usare un lessico habermasiano, colonizzando tanto la dimensione del ‘sistema’ quanto quella del ‘mondo della vita’ (Lebenswelt). Ma cosa si intende precisamente qui con ‘Ragione del mondo’ e in particolare con l’espressione ‘razionalità neoliberista’? Scopo di questa breve recensione vorrà essere da una parte la chiarificazione del significato di tali termini impiegati in riferimento ad un ambito che solo superficialmente è di carattere economico, dall’altra la messa in evidenza di alcune intuizioni chiave, che permettono una più ampia presa di consapevolezza sulla reale portata, per usare le parole degli autori, della disciplina neoliberista. Difatti, il merito più grande dell’opera è quello di porre la questione del neoliberismo in termini radicali, in termini cioè antropologici. Questo libro non è una scontata critica al capitalismo considerato come ideologia o come semplice sistema economico produttore di disuguaglianza, esso è qui «assunto nel suo essere una realtà sgombra da riferimenti arcaizzati e nel suo essere una matura costruzione storica»1.
- Details
- Hits: 2802
Quali alternative al neoliberismo?
di Massimiliano Lepratti
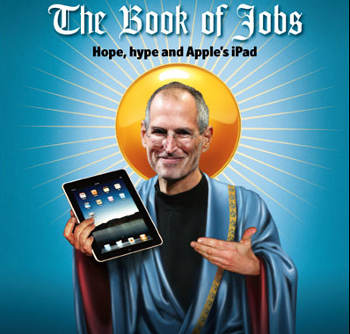 Nonostante la gravissima crisi attraversata dall'Europa e la fallacia delle ricette neoliberiste finora sperimentate in risposta, il campo delle teorie critiche si mostra incapace di offrire un solido orientamento di politica economica che metta in crisi l'egemonia culturale del neoliberismo e funga da guida per progettare una società egualitaria, inclusiva e sostenibile. Di conseguenza laddove un'ideologia culturalmente egemone non venga contrastata sul suo stesso terreno di teoria capace di dettare le agende, anche i tentativi di politiche alternative tendono a divenire timidi, inclini a mediare al ribasso e a piegarsi ai principi dominanti: l'Italia di Prodi/Padoa Schioppa o (peggio) di Renzi/Padoan ne sono solo alcuni esempi. Eppure i materiali culturali per sostenere la costruzione di un pensiero diverso a sinistra non mancherebbero: i grandi classici (da Smith a Ricardo a Marx) e i classici della dinamica dello sviluppo (ancora Marx, oltre a Keynes, e Schumpeter) continuano ad essere forieri di eccellenti spunti di analisi il cui livello scientifico e la cui capacità di lettura realistica del mondo sono senza dubbio superiori rispetto a quelli che per semplicità qui chiamiamo neoliberisti.
Nonostante la gravissima crisi attraversata dall'Europa e la fallacia delle ricette neoliberiste finora sperimentate in risposta, il campo delle teorie critiche si mostra incapace di offrire un solido orientamento di politica economica che metta in crisi l'egemonia culturale del neoliberismo e funga da guida per progettare una società egualitaria, inclusiva e sostenibile. Di conseguenza laddove un'ideologia culturalmente egemone non venga contrastata sul suo stesso terreno di teoria capace di dettare le agende, anche i tentativi di politiche alternative tendono a divenire timidi, inclini a mediare al ribasso e a piegarsi ai principi dominanti: l'Italia di Prodi/Padoa Schioppa o (peggio) di Renzi/Padoan ne sono solo alcuni esempi. Eppure i materiali culturali per sostenere la costruzione di un pensiero diverso a sinistra non mancherebbero: i grandi classici (da Smith a Ricardo a Marx) e i classici della dinamica dello sviluppo (ancora Marx, oltre a Keynes, e Schumpeter) continuano ad essere forieri di eccellenti spunti di analisi il cui livello scientifico e la cui capacità di lettura realistica del mondo sono senza dubbio superiori rispetto a quelli che per semplicità qui chiamiamo neoliberisti.
Detto questo, i motivi per cui ci troviamo in questa situazione di subalternità sono molteplici, ma due appaiono più significativi di altri:
1. il pensiero mainstream è in grado senza dubbio di dispiegare una quantità di mezzi culturali tali da spingere verso la minorità le idee alternative: mezzi giornalistici, comunicativi, istruzione – si pensi ai manuali economici studiati nelle università, l'assenza dell'economia politica nelle scuole superiori... - l'insieme di questo fuoco di fila riduce progressivamente da almeno 40 anni lo spazio per pensieri diversi.
- Details
- Hits: 2529
Thomas Piketty, il pragmatico dell’utopia light
Russell Jacoby
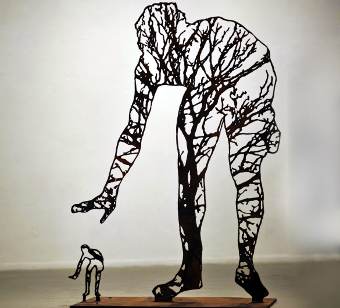 l saggio di Thomas Piketty Le Capital au XXIe siècle è un fenomeno sia sociologico sia intellettuale. Cristallizza lo spirito della nostra epoca come fece, a suo tempo, The Closing of the American Mind di Allan Bloom. Quel libro, che denunciava gli studi sulle donne, sul genere e sulle minoranze nelle università statunitensi, opponeva la mediocrità del relativismo culturale alla ricerca dell’eccellenza associata, nello spirito di Bloom, ai classici greci e romani. Ebbe pochi lettori era particolarmente pomposo ma alimentava il sentimento di una distruzione del sistema educativo statunitense, e degli stessi Stati uniti, a causa dei progressisti e della sinistra. Un sentimento che non ha affatto perso vigore. Le Capital au XXIe siècle (Il Capitale nel XXI secolo) si inquadra nello stesso registro inquieto, a parte il fatto che Piketty viene dalla sinistra e che la controversia si è spostata dall’educazione al campo economico. Anche in materia di insegnamento, il dibattito si focalizza ormai sul peso dei debiti di studio e sulle barriere suscettibili di spiegare le disuguaglianze scolastiche.
l saggio di Thomas Piketty Le Capital au XXIe siècle è un fenomeno sia sociologico sia intellettuale. Cristallizza lo spirito della nostra epoca come fece, a suo tempo, The Closing of the American Mind di Allan Bloom. Quel libro, che denunciava gli studi sulle donne, sul genere e sulle minoranze nelle università statunitensi, opponeva la mediocrità del relativismo culturale alla ricerca dell’eccellenza associata, nello spirito di Bloom, ai classici greci e romani. Ebbe pochi lettori era particolarmente pomposo ma alimentava il sentimento di una distruzione del sistema educativo statunitense, e degli stessi Stati uniti, a causa dei progressisti e della sinistra. Un sentimento che non ha affatto perso vigore. Le Capital au XXIe siècle (Il Capitale nel XXI secolo) si inquadra nello stesso registro inquieto, a parte il fatto che Piketty viene dalla sinistra e che la controversia si è spostata dall’educazione al campo economico. Anche in materia di insegnamento, il dibattito si focalizza ormai sul peso dei debiti di studio e sulle barriere suscettibili di spiegare le disuguaglianze scolastiche.
L’opera traduce un’inquietudine palpabile: la società statunitense, come l’insieme delle società del mondo, parrebbe sempre più iniqua. Le disuguaglianze si aggravano e fanno presagire un futuro grigio. Le Capital au XXIe siècle avrebbe dovuto intitolarsi Le disuguaglianze nel XXI secolo.
Sarebbe sterile criticare Piketty per la sua incapacità di raggiungere obiettivi che egli non si era dato. Tuttavia, tesserne le lodi non è sufficiente.
- Details
- Hits: 2468
"Stampare meno, Trasferire di più"
di Mark Blyth and Eric Lonergan
Dalla rivista online Foreign Affairs, un interessante studio sul "Quantitative Easing per il Popolo", di cui si è già parlato, in cui la politica monetaria si mette al servizio della politica di bilancio, per rilanciare con forza l'economia reale. (senza dimenticare che nell'eurozona il mantenimento della moneta unica impedisce di combattere davvero l'austerità)
 Perchè le banche centrali dovrebbero dare i soldi direttamente ai cittadini
Perchè le banche centrali dovrebbero dare i soldi direttamente ai cittadini
Nei decenni seguenti la II guerra mondiale, l’economia giapponese crebbe così rapidamente e per così tanto tempo che gli esperti dissero che il fenomeno era a dir poco miracoloso. Durante l’ultimo grande boom del paese, tra il 1986 e il 1991, la sua economia crebbe di quasi 1000 miliardi di dollari. Ma poi, in un modo che oggi suona molto familiare, scoppiò la bolla degli asset giapponesi, e i suoi mercati sprofondarono. Il debito pubblico esplose, e la crescita annua rallentò a meno dell’1%. Nel 1998, l'economia si stava contraendo.
Nel dicembre di quell’anno, un professore di economia di Princeton di nome Ben Bernanke sosteneva che i banchieri centrali avrebbero ancora potuto risollevare il paese. Il Giappone essenzialmente stava soffrendo per mancanza di domanda: i tassi di interesse erano già bassi, ma i consumatori non acquistavano, le imprese non chiedevano prestiti e gli investitori non facevano scommesse. Era una profezia auto-avverante: il pessimismo sullo stato dell'economia stava impedendo la ripresa. Bernanke sosteneva che la banca del Giappone doveva agire in modo più aggressivo e le suggeriva di considerare un approccio non convenzionale: dare contanti direttamente alle famiglie giapponesi. I consumatori avrebbero potuto spendere le inattese entrate trainando il paese fuori dalla recessione, facendo aumentare la domanda e i prezzi.
- Details
- Hits: 2833
Ci sono ancora speranze in Ucraina?
di Patrick Boylan
Nonostante la tensione per la voce infondata dell'invasione russa, appaiono perfino remoti segnali di fine ostilità in Ucraina: speranza o chimera?
 Da mesi i media denunciando “l'aggressione di Putin” contro l'Ucraina ed ora fanno vedere una controversa pistola fumante: presunte foto satellitari di blindati russi (ma senza le coordinate GPS). Quattro voci autorevoli, invece, ci invitano a ripensare la narrazione ufficiale. Infatti, in Ucraina c'è anche la NATO (ma non si vede): vuole installare i suoi missili sulla frontiera russa, fermare il multipolarismo e ripiombarci nel bipolarismo della Guerra Fredda. Gli eventi in Ucraina ci riguardano dunque tutti -- e da vicino. Cerchiamo allora di capirli meglio.
Da mesi i media denunciando “l'aggressione di Putin” contro l'Ucraina ed ora fanno vedere una controversa pistola fumante: presunte foto satellitari di blindati russi (ma senza le coordinate GPS). Quattro voci autorevoli, invece, ci invitano a ripensare la narrazione ufficiale. Infatti, in Ucraina c'è anche la NATO (ma non si vede): vuole installare i suoi missili sulla frontiera russa, fermare il multipolarismo e ripiombarci nel bipolarismo della Guerra Fredda. Gli eventi in Ucraina ci riguardano dunque tutti -- e da vicino. Cerchiamo allora di capirli meglio.
Lo scorso primo luglio, Henry Kissinger, ex Segretario di Stato USA e uomo politico notoriamente di destra, ha stupito tutti con un articolo sul Washington Post in cui chiedeva la cessazione delle ostilità tra le parti nell'est dell'Ucraina e tra Washington e Mosca. “Basta con la demonizzazione di Putin e la politica dello scontro, bisogna trattare” ha ammonito Kissinger ( originale in inglese - resoconto in italiano ).
Poi, nel mese di agosto, sono apparsi altri tre articoli sull'Ucraina dello stesso tenore, tutti scritti da esponenti autorevoli dell'establishment europeo e statunitense:
“L'Ucraina: l'Occidente è sulla strada sbagliata” di Gabor Steingart, Direttore del Handelsblatt, il Sole 24 Ore tedesco (08.08.2014: originale in inglese – traduzione in italiano );
- Details
- Hits: 2167
Ritratto di un cacciatore di malware
 A prima vista Nex sembra un ragazzo come tanti. Taglio di capelli alla moda, un paio di sneakers sgualcite ai piedi e in tasca uno smartphone che estrae di tanto in tanto per controllare la mail. Ci incontriamo un pomeriggio di luglio a Bologna in un bar che si affaccia su piazza Verdi, nel cuore della zona universitaria. Sono passate poche ore dalla fine di Hackmeeting 2014 – il raduno delle controculture digitali, tenutosi presso il centro sociale XM24 – e i muri dei portici circostanti sono ancora tappezzati delle locandine pubblicitarie dell’evento.
A prima vista Nex sembra un ragazzo come tanti. Taglio di capelli alla moda, un paio di sneakers sgualcite ai piedi e in tasca uno smartphone che estrae di tanto in tanto per controllare la mail. Ci incontriamo un pomeriggio di luglio a Bologna in un bar che si affaccia su piazza Verdi, nel cuore della zona universitaria. Sono passate poche ore dalla fine di Hackmeeting 2014 – il raduno delle controculture digitali, tenutosi presso il centro sociale XM24 – e i muri dei portici circostanti sono ancora tappezzati delle locandine pubblicitarie dell’evento.
Anche Nex vi ha preso parte, con un talk che ha fatto il tutto esaurito: nel buio della sala, spezzato soltanto da un fascio di luce irradiato da un proiettore, 150 persone si sono accalcate per ascoltare in religioso silenzio i suoi “racconti di sorveglianza digitale”. Due ore densissime, in cui l’hacker ha snocciolato gli episodi più significativi relativi agli ultimi due anni della sua vita. Anni vissuti pericolosamente, in prima linea contro l’industria del malware, ovvero contro quelle aziende private (come la tedesca Gamma International o l’italiana Hacking Team) che producono virus, spyware e software malevoli in grado di infettare qualsiasi dispositivo digitale – dagli smartphone ai personal computer – e metterne sotto controllo le comunicazioni. Una merce, com’è facile immaginare, richiestissima da polizie e servizi segreti di tutto il mondo, interessate a monitorare passo passo le attività di militanti politici e giornalisti non allineati.
- Details
- Hits: 3381
Su “Menti Tribali” di Jonathan Haidt
di Alessandro Del Ponte
Come si conquistano i voti di milioni di persone in sei mosse? “Menti Tribali. Perché le brave persone si dividono su politica e religione” di Jonathan Haidt (Edizioni Codice) racchiude le istruzioni fondamentali per l’aspirante politico di successo, esaltando il ruolo del ragionamento morale impulsivo, alla base dei nostri giudizi morali e delle nostre scelte in cabina elettorale
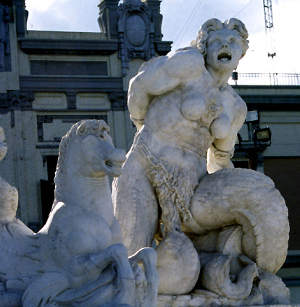 Immaginate di essere al ristorante della politica. No, non la buvette del Senato. Si tratta di un posto molto particolare. Non c’è la solita scelta: italiano, francese, cinese, indiano, turco o fusion. Qui si sceglie il partito cui dare fiducia. Se per i cittadini americani il buffet è piuttosto ristretto – democratico o repubblicano? – gli italiani hanno il loro bel daffare nel districarsi tra le scelte culinarie. Da Sinistra a Destra, transitando per la miriade di onorevoli partitini di centro (”Ma cos’è la Destra… Cos’è la Sinistra…” diceva Gaber), il menu è davvero ricco. Come districarsi nella scelta? O meglio, ribaltando la prospettiva: come aggiudicarsi il maggior numero di ghiottoni?
Immaginate di essere al ristorante della politica. No, non la buvette del Senato. Si tratta di un posto molto particolare. Non c’è la solita scelta: italiano, francese, cinese, indiano, turco o fusion. Qui si sceglie il partito cui dare fiducia. Se per i cittadini americani il buffet è piuttosto ristretto – democratico o repubblicano? – gli italiani hanno il loro bel daffare nel districarsi tra le scelte culinarie. Da Sinistra a Destra, transitando per la miriade di onorevoli partitini di centro (”Ma cos’è la Destra… Cos’è la Sinistra…” diceva Gaber), il menu è davvero ricco. Come districarsi nella scelta? O meglio, ribaltando la prospettiva: come aggiudicarsi il maggior numero di ghiottoni?
Jonathan Haidt, Professore di Psicologia Morale e Ethical Business alla New York University, ha elaborato il manuale del perfetto politico di successo.
The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion (Pantheon Books: New York, 2012), pubblicato in Italia sotto il titolo di Menti Tribali: Perché le brave persone si dividono su politica e religione (Edizioni Codice: Torino, 2013) è una lettura impegnativa, capace di soddisfare un pubblico avido di stimoli intellettuali. In poco più di 400 pagine dense di citazioni accademiche, l’autore spiega perché le persone sono spesso portate a dividersi su argomenti politici e religiosi, arrivando a difendere a ogni costo posizioni irrinunciabili. Pur non avendo dimensioni e linguaggio da Bignami, Menti Tribali, antesignano del più recente Tribù morali di Joshua Greene, può fare la differenza nel lavoro di un campaign manager, svelando i trucchi necessari per trasformare i presupposti di un flop colossale in un clamoroso successo.
- Details
- Hits: 2718
Forconi, proletarizzazione dei ceti medi e prospettive della lotta di classe
di Giorgio Paolucci
 Il movimento cosiddetto dei forconi inizialmente era costituito soprattutto dai piccoli autotrasportatori, ossia camionisti che, a causa dei continui aumenti del costo dei carburanti, dei pedaggi autostradali, della riduzione dei rimborsi pubblici delle accise e del prolungarsi della crisi, rischiavano seriamente di perdere perfino il loro mezzo di trasporto.
Il movimento cosiddetto dei forconi inizialmente era costituito soprattutto dai piccoli autotrasportatori, ossia camionisti che, a causa dei continui aumenti del costo dei carburanti, dei pedaggi autostradali, della riduzione dei rimborsi pubblici delle accise e del prolungarsi della crisi, rischiavano seriamente di perdere perfino il loro mezzo di trasporto.
Allora, dopo aver bloccato per diversi giorni la quasi totalità delle attività economiche e ottenuto dal governo Monti qualche agevolazione fiscale e un rimborso delle accise più consistente, le proteste cessarono, avvalorando così la convinzione che esse fossero espressione del disagio contingente di una specifica categoria che con la ripresa economica, allora ritenuta imminente, sarebbe ben presto rientrato.
In realtà, quel movimento, pur con le sue specificità, era la spia di un disagio sociale molto più diffuso e profondo perché le cause che lo avevano determinarlo affondavano le loro radici nella crisi strutturale del modo di produzione capitalistico e segnatamente nell’accelerazione che essa aveva impresso ai processi di concentrazione e centralizzazione dei capitali, ai processi di mondializzazione dell’economia nonché ai processi di scomposizione sociale innescati dalla nuova organizzazione e divisione internazionale del lavoro.
Infatti, la gran parte di questi piccoli trasportatori era formata da ex dipendenti di grandi imprese industriali che per ridurre i costi affidavano ai loro dipendenti la gestione in proprio di alcuni rami della loro attività e, nel caso specifico, il trasporto e la consegna delle merci ai loro clienti.
- Details
- Hits: 3669
Non basta trovarli, bisogna capirli!
Dino Erba
CLASH CITY WORKERS, Dove sono i nostri. Lavoro, classe e movimenti nell’Italia della crisi, La Casa Usher, Lucca, 2014. Pp. 202, € 10
 Leggendo questo libro
, sembra di tornare ai primordi del movimento operaio e contadino italiano quando, alla fine dell’Ottocento, gli apostoli del socialismo si prodigavano in inchieste sulla condizione proletaria nelle città e nelle campagne. Gli strumenti di inchiesta erano, allora, apparentemente rudimentali, in realtà erano assai taglienti, poiché si fondavano su quella critica dell’economia politica che, grazie a Marx ed Engels, aveva via via influenzato non solo gli apostoli del socialismo ma pure gli esponenti della cultura economica e giuridica borghese, nonché filosofica. Anche perché il movimento proletario italiano manifestava giovanili energie, con le quali la rampante classe dirigente italiana era costretta a confrontarsi.
Leggendo questo libro
, sembra di tornare ai primordi del movimento operaio e contadino italiano quando, alla fine dell’Ottocento, gli apostoli del socialismo si prodigavano in inchieste sulla condizione proletaria nelle città e nelle campagne. Gli strumenti di inchiesta erano, allora, apparentemente rudimentali, in realtà erano assai taglienti, poiché si fondavano su quella critica dell’economia politica che, grazie a Marx ed Engels, aveva via via influenzato non solo gli apostoli del socialismo ma pure gli esponenti della cultura economica e giuridica borghese, nonché filosofica. Anche perché il movimento proletario italiano manifestava giovanili energie, con le quali la rampante classe dirigente italiana era costretta a confrontarsi.
Nel corso del Novecento, questa preziosa eredità di conoscenze è stata prostituita al servizio di pratiche riformiste, fasciste, nazional-comuniste e perfino clericali. Infine, quando il gioco si è fattoduro, al tramonto del Novecento, fu sperperata dai pallidi intellettuali al servizio delle ultime mode. Costoro hanno contribuito ad approfondire il vuotopolitico-intellettuale, favorendo l’approdo alla stanca gestione dell’esistente che oggi caratterizza i governi del Bel Paese. Di destra e di sinistra. Secondo i medesimi criteri che caratterizzano i consigli di amministrazione di una SpA.
- Details
- Hits: 2487
Come unirsi contro l’Unione?
Mimmo Porcaro
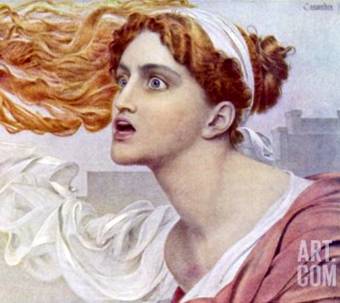 Uno dei principali problemi di chi vuole uscire dall’Unione europea e dall’Euro è quello di costruire una grande alleanza sociale e politica capace resistere alla dura reazione che i grandi poteri nazionali (ma soprattutto internazionali) non mancherebbero di scatenare di fronte a questo “inaccettabile” gesto di autodeterminazione. Un’alleanza capace, quindi, non solo di guadagnare il consenso politico e morale di milioni di cittadini ed elettori, ma anche di metter mano ad un concreto programma alternativo di rilancio dello sviluppo del paese, base materiale della resistenza contro le iniziative ostili che, almeno in un primo momento, si concretizzerebbero proprio nel tentativo di strangolamento economico. Una simile alleanza non può non prevedere un riavvicinamento di ciò che in questi anni è stato (a volte artificiosamente) separato: e quindi una riunificazione dei diversi spezzoni in cui si è frammentato il lavoro dipendente, ed una nuova relazione tra l’intero mondo del lavoro dipendente ed una parte significativa delle piccole e medie imprese. Questo riavvicinamento si presenta indubbiamente come cosa assai difficile, e richiede decisi mutamenti di atteggiamento sia agli uni che agli altri. Proprio per questo conviene parlarne da subito, e con franchezza, precisando che quanto dirò vale sia nell’ipotesi di una rottura prodotta dal nostro paese che nell’ipotesi di una rottura subita: le turbolenze ed i rischi di regressione in questo secondo caso non sarebbero inferiori (anche per la presenza di una ormai innegabile tendenza alla guerra) alle conseguenze di un nostro scatto di dignità nazionale.
Uno dei principali problemi di chi vuole uscire dall’Unione europea e dall’Euro è quello di costruire una grande alleanza sociale e politica capace resistere alla dura reazione che i grandi poteri nazionali (ma soprattutto internazionali) non mancherebbero di scatenare di fronte a questo “inaccettabile” gesto di autodeterminazione. Un’alleanza capace, quindi, non solo di guadagnare il consenso politico e morale di milioni di cittadini ed elettori, ma anche di metter mano ad un concreto programma alternativo di rilancio dello sviluppo del paese, base materiale della resistenza contro le iniziative ostili che, almeno in un primo momento, si concretizzerebbero proprio nel tentativo di strangolamento economico. Una simile alleanza non può non prevedere un riavvicinamento di ciò che in questi anni è stato (a volte artificiosamente) separato: e quindi una riunificazione dei diversi spezzoni in cui si è frammentato il lavoro dipendente, ed una nuova relazione tra l’intero mondo del lavoro dipendente ed una parte significativa delle piccole e medie imprese. Questo riavvicinamento si presenta indubbiamente come cosa assai difficile, e richiede decisi mutamenti di atteggiamento sia agli uni che agli altri. Proprio per questo conviene parlarne da subito, e con franchezza, precisando che quanto dirò vale sia nell’ipotesi di una rottura prodotta dal nostro paese che nell’ipotesi di una rottura subita: le turbolenze ed i rischi di regressione in questo secondo caso non sarebbero inferiori (anche per la presenza di una ormai innegabile tendenza alla guerra) alle conseguenze di un nostro scatto di dignità nazionale.
- Details
- Hits: 2303
Su una mia critica a Israele mediante slogan
di Ennio Abate
Dal 10 luglio 2014 ho intrattenuto un fitto confronto su quanto sta succedendo a Gaza con diversi interlocutori (in privato, sul sito di «Poliscritture», su FB). Qui replico pubblicamente a un amico ebreo che ha mosso varie accuse-obiezioni (nel testo tra virgolette) al commento con disegno (sotto) che pubblicai il 25 luglio (qui) . Tengo a precisare che il disegno – del 1984 e mio – era dedicato alla Shoa [E.A.]
«Quello stato è nato con la forza e la guerra,
la forza e la guerra possono mantenerlo o distruggerlo».
(Franco Fortini, I cani del Sinai, in Saggi ed Epigrammi, p. 407, Mondadori, Milano 2003)
 Caro…
Caro…
perché sei rimasto tanto colpito da scrivermi: «ti accuso di aver usato uno slogan falso e torvo»?
Sarà che in quel titolo sarcastico («Premiata macelleria di Stato israeliana dal 1948») si riassume la mia “ideologia filo palestinese” che mal sopporti? Sarà che ho messo in evidenza unicamente il lato omicida non solo dell’«operazione Margine protettivo» ma dello Stato d’Israele?
Sarà che ho dato peso alla «conta dei morti», operazione che ritieni emotiva e ideologica?
C’è qualcosa che ancora oggi non capisco della tua reazione. Ma, aggirando il tono inquisitorio (da accusatore a imputato) delle domande polemiche che mi hai rivolto, vedrò di dire pacatamente le mie ragioni:
Domanda: « “A che pro” quello slogan?».
Risposta: Allo scopo di esprimere l’insofferenza (non solo mia, per fortuna) per le troppo numerose uccisioni di civili inermi compiute da uno degli eserciti più potenti del mondo ormai da decenni per contrastare dei nemici (prima l’OLP ora Hamas), insidiosi senz’altro ma inconfrontabili alla sua potenza di fuoco. (L’asimmetria militare è un dato innegabile e non trascurabile quando si valuta quel conflitto).
- Details
- Hits: 2999
Psicoeconomia, deflazione e altro ancora
Sebastiano Isaia
 Con gli allarmistici articoli dedicati alla deflazione («Incombe l’incubo della deflazione») questa estate abbiamo assistito al più classico dei processi di inversione di causa ed effetto. Un po’ come quando lo stolto attribuisce la causa della sua febbre al termometro, l’innocuo strumento che si limita a registrare l’effetto termico della malattia che tanto lo tormenta (1).
Con gli allarmistici articoli dedicati alla deflazione («Incombe l’incubo della deflazione») questa estate abbiamo assistito al più classico dei processi di inversione di causa ed effetto. Un po’ come quando lo stolto attribuisce la causa della sua febbre al termometro, l’innocuo strumento che si limita a registrare l’effetto termico della malattia che tanto lo tormenta (1).
«Per ritrovare una fase depressiva così lunga sul fronte dei prezzi – scriveva Il Corriere della Sera del 12 agosto –, occorre andare indietro di oltre mezzo secolo. Oggi combattiamo contro una recessione recidiva, che sta sfibrando il tessuto produttivo. E perché il calo dei prezzi non è una buona notizia? Non è tanto per il fatto in sé quanto piuttosto per l’effetto che genera sulle aspettative del consumatore. Che aspettandosi ulteriori cali rinvia potenzialmente all’infinito gli acquisti in programma convinto che così facendo risparmierà ulteriormente. Un bel grattacapo per l’economia». Un grattacapo che da sempre ossessiona soprattutto quella che possiamo chiamare psicoeconomia, ossia l’economia politica che ha messo al centro della prassi economica le aspettative: dei consumatori, degli investitori, dei lavoratori, dei creditori e via discorrendo.
Lungi da me negare l’esistenza di moventi psicologici individuali e di massa nella sfera economica; il mio “materialismo” non è poi così volgare come forse crede qualche lettore dei miei modesti post.
- Details
- Hits: 6739
Il chiarimento del caos
Perché gli USA usano l'ISIS per conquistare l'Eurasia
di Piotr
Una straordinaria analisi a firma Piotr. Cos'è la Terza guerra mondiale a zone di cui parla il papa. I veri confini del dibattito su ISIS, Di Battista, l'Ucraina, i curdi
 1. I corsari erano dei privati (spesso armatori) che ingaggiavano comandanti abili nella navigazione per perseguire propri interessi in condominio con quelli politici di una potenza che li forniva, appunto, di una "lettera di corsa". Tale lettera li abilitava ad attaccare e saccheggiare navi di altre potenze sotto particolari condizioni (solitamente una guerra).
1. I corsari erano dei privati (spesso armatori) che ingaggiavano comandanti abili nella navigazione per perseguire propri interessi in condominio con quelli politici di una potenza che li forniva, appunto, di una "lettera di corsa". Tale lettera li abilitava ad attaccare e saccheggiare navi di altre potenze sotto particolari condizioni (solitamente una guerra).
Le attività dei pirati e quelle dei corsari erano praticamente le stesse. Cambiavano solo le coperture politiche ufficiali. Diversi corsari finirono la loro carriera come pirati, a volte impiccati dagli stessi governi che li avevano ingaggiati.
Di fatto i corsari potevano permettersi di fare quelle cose che uno Stato riteneva politicamente e/o economicamente imprudente fare.
Una variante molto più in grande ed organizzata erano le Compagnie commerciali dotate di privilegi, come la famosa Compagnia Inglese delle Indie Orientali, che benché totalmente private (la Corona inglese non possedeva nemmeno un'azione delle Compagnie inglesi) avevano il nulla osta per condurre guerre e attività di governo.
Corsari e pirati hanno smosso le fantasie romantiche e libertarie di generazioni di persone che invece storcevano il naso per le imprese dei loro mandanti.
Oggi la storia si ripete. In peggio.
- Details
- Hits: 2206
La spending spiana comuni
Guido Viale
 Senza soluzione di continuità nel passaggio da Tremonti a Bondi e da Cottarelli a Gutgeld, e da Prodi e Berlusconi a Monti e da Letta a Renzi, la spending review sta planando come un avvoltoio su coloro che ne potrebbero essere i protagonisti, perché sono gli unici a sapere come stanno veramente le cose, e che invece ne sono le vittime: i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. L’obiettivo più immediato sono i Comuni, con i quali si va a colpire la democrazia nel suo punto più vitale ma anche più esposto. Vitale perché i Comuni incarnano la tradizione europea dell’autogoverno democratico a base associativa; perché i Comuni e le loro aggregazioni rappresentano la democrazia di prossimità e il possibile punto di applicazione di una democrazia partecipata; perché i Comuni sono tuttora i responsabili dei servizi pubblici locali, cioè di ciò che più direttamente condiziona lo svolgimento della nostra vita quotidiana.
Senza soluzione di continuità nel passaggio da Tremonti a Bondi e da Cottarelli a Gutgeld, e da Prodi e Berlusconi a Monti e da Letta a Renzi, la spending review sta planando come un avvoltoio su coloro che ne potrebbero essere i protagonisti, perché sono gli unici a sapere come stanno veramente le cose, e che invece ne sono le vittime: i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. L’obiettivo più immediato sono i Comuni, con i quali si va a colpire la democrazia nel suo punto più vitale ma anche più esposto. Vitale perché i Comuni incarnano la tradizione europea dell’autogoverno democratico a base associativa; perché i Comuni e le loro aggregazioni rappresentano la democrazia di prossimità e il possibile punto di applicazione di una democrazia partecipata; perché i Comuni sono tuttora i responsabili dei servizi pubblici locali, cioè di ciò che più direttamente condiziona lo svolgimento della nostra vita quotidiana.
Ma i Comuni sono l’oggetto delle brame di chi governa la spending review proprio perché i sevizi pubblici locali sono l’obiettivo di un saccheggio e di un meccanismo estrattivo messi in moto da un capitalismo che non è più in grado di garantire margini d profitto adeguati con l’investimento nell’industria. E la forma giuridica della società per azioni (Spa), sia interamente pubblica che mista, cioè pubblico-privata - in cui si sono andati costituendo nel corso degli ultimi venti anni quasi tutti i servizi pubblici locali - rappresenta il primo stadio della privatizzazione. Gli affidamenti diretti (cioè senza gara: il cosiddetto in-house) di cui beneficiano li rende particolarmente esposti a questa aggressione. Per svariati motivi.
- Details
- Hits: 3275

Verso la metamorfosi completa dell'“operaio” sociale
Karlo Raveli

Detto in parole povere, ci stiamo finalmente avviando verso il funerale della “classe lavoratrice”. Anche se nel general intellect è tutt'ora dominante quel linguaggio (come Sistema Operativo) “marxista” ereditato dai primordi della lotta di classe nel capitalismo, quando la classe operaia, classe radicalmente antagonista del modo di sviluppo – che comprende la produzione... - capitalista, venne “scambiata...” con il suo settore lavoratore salariato, industriale oltretutto, con tutte le fatali conseguenze che tutt'ora sopportiamo.
Tant'è che lotta di classe operaia non è ancora, mai soggettivamente, esistita sul pianeta Terra.
Marx indicò in modo definitorio e categorico l'origine e il principio delle classi nell'attuale sistema sociale. È nella contraddizione fondamentale del capitalismo, tra appropriazione privata (sotto tutte le sue forme, le attuali ancor più) e carattere sociale della produzione e attività umana, che prendono corpo i due campi sociali radicalmente antagonisti. Quindi: non solo nello sfruttamento, alienazione e poi coscienza di classe. Il termine operaio, e classe operaia, non comprende solo il suo settore – oggi sempre più minoritario - degli sfruttati salariati, tanto più se fissi e stabili nella struttura produttiva “classica”.
Page 465 of 613