- Details
- Hits: 1885
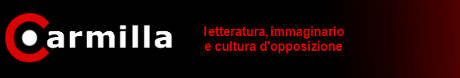
Opposizione balneare
di Luca Baiada
 C’è una formula tranquilla come una spiaggia a Ferragosto e pulita come il catrame. Viene dagli anni del potere democristiano: governo balneare. In momenti di incertezze e di impossibilità di coalizioni stabili, si traghettava la crisi attraverso la stagione estiva con un governicchio fragile, anzi nato morto. Un pauroso rovesciamento di prospettive ha portato l’Italia ad avere un governo rigidissimo («rigor Montis», si è scritto), e una opposizione balneare. Proviamo a misurarne la cellulite.
C’è una formula tranquilla come una spiaggia a Ferragosto e pulita come il catrame. Viene dagli anni del potere democristiano: governo balneare. In momenti di incertezze e di impossibilità di coalizioni stabili, si traghettava la crisi attraverso la stagione estiva con un governicchio fragile, anzi nato morto. Un pauroso rovesciamento di prospettive ha portato l’Italia ad avere un governo rigidissimo («rigor Montis», si è scritto), e una opposizione balneare. Proviamo a misurarne la cellulite.
La liquidazione del sistema proporzionale, nel 1993 presentato come un imbroglio, mentre adesso una truffa elettorale permette alle segreterie di partito di nominare il parlamento, garantisce l’impoverimento della funzione legislativa e assicura appoggio incondizionato a decisioni prese in modo opaco.
Il concetto stesso di partito sembra diventato una parolaccia, e ci si barcamena borbottando formule una più astrusa dell’altra. Riciclandosi in politica, nel 1994 Berlusconi disse di aver creato un rassemblement. Poi verranno i circoli e i predellini. Gli eredi del più grande partito comunista d’Europa, insieme a pezzi del mondo cattolico, hanno serbato il concetto di partito, ma l’hanno sottoposto a operazioni di potatura e innesto, cercando affannosamente l’aria della socialdemocrazia europea, o il glamour Usa. Tutto a parole o tutto nel peggio.
Si affacciano alla storia movimenti che vogliono tenere insieme persone e idee, ma che hanno orrore delle sezioni di partito e che inventano ogni alchimia possibile: orizzontalità del potere, oscurità delle persone presentata come un merito, formule fluide.
- Details
- Hits: 2287

Le illusioni perdute della generazione trenta-quaranta
di Roberto Ciccarelli
 Il manifesto dei Trenta-Quarantenni che si autodefiniscono "generazione perduta" stringe il cuore e impone rispetto. Rispetto per il "dramma" di "dieci milioni di italiani" che, giunti alla mezza età, sono "senza speranze né futuro". Rispetto per l'istinto di auto-compatimento che s'impadronisce di una vita quando si accorge di essere "il risultato di un esperimento dall'esito fallimentare, che ha avuto per laboratorio il Paese intero e noi come cavie". Rispetto per chi, in nome della "questione generazionale", avanza come Prometeo contro "chi pretende di tenerci ancora ai margini delle decisioni che riguardano il nostro presente ed il nostro futuro e quindi quello del Paese".
Il manifesto dei Trenta-Quarantenni che si autodefiniscono "generazione perduta" stringe il cuore e impone rispetto. Rispetto per il "dramma" di "dieci milioni di italiani" che, giunti alla mezza età, sono "senza speranze né futuro". Rispetto per l'istinto di auto-compatimento che s'impadronisce di una vita quando si accorge di essere "il risultato di un esperimento dall'esito fallimentare, che ha avuto per laboratorio il Paese intero e noi come cavie". Rispetto per chi, in nome della "questione generazionale", avanza come Prometeo contro "chi pretende di tenerci ancora ai margini delle decisioni che riguardano il nostro presente ed il nostro futuro e quindi quello del Paese".
Scrivono:
E' forte l'impressione di essere in presenza di 24 pugili suonati. I promotori del manifesto rientrano nel lavoro indipendente di ceto medio come giornalisti, docenti universitari precari architetti, e diversi avvocati, insomma in quella zona grigia dove i "giovani" professionisti vivono accanto al "precariato", e spesso lo sono pienamente.
- Details
- Hits: 2212

La Germania metterà in crisi la Nato?
di Michele Basso
 Oggi, per chi non ha gli occhi ottenebrati dal nazionalismo, spesso inconsapevole, presente anche nell’estrema sinistra, è possibile avere un quadro più chiaro degli sviluppi storici della nostra epoca. La crisi economica ha fatto crollare molti miti, ma dobbiamo vigilare perché ne possono subentrare altri. E’ svanita l’illusione che le borghesie dei diversi paesi possano superare i contrasti e dare vita a un lungo periodo di pace autentica, che non sia una tregua armata tra le guerre. Per la natura stessa del capitalismo la borghesia è costretta a rivoluzionare continuamente la produzione e la società, a cambiare i rapporti di forza, sia all’interno del paese, sia tra i diversi stati.
Oggi, per chi non ha gli occhi ottenebrati dal nazionalismo, spesso inconsapevole, presente anche nell’estrema sinistra, è possibile avere un quadro più chiaro degli sviluppi storici della nostra epoca. La crisi economica ha fatto crollare molti miti, ma dobbiamo vigilare perché ne possono subentrare altri. E’ svanita l’illusione che le borghesie dei diversi paesi possano superare i contrasti e dare vita a un lungo periodo di pace autentica, che non sia una tregua armata tra le guerre. Per la natura stessa del capitalismo la borghesia è costretta a rivoluzionare continuamente la produzione e la società, a cambiare i rapporti di forza, sia all’interno del paese, sia tra i diversi stati.
A sinistra, si reagisce spesso a questi cambiamenti senza un’adeguata riflessione: militanti, che una volta bruciavano le bandiere americane, ora si scagliano, non solo contro la Merkel, di cui c’importa poco, ma in generale contro il popolo tedesco, senza distinguere tra lavoratori e borghesi. Il nazionalismo scaccia l’internazionalismo proletario. Oggi, che gli interessi economici tedeschi confliggono con quelli dell’Italia, Grecia, Spagna, e, in maniera meno clamorosa, con la Francia, ritorna in voga tutta la retorica antitedesca, e si dimentica persino che, salvo qualche novantenne, la stragrande maggioranza dei tedeschi, se non altro per motivi cronologici, non ha mai avuto nessuna funzione in epoca nazista.
Chiusi nell’orticello europeo, inoltre, finiamo col trascurare le gigantesche trasformazioni che avvengono nel mondo, che hanno come primo attore ancora gli USA, e in cui la Germania ha un ruolo estremamente diverso da quello che le attribuiscono i luoghi comuni. Chi grida al lupo tedesco finisce col non capire la terribile guerra globale che la tigre americana sta combattendo.
- Details
- Hits: 2534

Verso l'addio all'Eurozona?
di Christian Marazzi
Gli scenari possibili della crisi della "moneta unica" di fronte alle scelte della Banca Centrale Europea, il dibattito degli economisti tedeschi e la ricerca di una "moneta comune" per i movimenti
 1. Il 2 agosto, la Banca Centrale Europea (BCE), malgrado le roboanti esternazioni del suo presidente Mario Draghi sulla difesa ad oltranza dell’euro di pochi giorni prima, ha in parte “deciso di non decidere”, almeno fino a metà settembre, quando la Corte costituzionale di Karlsruhe emetterà la sentenza sulla costituzione del Meccanismo di Stabilità Europeo (EMS), che si sostituirà all’attuale Fondo Salva-Stati, quest’ultimo dotato di 100 miliardi di euro, una cifra irrisoria per poter intervenire efficacemente contro gli assalti ai debiti sovrani dei paesi cosiddetti del Sud (ce ne vorrebbero 300 solo per salvare la Spagna).Questo significa che nelle prossime settimane, in mancanza di una autorità veramente in grado di “fare qualunque cosa per preservare l’euro”, i mercati saranno probabilmente soggetti a forti oscillazioni determinate dal “calcolo delle probabilità” sulla fuoriuscita o meno dall’euro di Spagna e Italia. La questione di fondo è: quanta sovranità i paesi del Sud sono di nuovo pronti a concedere per “tirare avanti” con i loro debiti crescenti?
1. Il 2 agosto, la Banca Centrale Europea (BCE), malgrado le roboanti esternazioni del suo presidente Mario Draghi sulla difesa ad oltranza dell’euro di pochi giorni prima, ha in parte “deciso di non decidere”, almeno fino a metà settembre, quando la Corte costituzionale di Karlsruhe emetterà la sentenza sulla costituzione del Meccanismo di Stabilità Europeo (EMS), che si sostituirà all’attuale Fondo Salva-Stati, quest’ultimo dotato di 100 miliardi di euro, una cifra irrisoria per poter intervenire efficacemente contro gli assalti ai debiti sovrani dei paesi cosiddetti del Sud (ce ne vorrebbero 300 solo per salvare la Spagna).Questo significa che nelle prossime settimane, in mancanza di una autorità veramente in grado di “fare qualunque cosa per preservare l’euro”, i mercati saranno probabilmente soggetti a forti oscillazioni determinate dal “calcolo delle probabilità” sulla fuoriuscita o meno dall’euro di Spagna e Italia. La questione di fondo è: quanta sovranità i paesi del Sud sono di nuovo pronti a concedere per “tirare avanti” con i loro debiti crescenti?
Prima della riunione del board della BCE i paesi in sofferenza avevano chiesto che l’istituto di Francoforte si mettesse ad acquistare direttamente e in modo illimitato i titoli pubblici spagnoli e italiani in modo da favorire una diminuzione dei tassi ed evitare che il loro accesso al mercato fosse precluso. Spagna e Italia non hanno solo un problema di liquidità, ma anche di solvibilità: l’intervento della BCE non dovrebbe essere solo quello di calmierare i mercati facendo scendere a livelli sostenibili i tassi di interesse, ma anche quello di sostituirsi eventualmente agli investitori che non vogliono più sottoscrivere questi stessi titoli.
- Details
- Hits: 2899

Il rivoluzionario conservatore
di Alberto Burgio
 Ricordando Cesare Cases a due anni dalla morte (avvenuta a Firenze il 28 luglio del 2005), Claudio Magris ebbe a dire che la sua vita e la sua opera sono «un capitolo della nostra storia e del nostro destino». Queste parole non mi è mai riuscito di dimenticarle. Di quanti si potrebbe affermare altrettanto? E perché a proposito di Cases è possibile, persino necessario? Un capitolo «della nostra storia»: della nostra formazione, di un itinerario di letture e di pensieri e di esperienze che in altri tempi si sarebbero dette «spirituali». Fin qui ci siamo.
Ricordando Cesare Cases a due anni dalla morte (avvenuta a Firenze il 28 luglio del 2005), Claudio Magris ebbe a dire che la sua vita e la sua opera sono «un capitolo della nostra storia e del nostro destino». Queste parole non mi è mai riuscito di dimenticarle. Di quanti si potrebbe affermare altrettanto? E perché a proposito di Cases è possibile, persino necessario? Un capitolo «della nostra storia»: della nostra formazione, di un itinerario di letture e di pensieri e di esperienze che in altri tempi si sarebbero dette «spirituali». Fin qui ci siamo.
Totalità aperta
Chi negli anni '70 aveva già - se non proprio il ben dell'intelletto - strumenti per decifrare pagine impervie, era certo di trovare pane per i suoi denti in quelle di Cases, disseminate tra le riviste e i giornali, un tempo numerosi, della sinistra italiana (da «Passato e presente» a «Lotta continua», dal «manifesto» a «Nuovi Argomenti», ai «Quaderni piacentini»). Pane e companatico: ricco di idee e di sfide «intellettuali e morali», di suggestioni e insegnamenti. E, perché no, di battute al vetriolo: urticanti, gratuite e irresistibili, epiche addirittura, come quella che demolì - così mi parve allora e credo tuttora - il povero Soldati, innalzato, dopo una stroncatura tombale dell'Attore (libro, anzi «fumettone», di una «noia mortale e teologica»), a paradigma d'insignificanza: onde Primo Levi sarebbe stato pienamente assolto, dopo Se questo è un uomo e La tregua, «anche se per il resto della sua vita fosse vissuto di conferenze all'Aci sui Lager o avesse scritto un romanzo di Mario Soldati».
Ma un capitolo «del nostro destino» perché? Ignoro cosa Magris intendesse: so finalmente, in qualche misura, cosa queste parole abbiano ridestato in me, da allora sospingendomi, con un'insistenza sempre premiata, verso un lascito inestimabile e, non per caso, pressoché dimenticato.
- Details
- Hits: 2646
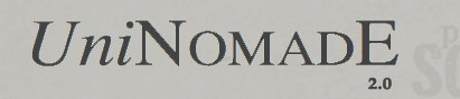
A volte ritornano
Un anno vissuto pericolosamente
di Andrea Fumagalli
 Un anno fa, a fine luglio 2011, l’asta dei titoli di stato decennali italiani fece registrare un forte incremento dei tassi d’interesse: iniziò ad aumentare il differenziale con i titoli di stato tedeschi (il famoso “spread”), che raggiunse quasi quota 600 a metà novembre. A fine giugno 2011 il Financial Time scopriva che Deutsche Bank aveva venduto circa 7 miliardi di Btp italiani degli 8 che deteneva nel proprio portafoglio. Tale massiccia vendita produsse a partire dal maggio 2011 una riduzione del valore dei titoli future quotati a Londra (i derivati relativi alle aspettative sul valore futuro atteso dei titoli di stato) di oltre 10 punti percentuali. Tutto ciò mise in moto, da un lato, aspettative pessimistiche sul valore futuro dei titoli italiani (comportando di conseguenza un aumento dei tassi d’interessi che aggravano il deficit pubblico), dall’altro, fecero incrementare il valore dei derivati CDS che assicurano contro il rischio di insolvenza o di perdita di valore dei titoli stessi. Chi detiene tali derivati nel proprio portafoglio può quindi lucrare laute plusvalenze e non sorprende affatto che i CDS siano concentrati per oltre il 90% in quelle stesse multinazionali della finanza (tra le quali Deutsche Bank) che hanno l’interesse di indurre aspettative negative sulla tenuta dei conti pubblici e creare il panico da default per quei paesi europei maggiormente esposti (i Piigs). Qui sta la fonte e il potere biopolitico della speculazione finanziaria.
Un anno fa, a fine luglio 2011, l’asta dei titoli di stato decennali italiani fece registrare un forte incremento dei tassi d’interesse: iniziò ad aumentare il differenziale con i titoli di stato tedeschi (il famoso “spread”), che raggiunse quasi quota 600 a metà novembre. A fine giugno 2011 il Financial Time scopriva che Deutsche Bank aveva venduto circa 7 miliardi di Btp italiani degli 8 che deteneva nel proprio portafoglio. Tale massiccia vendita produsse a partire dal maggio 2011 una riduzione del valore dei titoli future quotati a Londra (i derivati relativi alle aspettative sul valore futuro atteso dei titoli di stato) di oltre 10 punti percentuali. Tutto ciò mise in moto, da un lato, aspettative pessimistiche sul valore futuro dei titoli italiani (comportando di conseguenza un aumento dei tassi d’interessi che aggravano il deficit pubblico), dall’altro, fecero incrementare il valore dei derivati CDS che assicurano contro il rischio di insolvenza o di perdita di valore dei titoli stessi. Chi detiene tali derivati nel proprio portafoglio può quindi lucrare laute plusvalenze e non sorprende affatto che i CDS siano concentrati per oltre il 90% in quelle stesse multinazionali della finanza (tra le quali Deutsche Bank) che hanno l’interesse di indurre aspettative negative sulla tenuta dei conti pubblici e creare il panico da default per quei paesi europei maggiormente esposti (i Piigs). Qui sta la fonte e il potere biopolitico della speculazione finanziaria.
A un anno di distanza nulla è cambiato, anzi la situazione è peggiorata. E la peggior meschinità e falsità ideologica si è dipanata a diversi livelli.
A livello nazionale si sono imposti governi più o meno “tecnici” o si sono condizionati processi elettorali per rendere operative in breve tempo politiche emergenziali di austerity con l’ipocrita giustificazione di andare incontro alle esigenze dei “mercati” (leggi speculazione finanziaria), ma in realtà accelerando ulteriormente la tendenza alla concentrazione dei redditi, affinando la governance della espropriazione dell’eccedenza sociale del lavoro e incrementando il processo di finanziarizzazione della vita.
- Details
- Hits: 3203

“Chi detesta l’America, detesta se stesso”
di Elisabetta Teghil
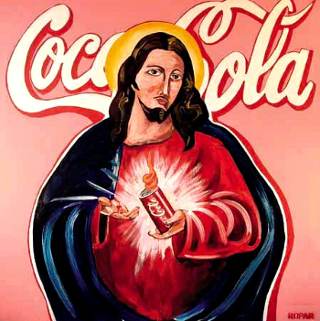 Ovunque sia presente un segno è presente anche l’ideologia. Tutto ciò che è ideologico possiede un valore semiotico.
Ovunque sia presente un segno è presente anche l’ideologia. Tutto ciò che è ideologico possiede un valore semiotico.
Ma le qualità semiotiche si manifestano in maniera continua ed esaustiva nella comunicazione sociale ed esse si realizzano in modo compiuto nel linguaggio.
La parola è il fenomeno ideologico per eccellenza.
Allora si capisce perché, da alcuni anni, si è diffusa una strana neo-lingua il cui vocabolario , apparentemente, è sorto dal nulla. Globalizzazione, flessibilità, governance, tolleranza zero, post-modernità, post-femminismo, legalità, non-violenza…tutte parole accompagnate dall’oblio e dalla damnatio memoriae di altre parole come capitalismo, classe, lotta di classe, sfruttamento, colonialismo, patriarcato, accomunate dalla condanna di essere “obsolete” e, comunque, “superate”.
Tutto questo è imperialismo culturale che si fonda su un rapporto di comunicazione che ha fatto tabula rasa delle conquiste sociali ed economiche di cento anni di lotte, oggi presentate come retrive e/o superate, come nel caso del femminismo, perché si è “ottenuto tutto”.
E’ l’ideologia neoliberista che si fonda su un rapporto di comunicazione teso ad ottenere la sottomissione.
- Details
- Hits: 2576

Stanno smantellando lo Stato di diritto con la scusa dello spread
Fabio Sebastiani intervista Luigi Cavallaro
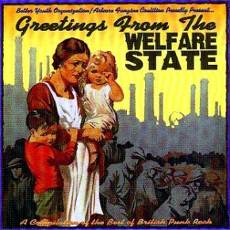 Tutti che guardano allo spread, intanto questa crisi ha cambiato completamente i connotati ai fondamenti dello Stato di diritto…
Tutti che guardano allo spread, intanto questa crisi ha cambiato completamente i connotati ai fondamenti dello Stato di diritto…
Più esattamente, questa crisi sta cambiando i connotati a quella peculiare declinazione dello Stato di diritto che è lo Stato sociale, a cominciare dalla sua pretesa di governare i processi economici. Si tratta in effetti della maturazione di un trend che ormai data da lontano. Per capirci, quando i nostri costituenti vararono la Costituzione, inserirono nel terzo comma dell’articolo 41 il principio secondo cui lo Stato doveva indirizzare e coordinare sia l’economia pubblica sia quella privata. Lo Stato, ai loro occhi, non doveva essere solo il “regolatore” dell’iniziativa economica e nemmeno il produttore di beni e servizi da offrire in alternativa alle merci capitalisticamente prodotte: doveva porre sia l’iniziativa economica pubblica sia quella privata nell’ambito di un proprio disegno globale, che individuava priorità, strategie, mezzi. Un obiettivo del genere, sebbene fermamente voluto sia dai cattolici che dai comunisti, era particolarmente inviso ai liberali, che erano ben disposti a godere dei benefici della spesa pubblica, ma certo non volevano saperne di cedere allo Stato poteri di indirizzo e controllo sulla loro attività. Si optò allora per un compromesso che – grazie alla mediazione di Luigi Einaudi, capofila dei liberali tra i costituenti – prese la forma dell’art. 81 della Costituzione: ogni legge di spesa doveva indicare la corrispondente fonte di entrata. Era un modo per dire che nemmeno lo Stato poteva sottrarsi al principio del pareggio di bilancio, perché Einaudi sapeva bene che, se si fosse consentito allo Stato di indebitarsi (come invece predicavano i keynesiani ortodossi), l’economia pubblica, che già si trovava collocata su una posizione di primazia, avrebbe preso il sopravvento sull’economia privata.
Un compromesso per la proprietà e il capitale…
Sì, ma nel 1966 la Corte costituzionale lo fece saltare, perché in una sentenza stabilì che anche il debito costituiva una forma di entrata.
- Details
- Hits: 9879

Dell'inutilità in tutti gli ambiti della vita culturale, politica e sociale
Luigi Tedeschi intervista Costanzo Preve
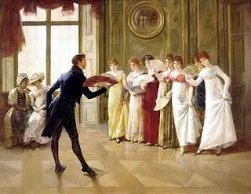 (Tedeschi) L’avanzare e il perdurare della crisi economica europea, sta progressivamente destrutturando la società. La recessione e i decrementi del Pil hanno determinato la fuoriuscita dalla produzione di rilevanti quote di manodopera dal sistema produttivo. Si allargano a macchia d’olio la disoccupazione, la sottoccupazione, il precariato, il lavoro nero. Soprattutto, l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani è diventato assai difficoltoso. La nostra società diviene sempre più decadente, per il venir meno del ricambio generazionale e la mobilità sociale. La liberalizzazione dell’economia, dei costumi, della cultura di massa, quali fenomeni scaturiti dall’avvento della globalizzazione, si rivelano miti virtuali, destinati ad essere smentiti dal disfacimento degli equilibri sociali provocato dalla crisi incombente. Se volessimo elaborare un bilancio del primo decennio del XXI° secolo, dovremmo rilevare che l’avvento della società globalizzata ha avuto solo la funzione di distruggere l’eredità sociale e culturale del ‘900, dato che i nuovi orizzonti, le nuove opportunità, le grandi sfide del nuovo secolo, si sono rivelate elementi di una strategia di ascesa al potere di una nuova elitaria classe dominante del mondo finanziario a discapito della masse sempre più escluse dai processi produttivi. L’emarginazione sociale coinvolge interi popoli; esclusione ed emarginazione sono fenomeni conseguenti al tramonto di un sistema economico basato sulla produzione e di una società fondata su equilibri ispirati al solidarismo interclassista. La fuoriuscita dal mondo del lavoro determina negli individui un senso di inutilità esistenziale, di estraneazione sociale, che conduce alla perdita della autostima di se stessi, ad un non senso della propria individualità, ormai non più compatibile con le prospettive di sviluppo di una società elitaria, basata sulla generalizzata esclusione delle masse non più integrabili nei processi evolutivi della società globalizzata.
(Tedeschi) L’avanzare e il perdurare della crisi economica europea, sta progressivamente destrutturando la società. La recessione e i decrementi del Pil hanno determinato la fuoriuscita dalla produzione di rilevanti quote di manodopera dal sistema produttivo. Si allargano a macchia d’olio la disoccupazione, la sottoccupazione, il precariato, il lavoro nero. Soprattutto, l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani è diventato assai difficoltoso. La nostra società diviene sempre più decadente, per il venir meno del ricambio generazionale e la mobilità sociale. La liberalizzazione dell’economia, dei costumi, della cultura di massa, quali fenomeni scaturiti dall’avvento della globalizzazione, si rivelano miti virtuali, destinati ad essere smentiti dal disfacimento degli equilibri sociali provocato dalla crisi incombente. Se volessimo elaborare un bilancio del primo decennio del XXI° secolo, dovremmo rilevare che l’avvento della società globalizzata ha avuto solo la funzione di distruggere l’eredità sociale e culturale del ‘900, dato che i nuovi orizzonti, le nuove opportunità, le grandi sfide del nuovo secolo, si sono rivelate elementi di una strategia di ascesa al potere di una nuova elitaria classe dominante del mondo finanziario a discapito della masse sempre più escluse dai processi produttivi. L’emarginazione sociale coinvolge interi popoli; esclusione ed emarginazione sono fenomeni conseguenti al tramonto di un sistema economico basato sulla produzione e di una società fondata su equilibri ispirati al solidarismo interclassista. La fuoriuscita dal mondo del lavoro determina negli individui un senso di inutilità esistenziale, di estraneazione sociale, che conduce alla perdita della autostima di se stessi, ad un non senso della propria individualità, ormai non più compatibile con le prospettive di sviluppo di una società elitaria, basata sulla generalizzata esclusione delle masse non più integrabili nei processi evolutivi della società globalizzata.
- Details
- Hits: 2577

Comunicatori inquieti e invadenti
di Federico Faloppa
Raffaele Simone Presi nella rete. La mente ai tempi del web, pp. 227, € 17, Garzanti, Milano 2012
 Come linguista, Raffaele Simone non ha certo bisogno di presentazioni: almeno due generazioni di studenti si sono formate sui suoi testi. Ma Raffaele Simone non ha certo bisogno di presentazioni neppure come osservatore attento delle trasformazioni culturali e sociali della contemporaneità, attraverso alcuni saggi a metà tra il pamphlet militante e la sintesi erudita. A cominciare dal j’accuse celeberrimo L’università dei tre tradimenti (Laterza, 1993), per giungere ai ritratti disincantati di Il paese del pressapoco (Garzanti, 2005) e all’impietosa analisi di Il mostro mite. Perché l’Occidente non va a sinistra (Garzanti, 2008), passando per il pioneristico La terza fase. Forme di sapere che stiamo perdendo (Laterza, 2000).
Come linguista, Raffaele Simone non ha certo bisogno di presentazioni: almeno due generazioni di studenti si sono formate sui suoi testi. Ma Raffaele Simone non ha certo bisogno di presentazioni neppure come osservatore attento delle trasformazioni culturali e sociali della contemporaneità, attraverso alcuni saggi a metà tra il pamphlet militante e la sintesi erudita. A cominciare dal j’accuse celeberrimo L’università dei tre tradimenti (Laterza, 1993), per giungere ai ritratti disincantati di Il paese del pressapoco (Garzanti, 2005) e all’impietosa analisi di Il mostro mite. Perché l’Occidente non va a sinistra (Garzanti, 2008), passando per il pioneristico La terza fase. Forme di sapere che stiamo perdendo (Laterza, 2000). Proprio a La terza fase si riallaccia l’ultimo suo lavoro, che non solo evoca, ma rielabora e amplia i contenuti di quel fortunato predecessore. Certo, scorrendo in parallelo l’indice dei due volumi non si può non avere una sensazione di déjà-lu. Ma si tratterebbe di un’impressione superficiale. Perché quella prima analisi sul cambiamento del nostro modo di pensare (e di acquisire il sapere) indotto dalla trasformazione tecnica e dalla rivoluzione digitale si è nel tempo arricchita e articolata: sia per un’ovvia esigenza di aggiornamento, sia soprattutto per l’urgenza di segnalare, ancor più criticamente, la profonda incidenza culturale e politica di quella trasformazione.
- Details
- Hits: 3790

Società e individuo da una prospettiva psicoanalitica: identità di una crisi
Emanuela Mangione
.jpg) Si può parlare oggi di una genesi sociale del narcisismo? Questa è una delle tematiche intorno a cui filosofi, psicoanalisti, ma anche economisti e politici si stanno interrogando; essenzialmente la questione riguarda le possibili connessioni tra l’attuale sistema sociale ed economico e certe patologie di tipo prevalentemente narcisistico, con aree sintomatiche in cui il protagonista risulta essere sempre più il corpo e le scissioni corpo mente.
Si può parlare oggi di una genesi sociale del narcisismo? Questa è una delle tematiche intorno a cui filosofi, psicoanalisti, ma anche economisti e politici si stanno interrogando; essenzialmente la questione riguarda le possibili connessioni tra l’attuale sistema sociale ed economico e certe patologie di tipo prevalentemente narcisistico, con aree sintomatiche in cui il protagonista risulta essere sempre più il corpo e le scissioni corpo mente.
A tale proposito mi sembra calzante l’espressione“liquidità del soggetto in una società liquida” (Garella,congresso SPI 2012). Una società, quella della postmodernità, che sembra porre l’individuo all’interno di una accelerazione costante alla ricerca di scommesse continue in cui impegnare il proprio futuro, in una sorta di surf dettato dall’imperativo etico di tenersi sempre sulla cresta dell’onda. Un narcisismo individuale imperante spinge la macchina del mondo umano a funzionare non tanto per realizzare un progetto, bensì per produrre una perpetuazione di se stessa attraverso un investimento asettico e senza fine che corrode i caratteri individuali, consumando le potenzialità della propria vita.
Da un punto di vista psicoanalitico è come se si configurasse un assetto simile a quello di una “patologia narcisistica da difetto” contraddistinta dalla carenza di quel “narcisismo minimo vitale” o “necessario” (Bolognini, 2008) le cui carenze possono limitare la capacità di accettare ed amare il proprio sé, sia nei riguardi di se stessi, che degli altri.
- Details
- Hits: 2657

Morire di fame o morire di tumore… this is the question
Teniamoci la fabbrica, tenetevi i padroni
di Militant
 Perdere il lavoro, per quanto di merda. Perdere la casa e regalarla alla banca con cui hai acceso il mutuo. Perdere la possibilità di immaginare un futuro per te e la tua famiglia in una regione in cui questa parola ha sempre avuto poco senso. Insomma, morire di fame, adesso. Oppure morire di tumore fra qualche anno. E’ questo il dubbio tutt’altro che amletico che ci pone la vicenda dell’Ilva di Taranto. Un dubbio che all’interno del quadro delle compatibilità capitalistiche non potrà essere sciolto. Sappiamo bene quanto questo ragionamento possa apparire astratto di fronte alla durezza del contingente, perchè con le idee non ci riempi il piatto. Almeno finchè non diventano forza materiale. Avevamo pensato di dire la nostra sulla mobilitazione operaia di Taranto, una lotta con cui non possiamo che essere solidali, ma girando in rete abbiamo trovato questo post sul sito Operai Contro che ci pare estremamente efficace oltre che condivisibile, per cui ve lo riproponiamo.
Perdere il lavoro, per quanto di merda. Perdere la casa e regalarla alla banca con cui hai acceso il mutuo. Perdere la possibilità di immaginare un futuro per te e la tua famiglia in una regione in cui questa parola ha sempre avuto poco senso. Insomma, morire di fame, adesso. Oppure morire di tumore fra qualche anno. E’ questo il dubbio tutt’altro che amletico che ci pone la vicenda dell’Ilva di Taranto. Un dubbio che all’interno del quadro delle compatibilità capitalistiche non potrà essere sciolto. Sappiamo bene quanto questo ragionamento possa apparire astratto di fronte alla durezza del contingente, perchè con le idee non ci riempi il piatto. Almeno finchè non diventano forza materiale. Avevamo pensato di dire la nostra sulla mobilitazione operaia di Taranto, una lotta con cui non possiamo che essere solidali, ma girando in rete abbiamo trovato questo post sul sito Operai Contro che ci pare estremamente efficace oltre che condivisibile, per cui ve lo riproponiamo.
CHE COSA SUCCEDE ALL’ILVA DI TARANTO?
Lo stabilimento siderurgico di Taranto è una bomba a cielo aperto. Lo è sempre stato, da oltre mezzo secolo, da quando negli anni ’50 polizia e carabinieri sgomberarono con la forza centinaia di contadini poveri dagli oliveti e mandorleti espropriati per fare posto alla tomba industriale di centinaia di operai e di proletari dei quartieri più vicini. Da allora la strage di vite umane, espressa in primo luogo come morti, malattie e infortuni fra gli operai, poi come morti e malattie fuori dello stabilimento, è stata pratica quotidiana in fabbrica e in città.
- Details
- Hits: 2989

L’oscuramento
di Alberto Burgio
 Immaginiamo che al tempo della disputa tra geocentrici ed eliocentrici esistesse già un sistema dell’informazione simile all’attuale (televisioni, quotidiani e rotocalchi). E supponiamo che dalla vittoria degli uni o degli altri dipendessero le condizioni di vita della gente che da quelle televisioni e da quei giornali veniva informata. Come giudicheremmo, in questa ipotesi, una informazione che avesse sistematicamente nascosto la disputa e, per esempio, rappresentato la realtà sempre e soltanto sulla base della teoria geocentrica? Di questo, a mio modo di vedere, si tratta nella lettera sul “Furto d’informazione” che abbiamo inviato a molte agenzie di stampa e ad alcuni giornali nei giorni scorsi e che il manifesto (soltanto il manifesto) ha pubblicato integralmente in prima pagina. Il tema della nostra denuncia è l’«ordine del discorso pubblico» sulla crisi. Un tema concretissimo e materiale, produttivo di fatti altrettanto concreti, che recano nomi illustri: senso comune, ideologia, consenso.
Immaginiamo che al tempo della disputa tra geocentrici ed eliocentrici esistesse già un sistema dell’informazione simile all’attuale (televisioni, quotidiani e rotocalchi). E supponiamo che dalla vittoria degli uni o degli altri dipendessero le condizioni di vita della gente che da quelle televisioni e da quei giornali veniva informata. Come giudicheremmo, in questa ipotesi, una informazione che avesse sistematicamente nascosto la disputa e, per esempio, rappresentato la realtà sempre e soltanto sulla base della teoria geocentrica? Di questo, a mio modo di vedere, si tratta nella lettera sul “Furto d’informazione” che abbiamo inviato a molte agenzie di stampa e ad alcuni giornali nei giorni scorsi e che il manifesto (soltanto il manifesto) ha pubblicato integralmente in prima pagina. Il tema della nostra denuncia è l’«ordine del discorso pubblico» sulla crisi. Un tema concretissimo e materiale, produttivo di fatti altrettanto concreti, che recano nomi illustri: senso comune, ideologia, consenso.
Naturalmente la crisi è fatta di dinamiche economico-finanziarie, alla base delle quali operano, sul piano nazionale e «globale», determinati assetti di potere e una determinata struttura dei processi di produzione e circolazione. Su questo terreno si sono verificate, a partire dal 2007, le vicende che hanno innescato la tempesta finanziaria. Ma la questione che subito si pone – basta un attimo per comprenderlo – è che qualunque cosa si dica a questo riguardo è frutto di interpretazioni. Soltanto persone faziose, intolleranti come Giuliano Ferrara possono pretendere che un’opinione (la loro) sia «oggettiva» e inoppugnabile. Chiunque altro converrà che ogni narrazione implica assunzioni teoriche, ipotesi e, appunto, interpretazioni.
- Details
- Hits: 4014

La Germania incomincia a fare i conti sull’Euro
di Vladimiro Giacché
 Da tempo l’interpretazione dei discorsi dei governanti europei non ha nulla da invidiare, quanto a complessità, all’interpretazione dei discorsi dei leader sovietici ai quali si dedicavano dei veri e propri specialisti, i sovietologi. Da mesi, ormai ogni giorno, stuoli di eurologi si rompono la testa per capire il senso dell’ultima intervista della Merkel o dell’ultimo intervento di Draghi: e in base a quello che hanno capito comprano o vendono titoli di Stato. Anche in questo fine settimana gli eurologi hanno avuto il loro bel da fare con l’intervista rilasciata da Wolfgang Schäuble alla “Welt am Sonntag”.
Da tempo l’interpretazione dei discorsi dei governanti europei non ha nulla da invidiare, quanto a complessità, all’interpretazione dei discorsi dei leader sovietici ai quali si dedicavano dei veri e propri specialisti, i sovietologi. Da mesi, ormai ogni giorno, stuoli di eurologi si rompono la testa per capire il senso dell’ultima intervista della Merkel o dell’ultimo intervento di Draghi: e in base a quello che hanno capito comprano o vendono titoli di Stato. Anche in questo fine settimana gli eurologi hanno avuto il loro bel da fare con l’intervista rilasciata da Wolfgang Schäuble alla “Welt am Sonntag”.
L’impressione generale è che il ministro delle finanze tedesco si barcameni con difficoltà, dando un colpo al cerchio e uno alla botte. Da una parte Schäuble insiste sul fatto che l’impossibilità per la Grecia di conseguire gli obiettivi fissati dalla troika dipenda dal fatto che i programmi imposti da FMI, BCE e Unione Europea sono stati applicati male e non dalla loro insensatezza. Aggiunge poi che non ci sono spazi “per ulteriori concessioni” (sic) alla Grecia. Sulla Spagna tenta senza grande fortuna uno slalom, prima minimizzando l’entità del problema dei rendimenti – ormai elevatissimi – dei titoli di Stato spagnoli (“non viene giù il mondo se a un’asta di titoli di Stato si deve pagare un paio di punti percentuali in più”), poi dichiarando che gli aiuti sinora offerti sono sufficienti e negando, contro ogni evidenza, che ci sia del vero nei rumors di un’ulteriore prossima richiesta di aiuto da parte della Spagna. Queste parti dell’intervista di Schäuble sono di per sé tali da alimentare lo scetticismo sulla concreta possibilità per Draghi di intervenire “sino a dove necessario” per contrastare l’esplosione dei rendimenti dei titoli di Stato spagnoli e italiani. E da questo punto di vista non c’è niente di nuovo: è almeno da un anno e mezzo che i governanti tedeschi ci hanno abituato a dichiarazioni che gettano benzina sul fuoco, alimentando la convinzione che non potrà esserci alcun intervento risolutivo da parte europea nei confronti dei paesi che hanno difficoltà di approvvigionamento sui mercati dei capitali.
- Details
- Hits: 3155

Un particolare tipo di regolazione: la de-regolazione
di Antiper
 Uno dei mantra sulla crisi finanziaria internazionale esplosa nel 2007-2008 è quello secondo cui, tale crisi, sarebbe figlia delle politiche di “de-regulation” avviate da Reagan a partire soprattutto dagli anni '80 e proseguite nei decenni successivi. In particolare, la de-regolazione dei mercati finanziari e la rimozione [2] del divieto imposto alle banche di usare in modo speculativo i conti correnti - e non solo solo il proprio denaro o quello esplicitamente destinato a tale scopo -, combinata con l'enorme potere accumulato dai manager, avrebbero favorito la tendenza alla de-responsabilizzazione, all'assunzione di enormi rischi speculativi e, in definitiva, a quella dilagante “mancanza di etica” che avrebbe poi prodotto il disastro.
Uno dei mantra sulla crisi finanziaria internazionale esplosa nel 2007-2008 è quello secondo cui, tale crisi, sarebbe figlia delle politiche di “de-regulation” avviate da Reagan a partire soprattutto dagli anni '80 e proseguite nei decenni successivi. In particolare, la de-regolazione dei mercati finanziari e la rimozione [2] del divieto imposto alle banche di usare in modo speculativo i conti correnti - e non solo solo il proprio denaro o quello esplicitamente destinato a tale scopo -, combinata con l'enorme potere accumulato dai manager, avrebbero favorito la tendenza alla de-responsabilizzazione, all'assunzione di enormi rischi speculativi e, in definitiva, a quella dilagante “mancanza di etica” che avrebbe poi prodotto il disastro.
Ora, parlare di etica alle banche e alle imprese capitalistiche è un po' come parlare di dieta al topo davanti al formaggio: bei discorsi sì, ma l'istinto è quello che è. Inoltre, la “mancanza di etica” degli squali di Wall Street non è certo una novità e poteva essere ben rilevata molto prima del 2007-2008 (magari nel 2000-2001 all'epoca dei crolli del Nasdaq e dei fallimenti di Enron, WorldCom e di una serie di banche USA di media grandezza; o, prima ancora, verso la fine degli anni '90, all'epoca dei crolli delle borse asiatiche, messicana, brasiliana, russa); risulta dunque evidente che la “mancanza di etica”, se fosse una spiegazione, lo sarebbe di tutte le crisi.
Certamente, nel corso degli ultimi decenni vi sono state “de-regolazioni” che hanno gonfiato le vele alla speculazione finanziaria.
- Details
- Hits: 3625

La svolta di Draghi è comunque inutile (quindi dannosa)
di Alberto Bagnai
“La svolta di Draghi”… Come “La scelta di Sophie”… Il solito fottuto genitivo soggettivo, quello che nei titoli si porta molto (ricordate “Le obiezioni del piddino”?)Vi offro un lungo post della lunga, lunghissima serie intitolata “ma dde che ssamo a parla’?”
 Ho in comune con il prof. Santarelli il fatto di avere un percorso accademico piuttosto variegato. Come lui ha preso il PhD in Anatomia finanziaria comparata ai Bagni Luigi 93 di Cattolica, così io ho preso un master in Pragmatismo concettuale al Dopolavoro Ferroviario di Roma. Ricordo con affetto tutti i miei insegnanti. Questa storia della svolta di Draghi mi ha fatto tornare in mente Giuliano. Quale fosse il suo lavoro non l’ho mai capito troppo bene: agente assicurativo? Rappresentante? Intermediario? Chissà. Certo che però lui ogni mattina era lì, sul pontile. Di lavori di intermediazione che lasciano le mattinate libere, ecco, ora, a posteriori, me ne viene in mente uno solo, e devo dire che lui il physique du rôle, per quel mestiere, ce l’aveva. Parlo nella quasi certezza che non mi legga, perché allora, trent’anni or sono, aveva passato la cinquantina, tanto che io, in un accesso di classicismo, solevo chiamarlo Giuliano l’aprostata, confondendo ad arte l’apostasia con l’adenoma (che poi son due cose che iniziano entrambe per “a”, come apolitico, apartitico e anfame – per chi se lo ricorda…).
Ho in comune con il prof. Santarelli il fatto di avere un percorso accademico piuttosto variegato. Come lui ha preso il PhD in Anatomia finanziaria comparata ai Bagni Luigi 93 di Cattolica, così io ho preso un master in Pragmatismo concettuale al Dopolavoro Ferroviario di Roma. Ricordo con affetto tutti i miei insegnanti. Questa storia della svolta di Draghi mi ha fatto tornare in mente Giuliano. Quale fosse il suo lavoro non l’ho mai capito troppo bene: agente assicurativo? Rappresentante? Intermediario? Chissà. Certo che però lui ogni mattina era lì, sul pontile. Di lavori di intermediazione che lasciano le mattinate libere, ecco, ora, a posteriori, me ne viene in mente uno solo, e devo dire che lui il physique du rôle, per quel mestiere, ce l’aveva. Parlo nella quasi certezza che non mi legga, perché allora, trent’anni or sono, aveva passato la cinquantina, tanto che io, in un accesso di classicismo, solevo chiamarlo Giuliano l’aprostata, confondendo ad arte l’apostasia con l’adenoma (che poi son due cose che iniziano entrambe per “a”, come apolitico, apartitico e anfame – per chi se lo ricorda…).
Insomma, un bel giorno Giuliano arriva tutto in tiro (visita a un cliente?), e il commento mi affiorò spontaneo alle labbra: “Ammazza Giulia’, quanto sei fico oggi! Hai svortato?”. Rispose scanzonato, da vero romanaccio: “Sì, ma ho pure ‘nfrociato!” (Per i non romani: “svorta’” significa dare una svolta in senso positivo a una situazione – ad esempio economica – ma anche cambiare direzione con l’automobile; “infrociare” significa andare a sbattere – con l’automobile. La risposta di Giuliano giocava sull’ambiguità della “svorta”).
- Details
- Hits: 3017

L'agente segreto dei veleni di Stato
di Massimiliano Ferraro
 L’affondamento nel Mediterraneo di vecchie navi mercantili cariche di rifiuti tossici e radioattivi è un capitolo della storia italiana ancora in buona parte oscuro. Un fenomeno dibattuto su cui tutte le ipotesi restano ancora plausibili secondo la logica. Le hanno chiamate navi dei veleni, ma per i governi che via via si sono succeduti fino ad oggi non sono mai esistite. Eppure secondo Francesco Fonti, controverso pentito di ‘ndrangheta, fin dagli anni settanta dei rappresentanti dello Stato avrebbero trattato con la malavita le condizioni per fare sparire illegalmente scorie e veleni scomodi. Confessioni le sue che nel 2005 hanno aperto scenari impensabili e dolorosi ai quali si è infine deciso di non tenere conto.
L’affondamento nel Mediterraneo di vecchie navi mercantili cariche di rifiuti tossici e radioattivi è un capitolo della storia italiana ancora in buona parte oscuro. Un fenomeno dibattuto su cui tutte le ipotesi restano ancora plausibili secondo la logica. Le hanno chiamate navi dei veleni, ma per i governi che via via si sono succeduti fino ad oggi non sono mai esistite. Eppure secondo Francesco Fonti, controverso pentito di ‘ndrangheta, fin dagli anni settanta dei rappresentanti dello Stato avrebbero trattato con la malavita le condizioni per fare sparire illegalmente scorie e veleni scomodi. Confessioni le sue che nel 2005 hanno aperto scenari impensabili e dolorosi ai quali si è infine deciso di non tenere conto.
Siamo in Italia, il paese dei segreti inconfessabili, dove si è abituati a camminare in equilibrio sul filo sottile che separa la dietrologia dalla vergogna. Tuttavia, vent’anni dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio, di cui ancora si scoprono agghiaccianti verità nascoste, le parole di Fonti meriterebbero una rinnovata attenzione da parte della magistratura e dei media. Se fosse tutto vero, quante e quali navi tossiche sono state affondate nei nostri mari? Per ordine di chi?
Forse è ancora possibile provare a risalire a qualcuno che conosce la risposta a queste e ad altre domande: un uomo alto circa un metro ottanta, sui sessant’anni, che quando ne aveva trenta di meno aveva un fisico atletico e una chioma di capelli castani ben pettinati all’indietro. Non sappiamo il suo vero nome, ma conosciamo lo pseudonimo con il quale era noto alla segreteria del Servizio Segreto Militare: Pino. È lui la persona da cercare, quello che sa, il rappresentante dello Stato nell’affare miliardario dello smaltimento illecito dei veleni.
- Details
- Hits: 2990

L’arsenale della Bce
di Domenico Mario Nuti
 La crisi attuale dell’euro è stata definita da Nouriel Roubini ed alcuni bloggers come “uno scontro ferroviario al rallentatore”. Negli ultimi dodici mesi i treni hanno continuato nella loro corsa verso lo scontro, addirittura accelerando la loro velocità, ma lo scontro non va dato per scontato. Ci sono ancora delle misure – sia pure problematiche a dire il vero – che possono ancora evitare la collisione.
La crisi attuale dell’euro è stata definita da Nouriel Roubini ed alcuni bloggers come “uno scontro ferroviario al rallentatore”. Negli ultimi dodici mesi i treni hanno continuato nella loro corsa verso lo scontro, addirittura accelerando la loro velocità, ma lo scontro non va dato per scontato. Ci sono ancora delle misure – sia pure problematiche a dire il vero – che possono ancora evitare la collisione.
I tedeschi sono contrari alla cosiddetta “mutualizzazione del debito pubblico europeo”, mediante l’emissione di obbligazioni per le quali tutti i membri dell’EMU sarebbero responsabili individualmente e collettivamente (jointly and severally). Un’opposizione ragionevole, come ho argomentato nel post precedente sul mio Blog Transition, perché inevitabilmente sarebbero i tedeschi e i pochi paesi rimanenti che godono di un rating AAA a finire col pagare per tutti.
I tedeschi inoltre si oppongono ad un aumento dei fondi del cosiddetto Meccanismo Europeo di Stabilizzazione (MES), detto anche Fondo Salva-stati, molto meno ragionevolmente in vista dell’ingente esposizione della Germania alla crisi dell’euro. Per di più l’impiego del MES come scudo anti-spread, che pareva essere stato approvato dal Consiglio Economico del 28-29 giugno e che avrebbe consentito di guadagnare un po' di tempo per trovare altre soluzioni, viene ritardato proprio nel momento in cui esso è più urgente proprio dalle tattiche di temporeggiamento della Corte Costituzionale Tedesca.
- Details
- Hits: 2604

La democrazia delle parole nel gioco politico
di Paolo Favilli
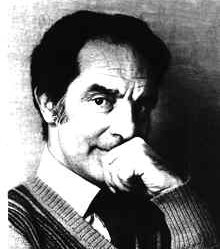 «Una democrazia vive se la parola è operante, se cioè la critica, la denuncia, l'argomentazione, la domanda di verità non passano senza lasciare un segno. E solo in questo clima la parola giusta non si confonde con la parola ingiusta o calunniosa o vuota». In questi termini Italo Calvino stabilisce un importante rapporto tra qualità della democrazia e parola critica, tra democrazia e parole che non confondono i significati, tra democrazia e qualità del discorso pubblico. Lo fa, come tutti i grandi anticipatori, nel momento in cui il fenomeno comincia a diventare componente preoccupante del discorso pubblico, quando il linguaggio politico comincia a eludere le «cose reali». Quando la genericità degli accostamenti concettuali si trasforma quasi inevitabilmente in menzogna no, il discorso «tende a diventare «generico cioè menzognero». Se usiamo le note sul linguaggio politico di Calvino come misura della qualità della democrazia oggi, non possiamo che prendere atto di una crisi assai profonda. Qualche giorno fa, su questo giornale, ho sostenuto che persino le riflessioni problematiche di una personalità intellettuale di alto livello, come Mario Tronti, possono dar adito a ricadute di esercizio retorico finalizzate all'immediatezza della manovra elettorale.
«Una democrazia vive se la parola è operante, se cioè la critica, la denuncia, l'argomentazione, la domanda di verità non passano senza lasciare un segno. E solo in questo clima la parola giusta non si confonde con la parola ingiusta o calunniosa o vuota». In questi termini Italo Calvino stabilisce un importante rapporto tra qualità della democrazia e parola critica, tra democrazia e parole che non confondono i significati, tra democrazia e qualità del discorso pubblico. Lo fa, come tutti i grandi anticipatori, nel momento in cui il fenomeno comincia a diventare componente preoccupante del discorso pubblico, quando il linguaggio politico comincia a eludere le «cose reali». Quando la genericità degli accostamenti concettuali si trasforma quasi inevitabilmente in menzogna no, il discorso «tende a diventare «generico cioè menzognero». Se usiamo le note sul linguaggio politico di Calvino come misura della qualità della democrazia oggi, non possiamo che prendere atto di una crisi assai profonda. Qualche giorno fa, su questo giornale, ho sostenuto che persino le riflessioni problematiche di una personalità intellettuale di alto livello, come Mario Tronti, possono dar adito a ricadute di esercizio retorico finalizzate all'immediatezza della manovra elettorale.
Che politici, uomini di potere, come esemplificavo in quell'articolo, utilizzino, peraltro tramite una retorica assai povera, soprattutto ripetitiva, l'indeterminatezza delle parole per sfuggire al peso delle cose è, ormai, prassi consueta.
Vi sono però tentativi di dare sostanza intellettuale ad una proposta politica che è la medesima degli uomini di potere citati, tramite una retorica meno primitiva, una retorica fatta di riferimenti culturali alti, una retorica che però, tramite «genericità», rientra perfettamente nelle «menzogne» così come sono definite dalla formulazione di Calvino.
- Details
- Hits: 2507

Monti alla corte di Putin, Putin alla corte del FMI
di Comidad
 Mentre allo spread ed alle borse succedeva di tutto, un Mario Monti sempre più patetico volava in Russia per svolgere il ruolo di procuratore d'affari per conto dell'ENI, come già i suoi due predecessori alla Presidenza del Consiglio. Ma si tratta ormai di affari parecchio ridimensionati, poiché si sta parlando di un ENI azzoppato dalla perdita della Libia, che ha comportato non solo la chiusura del principale rubinetto di petrolio, ma anche della cassaforte finanziaria di tutte le multinazionali italiane.
Mentre allo spread ed alle borse succedeva di tutto, un Mario Monti sempre più patetico volava in Russia per svolgere il ruolo di procuratore d'affari per conto dell'ENI, come già i suoi due predecessori alla Presidenza del Consiglio. Ma si tratta ormai di affari parecchio ridimensionati, poiché si sta parlando di un ENI azzoppato dalla perdita della Libia, che ha comportato non solo la chiusura del principale rubinetto di petrolio, ma anche della cassaforte finanziaria di tutte le multinazionali italiane.
Sino ad un anno e mezzo fa, Libia e Italia erano più che soci d'affari, costituivano un unico sistema economico-finanziario; e gli effetti della mutilazione oggi si avvertono. E pensare che appena nel febbraio dello scorso anno, l'ENI poteva permettersi di fare da guida e mallevadore per gli affari della multinazionale russa Gazprom in Libia. Chi trovasse in queste reminiscenze dei motivi per rimpiangere il governo precedente, si chieda anche perché mentre il Buffone di Arcore baciava la mano a Gheddafi, intanto i suoi giornali lo chiamavano beduino. [1]
Nel marzo dello scorso anno appariva ancora realistico ipotizzare per la crisi libica uno scenario di tipo kosovaro, con la secessione della Cirenaica. In effetti poi la NATO ha potuto avere in Libia un margine di manovra praticamente illimitato, che ha condotto ad uno scenario di tipo congolese, con uno Stato ed un governo puramente fittizi, e con il territorio direttamente spartito tra le principali multinazionali angloamericane. Anche il black-out informativo dalla Libia non ha precedenti, dato che passano solo i video-fiction della propaganda NATO.
- Details
- Hits: 2838

Scenari economici e scemari politici
di Aldo Carra
Dal Fmi alle società di consulenza, si moltiplicano modelli e previsioni. Il paradosso è che proprio quando l’attendibilità scientifica dei modelli previsionali diminuisce, il loro “peso politico” aumenta
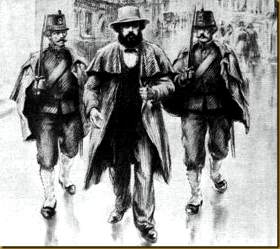 Adesso il Fondo Monetario Internazionale di scenari sulla situazione italiana ne ha formulati addirittura sette e lo ha fatto considerando le diverse politiche che potranno essere fatte.
Adesso il Fondo Monetario Internazionale di scenari sulla situazione italiana ne ha formulati addirittura sette e lo ha fatto considerando le diverse politiche che potranno essere fatte.
Secondo il documento elaborato dai tecnici dell’Fmi, il rapporto debito/Pil, che per il 2012 è previsto pari al 126,4%, potrebbe salire al 128% se dovessero registrarsi bassa domanda e “fallimento delle riforme”, oppure al 131% se dovessero aggiungersi scarsa fiducia dei mercati sulla sotenibilità del nostro debito e “mancata attuazione delle riforme già fatte”.
Se poi ci dovesse essere il contagio tra turbolenze dell’area euro e una “frenata delle riforme strutturali”, lo spread potrebbe fare un altro balzo in avanti, il Pil fermarsi ed il rapporto debito/Pil balzerebbe addirittura al 140%.
Come si vede i se sono tanti, ma la costante è “l’attuazione delle riforme strutturali” varate e la “prosecuzione” sulla strada intrapresa.
Poiché queste cose le dicono i "tecnici" dell’Fmi, cioè della più importante autorità monetaria, quasi nessuno osa contestarle, e anzi molti politici e i tecnici prestati alla politica si sentono sollevati: adesso sanno cosa dovranno fare e, con certezza quasi matematica, cosa di conseguenza accadrà.
Potenza della tecnica quando la politica, di fronte alla complessità dei problemi, da in appalto la sua funzione e si riduce a fare i compiti che i tecnici prescrivono. Verrebbe naturale a questo punto chiedersi: ma allora a cosa è servita la terapia shock dei professori che hanno preso in cura il malato con un deficit al 120%? Perché non ci sono stati e nemmeno si intravedono effetti positivi?
- Details
- Hits: 2096
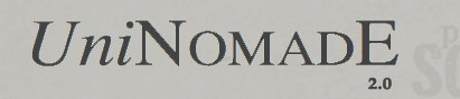
Senza margini. Appunti per l’autunno
di Sandro Mezzadra e Federico Rahola
 Attorno alla Spagna, in queste settimane, stiamo assistendo al dispiegarsi di un nuovo capitolo del tentativo di costruire, con immane violenza, una nuova costituzione materiale dell’Unione Europea. All’ortodossia ordoliberale di stampo tedesco si associa una perentoria gerarchizzazione degli spazi, immaginata come al solito con poca fantasia: i margini dell’Europa sono la linea del fronte, e dal presunto centro si irradiano le linee guida di una terapia shock che punta a determinare una vera e propria trasformazione “antropologica”, secondo retoriche che ormai si incontrano negli stessi organi di stampa “liberal” dell’Europa settentrionale. Il neo-liberalismo mostra oggi interamente – a partire dalla generalizzazione del debito come principale dispositivo di governo – il suo fondo autoritario, punitivo e lavorista: ogni interstizio della vita va messo al lavoro, in un vero e proprio paradossale revival della teoria del valore-lavoro (si aumenta l’età pensionabile, si aboliscono le festività, si punta a far entrare prima possibile i giovani nel mercato del lavoro). Ma di quale lavoro stiamo parlando? Le statistiche sulla disoccupazione, in particolare giovanile, raggiungono soglie fino a poco tempo fa impensabili, le politiche di austerity hanno un effetto moltiplicatore sulla depressione economica, e ormai nessuno crede più davvero alla favola continuamente procrastinata di una ripresa di là da venire.
Attorno alla Spagna, in queste settimane, stiamo assistendo al dispiegarsi di un nuovo capitolo del tentativo di costruire, con immane violenza, una nuova costituzione materiale dell’Unione Europea. All’ortodossia ordoliberale di stampo tedesco si associa una perentoria gerarchizzazione degli spazi, immaginata come al solito con poca fantasia: i margini dell’Europa sono la linea del fronte, e dal presunto centro si irradiano le linee guida di una terapia shock che punta a determinare una vera e propria trasformazione “antropologica”, secondo retoriche che ormai si incontrano negli stessi organi di stampa “liberal” dell’Europa settentrionale. Il neo-liberalismo mostra oggi interamente – a partire dalla generalizzazione del debito come principale dispositivo di governo – il suo fondo autoritario, punitivo e lavorista: ogni interstizio della vita va messo al lavoro, in un vero e proprio paradossale revival della teoria del valore-lavoro (si aumenta l’età pensionabile, si aboliscono le festività, si punta a far entrare prima possibile i giovani nel mercato del lavoro). Ma di quale lavoro stiamo parlando? Le statistiche sulla disoccupazione, in particolare giovanile, raggiungono soglie fino a poco tempo fa impensabili, le politiche di austerity hanno un effetto moltiplicatore sulla depressione economica, e ormai nessuno crede più davvero alla favola continuamente procrastinata di una ripresa di là da venire.
Davvero, come ha affermato in questi giorni Mario Draghi, l’euro è “irreversibile”?
- Details
- Hits: 3187
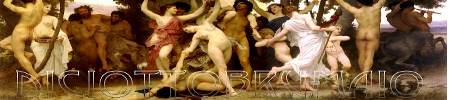
Quelli che Marx dopotutto ...
Olympe de Gouges
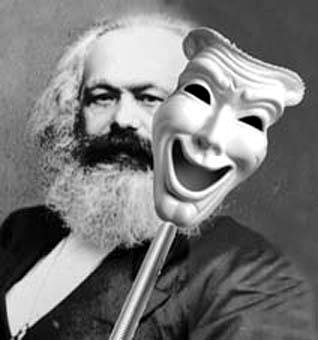 Le dottrine dell'economia volgare, ossia quelle teorie borghesi che da una certa epoca in poi non hanno come compito di analizzare il modo di produzione esistente, sono tutte uguali nella sostanza, salvo appunto la rappresentazione di ciò che esse spacciano per realtà. C’è quella che punta sull'identità d’interessi tra capitale e lavoro, sull'armonia e sul benessere universale come conseguenza della libera concorrenza, l’utopia dell’equilibrio perfetto. È entrata in crisi un secolo fa, ma nelle fasi alte del ciclo economico essa viene rispolverata perché fa la sua figura nella chiacchiera accademica. Oggi è smentita dai fatti e in modo sempre più effervescente dagli effetti dalla crisi che si compie sotto i nostri occhi. Poi ci sono le teorie di pronto soccorso, laddove è spiegato il “perché il sistema capitalistico genera, inevitabilmente, una grande crisi”.
Le dottrine dell'economia volgare, ossia quelle teorie borghesi che da una certa epoca in poi non hanno come compito di analizzare il modo di produzione esistente, sono tutte uguali nella sostanza, salvo appunto la rappresentazione di ciò che esse spacciano per realtà. C’è quella che punta sull'identità d’interessi tra capitale e lavoro, sull'armonia e sul benessere universale come conseguenza della libera concorrenza, l’utopia dell’equilibrio perfetto. È entrata in crisi un secolo fa, ma nelle fasi alte del ciclo economico essa viene rispolverata perché fa la sua figura nella chiacchiera accademica. Oggi è smentita dai fatti e in modo sempre più effervescente dagli effetti dalla crisi che si compie sotto i nostri occhi. Poi ci sono le teorie di pronto soccorso, laddove è spiegato il “perché il sistema capitalistico genera, inevitabilmente, una grande crisi”.
C’è voluto del tempo, i fatti si sono dovuti dimostrare arcigni e testardi quanto mai, ma alla fine lorsignori si sono dovuti arrendere: “La causa causante della crisi attuale è stata un cambiamento strutturale dell'economia reale: il declino dei redditi nell'industria si deve a ciò che di solito è un bene (l'aumento della produttività) e alla globalizzazione che ha prodotto una forte moderazione salariale. In altri termini: il settore industriale è vittima del suo proprio successo”.
A dire il vero non si tratta, se si gratta la vernice, di una teoria molto nuova (vds. teorie “dei cicli economici”, della “sproporzione” e altre consanguinee).
- Details
- Hits: 3563

Un timido guerrafondaio
di Emiliano Brancaccio
 I miei ultimi interventi sulla crisi della zona euro hanno suscitato alcune interessanti reazioni. Gli articoli e le interviste sulle ambiguità di Syriza, sul fatto che c’è modo e modo di abbandonare la moneta unica e sulla necessità che la sinistra inizi a dotarsi di una exit strategy dall’euro hanno animato dibattiti ai quali hanno partecipato vari studiosi ed esponenti politici.
I miei ultimi interventi sulla crisi della zona euro hanno suscitato alcune interessanti reazioni. Gli articoli e le interviste sulle ambiguità di Syriza, sul fatto che c’è modo e modo di abbandonare la moneta unica e sulla necessità che la sinistra inizi a dotarsi di una exit strategy dall’euro hanno animato dibattiti ai quali hanno partecipato vari studiosi ed esponenti politici.
Il segretario del PRC, ad esempio, ha ritenuto opportuno criticarmi sostenendo che della “bomba atomica” si può discutere solo dopo che sia esplosa, non prima. Questo atteggiamento tattico è prevalente tra gli attuali esponenti della sinistra, ma sembra trascurare un piccolo dettaglio: i tempi di innesco e la specifica traiettoria della “bomba” in questione non saranno affatto irrilevanti per i destini di coloro ai quali il PRC e il resto della sinistra vorrebbero chiedere voti. Eludere la questione sperando che nessuno si accorga dello stallo in cui versano le forze di sinistra temo sia illusorio, e potrebbe compromettere persino obiettivi modestissimi come la mera autoriproduzione di qualche residuo gruppo dirigente.
Ma non è finita qui. Nel corso di un seminario organizzato pochi giorni fa dalla Fondazione Di Vittorio e dall’ARS, uno stimato collega economista, della scuola di Federico Caffé, si è lanciato in un’animosa invettiva contro il sottoscritto. Il collega mi ha sostanzialmente dato del “guerrafondaio” semplicemente perché ho sostenuto che i tempi dovrebbero ritenersi maturi affinché le forze di “sinistra” elaborino un autonomo punto di vista sulle diverse, possibili modalità di deflagrazione dell’eurozona.
- Details
- Hits: 6805

Caro Emiliano ti scrivo...
di Alberto Bagnai
 Caro Emiliano,
Caro Emiliano,
ho letto con interesse il tuo intervento su Gli intellettuali “di sinistra” e la crisi della zona euro. Poi lo ho riletto contando le “i”. Ce ne sono 888 (me lo dice Word): manca però qualche puntino. Se me lo consenti, lo metto io (libero tu di toglierlo, se ti sembra sia messo male).
Due (o tre) premesse
Faccio due premesse, anzi tre. Credo a te interessi solo la prima, le altre sono cose che sai e che affermo solo per collocare il nostro scambio, che è uno scambio fra professionisti, nella giusta prospettiva scientifica, a beneficio dei profani.
Premessa prima
La prima premessa è che non ti conosco personalmente. Da quando ho iniziato la mia attività divulgativa, che necessariamente implica un risvolto politico, ho capito una cosa fondamentale: in politica le persone bisogna guardarle negli occhi. Sarà per evitare questo compito non sempre piacevole che ho preferito, fin da piccolo, dedicarmi alla ricerca. Ma ora c’è urgenza, non ci si può sottrarre alle proprie responsabilità. E allora bisogna guardare la gente negli occhi. Ripeto: con te non è stato possibile, e può essere quindi che quanto segue sia, come dire, sfuocato. Ma servirà comunque a capire se varrà la pena (in futuro) di guardarsi negli occhi.
Premessa seconda
La seconda è che conosco e apprezzo la tua attività scientifica nel campo che oggi interessa tutti.
Page 526 of 610

