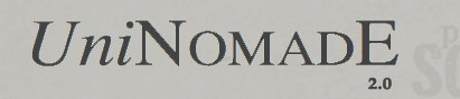
La farsa dell’emergenza economica
Andrea Fumagalli
 L’emergenza ha sempre caratterizzato le decisioni salienti della politica italiana, soprattutto quando si tratta di tematiche socio-economiche. La politica dell’emergenza – si sa – è diventata lo strumento principale dell’arte del comando. Certo, da sola, rischia di non essere sufficiente, se non è accompagnata anche da una “predisposizione istituzionale” che accomuna maggioranza e opposizione, sotto l’egida del presidente della repubblica.
L’emergenza ha sempre caratterizzato le decisioni salienti della politica italiana, soprattutto quando si tratta di tematiche socio-economiche. La politica dell’emergenza – si sa – è diventata lo strumento principale dell’arte del comando. Certo, da sola, rischia di non essere sufficiente, se non è accompagnata anche da una “predisposizione istituzionale” che accomuna maggioranza e opposizione, sotto l’egida del presidente della repubblica.
Nell’estate del 1992, la necessità di operare in fretta e firmare accordi capestro ai danni dei lavoratori e delle lavoratrici (abolizione della scala mobile) era dettata dall’emergenza di entrare nell’Europa dell’euro.
Nell’estate 2011, la necessità di operare in fretta e promulgare leggi finanziarie draconiane, oltre ad accompagnarsi ad accordi sindacali, di nuovo a danno dei lavoratori e delle lavoratrici (ridimensionamento del contratto collettivo di lavoro) è dettata, invece, dalla necessità di non uscire dall’Europa dell’euro.
Tutti d’accordo, dunque, nel fare presto, “per dare un segnale chiaro e inequivocabile alla speculazione finanziaria”, ma pochi entrano nel merito dei contenuti della manovra correttiva.
In primo luogo, occorre osservare che sono due i provvedimenti che si stanno varando. Il primo è il decreto legge che imposta la finanziaria per il periodo 2011-2014 e intende recuperare 33,3 mld di euro. Il secondo è invece la legge delega fiscale, che richiederà tempi più lunghi e che prevede interventi per 14,7 mld. Tale legge delega è stata modificata nel passaggio dal Senato alla camera. Nel testo presentato a Palazzo Madama, sia nel 2011 che nel 2012, le maggiori entrate producevano un effetto marginale sui saldi, mentre nel biennio successivo la riduzione del deficit operava prevalentemente attraverso il contenimento delle spese: circa il 61% nel 2013 e il 74% nel 2014. Ora dal testo licenziato dalle Camere, nel 2011 all’apporto più significativo delle entrate, cui è affidato circa l’89% della correzione, si unisce una contenuta riduzione della spesa. Nel 2012 l’apporto alla manovra netta è interamente legato alle entrate, a fronte di un aumento delle spesa. Nel biennio successivo, entrambe le componenti contribuiscono al miglioramento dei saldi, anche se resta prevalente l’apporto delle entrate: 54,6% nel 2013 e 60,1% nel 2014.
Complessivamente, la manovra economica ammontava inizialmente a 48 mld. Con le ultime modifiche introdotte alla Camera relative al taglio delle agevolazioni fiscali (del 5% per il 2013 e del 20% a partire dal 2014 che, se non sarà selettivo, finirà per colpire tutti i bonus) l’Erario prevede un recupero di gettito a regime pari a 3,5 mld nel 2013 e a 20 mld nel 2014. L’effetto complessivo della manovra arriva così a quasi 80 miliardi, di cui più della metà concentrati nel solo 2014. L’obiettivo è il quasi-pareggio di bilancio nel 2014 (-0,2%), con un avanzo primario, cioè al netto degli interessi passivi sul debito, del 5,2% del Pil. Tale manovra è distribuita nel tempo in modo asimmetrico e ciò è indicativo delle intenzioni del governo attuale. Infatti, per l’anno in corso, la correzione sarà solo di 2 mld, nel 2012 di 6 mld. Sarà quindi quando l’attuale legislatura sarà terminata che si concentrerà il grosso della manovra: 20 mld nel 2013 e 45 mld nel 2014.
Vediamo ora più in dettaglio i provvedimenti decisi, grazie anche alle elaborazioni di Roberto Romano del servizio studi della Cgil Lombardia. Il decreto legge della Finanziaria impone tagli per 23 mld e dovrebbe consentire maggiori entrate fiscali per 4 mld. Più in particolare, il contenimento della spesa pubblica, senza prendere in considerazione la cd. riduzione dei costi della politica (una sorta di specchietto per le allodole a vantaggio della stampa compiacente e con effetti quantitativi a dir poco risibili), interessa tre capitoli principali di spesa: minori trasferimenti alla sanità per 5, 45 mld di euro, con l’effetto di intervenire pesantemente sulla qualità del servizio e sulla garanzia dell’universalità dell’accesso. A ciò si aggiunga l’impossibilità di assunzioni e di far fronte al turn-over e sul lato fiscale all’introduzione di varie forme di ticket sanitari (25 euro per le visite al pronto soccorso con bollino bianco e di 10 euro in su per le visite specialistiche).
Complessivamente l’intervento sul fronte della sanità, tra tagli e entrate fiscali, diventa il più corposo di tutta la manovra. Si tratta, di fatto, di favorire uno strisciante processo di privatizzazione della salute a scapito delle fasce di reddito meno abbienti; riduzione dei trasferimenti agli enti locali per 6,4 mld (regioni a statuto ordinario – 1,6 mld, regioni a statuto straordinario – 2 mld, province – 0,8 mld, comuni con più di 5000 abitanti – 2 mld). Tale provvedimento è accompagnato in modo, stavolta non strisciante, dalla raccomandazione di compensare i mancati introiti con la privatizzazione delle imprese municipalizzate adibite alla fornitura dei servizi di pubblica utilità (acqua, energia, trasporti, ecc.), proprio dopo la vittoria del referendum per mantenere pubblica e comune l’erogazione dell’acqua. Gli effetti di tale provvedimento, oramai una costante delle ultime finanziarie (alla faccia del federalismo fiscale), porteranno presumibilmente ad un incremento delle tariffe dei servizi locali, ad una riduzione degli spazi di welfare locale e ad un incremento dell’imposizione locale.
Riduzioni delle spese ministeriali per 5 mld (valore stimato tutto da verificare poi nella concretezza), riduzione delle spese per il pubblico impiego per 740 milioni, in seguito al blocco della contrattazione collettiva e la minor indicizzazione degli assegni previdenziali (per un risparmio pari a 680 milioni), con l’effetto di diminuire il livello delle pensioni, pur se concentrato per i livelli superiore ai 1.400 euro al mese (è il contentino per i sindacati compiacenti).
Relativamente alla legge delega fiscale, che entrerà in vigore solo a partire dal biennio 2013-14, le maggiori entrate fiscali complessivamente ammonteranno a 36,5 mld, con un incremento della pressione fiscale di 2,7 punti (alla faccia della riduzione delle tasse). Esse interessano 3 voci principali:
Aumento dell’imposta indiretta (IVA del 10% e del 20%) di un punto percentuale, con una stima di incremento delle entrate di 6 mld. E’ uno dei provvedimenti più iniqui in quanto regressivo sulla distribuzione dei redditi e con l’effetto di un aumento dei prezzi che andrà a penalizzare ulteriormente la dinamica salariale e il mantenimento del potere d’acquisto dei salari, dal momento che con molta probabilità la forbice tra inflazione effettiva e inflazione programmata (che segna il limite massimo di adeguamento dei salari) tenderà ad ampliarsi.
Futura armonizzazione della tassazione sulle rendite finanziarie al 20% per introiti dell’ordine dei 2 mld. Al momento è previsto un incremento del bollo sul deposito titoli e l’aumento dell’Irap per banche, in attesa che la legge delega venga apporovata. Si tratta degli unici provvedimenti che si possono sottoscrivere, anche se l’armonizzazione della tassazione sulle rendite finanziarie non è detto che riesca a passare per le ovvie opposizioni dei poteri forti interessati. In realtà, si tratterebbe dell’unico intervento strutturale e duraturo, e per di più introduce un elemento di equità di trattamento fiscale in un contesto che vede la tassa sui depositi bancari (la forma di risparmio più comune per chi non possiede grandi redditi) più che doppia rispetto alle tasse sulle rendite finanziarie (interessi sui titoli e plusvalenze). Occorre però ricordare che si tratterà di un provvedimento dovuto, richiesto a livello europeo, per armonizzare l’imposizione fiscale europea e non l’esito di una precisa scelta politica.
Sulla base di tali provvedimenti e dei dati allegati, gli obiettivi del piano di stabilità e del piano nazionale delle riforme (pareggio di bilanci al 2014) possono sulla carta essere conseguiti. Tuttavia, nella relazione tecnica che accompagna la manovra, non vi è traccia delle stime di crescita del Pil e soprattutto degli effetti strutturali depressivi (minor crescita) e sociali (minor servizi) che tale manovra avrà sicuramente sulla dinamica congiunturale, soprattutto nel biennio 2013-14.
Per supplire a tale lacuna (che già basterebbe a definire poco trasparente la manovra correttiva), possiamo far riferimento ai dati previsivi del documento di economia e finanza 2011, approvato dal Parlamento in data 5 maggio 2011 e quindi prima dell’attuale manovra. In tale documento, gli effetti strutturali di un’ipotetica (allora) misura correttiva erano calcolati per il periodo 2012-204 nell’ordine di 0.8% per anno. Si tratta di dati non credibili visto che un intervento correttivo di 20 mld e di oltre 40 mld hanno rispettivamente un impatto recessivo di oltre l’1,4% nel 2013 e 2,7% nel 2014 sulla dinamica del Pil. E’ proprio per questo che all’ultimo momento, nel passaggio dal Senato alla Camera, per la paura che la manovra correttiva non venga valutata positivamente in sede europea, che, in modo del tutto frettoloso, si sono aggiunti i 20 mld di tagli alle agevolazioni fiscali. Come ricordato, si tratta di provvedimenti che devono essere ancora approvati in quanto contenuti nella legge delega e non nel decreto legge approvato il 15 luglio. Ne consegue, che in simili condizioni, nulla assicura che l’obiettivo del pareggio potrà essere conseguito. Ciò che invece appare certo è che si sono reperite le risorse per tranquillizzare i detentori dei titoli pubblici, per il 50% collocato all’estero e per l’80% in possesso delle Sim, dalle banche, dalle assicurazioni, nonché degli stati sovrani oggi leader in Europa (Germania e Francia, in primis).
1. A leggere i commenti sui giornali, a partire da quello di Alesina e Giavazzi sul Corriere della Sera del 16 luglio, il dibattito politico ed economico verte esclusivamente sul fatto se la manovra finanziaria varata in questi giorni sia credibile per i mercati e, quindi, sufficiente. Solo in seconda battuta, qualcuno interviene sull’entità e sul merito dei sacrifici richiesti, ma sempre in un’ottica di necessità inevitabile per evitare il peggio. Due sono i protagonisti indiscussi che animano il dibattito: i mercati finanziari e il rischio di default.
I primi vengono considerati come agenti economici neutri, oggettivamente e quasi metafisicamente definiti, giudici crudeli e inflessibili ma imparziali della credibilità, dell’efficienza e della reputazione di uno stato sempre meno sovrano. Le società di rating ne rappresentano le preferenze, anch’esse imparziali e oggettive. I mercati finanziari, in fondo, coincidono con il senso comune, l’opinione pubblica generalizzata, non influenzabile da decisioni individuali.
Il secondo protagonista è il default (fallimento), presentato come il peggiore di tutti i mali, causa di ogni possibile iattura nel futuro. Di converso, la riduzione del deficit pubblico e quindi l’eliminazione del rischio di default viene visto come condizione indispensabile per la crescita economica e della ricchezza, in grado di favorire quelle magnifiche sorti progressive che ci renderanno finalmente felici e contenti.
Tali costruzioni ideologiche sono ben sedimentate a livello sociale e di intellighenzia e costituiscono una delle basi, comune sia a destra che a sinistra, su cui si fonda il meccanismo biopolitico dello sfruttamento contemporaneo della cooperazione sociale. Ciò che distingue la sinistra dalla destra è al limite il metodo per consentire tale sfruttamento, a partire, però, dalla comune negazione della sua esistenza e di qualsiasi conflitto di classe che ne potrebbe derivare.
2. I mercati finanziari sono oggi il cuore stesso del comando capitalistico, rappresentano ciò che nell’epoca fordista era la grande impresa manageriale manifatturiera: sono, in altre parole, la controparte sociale ed economica, che gestisce e indirizza i meccanismi di sfruttamento del lavoro e della vita. Se essi sono rappresentati ideologicamente in termini di pubblica opinione, espressione “democratica” ed “efficiente” delle libere scelte individuali, è evidente che essi diventano automaticamente lo specchio di una realtà sociale coesa, libera e pacificata, al cui interno nessun conflitto e nessuna discriminazione può avere luogo.
In realtà le cose non stanno affatto così. Negli ultimi trent’anni, in concomitanza con il processo di estensione continua dei mercati finanziari (finanziarizzazione), i mercati finanziari sono quelli che più si sono concentrati in poche mani. Per capire questo punto è necessario distinguere tra coloro che operano nei mercati finanziari investendo, volenti o nolenti, quote del proprio reddito da lavoro (qualunque esso sia), spesso senza neanche saperlo (i clienti) e coloro che gestiscono tali investimenti per lucrare plusvalenze e innescare meccanismi di valorizzazione, chiamati, con un termine apparentemente neutro, “investitori istituzionali”. Più il numero dei “clienti” aumenta (così come nel fordismo, aumentava il numero dei compratori di automobili, ad esempio), più gli investitori istituzionali si sono ridotti di numero e fortemente concentrati (così come nel fordismo, si è assistito alla crescita di mercati sempre più oligopolistici, come nel caso dell’automobile).
La grave crisi finanziaria del 2008-09 ha accentuato ulteriormente questo processo. In contemporanea, si è ampliato il portafoglio dei titoli finanziari, grazie all’incremento dei titoli di debito sovrani, esito scontato della crescita dei deficit nazionali stessi – in Europa come in Usa e Giappone -, finalizzata proprio a ripianare i buchi di bilancio del sistema finanziario-creditizio. Oggi, non più di dieci Società d’intermediazione mobiliari (il cui acronimo, comunemente utilizzato – Sim – richiama, in modo ovviamente del tutto accidentale, quello di Stato Imperialista delle Multinazionali, usato dalle Brigate Rosse negli anni ‘70) controllano tra il 60% e il 70% del totale dei flussi finanziari in circolazione e il cui ammontare in valore è pari a circa 12 volte il Pil mondiale. Il restante 30-40% è in massima parte detenuto da banche e assicurazioni (oggi sempre più interrelate con le stesse Sim) e da Stati sovrani (quali Cina, India, paesi europei, ecc.) . La quota di attività finanziarie mondiali detenuto da singoli risparmiatori è risibile e irrilevante. In tale contesto, il trend delle borse è fortemente influenzate dalle scelte strategiche fatte dalle Sim e dei grandi investitori istituzionali. Lungi dall’essere il risultato delle libere forze di mercato, l’andamento dei mercati borsistici e l’attività speculativa in essa dominante è piuttosto l’esito della struttura gerarchica di tali mercati.
Il potere dei mercati finanziari è un potere violento, imposto con la forza del terrorismo mediatico, amplificato da stuoli di servitori, al punto di assumere connotati metafisici. Le società di rating ne rappresentano il braccio armato. La manovra finanziaria votata in questi giorni in Italia, non dissimile da quelle promulgate in Islanda, Irlanda, Grecia, Portogallo e Spagna, é semplicemente l’offerta votiva: garantisce infatti che i debiti contratti dallo Stato Italiano per far fronte ai perversi effetti della crisi economica causati dagli stessi mercati finanziari verranno onorati.
3. In questi giorni, il debito pubblico italiano è arrivato al massimo storico, sino a sfiorare i 1.900 miliardi di euro. Subito la stampa si è precipitata ad affermare che ogni residente in Italia ha un debito figurativo di 33.000 euro a testa. E’ un affermazione solitamente usata per creare quel panico e allarmismo tipico della shock economy di oggi. Ma tale debito in realtà può essere considerato anche un credito contratto dai cittadini con lo Stato Italiano (per lo più concentrato nelle regioni più ricche del paese e fonte di rendita finanziaria a tassazione privilegiata). Tale diversa interpretazione viene usata, invece, per affermare che un possibile fallimento dello Stato e il congelamento del debito stesso avrebbe pesanti ripercussioni sui redditi dei suoi abitanti. A seconda della convenienza politica, dunque, il debito pubblico viene definito in modi diversi, pur di giustificare l’imprescindibile necessità di controllarlo e, soprattutto, ridurlo.
Tale conclusione è tuttavia priva di qualsiasi validità teorica ed empirica. Da un punto di vista teorico, non vi è nessuna teoria economica, anche tra quelle più “liberiste”, in grado di dimostrare il nesso tra riduzione del debito pubblico e crescita economica. Anzi, l’evidenza empirica va in direzione contraria. Ciò che la teoria economica al limite pone in discussione sono due aspetti: il grado di sostenibilità del rapporto debito pubblico / Pil e le modalità del suo finanziamento.
Riguardo al primo punto, è necessario analizzare il differenziale tra tasso d’interesse sul debito e tasso di crescita del Pil. Solo se tale differenziale è positivo e per un certo numero di anni, la sostenibilità del debito può essere messa in discussione. Si tratta di una situazione che può essere salvaguardata se vengono promulgare precise scelte di politica economica atte a mantenere bassi i tassi d’interesse (come negli Usa). Al momento attuale, tale condizione non è verificata nel caso italiano, per l’incremento dei tassi d’interesse in seguito alla pressione speculativa, ma lo è sempre stata negli ultimi trent’anni. Diventa perciò importante le modalità di finanziamento del debito pubblico. La prassi liberista finora perseguita è di lasciar decidere al mercato finanziario (ovvero agli investitori istituzionali), con i risultati che abbiamo visto in termini di pressione speculativa, già a partire dal caso greco. Proprio partendo dall’esperienza della Grecia di un anno fa, la Bce è stata costretta, modificando in parte i compiti dettati dal Trattato di Maastricht, a intervenire sulle modalità di finanziamento, acquistando direttamente i titoli di stato dei paesi europei più a rischio. In tal modo, la domanda di titoli risulta superiore all’offerta e ciò porta all’abbassamento dei tassi d’interesse. Occorrerebbe che tale pratica diventi la norma e non l’eccezione in modo da creare un possibile baluardo alle tensioni speculative in atto e spesso fomentate dal comportamento rinunciatario della stessa Bce. Ma si può fare di più, ad esempio consentire alla Bce di emettere degli Eurobonds, in grado di finanziare i debiti pubblici dei paesi più in difficoltà. Un’iniziativa di tal genere, non a caso fortemente contrastata dalla Germania, sarebbe il possibile preludio alla definizione di una unica politica fiscale, con l’effetto di erodere l’autonomia fiscale dei singoli stati-nazione europei. Il problema della sostenibilità del debito è quindi più politico che economico.
Riguardo il secondo punto (il finanziamento del debito pubblico), può essere utile analizzare chi detiene i titoli di debito pubblico italiani. Al riguardo, occorre notare che fino agli inizi degli anni ’90 il debito pubblico italiano era quasi interamente un debito interno. Negli ultimi venti anni la situazione è profondamente mutata: la quota dei detentori esteri di titoli di stato è passata dal 5,59% del 1991 al 52,4% del 2010 (dati Bankitalia). Se uno Stato è in debito coi suoi cittadini, questo vuol dire che tra il primo e i secondi si stabilisce una relazione di reciprocità se non proprio di coincidenza, visto che i secondi non possono avere alcun interesse al collasso del primo e quindi possono essere disponibili anche ad accettare misure draconiane e di sacrifici per evitare il default del bilancio pubblico e l’annullamento del debito. Diversa è invece la situazione quando i creditori sono nella maggior parte costituiti dai grandi investitori finanziari, i quali ultimi possono avere tutto l’interesse a speculare vendendo e ricomprando titoli, o semplicemente a cedere titoli in portafoglio per andare a cercare altrove più lauti guadagni. In poche parole tanto più è consistente il debito estero di uno Stato, tanto minore è la sua effettiva sovranità nazionale. Come afferma una ricerca dell’Adusbef (http://www.adusbef.it/download.asp?Id=8134&r=1) sui detentori di titoli di stato italiani (elaborazioni dati Bankitalia): “L’enorme debito pubblico italiano è nei portafogli di banche, assicurazioni ed altre istituzioni finanziarie estere per l’86,34 per cento, contro il 13,66 per cento in mano alle famiglie”. Risulta quindi abbastanza chiaro che i creditori nei confronti dello Stato italiano sono solo in minima parte le famiglie e in massima parte proprio quegli investitori istituzionali che sono stati all’origine della crisi economico-finanziaria e all’incremento del debito pubblico. Voler a tutti costi evitare il default significa allora difendere gli interessi degli speculatori finanziari.
4. Siamo dunque in un contesto mediatico in cui si spaccia per interesse pubblico ciò che è invece puro interesse privato. L’“imprescindibile necessità” di ridurre il debito pubblico non va dunque a vantaggio dell’economia italiana e delle famiglie ivi residenti ma serve unicamente a garantire la liquidità e le rendite al sistema finanziario, così da favorire il processo di valorizzazione via plusvalenze derivante dall’attività speculativa. Il potere finanziario viene in tal modo rafforzato a scapito delle condizioni di vita di buona parte degli uomini e delle donne che vivono in questo paese. Non può quindi stupire che la manovra correttiva adottata sia semplicemente una manovra di “classe”. Senza entrare nel merito del provvedimenti, è sufficiente analizzare i possibili risultati che ne derivano in termini di distribuzione del reddito. Uno studio di Massimo Baldini, pubblicato sul sito de La Voce.info lo scorso 15 luglio 2011 (http://www.lavoce.info/articoli/pagina 1002433.html), analizza gli effetti distributivi sui redditi delle famiglie italiane del taglio del 5 per cento, e del 20 per cento a regime, di alcune tra le principali agevolazioni fiscali (solo una delle tante misure adottate). Secondo i calcoli effettuati usando un modello di microsimulazione fiscale sviluppato presso il Centro di analisi delle politiche pubbliche dell’Università di Modena e Reggio Emilia, i risultati sono inequivocabili: poiché le più significative detrazioni (per lavoro e famiglia) diminuiscono al crescere del reddito del contribuente, i tagli risultano particolarmente elevati per le famiglie con reddito medio e basso. Come si può osservare dalla figura seguente con il solo riferimento al taglio del 20%, le famiglie del primo decile più povero avrebbero una perdita del proprio reddito ttra il 5 e 6%, mentre quelle del decile più ricco avrebbero una perdita trascurabile (< 1%).
Incidenza percentuale sul reddito disponibile della riduzione delle detrazioni Irpef e dell’inasprimento dell’Iva, per decili di reddito: caso 20%.
Con tali dinamiche (a cui bisogna aggiungere l’effetto regressivo sui reddito dell’introduzione dei ticket sanitari, dell’incremento delle tariffe e dell’imposizione locale per far fronti ai tagli agli stessi enti locali), la distribuzione del reddito si concentrerà ulteriormente con effetti negativi (via riduzione del moltiplicatore del reddito) sulla domanda interna e sulla dinamica delle entrate fiscali e del Pil, rendendo di fatto improbabile il raggiungimento del bilancio in pareggio nel 2014.
Scopo della manovra finanziaria è dunque garantire il pagamento del debito agli investitori istituzionali e mantenere inalterato processo di valorizzazione biopolitica contemporaneo tramite il perpetuarsi dell’espropriazione dei beni comuni, della cooperazione sociale, in una parola il comando sul lavoro.
Con la scusa di proteggere l’economia italiana dal rischio di default, la farsa dell’emergenza rischia di trasformarsi in tragedia sociale.
5. Che fare, allora? L’anno appena passato è stato caratterizzato dall’ampliarsi dei conflitti sociali, non solo in Italia ma in tutto Europa e nel mediterraneo. Dalla Gran Bretagna – di solito poco propensa al conflitto di piazza – sino al Maghreb e al Mashreq, passando per la Grecia dei grandi scioperi generali e la Spagna degli “indignados”, gruppi autonomi di studenti, di donne, di migranti, di precari (oramai tutti i lavoratori) e nuove forme di sindacalismo si stanno attrezzando. In Italia, le lotte alla Fiat contro il piano Marchionne, degli studenti contro il piano Gelmini, le lotte dei migranti contro la sanatoria truffa, la rinascita di un potenziale nuovo movimento delle donne, il percorso degli Stati Generali della Precarietà verso il primo sciopero precario del prossimo autunno sono tutti segnali che ci confermano che la pacificazione sociale è lungi dall’essere garantita non solo a livello sociale ma anche sul piano più strettamente politico. L’esito dei referendum sui beni comuni e delle elezioni municipali in molte realtà metropolitane ne danno conferma. L’accordo bipartizan sui tempi della manovra in nome dell’emergenza economica (pur con tutti i distinguo sulla sostanza della manovra, ma perfetta comunanza sulla necessità dei sacrifici a destra come a sinistra) rappresenta oggi la chiave di volta della strategia politica per impedire che un nuovo protagonismo sociale possa prendere piede.
Per questo è importante, pur nella diversità delle strategie e delle alleanze (alcune purtroppo “calate dall’alto”), che le realtà di movimento, all’interno del nuovo conflitto di classe che perdura in questo paese, lancino la parola d’ordine del diritto alla bancarotta e del default (ovvero, più prossicamente, non pagare), oltre a quelle relative a un nuovo welfare e a un nuovo diritto del lavoro.
Sulla base dell’analisi svolta, infatti, il rifiuto di pagare oggi i debiti (o pagarne solo una parte) alle banche e agli investitori istituzionali non è altro che l’esercizio di un contropotere al potere finanziario che ci strangola. Non saranno sicuramente i residenti italiani a dolersene, ma piuttosto l’oligarchia finanziaria: ed è questo che non si deve sapere. Si potrebbe obiettare: ma di fronte ad una simile prospettiva, quali potrebbero essere le conseguenze e come tale contropotere potrebbe essere attivato?
Per rispondere a tali domande, occorre innanzitutto ricordare che l’Italia è un paese troppo grande per poter fallire (too big to fail). L’euro, da questo punto di vista, rappresenta uno scudo che obbligherebbe (come per la Spagna) i paesi dell’Unione Monetaria a dover intervenire, anche obtorto collo, con politiche paracadute. Di fronte alla minaccia di non pagare nei termini pattuiti le tranches degli interessi, la minaccia di sanzioni diventa a questo punto risibile e obbligherebbe l’Europa a perseguire una politica fiscale comune, per evitare che la crisi dell’euro contamini tutte le economie. Si tratta a tutti gli effetti di una sorta di potenziale ricatto della seguente natura: il governo italiano chiede il congelamento dei debiti presso gli investitori istituzionali e la loro trasformazioni in Eurobonds a tasso d’interesse con spread fisso rispetto al tasso ufficiale di sconto fissato dalla Bce pena l’insolvenza unilaterale. Parallelalamente, gli Eurobond emessi possono essere dotati di scadenza variabile in modo di allungarne la durata. Per il sistema finanziario, ciò significherebbe una netta perdita in termine di guadagno (dovendosi accontentare sia di interessi più bassi che di plusvalenze minori) e di conseguenza un ridimensionamento dell’attività speculativa. Di fatto è come se vennisero introdotti dei limiti alla libera circolazione dei titoli sovrani.
Più complesso è definire come tali azioni possano essere implementati sul piano delle relazoni politche interne all’Europa. Perché un tale contropotere ai mercati finanziari possa effettivamente realizzarsi, è necessario che gli attuali governi vengano messi di fronte a un aut-aut: o essere travolti dall’insorgenza della moltitudine o accettare il male minore della rinegoziazione del debito in chiave comune europea. Ed è a questo livello che i movimenti sociali possono giocare un ruolo fondamentale sia sul piano della comunicazione che dell’azione. Magari cominciando a ribadire con forza i veri motivi e gli interessi economici che stanno dietro l’approvazione di manovre finanziarie come questa. Il re è nudo.































Add comment