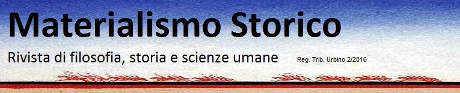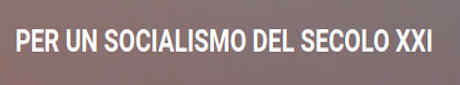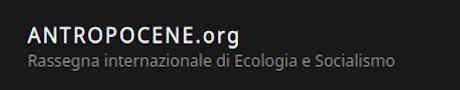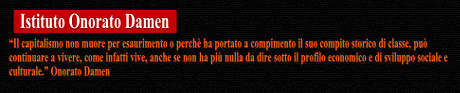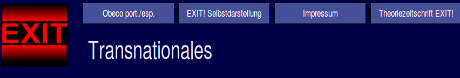- Details
- Hits: 1112
Losurdo e la sfida di un materialismo storico per il XXI secolo
di Sabato Danzilli
 La raccolta di saggi contenuta in Domenico Losurdo tra filosofia, storia e politica, pubblicata da La scuola di Pitagora, a cura di Stefano Giuseppe Azzarà, Paolo Ercolani ed Emanuela Susca, offre una panoramica completa dei principali interessi della ricerca di Domenico Losurdo, con interventi da parte dei suoi collaboratori più stretti e di alcuni colleghi. Il filosofo pugliese, scomparso quasi tre anni fa, è stato tra i più importanti pensatori della sinistra italiana degli ultimi decenni, e la sua influenza si estende sempre più sul piano internazionale.
La raccolta di saggi contenuta in Domenico Losurdo tra filosofia, storia e politica, pubblicata da La scuola di Pitagora, a cura di Stefano Giuseppe Azzarà, Paolo Ercolani ed Emanuela Susca, offre una panoramica completa dei principali interessi della ricerca di Domenico Losurdo, con interventi da parte dei suoi collaboratori più stretti e di alcuni colleghi. Il filosofo pugliese, scomparso quasi tre anni fa, è stato tra i più importanti pensatori della sinistra italiana degli ultimi decenni, e la sua influenza si estende sempre più sul piano internazionale.
La sua analisi unisce infatti una grande profondità storica a un forte carattere militante. L’indagine storica dei sistemi filosofici presi in considerazione nelle sue opere, compiuta con rigore, non rimane mai confinata in un ambito strettamente teoretico, ma è sempre sottoposta a un esame attraverso una verifica della declinazione nella pratica politica concreta del pensiero dell’autore considerato. In Losurdo è infatti centrale il ruolo del “giudizio politico” nella comprensione del proprio tempo, che è il compito specifico della filosofia.
Il libro si articola in tre sezioni: “Filosofia classica tedesca, universalismo e liberalismo”, “Crisi del marxismo e ricostruzione del materialismo storico” e “Tradizione conservatrice e ideologie della guerra”.
- Details
- Hits: 1209
I keynesiani mainstream e la MMT
di Marco Cattaneo
 Ho letto con molto interesse questo articolo di Thomas Palley, pubblicato pochi mesi fa (fine 2020). Come indica il titolo, “What’s wrong with Modern Money Theory: macro and political restraints on deficit-financed fiscal policy”, si tratta di una disamina critica della MMT.
Ho letto con molto interesse questo articolo di Thomas Palley, pubblicato pochi mesi fa (fine 2020). Come indica il titolo, “What’s wrong with Modern Money Theory: macro and political restraints on deficit-financed fiscal policy”, si tratta di una disamina critica della MMT.
L’autore è un economista di impostazione keynesiana e di orientamento politico progressista. Pur condividendo le finalità generali di quanto gli economisti MMT propongono, Palley ritiene però sostanzialmente errata la base teorica della MMT.
L’articolo è interessante in quanto costituisce una sintesi, molto articolata, delle critiche alla MMT così come espresse da commentatori che non sono sospettabili di pregiudizi ideologici negativi nei confronti della MMT stessa (o più precisamente nei confronti delle sue finalità). Critiche, quindi, di natura essenzialmente tecnica e concettuale.
Come ho detto in altre sedi, mi riconosco al 95% nel pensiero MMT. Confutare le critiche di Palley mi pare un esercizio utile in quanto si tratta, in sostanza, delle medesime argomentazioni che spingono i governi e le istituzioni sovranazionali ad adottare un approccio ancora decisamente troppo timido nel contrastare i problemi dell’economia anche (ma non solo) in seguito alla crisi pandemica. Troppo timido, purtroppo per noi, soprattutto nel caso dell’Eurozona e in particolare dell’Italia.
Qui di seguito, i punti salienti (a mio avviso) dell’articolo di Palley, e le mie controdeduzioni.
- Details
- Hits: 1551
Panzieri e Krahl
di Andrea Cengia
Prospettive di lettura della produzione ad alta intensità tecnologica
 L’ipotesi che guida questo testo è che si possano individuare alcune linee di continuità tra il pensiero di Raniero Panzieri e quello di Hans-Jürgen Krahl. La riflessione teorico-politica più significativa di entrambi gli autori ruota attorno alla problematicità del capitalismo a forte base tecnologica, nell’arco di tempo che attraversa gli anni Sessanta del Novecento. Nel caso di Panzieri, (e del primo operaismo italiano che ha nella rivista Quaderni rossi il suo punto di riferimento) la riflessione teorica parte dall’osservazione delle imponenti ristrutturazioni del capitalismo italiano dei primi anni Sessanta. Krahl invece constaterà, alla fine del medesimo decennio, la maturazione di questo processo di trasformazione tecnologica (sia dal lato del capitale che dal lato della soggettività antagonista) e potrà quindi mettere in luce gli effetti e le modificazioni subite dalla società nello stato della sua maturata trasformazione macchinica. Panzieri e Krahl, quindi, sono due interpreti del capitalismo e dei suoi esiti a noi più vicini, primo su tutti la trasformazione della composizione organica del capitale.
L’ipotesi che guida questo testo è che si possano individuare alcune linee di continuità tra il pensiero di Raniero Panzieri e quello di Hans-Jürgen Krahl. La riflessione teorico-politica più significativa di entrambi gli autori ruota attorno alla problematicità del capitalismo a forte base tecnologica, nell’arco di tempo che attraversa gli anni Sessanta del Novecento. Nel caso di Panzieri, (e del primo operaismo italiano che ha nella rivista Quaderni rossi il suo punto di riferimento) la riflessione teorica parte dall’osservazione delle imponenti ristrutturazioni del capitalismo italiano dei primi anni Sessanta. Krahl invece constaterà, alla fine del medesimo decennio, la maturazione di questo processo di trasformazione tecnologica (sia dal lato del capitale che dal lato della soggettività antagonista) e potrà quindi mettere in luce gli effetti e le modificazioni subite dalla società nello stato della sua maturata trasformazione macchinica. Panzieri e Krahl, quindi, sono due interpreti del capitalismo e dei suoi esiti a noi più vicini, primo su tutti la trasformazione della composizione organica del capitale.
Da un punto di vista teorico, i punti comuni ai due autori vanno rintracciati nel costante riferimento, esplicito o implicito, all’eredità della scuola di Francoforte e del suo universo culturale di cui Panzieri infatti è stato considerato, uno degli “ambasciatori”1in Italia. Nel riferirsi a Pollock e alla scuola di Francoforte il fondatore dei Quaderni rossi ha saputo unire quella riflessione con le originali istanze dell’operaismo italiano.
- Details
- Hits: 1935
Lo Stato, il Pubblico, il Comune: tre concetti alla prova della crisi sanitaria
di Etienne Balibar (University of California, Irvine)
Pubblicato su “Materialismo Storico. Rivista di filosofia, storia e scienze umane", n° 2/2020, a cura di Stefano G. Azzarà, licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0
 Lo scopo di questo breve scritto è abbozzare alcune riflessioni congiunturali, relative all’articolazione di tre concetti che occupano un posto centrale nel dibattito pubblico. Riflessioni che, lungi dal distoglierci dalla situazione di crisi in cui siamo entrati, dovrebbero anzi permetterci di comprendere meglio le scelte che la crisi sta imponendo. È tuttavia necessaria qualche osservazione preliminare, affinché la discussione non assuma un carattere eccessivamente accademico.
Lo scopo di questo breve scritto è abbozzare alcune riflessioni congiunturali, relative all’articolazione di tre concetti che occupano un posto centrale nel dibattito pubblico. Riflessioni che, lungi dal distoglierci dalla situazione di crisi in cui siamo entrati, dovrebbero anzi permetterci di comprendere meglio le scelte che la crisi sta imponendo. È tuttavia necessaria qualche osservazione preliminare, affinché la discussione non assuma un carattere eccessivamente accademico.
1. Apprendere nella crisi
Innanzi tutto, voglio sottolineare l’incertezza dei tempi. Sto scrivendo alla metà di maggio (2020), per una pubblicazione che sarà disponibile a luglio… È molto presto per sviluppare una riflessione compiuta sul tema, e questo perché vi è l’intenzione di mettere in circolazione una pluralità di proposte nel momento stesso in cui queste si rendono necessarie a causa dell’intensità della crisi. Eppure, sarà forse già troppo tardi… Non abbiamo alcuna certezza che ciò che pensiamo oggi potrà essere ancora sostenibile tra due mesi. Non sappiamo se e quando “finiranno” la pandemia e la crisi sanitaria che questa provoca. Non sappiamo quale sarà l’entità e quali gli effetti della crisi economica che ne consegue. Non sappiamo quali saranno le ripercussioni, in termini di sofferenza e distruzione, ma anche di proteste, rivolte, di movimenti sociali e politici. E tuttavia, è da questo insieme di cose che dipende il referente di realtà delle parole di cui ci serviamo e, conseguentemente, il loro senso.
- Details
- Hits: 1854
Metamorfosi del taylorismo
Le insidie della "umanizzazione" del lavoro
di Carlo Formenti
 L’atteggiamento dei movimenti operai di ispirazione marxista nei confronti della tecnologia è sempre stato determinato dalla convinzione che lo sviluppo delle forze produttive è di per sé -a prescindere dal suo essere prodotto del processo di accumulazione capitalistica - un fattore progressivo, nella misura in cui crea le condizioni per la transizione a una forma più avanzata di civiltà. Per questo motivo, la rivolta luddista contro l’introduzione dei telai meccanici nell’Inghilterra dell’Ottocento - benché gli storici ne riconoscano il ruolo nella genesi di una embrionale coscienza di classe (1) – è stata generalmente classificata come una vana resistenza – eroica, ma oggettivamente conservatrice – al processo di industrializzazione, dal momento che questo avrebbe favorito la crescita numerica degli “affossatori” del modo di produzione capitalistico. Per la stessa ragione Marx, tanto nel Manifesto quanto nel Capitale, esalta la funzione “rivoluzionaria” del capitale che, nella sua irresistibile avanzata, spazza via tutte le forme economiche e sociali “arretrate” (arrivando a celebrare la missione “civilizzatrice” dell’imperialismo britannico in India (2) – pur riconoscendone i crimini). Per lo stesso motivo, infine, tanto Lenin che Gramsci diedero un giudizio positivo sulle “scoperte” di Taylor, ritenendo che i principi dell’organizzazione “scientifica” del lavoro rappresentassero un’importante innovazione di cui la classe operaia avrebbe dovuto impadronirsi, per sviluppare la produzione e avanzare più rapidamente verso il socialismo.
L’atteggiamento dei movimenti operai di ispirazione marxista nei confronti della tecnologia è sempre stato determinato dalla convinzione che lo sviluppo delle forze produttive è di per sé -a prescindere dal suo essere prodotto del processo di accumulazione capitalistica - un fattore progressivo, nella misura in cui crea le condizioni per la transizione a una forma più avanzata di civiltà. Per questo motivo, la rivolta luddista contro l’introduzione dei telai meccanici nell’Inghilterra dell’Ottocento - benché gli storici ne riconoscano il ruolo nella genesi di una embrionale coscienza di classe (1) – è stata generalmente classificata come una vana resistenza – eroica, ma oggettivamente conservatrice – al processo di industrializzazione, dal momento che questo avrebbe favorito la crescita numerica degli “affossatori” del modo di produzione capitalistico. Per la stessa ragione Marx, tanto nel Manifesto quanto nel Capitale, esalta la funzione “rivoluzionaria” del capitale che, nella sua irresistibile avanzata, spazza via tutte le forme economiche e sociali “arretrate” (arrivando a celebrare la missione “civilizzatrice” dell’imperialismo britannico in India (2) – pur riconoscendone i crimini). Per lo stesso motivo, infine, tanto Lenin che Gramsci diedero un giudizio positivo sulle “scoperte” di Taylor, ritenendo che i principi dell’organizzazione “scientifica” del lavoro rappresentassero un’importante innovazione di cui la classe operaia avrebbe dovuto impadronirsi, per sviluppare la produzione e avanzare più rapidamente verso il socialismo.
- Details
- Hits: 1194
L'afasia e l'ultramondo
di Il Pedante
 1.
1.
Rincasavo a notte fonda dopo una serata con gli amici. Camminando notai un uomo inginocchiato sul marciapiede, con la fronte che toccava terra. Da un certa distanza, sembrava quasi un fedele prostrato alla Mecca. Mi avvicinai e vidi che muoveva la testa ansimando. Mi avvicinai ancora e capii che non stava pregando, ma leccava forsennatamente l'asfalto, come un morto di fame. Mi rivolse uno sguardo allucinato. Io abbassai il mio e mi allontanai in fretta senza voltarmi.
2.
«Il monito del vescovo: dire no al vaccino significa non essere cristiani».
3.
«Quell'essere senza occhi seduto al tavolo di fronte se l'era bevuta con l'entusiasmo del fanatico e avrebbe snidato, denunciato e vaporizzato come una furia chiunque avesse fatto notare che fino alla settimana precedente la razione di cioccolato era stata di trenta grammi».
4.
Il Partito vi diceva che non dovevate credere né ai vostri occhi né alle vostre orecchie. Era, questa, l'ingiunzione essenziale e definitiva.
***
Per quanto siano distanti, le opinioni possono solo confrontarsi su un terreno comune e ancorarsi a un denominatore che definisca il quadrante dello scontro.
- Details
- Hits: 1078
La paura, i “nemici interni” e la mascherina all’aperto
di Edmond Dantès
 “E lasciamo stare che l’uno cittadino l’altro schifasse, e quasi niuno vicino avesse dell’altro cura, e i parenti insieme rade volte o non mai si visitassero e di lontano; era con sì fatto spavento questa tribolazione entrata ne’ petti degli uomini e delle donne, che l’un fratello l’altro abbandonava, e il zio il nipote, e la sorella il fratello, e spesse volte la donna il suo marito; e, che maggior cosa è e quasi non credibile, li padri e le madri i figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare e di servire schifavano”.
“E lasciamo stare che l’uno cittadino l’altro schifasse, e quasi niuno vicino avesse dell’altro cura, e i parenti insieme rade volte o non mai si visitassero e di lontano; era con sì fatto spavento questa tribolazione entrata ne’ petti degli uomini e delle donne, che l’un fratello l’altro abbandonava, e il zio il nipote, e la sorella il fratello, e spesse volte la donna il suo marito; e, che maggior cosa è e quasi non credibile, li padri e le madri i figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare e di servire schifavano”.
Giovanni Boccaccio, Decameron, I
Le riflessioni che svolgerò qui sotto nascono da una premessa teorica molto semplice: l’idea che portare la mascherina all’aperto, in qualsiasi luogo e situazione, sia una grande idiozia. Contrariamente che nei luoghi chiusi, negli spazi aperti è assolutamente improbabile che venga trasmesso un virus influenzale. Ma andiamo a leggere cosa prevede il DPCM del 3 dicembre 2020, l’ennesimo di una sfilza di decreti surreali e contraddittori, in merito all’uso delle mascherine:
«Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande».
- Details
- Hits: 1055
Note sul movimento comunista internazionale. Dalla storia ad oggi
di Salvatore Tinè*
 Questo numero della rivista “Marx Ventuno” mi pare molto importante per vari motivi. In primo luogo, per gli elementi di informazione e di riflessione sullo stato attuale del movimento comunista internazionale contenuti nel rapporto del gruppo di ricerca della Accademia Marxista dell’Accademia Cinese di Scienze Sociali. E’ un rapporto interessante perché la riflessione sullo stato dei principali partiti comunisti nel mondo contemporaneo e quindi sui modi e le forme anche nuove e originali in cui viene ridefinendosi l’unità del movimento comunista ne ripercorre le origini e la storia. Il centenario della nascita del Komintern caduto nel 2019 è stato per tanti partiti comunisti l’occasione per riflettere su una fase della loro storia per molti aspetti cruciale e decisiva.
Questo numero della rivista “Marx Ventuno” mi pare molto importante per vari motivi. In primo luogo, per gli elementi di informazione e di riflessione sullo stato attuale del movimento comunista internazionale contenuti nel rapporto del gruppo di ricerca della Accademia Marxista dell’Accademia Cinese di Scienze Sociali. E’ un rapporto interessante perché la riflessione sullo stato dei principali partiti comunisti nel mondo contemporaneo e quindi sui modi e le forme anche nuove e originali in cui viene ridefinendosi l’unità del movimento comunista ne ripercorre le origini e la storia. Il centenario della nascita del Komintern caduto nel 2019 è stato per tanti partiti comunisti l’occasione per riflettere su una fase della loro storia per molti aspetti cruciale e decisiva.
E’ stato infatti proprio negli anni della nascita e della formazione dell’Internazionale comunista, come partito mondiale centralizzato della rivoluzione proletaria internazionale, ma imperniato sulla funzione dirigente del partito e dello stato sovietici, che il movimento comunista ha acquisito già nel corso degli anni ’20 e poi nel decennio successivo certo in uno dei periodi più drammatici e convulsi dell’intera storia mondiale, alcuni dei tratti caratteristici destinati a segnarne l’intera storia.
Come si rileva nel Rapporto dell’Accademia marxista cinese, questa forma organizzativa del partito mondiale centralizzato assunta dall’unità movimento comunista in quel periodo è stata oggetto di una approfondita riflessione critica e anche di giudizi e valutazioni diversi tra loro nel corso delle molte iniziative e dibattiti organizzati dai partiti comunisti in occasione del centenario del Komintern.
- Details
- Hits: 1001
Capitalismo e catastrofe
di Alex Callinicos
Il Covid e il cambiamento climatico non sono aberrazioni: sono aspetti della permanente crisi globale del sistema
 “La fine è vicina. L’esecuzione efficace dei test potrà migliorare le distanze sociali fino all'arrivo dei vaccini […] Avere diversi vaccini altamente efficaci per questo orribile virus dopo meno di un anno è un risultato abbastanza sorprendente, tra le cose più grandi che noi abbiamo - con noi intendo sia l'umanità in generale che i biologi molecolari in particolare - mai realizzato.”
“La fine è vicina. L’esecuzione efficace dei test potrà migliorare le distanze sociali fino all'arrivo dei vaccini […] Avere diversi vaccini altamente efficaci per questo orribile virus dopo meno di un anno è un risultato abbastanza sorprendente, tra le cose più grandi che noi abbiamo - con noi intendo sia l'umanità in generale che i biologi molecolari in particolare - mai realizzato.”
Così scriveva Rupert Beale del Francis Crick Institut nella London Review of Books all'inizio del mese scorso. Ma prima di iniziare a festeggiare, dovremmo ricordare che un anno fa la possibilità che il mondo potesse essere travolto da una pandemia che avrebbe ucciso milioni di persone e innescato la peggiore crisi economica dagli anni '30 era al di là dell'immaginazione di quasi tutti noi.
Beale conclude il suo articolo con un avvertimento: “Siamo stati abili, ma anche fortunati. Sviluppare un vaccino Sars-CoV-2 è risultato relativamente facile. Il virus che causerà la prossima pandemia potrebbe non essere così indulgente.” La recente rapida diffusione delle infezioni grazie all'emergere di un nuovo ceppo di Covid-19 è un cupo avvertimento dei limiti della nostra capacità di comprendere, e tanto meno di controllare la natura.
Quindi ora dovremmo saperne di più. Molti di noi hanno letto pionieri marxisti come Mike Davis e Rob Wallace che per anni avvertivano che la distruzione della natura da parte del capitalismo stava creando le condizioni per pandemie come il Covid-19. Forse questa pandemia non era prevedibile, ma lo era certamente il fatto che ci sarebbero state delle pandemie (al plurale) paragonabili alla terribile epidemia influenzale del 1918-19, la quale uccise tra i 50 ei 100 milioni di persone.
- Details
- Hits: 4125
Sulla ‘legge’ del valore-lavoro in Marx. Una nuova soluzione formale.
di Andrea Pannone

Introduzione
Il recente bicentenario della nascita di Karl Marx (1818-2018) e l’evoluzione della crisi dell’economia mondiale, palesatasi a partire dal 2008 e successivamente aggravata dall’emergenza pandemica tutt’ora in corso, hanno riacceso l’interesse per il contributo economico e politico del filosofo di Treviri e per il contenuto della sua opera più rappresentativa -i tre libri de Il Capitale – rivitalizzando apparentemente il dibattito sulla possibile attualizzazione di (almeno) parte di quell’analisi (si veda ad esempio Bellofiore 2019, Bellofiore e Fabiani 2019, Gattei 2020, Bellofiore 2020, Brancaccio 2020). Nonostante il lodevole intento di questi contributi, resta quasi del tutto assente il tentativo di ripensare formalmente la ‘legge’ del valore-lavoro e il suo rapporto con la circolazione delle merci, in un modo che sia altresì coerente con alcune specificità di funzionamento di un’economia capitalistica moderna. Questa assenza costituisce, a mio parere, un limite fondamentale della più recente discussione sul Capitale proprio in virtù del fatto che, a partire dal presunto errore marxiano nell’esposizione formale della formazione di un saggio generale del profitto, la ‘legge’ del valore- lavoro è stata progressivamente data per defunta.
Il presente lavoro si cimenta esplicitamente su questo punto cercando di fornire una soluzione formale non convenzionale. Nel primo paragrafo viene richiamato brevemente il problema della matematizzazione della legge del valore, partendo da Bortkiewitz fino alla soluzione fornita da Sraffa in Produzione di Merci a mezzo merci.
- Details
- Hits: 918
Nuovi bisogni emancipativi
Hans-Jürgen Krahl (1943-1970)
di Massimiliano Tomba
 Movimenti antiautoritari nella società tardocapitaliste
Movimenti antiautoritari nella società tardocapitaliste
Il nome di Hans-Jürgen Krahl è indissolubilmente legato al ’68 tedesco. La sua morte, in seguito ad un incidente stradale nel febbraio 1970, fu sentita come una indubbia perdita per il movimento di emancipazione nelle metropoli. “La breve biografia politica di Hans-Jürgen Krahl, la cui attività di agitatore e il suo lavoro teorico hanno contribuito significativamente a determinare la politica del movimento di protesta, riflette il processo di formazione di molti giovani della sinistra che non ritrovano più un nocciolo razionale in un partito comunista rivoluzionario e che intrapresero un lungo tragitto di tradimento nei confronti della loro classe borghese rifuggendo le garanzie del potere ricevute in eredità”1. Allievo di Adorno, con il quale si addottora con una Dissertazione dal titolo Naturgesetz der kapitalistischen Bewegung bei Marx (La legge naturale del movimento di capitale in Marx), Krahl si confronta costantemente con la riflessione della Scuola di Francoforte e la tradizione della filosofia classica tedesca, cercando di ripensarne i fondamenti nella direzione di un percorso teorico intrecciato alla prassi politica. Al centro di questa riflessione c’è l’analisi dei rapporti economici e sociali dei sistemi di dominio tardocapitalistici. Un tema presente nelle discussioni dei movimenti antiautoritari della fine degli anni Sessanta.
- Details
- Hits: 1398
L’imperialismo: fase suprema dello sfacelo capitalistico
di Carmelo Germanà
La parabola discendente del ciclo economico capitalistico del secondo dopoguerra, accelerata dal Covid-19, prosegue inesorabilmente. Vecchie e nuove potenze imperialistiche si confrontano per il predominio del pianeta a sottolineare la permanente conflittualità generata da un sistema economico i cui attori regolano i loro conti con l’esercizio della violenza e della rapina. L’imperialismo moderno è l’espressione del capitalismo giunto a minacciare la stessa vita sulla terra
 L’antistoricità del sistema capitalista si evidenzia compiutamente nella ricorrenza delle sue crisi, quando le contraddizioni accumulate esplodono in tutta la loro forza. In queste circostanze emerge con grande evidenza il paradosso originato dall’enorme sviluppo delle forze produttive, le quali a un certo punto non sono più in grado di garantire una adeguata redditività del capitale investito. Di conseguenza si palesa il contrasto tra la sempre maggiore ricchezza prodotta e il diffondersi, allo stesso tempo, tra i lavoratori e nella società di incertezza e povertà. L’attuale devastante situazione non è causata dal Covid-19, come vorrebbe far credere la propaganda borghese, la pandemia ha certamente amplificato gli effetti, ma la crisi era già presente da prima ed è tutta interna ai meccanismi dell’accumulazione capitalista. La finanziarizzazione delle economie mature è stata la risposta data dal capitale a questa crisi che si protrae, con alti e bassi, da decenni. Crisi che ha colpito in particolare la maggiore potenza imperialista mondiale: gli Stati Uniti d’America. Le misure messe in atto dagli stati, lungi dal risolvere i problemi, non fanno altro che ampliarli e procrastinarli nel tempo.
L’antistoricità del sistema capitalista si evidenzia compiutamente nella ricorrenza delle sue crisi, quando le contraddizioni accumulate esplodono in tutta la loro forza. In queste circostanze emerge con grande evidenza il paradosso originato dall’enorme sviluppo delle forze produttive, le quali a un certo punto non sono più in grado di garantire una adeguata redditività del capitale investito. Di conseguenza si palesa il contrasto tra la sempre maggiore ricchezza prodotta e il diffondersi, allo stesso tempo, tra i lavoratori e nella società di incertezza e povertà. L’attuale devastante situazione non è causata dal Covid-19, come vorrebbe far credere la propaganda borghese, la pandemia ha certamente amplificato gli effetti, ma la crisi era già presente da prima ed è tutta interna ai meccanismi dell’accumulazione capitalista. La finanziarizzazione delle economie mature è stata la risposta data dal capitale a questa crisi che si protrae, con alti e bassi, da decenni. Crisi che ha colpito in particolare la maggiore potenza imperialista mondiale: gli Stati Uniti d’America. Le misure messe in atto dagli stati, lungi dal risolvere i problemi, non fanno altro che ampliarli e procrastinarli nel tempo.
Il dominio della finanza significa per gli Usa drenare parassitariamente plusvalore da ogni angolo del pianeta. I meccanismi di tale rapina risiedono nel signoraggio del dollaro e nella produzione di capitale fittizio che permettono alla borghesia americana di incamerare una rendita finanziaria ingente.[1]
- Details
- Hits: 1930
Biopolitica del vaccino
di Andrea Fumagalli
In questo testo[1] si denunciano alcuni nodi problematici nella produzione e distribuzione del vaccino anti-Covid19, esito del prevalere di interessi economici sul essere collettivo e dell’abbraccio mortale tra grandi case farmaceutiche e le istituzioni di governi che hanno il monopolio di vaccinazione. Non è una novità. La storia della medicina moderna, in particolar modo dei vaccini, ha assunto sempre più il carattere di un profittevole business economico: non sempre curare conviene. A differenza di altre malattie diffuse nei paesi poveri, puntare sulla ricerca vaccinale per il Covid è al centro delle attuali strategie biopolitiche di profitto. La posta in gioco è troppo alta e le mutazioni del virus potranno reiterare nel tempo la necessità della vaccinazione, incrementando i relativi guadagni. Soprattutto se i brevetti del vaccino rimarranno saldamente in possesso dell’industria delle Big Pharma
 Una delle questioni al centro del dibattito pubblico è oggi il tema dei vaccini. Le istituzioni hanno il monopolio della vaccinazione, possono concederla o negarla: non esiste uno statuto dei diritti del vaccinando. Ed esiste la paura come sentimento diffuso, promosso anzi. Il vaccino potrebbe essere la risoluzione dell’epidemia Covid-19, lo strumento che ci consentirà di ritornare a una vita normale, sempre però mantenendo le dovute cautele, comportandoci responsabilmente e facendo ancora qualche sacrificio.
Una delle questioni al centro del dibattito pubblico è oggi il tema dei vaccini. Le istituzioni hanno il monopolio della vaccinazione, possono concederla o negarla: non esiste uno statuto dei diritti del vaccinando. Ed esiste la paura come sentimento diffuso, promosso anzi. Il vaccino potrebbe essere la risoluzione dell’epidemia Covid-19, lo strumento che ci consentirà di ritornare a una vita normale, sempre però mantenendo le dovute cautele, comportandoci responsabilmente e facendo ancora qualche sacrificio.
Il vaccino è l’illusione in grado farci sopportare le restrizioni che ci sono imposte, facendoci credere che non saranno per sempre. Ma non si distingue mai, nella comunicazione di stato, il provvisorio dal definitivo; sul punto prevale un’ambigua reticenza. In realtà il monopolio statale e l’oligopolio delle Big Pharma sul vaccino rafforza il dominio del capitale sulla vita umana. Si tratta di un rapporto squilibrato, dove il coltello dalla parte del manico è detenuto dalle Big Pharma. Sono loro che producono il vaccino e che dettano le condizioni per le forniture.
- Details
- Hits: 1113
La Bideneconomics spiegata dal capo dei consiglieri economici Usa
di Giacomo Marchetti
 Abbiamo tradotto questa lunga conversazione, di circa un’ora, tra Ezra Klein e Brian Deese, capo-economista del neopresidente Biden che già lavorava nell’amministrazione Obama.
Abbiamo tradotto questa lunga conversazione, di circa un’ora, tra Ezra Klein e Brian Deese, capo-economista del neopresidente Biden che già lavorava nell’amministrazione Obama.
Qui viene spiegato l’attuale ampio programma economico federale. nonché le differenze che sussisterebbero tra il 2009 e l’oggi.
Inizialmente pubblicata in forma di podcast, è apparsa come trascrizione sul New York Times il 9 aprile.
Deese è il tipico prodotto di quel sistema delle “porte girevoli” che caratterizza le élite statunitensi, lo dimostra il suo curriculum che da “giovane economista” dello staff di Obama l’ha portato, prima di giungere nell’amministrazione Biden, con un ruolo dirigenziale nella BlackRock.
Due principi, innanzitutto, sembrano innervare le politiche fin qui intraprese e da prendere da parte dell’attuale amministrazione statunitense: la coscienza della crescente disuguaglianza economica e del cambiamento climatico, secondo le parole dell’intervistato. Deese li pone come due elementi che differenziano il contesto attuale da quello precedente durante l’era Obama.
Ma l’urgenza dell’azione economica in grado di risanare la frattura sociale prodottasi, e riparare la catastrofe ambientale che si sta consumando, è vista all’interno del vero aspetto di novità sostanziale: l’emersione della Cina come potenza economica.
- Details
- Hits: 1413
Intervista a Karl Marx (1871)
di R. Landor
Landor, corrispondente del The World, intervista Marx a Londra il 3 luglio 1871. Soltanto un paio di mesi prima, la Comune di Parigi era stata soffocata nel sangue. Il testo venne pubblicato il seguente 18 luglio
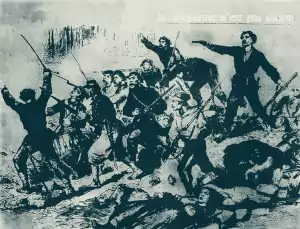 Londra, 3 luglio 1871. Mi avete chiesto di raccogliere informazioni sull’Associazione Internazionale e io ho cercato di farlo. Attualmente, si tratta di un’ardua impresa. Londra è indiscutibilmente il quartier generale dell’Associazione, ma gli inglesi sono spaventati e sentono odor d’Internazionale dappertutto, come re Giacomo sentiva odor di polvere da sparo dopo la famosa congiura. Naturalmente, il livello di consapevolezza dei membri dell’Associazione è aumentato con la sospettosità del pubblico e se gli uomini che la dirigono hanno un segreto da custodire, il loro stampo è tale da custodirlo bene. Ho fatto visita a due dei suoi esponenti più in vista; con uno di essi ho parlato liberamente e qui di seguito riferisco il succo della nostra conversazione. Mi sono personalmente accertato di una cosa, e cioè che si tratta di un’associazione di veri lavoratori, ma che questi lavoratori sono guidati da teorici politici e sociali appartenenti a un’altra classe. Uno degli uomini che ho visto, fra i massimi dirigenti del Consiglio, si è fatto intervistare seduto al suo banco da lavoro, e a tratti smetteva di parlare con me per ascoltare le lamentele espresse in tono tutt’altro che cortese da uno dei tanti padroncini del quartiere che gli davano da lavorare. Ho sentito quello stesso uomo pronunciare in pubblico discorsi eloquenti, animati in ogni loro passo dalla forza dell’odio verso le classi che si autodefiniscono governanti. Ho capito quei discorsi dopo aver assistito a uno squarcio della vita domestica dell’oratore. Egli deve essere consapevole di possedere abbastanza cervello da organizzare un governo funzionante ma di essere costretto a dedicare la sua vita alla più estenuante routine di un lavoro puramente meccanico.
Londra, 3 luglio 1871. Mi avete chiesto di raccogliere informazioni sull’Associazione Internazionale e io ho cercato di farlo. Attualmente, si tratta di un’ardua impresa. Londra è indiscutibilmente il quartier generale dell’Associazione, ma gli inglesi sono spaventati e sentono odor d’Internazionale dappertutto, come re Giacomo sentiva odor di polvere da sparo dopo la famosa congiura. Naturalmente, il livello di consapevolezza dei membri dell’Associazione è aumentato con la sospettosità del pubblico e se gli uomini che la dirigono hanno un segreto da custodire, il loro stampo è tale da custodirlo bene. Ho fatto visita a due dei suoi esponenti più in vista; con uno di essi ho parlato liberamente e qui di seguito riferisco il succo della nostra conversazione. Mi sono personalmente accertato di una cosa, e cioè che si tratta di un’associazione di veri lavoratori, ma che questi lavoratori sono guidati da teorici politici e sociali appartenenti a un’altra classe. Uno degli uomini che ho visto, fra i massimi dirigenti del Consiglio, si è fatto intervistare seduto al suo banco da lavoro, e a tratti smetteva di parlare con me per ascoltare le lamentele espresse in tono tutt’altro che cortese da uno dei tanti padroncini del quartiere che gli davano da lavorare. Ho sentito quello stesso uomo pronunciare in pubblico discorsi eloquenti, animati in ogni loro passo dalla forza dell’odio verso le classi che si autodefiniscono governanti. Ho capito quei discorsi dopo aver assistito a uno squarcio della vita domestica dell’oratore. Egli deve essere consapevole di possedere abbastanza cervello da organizzare un governo funzionante ma di essere costretto a dedicare la sua vita alla più estenuante routine di un lavoro puramente meccanico.
- Details
- Hits: 1222
Verso il 25 aprile. Segnalazioni
di Donato Salzarulo
 «Il dono di riattizzare nel passato la scintilla della speranza è presente solo in quello storico che è compenetrato dall’idea che neppure i morti saranno al sicuro dal nemico, se vince. E questo nemico non ha smesso di vincere.»
«Il dono di riattizzare nel passato la scintilla della speranza è presente solo in quello storico che è compenetrato dall’idea che neppure i morti saranno al sicuro dal nemico, se vince. E questo nemico non ha smesso di vincere.»
(W. Benjamin, Sul concetto di storia)
1.- Il 6 Aprile 2021 è stato pubblicato sul sito dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri (www.reteparri.it) un appello, sottoscritto da più di cento storici e studiosi, «per un riconoscimento ufficiale dei crimini fascisti in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’invasione della Jugoslavia da parte dell’esercito italiano».
Infatti, fu il 6 Aprile del 1941 che le truppe italiane, di concerto con quelle tedesche ed ungheresi, attaccarono il Regno jugoslavo da diversi punti e l’occuparono. Nella spartizione del “bottino” all’Italia toccò buona parte della Slovenia (tra cui Lubiana), della Dalmazia, del Montenegro e del Kosovo.
Come scrivono gli storici nell’appello, «durante l’occupazione fascista e nazista, e fino alla Liberazione nel 1945, in questo territorio si contano circa un milione di morti. L’Italia fascista ha contribuito indirettamente a queste uccisioni con l’aggressione militare e l’appoggio offerto alle forze collaborazioniste che hanno condotto vere e proprie operazioni di sterminio. Ma anche direttamente con fucilazioni di prigionieri e ostaggi, rappresaglie, rastrellamenti e campi di concentramento, nei quali sono stati internati circa centomila jugoslavi.
- Details
- Hits: 1664
Economia intossicata dagli stimoli: il sistema finanziario globale in una gigantesca bolla di liquidità
di Tomasz Konicz
 I mercati azionari sono in pieno boom. Nonostante la crisi del coronavirus e l'impoverimento di centinaia di milioni di salariati. Ciò che a prima vista appare come contraddittorio, è una conseguenza della lotta contro la crisi ed è il sintomo di un sistema finanziario globale che è esso stesso in ginocchio, e lo è ancora di più proprio per il fatto che si trova in una gigantesca bolla di liquidità. A circa un anno dall'ultimo scoppio di crisi - innescato dalle conseguenze della pandemia, ha fatto sprofondare centinaia di milioni di lavoratori salariati nella miseria più nera - i mercati finanziari stanno vivendo quella che è una delle più grandi impennate di tutta la loro storia. I mercati statunitensi - quanto meno - difficilmente potrebbero stare meglio. Dopo aver subito un collasso, corrispondente a circa il 34% nel mese in cui ha avuto inizio la pandemia, nel mese di marzo del 2020; nei dodici messi successivi l'indice Standard & Poor 500 ha raggiunto i suoi nuovi massimi storici, salendo del 75%, proprio nel momento in cui la malnutrizione e la vera e propria fame sono magicamente aumentati anche negli Stati Uniti. Dalla fine della seconda guerra mondiale, per le azioni è stato l'anno migliore, hanno sottolineato i media americani in quello che è stato l'anniversario del fantasmagorico boom delle azioni, il quale si è accompagnato ad una crollo di 3,5 punti percentuali del prodotto interno lordo degli Stati Uniti.
I mercati azionari sono in pieno boom. Nonostante la crisi del coronavirus e l'impoverimento di centinaia di milioni di salariati. Ciò che a prima vista appare come contraddittorio, è una conseguenza della lotta contro la crisi ed è il sintomo di un sistema finanziario globale che è esso stesso in ginocchio, e lo è ancora di più proprio per il fatto che si trova in una gigantesca bolla di liquidità. A circa un anno dall'ultimo scoppio di crisi - innescato dalle conseguenze della pandemia, ha fatto sprofondare centinaia di milioni di lavoratori salariati nella miseria più nera - i mercati finanziari stanno vivendo quella che è una delle più grandi impennate di tutta la loro storia. I mercati statunitensi - quanto meno - difficilmente potrebbero stare meglio. Dopo aver subito un collasso, corrispondente a circa il 34% nel mese in cui ha avuto inizio la pandemia, nel mese di marzo del 2020; nei dodici messi successivi l'indice Standard & Poor 500 ha raggiunto i suoi nuovi massimi storici, salendo del 75%, proprio nel momento in cui la malnutrizione e la vera e propria fame sono magicamente aumentati anche negli Stati Uniti. Dalla fine della seconda guerra mondiale, per le azioni è stato l'anno migliore, hanno sottolineato i media americani in quello che è stato l'anniversario del fantasmagorico boom delle azioni, il quale si è accompagnato ad una crollo di 3,5 punti percentuali del prodotto interno lordo degli Stati Uniti.
- Details
- Hits: 1261
Lotte di classe nel capitalismo avanzato
Avventure della dialettica nel lavoro di Hans-Jürgen Krahl
di Andrea Cavazzini
 Un teorico critico e la sua congiuntura
Un teorico critico e la sua congiuntura
Questa rapida esposizione dedicata a Hans-Jürgen Krahl (1943-1970) è strettamente connessa ad altre riflessioni sviluppate in altri testi dedicati alla Germania e al movimento studentesco in generale1. In effetti, Krahl riflette sull’aporia connessa alla relazione esistente tra il proletariato e la sua coscienza (che possiamo formulare come relazione tra classe e coscienza di classe, o perfino tra strutture sociali e determinazioni politiche). Una riflessione che si incontra anche pensando alla congiuntura dell’Europa centrale e del marxismo tedesco nel periodo immediatamente precedente e immediatamente successivo alla Rivoluzione d’ottobre, alla I guerra mondiale, e al fallimento della Rivoluzione tedesca. Prima della I guerra mondiale, queste aporie riguardavano in prima battuta la contraddizione tra, da una parte il peso sociale e politico del movimento operaio tedesco, la forza e il prestigio delle sue organizzazioni, dall’altra la sua drammatica impotenza politica, la sua posizione subalterna nei confronti dello Stato imperialista, la sua acquiescenza alle ideologie conformiste, la sua impreparazione tattica e strategica al tempo della caduta del Reich. Dopo la guerra, questa contraddizione prese la forma di una distanza tra la radicalizzazione politica degli strati intellettuali verso destra e verso sinistra (che sublimò la crisi della civiltà borghese, l’espansione di una accesa, perfino apocalittica atmosfera ideologica, la formazione di uno strato di militanti preparati per l’azione rivoluzionaria professionale – diffusione di discorsi e pratiche bolsceviche, la fondazione della Terza Internazionale); e una offensiva delle masse che sembrava definitivamente bloccata a Ovest, e destinata a una stabilizzazione di lungo termine nella Russia sovietica.
- Details
- Hits: 993
Populismo giustizialista e controllo sociale: come si è arrivati a tutto questo?
di Osservatorio Repressione
 Negli ultimi decenni, una questione si è dimostrata trasversale a tutte le forze politiche, quella relativa alla sicurezza.
Negli ultimi decenni, una questione si è dimostrata trasversale a tutte le forze politiche, quella relativa alla sicurezza.
Oggi, l’idea di sicurezza è divenuta capace di generare consenso vasto e acritico per il solo fatto di essere nominata e abbiamo assistito al diritto penale divenire dominante manifestando tutti i sintomi del morbo populista: l’allarmismo sulla sicurezza che condiziona un’opinione pubblica che si sente sempre più insicura, eccitata dall’antipolitica e dalla spettacolarizzazione della giustizia; il ruolo moralizzatore assunto dalla magistratura; la strumentalizzazione delle vittime che trasfigura la giustizia in un risarcimento simbolico all’intera comunità e che rende insostenibile la presunzione d’innocenza.
Ma dietro alla criminalizzazione si profila lo spettro della guerra di tutti contro tutti in cui lo Stato, che non è più in grado di distribuire giustizia sociale, promette sicurezza. Il declino del welfare ha allargato le maglie del linguaggio della colpa e della pena, ha esteso l’uso delle istituzioni penitenziarie e del controllo sociale coattivo, come a compensare la fragilità dello stato sociale.
Nonostante le statistiche sulla criminalità descrivano una società più sicura e una diminuzione costante del numero dei reati nell’ultimo decennio, la percezione d’insicurezza e paura – alimentate da politica e media – genera consenso verso chi si propone come giustiziere.
- Details
- Hits: 2714
Il gatto, il topo, la cultura e l'economia
di Anselm Jappe
 Una delle favole dei fratelli Grimm – immagino che siano conosciute anche in Messico – si chiama “Il gatto e il topo in società”. Un gatto convince un topo dell’amicizia che ha per lui; mettono su casa insieme, e in previsione dell’inverno comprano un vasetto di grasso che nascondono in una chiesa. Ma con il pretesto di dover andare a un battesimo, il gatto esce diverse volte e si mangia man mano tutto il grasso, divertendosi poi a dare risposte ambigue al topo su quanto ha fatto. Quando finalmente vanno insieme alla chiesa per mangiare il vasetto di grasso, il topo scopre l’inganno, e il gatto per tutta risposta mangia il topo. L’ultima frase della favola annuncia la morale: “Così va il mondo”.
Una delle favole dei fratelli Grimm – immagino che siano conosciute anche in Messico – si chiama “Il gatto e il topo in società”. Un gatto convince un topo dell’amicizia che ha per lui; mettono su casa insieme, e in previsione dell’inverno comprano un vasetto di grasso che nascondono in una chiesa. Ma con il pretesto di dover andare a un battesimo, il gatto esce diverse volte e si mangia man mano tutto il grasso, divertendosi poi a dare risposte ambigue al topo su quanto ha fatto. Quando finalmente vanno insieme alla chiesa per mangiare il vasetto di grasso, il topo scopre l’inganno, e il gatto per tutta risposta mangia il topo. L’ultima frase della favola annuncia la morale: “Così va il mondo”.
Direi che il rapporto tra la cultura e l’economia rischia fortemente di assomigliare a questa favola, e vi lascio indovinare chi, tra la cultura e l’economia, svolge il ruolo del topo e chi quello del gatto. Soprattutto oggi, nell’epoca del capitalismo pienamente sviluppato, globalizzato e neoliberale. Le questioni che vuole affrontare questo “foro de arte publico”, e che vertono tra l’altro sulla questione chi deve finanziare le istituzioni culturali e quali aspettative, e di quale pubblico, deve soddisfare un museo, rientrano in una problematica più generale: quale è il posto della cultura nella società capitalistica odierna? Per tentare di rispondere, io prenderò dunque le cose un po’ più alla larga.
A parte la produzione – materiale e immateriale – con cui ogni società deve soddisfare i bisogni vitali e fisici dei suoi membri, essa crea ugualmente una serie di costruzioni simboliche.
- Details
- Hits: 1838

La controversia sull’imperialismo e l’accumulazione del capitale tra Rosa, Nikolaj e Ilič
di Eros Barone
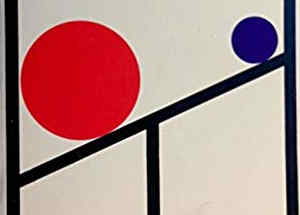 Si tratta di vedere non soltanto i contrasti, ma anche l’unità. Nelle crisi questa unità si afferma con forza elementare, mentre secondo Rosa Luxemburg quest’unità è assolutamente impossibile. In altri termini: nel capitalismo Rosa Luxemburg cerca delle contraddizioni superficiali, logico-formali, che non siano dinamiche, che non si sopprimano, che non siano elementi di un’unità contraddittoria, ma neghino invece recisamente questa unità. In realtà abbiamo a che fare con contraddizioni dialettiche che sono contraddizioni di una totalità, che si sopprimono periodicamente e si riproducono costantemente, per fare poi esplodere l’intero sistema capitalistico in quanto tale solo a un determinato livello dello sviluppo, ossia per annientare insieme a sé anche il tipo precedente di unità,
Si tratta di vedere non soltanto i contrasti, ma anche l’unità. Nelle crisi questa unità si afferma con forza elementare, mentre secondo Rosa Luxemburg quest’unità è assolutamente impossibile. In altri termini: nel capitalismo Rosa Luxemburg cerca delle contraddizioni superficiali, logico-formali, che non siano dinamiche, che non si sopprimano, che non siano elementi di un’unità contraddittoria, ma neghino invece recisamente questa unità. In realtà abbiamo a che fare con contraddizioni dialettiche che sono contraddizioni di una totalità, che si sopprimono periodicamente e si riproducono costantemente, per fare poi esplodere l’intero sistema capitalistico in quanto tale solo a un determinato livello dello sviluppo, ossia per annientare insieme a sé anche il tipo precedente di unità,
Nikolaj I. Bucharin
-
L’origine e il significato dell’Accumulazione del capitale di Rosa Luxemburg
L’interesse di Rosa Luxemburg verso i problemi dell’accumulazione capitalistica nacque dalle difficoltà concettuali che ella riscontrò nell’esporre gli schemi marxisti della riproduzione allargata, allorché era impegnata nella stesura di un manuale popolare di economia politica nel periodo a cavallo tra il primo e il secondo decennio del ’900.
Come è noto, nella Terza Sezione del II volume del Capitale Marx delinea in primo luogo il processo della riproduzione semplice, in cui non esiste accumulazione, secondo il seguente schema, laddove I è il settore che produce i mezzi di produzione e II quello che produce i mezzi di consumo:
- Details
- Hits: 2154
Bordiga, ovvero il ritorno del rimosso
di Carlo Formenti
 Perché parlare di Amedeo Bordiga? Lo spunto mi è venuto dalla lettura di un’antologia di testi del primo leader del Partito Comunista d’Italia, tradotti in inglese e pubblicati da un editore di Boston a cura di Pietro Basso: The Science and Passion of Communism. Selected Writings of Amedeo Bordiga (1912-1965). Anche se, a dire il vero, era da tempo che mi tentava l’idea di ragionare su questa ingombrante figura storica del marxismo italiano, sia perché la mia prima esperienza di militanza politica (parlo del 1962-63, anni in cui ero poco più che adolescente), fu in una formazione bordighista; sia perché ho sempre pensato che la damnatio memoriae alla quale Bordiga è stato condannato dal Partito Comunista Italiano sia stata un grave sbaglio, da un lato perché i suoi errori teorici e politici non furono tali da giustificare questa rimozione totale, dall’altro perché proprio analizzando quegli errori – invece di rimuoverli -, assieme ad alcuni suoi illuminanti contributi sulle tendenze del capitalismo dopo la Seconda guerra mondiale, si sarebbe potuto arricchire il patrimonio teorico del marxismo contemporaneo.
Perché parlare di Amedeo Bordiga? Lo spunto mi è venuto dalla lettura di un’antologia di testi del primo leader del Partito Comunista d’Italia, tradotti in inglese e pubblicati da un editore di Boston a cura di Pietro Basso: The Science and Passion of Communism. Selected Writings of Amedeo Bordiga (1912-1965). Anche se, a dire il vero, era da tempo che mi tentava l’idea di ragionare su questa ingombrante figura storica del marxismo italiano, sia perché la mia prima esperienza di militanza politica (parlo del 1962-63, anni in cui ero poco più che adolescente), fu in una formazione bordighista; sia perché ho sempre pensato che la damnatio memoriae alla quale Bordiga è stato condannato dal Partito Comunista Italiano sia stata un grave sbaglio, da un lato perché i suoi errori teorici e politici non furono tali da giustificare questa rimozione totale, dall’altro perché proprio analizzando quegli errori – invece di rimuoverli -, assieme ad alcuni suoi illuminanti contributi sulle tendenze del capitalismo dopo la Seconda guerra mondiale, si sarebbe potuto arricchire il patrimonio teorico del marxismo contemporaneo.
Il lavoro di rimozione è stato molto accurato, per cui immagino che moltissimi compagni (soprattutto se al di sotto dei cinquanta - sessant’anni) non sappiano nemmeno chi fosse. Perciò credo sia prima di tutto il caso di tracciarne un sintetico profilo biografico. Nato a Ercolano nel 1889, Bordiga ha compiuto il suo apprendistato politico nella federazione giovanile del Partito Socialista, a partire dal 1910. In quegli anni i socialisti erano in grande crescita: nelle varie leghe erano inquadrati più di un milione e mezzo di lavoratori, e il partito controllava la CGIL, nata nel 1906.
- Details
- Hits: 870
La logica eleatica della nuova scuola o il paradosso dei problemi spacciati per soluzioni
di Luigi Cerchi
 1. La voce del padrone
1. La voce del padrone
Il 24 marzo 2021 la rete Eurydice, di cui è parte integrante l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, ha pubblicato un rapporto, Teachers in Europe. Careers, development and well-being, che ha preso in esame la condizione dei docenti della scuola secondaria inferiore nei paesi dell’Organizzazione del trattato nordatlantico (tranne i due nordamericani), dell’Associazione europea di libero scambio e dell’Unione Europea nonché in Bosnia ed Erzegovina e nella Repubblica di Serbia, per un totale di trentotto stati. Si tratta di uno studio che rientra in una serie di pubblicazioni che tale rete periodicamente effettua allo scopo sia di diagnosticare lo stato di avanzamento della ristrutturazione scolastica in questa fase storica sia di fornire delle indicazioni di indirizzo alle varie realtà locali chiamate a declinare un comune imperativo di efficienza e produttività. Il carattere plurale della compagine scolastica tende infatti a disarticolare o quantomeno ad attenuare la spinta riformatrice che si dipana dalle indicazioni strategiche dei nuovi assetti di mercato ed occorre una cinghia di trasmissione che funga al contempo da rilevazione degli esiti, da individuazione delle misure ancora da intraprendere e da sollecitazione di eventuali modifiche al piano originario che siano in grado di accentuarne la spinta propulsiva. Questa matrice intrinsecamente borghese della pubblicazione ne vincola e predetermina il raggio d’azione e costituisce un’avvertenza fondamentale per un approccio che voglia non solo subirne la veste informativa e divulgativa ma finanche leggere la realtà nascosta tra le righe di un testo in gran parte statistico.
- Details
- Hits: 1530
Tra soggetto e oggetto, la verità: Lukács e Marx
di Collettivo Le Gauche
 Soggetto
Soggetto
Martin Heidegger è uno dei filosofi più importanti del secolo scorso che influenza fortemente la lettura del presente da parte di molti. Il confronto critico con lui ha particolare importanza perché egli ha correttamente individuato uno degli elementi più importanti che distinguono l’uomo dall’animale: la sua progettualità.
Certo, nemmeno la materia “inerme” sta mai ferma (pensiamo al moto dei pianeti, del ciclo dell’acqua, dei rivolgimenti geologici), però l’uomo, in quanto essere biologico, ha un livello di complessità superiore a quello della materia che si trasforma per puro gioco delle leggi della fisica e della chimica, avendo delle leggi proprie peculiari al suo essere biologico e riproducendosi come individuo, come società e come specie ponendo i propri presupposti, a differenza dei moti naturali che non necessariamente pongono i loro presupposti, e infatti si possono consumare ed annullare spontaneamente.
Le forme di vita meno coscienti si adattano tramite mutazioni genetiche casuali che creano varietà di caratteristiche entro tale specie, di cui sopravvivono soltanto gli esemplari più adatti alle condizioni in cui sono posti. Questo adattamento avviene “sulle spalle del singolo esemplare” tramite la sua vita e morte e le mutazioni genetiche ecc., quindi possiamo parlare di adattamento passivo.
Al crescere della complessità biologica, però, gli organismi si emancipano sempre più dalla loro assoluta passività e impossibilità di adattamento individuale, pur con ovvi salti: una pianta che spontaneamente tende le foglioline verso la luce del sole è incomparabilmente più passiva rispetto ad un animale che si può muovere e che può quindi cambiare il suo ambiente circostante.
- Details
- Hits: 2273
Epidemie, storia, capitalismo. Passi indietro e passi avanti
di Roberto Fineschi (Siena School for Liberal Arts)
Pubblicato su “Materialismo Storico. Rivista di filosofia, storia e scienze umane", n° 2/2020, a cura di Stefano G. Azzarà, licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0
 1. Pare che le epidemie siano un qualcosa di tipicamente umano, un tutt’uno con la vita associata. Quando nell’antica Mesopotamia sono nate le prime civiltà si è creato il contesto ideale perché esse prosperassero e si diffondessero. La vita comune di ingenti masse di individui che mangiano, bevono, espletano le proprie necessità fisiologiche, producono nello stesso luogo creò presupposti mai esistiti in precedenza per cui condizioni igieniche estreme e contiguità massiccia favorirono malattie e contagi; a ciò va aggiunta la convivenza promiscua con animali di vario tipo dai quali e ai quali trasmettere germi, bacilli ed ogni altra forma di vita potenzialmente nociva. La domesticazione umana, animale e ambientale va all’unisono con infezioni e malattie. Si calcola che, anche al tasso naturale di crescita, la popolazione mondiale dal 10.000 a.C al 5.000 a.C avrebbe dovuto almeno raddoppiare, invece, alla fine del periodo, essa era aumentata di appena un 25%, passando da 4 a 5 milioni, nonostante condizioni che in teoria avrebbero dovuto implicare anche più di una duplicazione (rivoluzione neolitica). Nei cinquemila anni successivi aumentò invece di una ventina di volte. Si ipotizza che, proprio a causa di epidemie e di un plurimillenario processo di adattamento della specie alle nuove condizioni di vita, l’espansione della popolazione sia stata drasticamente rallentata. Epidemiologicamente, si trattò con tutta probabilità del periodo più mortifero della storia umana. Sembra che le popolazioni mesopotamiche avessero già l’idea del contagio per trasmissione e che adottassero misure analoghe a quella della quarantena.
1. Pare che le epidemie siano un qualcosa di tipicamente umano, un tutt’uno con la vita associata. Quando nell’antica Mesopotamia sono nate le prime civiltà si è creato il contesto ideale perché esse prosperassero e si diffondessero. La vita comune di ingenti masse di individui che mangiano, bevono, espletano le proprie necessità fisiologiche, producono nello stesso luogo creò presupposti mai esistiti in precedenza per cui condizioni igieniche estreme e contiguità massiccia favorirono malattie e contagi; a ciò va aggiunta la convivenza promiscua con animali di vario tipo dai quali e ai quali trasmettere germi, bacilli ed ogni altra forma di vita potenzialmente nociva. La domesticazione umana, animale e ambientale va all’unisono con infezioni e malattie. Si calcola che, anche al tasso naturale di crescita, la popolazione mondiale dal 10.000 a.C al 5.000 a.C avrebbe dovuto almeno raddoppiare, invece, alla fine del periodo, essa era aumentata di appena un 25%, passando da 4 a 5 milioni, nonostante condizioni che in teoria avrebbero dovuto implicare anche più di una duplicazione (rivoluzione neolitica). Nei cinquemila anni successivi aumentò invece di una ventina di volte. Si ipotizza che, proprio a causa di epidemie e di un plurimillenario processo di adattamento della specie alle nuove condizioni di vita, l’espansione della popolazione sia stata drasticamente rallentata. Epidemiologicamente, si trattò con tutta probabilità del periodo più mortifero della storia umana. Sembra che le popolazioni mesopotamiche avessero già l’idea del contagio per trasmissione e che adottassero misure analoghe a quella della quarantena.
Page 193 of 612