Il lavoro nelle tradizioni politiche moderne: bilancio e prospettive*
di Carlo Galli
 Non si può parlare di lavoro, in chiave storica e teorica, senza confrontarsi con le principali categorie del discorso filosofico-politico: soggetto, proprietà, Stato, società, pubblico/privato, libertà/alienazione, disciplinamento; insomma con la nozione di politica moderna in generale. Infatti, il lavoro interseca le quattro grandi invenzioni della modernità: lo Stato, il mercato, il partito e la tecnoscienza.
Non si può parlare di lavoro, in chiave storica e teorica, senza confrontarsi con le principali categorie del discorso filosofico-politico: soggetto, proprietà, Stato, società, pubblico/privato, libertà/alienazione, disciplinamento; insomma con la nozione di politica moderna in generale. Infatti, il lavoro interseca le quattro grandi invenzioni della modernità: lo Stato, il mercato, il partito e la tecnoscienza.
Il mondo antico conosce il lavoro, naturalmente, ma nella teorizzazione classica il lavoro ha scarso rilievo. Certamente, in Platone (Repubblica 369b-374d) e in Aristotele (Politica 1252b) c’è l’idea che la città è prima di tutto cooperazione, un operare comune, e che questo cooperare grava sulla città, la fonda e la determina; ma c’è, altrettanto chiaramente, l’idea che ciò che è importante – l’attività di governo, o l’attività della filosofia, variamente intrecciate o addirittura coincidenti –, non è il lavoro. La politica ha a che fare con la libertà, la filosofia, la scienza, la guerra e la gloria, mentre il lavoro appartiene al regno della necessità. Del resto, mai i Greci hanno sentito il bisogno di pensare una divinità del lavoro: i Titani lavorano perché sconfitti; Afrodite è la dea della universale fecondità, della riproduzione ma non della produzione, e il suo infelice marito, Efesto, benché lavori è il dio del fuoco; Demetra è la dea delle messi, non la dea dei contadini; Ermes è il dio della comunicazione, del commercio e anche del furto; ma il dio del lavoro si cercherebbe invano: il lavoro non è cosa da dei.
Una delle poche voci importanti del mondo greco in cui il lavoro diventa una realtà politica è l’Epitaphios Logos, il discorso di Pericle che commemora i caduti ateniesi del primo anno (431/430 a.C.) della guerra del Peloponneso, riportato, probabilmente con fedeltà, da Tucidide nel II libro della Guerra del Peloponneso.
In quel discorso, che contiene una delle pochissime teorizzazioni greche della democrazia, Pericle, senza abbandonare l’ideale classico dell’eccellenza – che nella tradizione aristocratica è possibile esclusivamente a colui che sia libero dalla fatica e dalla necessità, cioè appunto l’aristocratico –, afferma che solo gli ateniesi sono capaci di realizzare l’autogoverno e di raggiungere l’obiettivo dell’eccellenza, cioè del governo di se stessi su se stessi, in quanto lavorano, non in quanto sono liberi dal lavoro (con lavoro, qui, si intendono i mestieri, il commercio, l’artigianato). Si tratta, evidentemente, di un’affermazione provocatoria; è il grido di guerra di Pericle contro l’ideologia degli aristocratici. In ogni caso, la cittadinanza, anche in Pericle, non deriva dal lavoro. La cittadinanza, l’essere parte di questa comunità che si autogoverna, deriva dall’autoctonia. Quello che Pericle sembra voler dire è: «Lavoriamo e siamo anche capaci di autogovernarci. Siamo capaci di contemperare la necessità, il lavoro, con la libertà, la politica». Non si dice «attraverso il lavoro siamo liberi», come dirà invece la modernità.
Nella tradizione ebraica e poi cristiana, il lavoro è punizione del peccato, come è chiaro nella maledizione divina lanciata su Adamo e Eva, cacciati dall’Eden. E la società trinitaria indoeuropea, le cui tracce sono presenti nella tripartizione medievale tra oratores, bellatores, laboratores, colloca il lavoro al livello più basso della gerarchia sociale: necessario, naturalmente, e anch’esso voluto da Dio come parte dell’ordine dell’essere, ma destinato a essere santificato (legittimato) e governato dal di fuori, da chi non lavora.
Con l’età moderna cambia tutto. La lettura estremistica, violentemente anti-umanistica, del testo biblico, operata da Lutero, diventa il veicolo attraverso il quale si afferma l’indipendenza soggettiva dei ceti che hanno interesse ad allentare o rompere i legami e le gerarchie tradizionali, a rovesciare le concrete relazioni di potere per cui chi lavora è subordinato a chi fa la guerra e a chi prega. Quella che nasce da Lutero è una lettura dell’essere cristiani che perfino contro le intenzioni del riformatore risulta a forte caratura soggettiva; il risultato è stato colto da Weber, il quale ha visto che la soggettività moderna si afferma attraverso una radicalizzazione e una soggettivizzazione del cristianesimo. Lungi dall’essere soltanto punizione, il lavoro è infatti anche la via attraverso la quale il soggetto costruisce se stesso: la soggettività si tempra e si misura in questo mondo attraverso l’«ascesi intramondana». Il «soggetto-che-lavora»diventa per la prima volta il fondamento, il cuore, il cardine della politica; perché «politica» c’è sempre, ma «politica fondata sul soggetto» è davvero una invenzione moderna. Solo in quanto lavora il soggetto fonda la politica. Questa è la cifra fondamentale della modernità: il lavoro passa da essere pura oggettività a essere costitutivo della soggettività e della pubblicità (della politica). Il lavoro è insomma l’attività attraverso la quale si costituisce il soggetto, e – al tempo stesso – quel soggetto che si è costituito in quel modo costruisce la politica. Nessun Antico avrebbe potuto dire che l’elemento fondativo della vita comune è il lavoro, ed è il soggetto: prima dell’età moderna si pensava agli individui ma non ai soggetti; esisteva il lavoro, ma non era il fondamento della soggettività né il fine della città.
All’interno di questo paradigma generale – soggettivizzazione del lavoro e «laburizzazione» del soggetto, e al tempo stesso apertura di questo soggetto alla dimensione politica – l’età moderna presenta significative differenziazioni. Il lavoro può avere come proprio centro il soggetto, oppure essere la naturale forma di auto-sostentamento della forma politica nella sua totalità, oppure ancora può avere una caratteristica di insuperabile parzialità.
Il paradigma di Hobbes è però un po’ differente: in Hobbes c’è l’idea che la politica è necessaria perché sia possibile il lavoro produttivo, e la proprietà. Prima della politica, infatti, non c’è propriamente il lavoro: c’è il prendere, non c’è il produrre in forma sistematica, non c’è neppure il dividere – per usare tre categorie schmittiane –; e il prendere significa che ciascuno prende ciò che l’altro ha preso, mentre il produrre, il dividere e il consumare (e anche la proprietà) sono possibili soltanto dopo la politica. La politica nasce quindi dall’incertezza del lavoro, dall’esigenza di lavoro, dal desiderio di lavoro. Il lavoro è come incertezza una precondizione della politica, mentre come presenza ne è il contenuto finale, ma non è costitutivo della politica: perché ci sia politica ci deve essere il patto, il cui primo contenuto e fine è la vita singola. Non c’è mai stata una riduzione degli obiettivi della politica così radicale: la politica non serve alla gloria, né a fare la guerra, ma solo a rendere possibile la tutela della vita e il godimento dei «frutti dell’industria» (Leviatano).
John Locke (Secondo Trattato sul governo) instaura un’importante variazione rispetto a Hobbes. Anche in lui c’è il patto; anzi, ce ne sono due, quello di unione che fonda la società politica, e quello che dalla società politica dà vita al governo, il «trust», e tuttavia la differenza decisiva rispetto alla costruzione hobbesiana sta nel fatto che mentre Hobbes prospetta una figura disincarnata della politica – la «carne», cioè il lavoro, viene dopo (prima, semmai, c’è solo la nuda vita) –, per Locke invece la «carne» comincia da prima, dalla natura, e permane e persiste attraverso il patto: la politica serve non a renderla possibile ma a rafforzarla, a darle misura ed equilibrio. Questa «carne» è la proprietà come diritto naturale, e la proprietà a sua volta ha come «titolo radicale» il lavoro, che avviene proficuamente già nello stato di natura: dapprima nella forma dell’occupazione e della lavorazione della terra; ma appena la civiltà progredisce si può essere proprietari non solo di ciò che si è coltivato direttamente, ma di ciò che si può guadagnare lecitamente attraverso il lavoro nelle sue forme più astratte e generali, e attraverso l’uso del denaro. C’è qui l’idea dell’individuo proprietario di se stesso – che vuol dire la fine dell’autorità, delle gerarchie ecclesiastiche, del dominio aristocratico: ciascuno è proprietario di sé; ovvero, ciascuno (maschio bianco) è titolare dei diritti naturali – vita, libertà, proprietà –. È per tutelare e garantire queste realtà prepolitiche che per Locke si rende necessaria la politica, l’uscita dallo stato di natura attraverso il patto.
In Locke dunque le due dimensioni, il lavoro e la politica, sono distinte, ma c’è una predominanza della dimensione lavoro. Infatti, c’è una chiara consapevolezza della intrinseca e naturale politicità del lavoro: è il lavoro che ci fa stare insieme, non il patto; questo perfeziona e formalizza la nostra socialità, la ripulisce, toglie le difficoltà dello stato di natura, ma il legame sociale è dato dal lavoro (in Europa: fuori da questa c’è l’appropriazione delle terre incolte o poco sfruttate). Con Locke, il protagonista della politica è l’individuo proprietario di sé che, divenuto proprietario di beni attraverso il proprio lavoro, vive insieme ad altri in relazioni di potere codificate da una legge che tutti hanno contribuito a creare.
C’è in Locke la matrice, non ancora del tutto sviluppata, dell’economia politica classica: il lavoro ha come protagonista l’individuo; ha una base naturale, una intrinseca socialità (è il lavoro che produce i beni, ciò che è buono per il singolo e per la società: è in embrione la teoria del valore/lavoro) che la politica istituzionale formalizza.
La coappartenenza di lavoro, soggettività, società e politica è il grande lascito della civiltà moderna, ma è anche l’origine della doppiezza borghese sul lavoro: da una parte, quando è utile, si gioca la polemicità e la politicità del lavoro contro gli ordini politici e sociali tradizionali; dall’altra, quando serve, si può affermare la naturalità del lavoro, anche e proprio nelle sue forme capitalistiche.
Infatti, nel paradigma moderno costituito da individuo, soggettività, lavoro, politica, è presto visibile un’ulteriore variante: quella di Sieyes. In Che cos’è il Terzo stato? Sieyes spoliticizza il lavoro, ovvero trasforma il lavoro in natura, e fa della divisione del lavoro la struttura non discutibile, ovvia, della coesistenza umana, il metabolismo materiale della nostra natura sociale, della nazione. A questo punto, l’utilizzazione del lavoro come titolo per definire la legittimità della vita associata è già avvenuta, l’illuminismo ha già compiuto la sua opera: se il lavoro non è più politica, ma natura, la politica è fare la guerra e la rivoluzione, tagliare la testa ai nobili, che non stanno alle regole del gioco, cioè rifiutano l’uguaglianza formale.
Siamo qui nel cuore della neutralizzazione borghese del lavoro, che consiste appunto nel non volere più vedere l’elemento di polemicità, cioè di potere diseguale, oltre che di socialità, contenuto nel lavoro, e nello spostare la polemicità verso un nemico che è interno ed esterno al tempo stesso: interno, perché la nobiltà vive in Francia; esterno, perché ideologicamente estraneo alla nazione rivoluzionaria. Infatti, riprendendo in negativo la tesi, diffusa dalla fine del Seicento, delle origini franco-germaniche della nobiltà francese, Sieyes invitava il Terzo stato a «rimandare nelle foreste della Franconia tutte le famiglie che mantengono la folle pretesa di essere nate dalla razza dei conquistatori e di aver ereditato da loro il diritto di conquista». Politica e lavoro qui si separano: il lavoro non è politica, è naturale (si noti che tanto contro la politicità positiva del lavoro quanto contro la sua neutralizzazione si era mosso Rousseau nel Discorso sull’origine della disuguaglianza: il lavoro, strettamente collegato alla proprietà, è il male originario della civiltà).
Eppure, contemporaneamente, resta anche la possibilità opposta: non è vero che l’intrinseca politicità del lavoro emerga soltanto con il marxismo. È chiarissimo infatti a un autore coevo di Sieyes come Bentham che la proprietà implica dislivelli di potere nella relazione sociale (certo, il suo problema è l’omeostasi, cioè trovare le forme dell’equilibrio perché la società non si distrugga).
Ma è nel pensiero dialettico, con Hegel, che politica e lavoro tornano a coesistere nel modo più complesso. Il lavoro per Hegel è politico, ma di una politicità non orizzontale (come relazione fra uguali): anzi implica un dislivello di potere, mai del tutto neutralizzabile. Per di più, contro l’ideologia dell’illuminismo, che egli definisce come paradigma dell’utilità, ovvero della neutralizzazione del lavoro – il lavoro è naturale, e l’utilità del singolo può e deve diventare direttamente l’utilità collettiva –, Hegel afferma che l’utilità stessa non è naturale, ma derivata: prima del paradigma universale e neutrale dell’utilità c’è il fatto che chi lavora è un vinto, un subalterno. Il lavoro – è la grande scoperta di Hegel – è un’attività asimmetrica, inscritta nei rapporti di potere, generata da una disuguaglianza polemica e politica; e il rapporto di potere che vi si instaura collega e al tempo stesso separa il signore dal servo. Questo non è il rapporto di potere fra il capitalista e il proletario, i quali sono entrambi lavoratori: il signore hegeliano è invece colui che, nella scena mortale pensata da Hegel, non ha avuto paura della morte, ha vinto: viene riconosciuto dallo sconfitto, il servo, come coscienza essenziale e non lavora. E infatti, nella Fenomenologia dello Spirito, da questo momento il signore esce dalla storia e scompare.
Chi lavora è dunque il servo, un vinto; anche se sulla scena non ci sono i vincitori. Ma è questa soggettività debolissima, che proprio in quanto debole è costretta a lavorare, che alla fine del processo (nella tarda modernità) riemerge come quella che, lavorando, ha non solo elaborato il mondo, ma ha costruito se stessa ed è giunta alla libertà e alla certezza della ragione. La possibilità di sostenere, come faceva Vico, che verum et factum convertuntur è data proprio dal lavoro moderno, che fa il mondo e al tempo stesso fa il soggetto. C’è qui una importante differenza rispetto alla politicità del lavoro pensata dai liberali come Locke: in un contesto dialettico lo stesso soggetto (e non solo la sua proprietà) è costruito attraverso il lavoro (questa è la nozione di Bildung).
C’è qui una politicità del lavoro che è una socialità del lavoro: la società civile è per Hegel il sistema dei bisogni, segnato solo dal lavoro individuale e dalla sua capacità relazionale. E, riguardo alla società, c’è la piena consapevolezza che il lavoro non è indifferenziata laboriosità, e che la divisione del lavoro implica anche i dislivelli di potere e tutte le contraddizioni del lavoro, quelle che producono la dialettica della società civile, e anche la «plebe» (parr. 244-248 della Filosofia del diritto). Hegel vede insomma la piena politicità del lavoro e le sue contraddizioni, e vede soprattutto la centralità del lavoro in senso non retorico: «lavoro» non è una metafora per dire «naturale socialità», ma è il lato materiale della «fatica del concetto» (senza che, però, a differenza di quanto accade con la filosofia, vi sia una sintesi che pacifica il lavoro; la soluzione delle contraddizioni del lavoro è fuori dalla società, è nello Stato – il quale a sua volta non è certo un assoluto, perché presenta altre contraddizioni – e fuori dello Stato). Non a caso, quindi, Adorno rimprovererà a Hegel di «avere chiosato senza ritegno l’elogio borghese del lavoro».
Marx, da parte sua, afferra l’idea fondamentale di Hegel, la politicità dialettica (cioè contraddittoria) del lavoro (un’idea, lo si ripete, che – priva però dell’elemento della disuguaglianza e del conflitto – era presente anche nel paradigma classico dell’economia politica, noto a Hegel attraverso Jean-Baptiste Say) e le dà un contenuto materiale, che consiste nell’analisi del processo economico; e la contraddizione che Hegel vedeva e accettava – cioè la «plebe», quel «resto» che la società capitalistica sempre produce, quella contraddizione economica dentro lo Stato che risolveva con il colonialismo, spostando cioè le contraddizioni fuori dallo Stato, diventa in Marx molto più radicale, mentre esibisce una chance di soluzione.
Anche in Marx il lavoro è l’elemento di costruzione della socialità, è costitutivo della politica, e produce contraddizioni; bisogna però vedere come si articola veramente quel lavoro. In primo luogo, mentre in Hegel il lavoro è ancora un Tutto, un sistema complessivo di relazioni al cui interno si danno contraddizioni, in Marx diventa invece una parte: il lavoro non è uno, ma è un due, e in questa dualità – il lavoro del capitalista e il lavoro del proletario – c’è chi vince (che non è il signore hegeliano) e c’è chi perde: l’uno, il capitalista, mette all’opera l’altro, il proletario. Detto altrimenti: per Marx è centrale capire che il lavoro nel sistema del capitale è «forza-lavoro». L’alienazione (meglio, la reificazione) è la cifra fondamentale del lavoro, come per Hegel, ma non è inevitabile: è necessaria solo all’interno del processo di lavoro capitalistico.
In Marx il lavoro è il vero titolo della cittadinanza – questo gli è chiaro fino da La questione ebraica (1843), la critica all’uguaglianza formale garantita dallo Stato, mentre in realtà è il lavoro e non lo Stato che socializza gli uomini, rendendoli diversi –: lo Stato è una sovrastruttura funzionale a una parte specifica della società (la borghesia). Non solo è il lavoro subordinato a costituire il titolo della cittadinanza (i proletari sono quelli che fanno funzionare la macchina sociale), ma soprattutto lì, nel lavoro comandato e mercificato, emerge un’umanità talmente ridotta all’osso, a «essenza di genere», che le è possibile – nel momento in cui riconosce la propria condizione – esprimere un’umanità piena; quello di Marx non è semplicemente un umanesimo del lavoro, ma è un umanesimo del lavoro politicamente liberabile. Di un lavoro che non è più sfruttato ma è restituito alla sua funzione di scambio organico con la natura. Nel lavoro-parte (che implica anche un partito del lavoro, o dei lavoratori), nel lavoro alienato, sta scritta la possibilità di una disalienazione del lavoro (una parte del marxismo del Novecento ha visto in Marx perfino la possibilità di superare la stessa dimensione del lavoro).
In Marx – uomo dell’Ottocento – lo Stato non è più un arcano: è il primo bersaglio della sua critica giovanile; l’economia politica è il vero problema, che egli impiega tutta la vita a dipanare; ma non è un problema neppure la tecnoscienza. Quarant’anni dopo questa è divenuta il problema.
In Nietzsche infatti quel problema è centrale. Per lui, l’idea di un soggetto che costruisce se stesso, la società e lo Stato, attraverso il lavoro – tanto nella prospettiva liberale quanto in quella socialista – è la grande menzogna moderna, identica (benché rovesciata) alla grande menzogna antica del lavoro come punizione della colpa; in realtà, nel lavoro si svela la menzogna. Lavoro come colpa e lavoro come libertà sono due facce della stessa medaglia, della stessa logica che vuole che il soggetto sia se stesso solo attraverso un duro disciplinamento, cioè quando è assoggettato (a un padrone, o a un ideale). Il risultato dell’etica moderna del lavoro e infatti che il lavoro che si è insignorito del soggetto; che il lavoro si rivela essere il destino dei servi.
In Umano, troppo umano I e II (1878), il primo testo della fase matura di Nietzsche, emerge che l’epoca del lavoro (la modernità) non può non rovesciarsi in «macchina» (inganno, mechané). Il lavoro non è la libertà ma il sistema del dominio su base tecnologica, è la «macchina» come nuova oggettività che nega la soggettività. Il valore del lavoro è il principio di utilità, non di soggettività; il soggetto di cui si parla quando si parla di lavoro non è un soggetto, ma la funzione del paradigma fondamentale della civiltà moderna: l’utilità. Già Hegel lo aveva individuato, addebitandogli la colpa del Terrore; tuttavia, egli pensava ancora che la modernità potesse superare il principio di utilità, e trasformarlo nel principio della libertà. Per Nietzsche invece, l’idea moderna può certamente narrare se stessa come paradigma di libertà e di affermazione del soggetto che col lavoro si insignorisce del mondo; ma la verità di questa narrazione ideologica è che il soggetto è insignorito dalla macchina, dall’utilità che si fa concreta: il soggetto è semmai un oggetto. Come appare nei Frammenti postumi 1887-1888, l’umanità come macchina totale è un «enorme ingranaggio di ruote sempre più piccole, volte al massimo dello sfruttamento e a minimizzare il valore dell’uomo. L’uomo si deteriora perché non si sa più a che cosa mai quest’enorme processo sia servito».
Il che è la fine non solo della filosofia classica tedesca, ma anche della logica moderna della laburizzazione del soggetto. Il soggetto si soggettivizza altrove e altrimenti, non nel lavoro: «ogni attimo in cui facciamo le nostre cose migliori, noi non lavoriamo. Il lavoro non è che un mezzo per questi attimi» (Frammenti Postumi 1882-1884). Non solo il lavoro non è lo spazio della libertà (o della liberazione): non è neppure il problema principale, benché insolubile. È una questione derivata, mentre la principale è la metafisica, la duplicazione del mondo – che nella modernità diventa la costruzione dell’orizzonte dell’utilità – e la tecnica, che da questa discende. Col lavoro, infatti, non si costruisce se stessi, ma si esegue un principio che ci trascende, il principio di utilità. Nietzsche non è un aristocratico che odia i lavoratori – per lui, lo sfruttamento del lavoro nella sua forma rapace e brutale è idiota, è come ammazzare di fatica un cavallo; il socialismo si previene non sfruttando troppo duramente il lavoro (la logica è quella dell’allevamento, insomma) –; semplicemente, Nietzsche non vede più nel lavoro il problema (l’alienazione) e al contempo anche la soluzione (la libertà); vi vede solo il problema, insolubile all’interno delle coordinate epocali che lo pongono: il lavoro è una disciplina da cui non nasce alcuna libertà. Con il lavoro si resta all’interno dell’epoca, e delle sue contraddizioni – e sono queste il vero problema –. Nietzsche insomma vede che liberalismo e socialismo non sono due alternative, il secondo capace di risolvere i problemi posti dal primo, ma due facce della stessa avvilita e avvilente narrazione moderna, «malata» (come dice lui), incapace cioè di riflessività, in crisi perché non riesce a criticare se stessa.
Con Nietzsche il lavoro è ormai marginale; il soggetto si costituisce fuori da esso, nelle forme del desiderio e dell’entusiamo (e del consumo). Il connubio – privo di relazione dialettica – fra macchina e godimento tiene ora il campo.
Sul lato della macchina, la profondità e l’acutezza della diagnosi nietzscheana trova riscontro nell’opera di Ernst Jünger, che in Der Arbeiter (1932) abbraccia in toto l’eredità di Nietzsche, di colui che, nato postumo, è diventato il maestro di un secolo. Di conseguenza, anche per Jünger il lavoro è «macchina»; e l’Operaio, l’Arbeiter, è un addetto alla «macchina», è un Titano. Ovvero, non è più un soggetto moderno, non costruisce più la propria libertà nel lavoro, ma al lavoro è condannato da un destino che ha messo in moto da sé ma che lo ha trasceso. Così, la cifra fondamentale dell’epoca contemporanea non è la libertà ma la coazione.
Tutto ciò significa, tra l’altro, che guerra e politica, guerra e lavoro non sono più distanti, come sosteneva la civiltà liberale, ma sono la stessa cosa: lavoro e guerra sono la stessa figura della violenza, e la violenza è la cifra ultima della utilità. Il Lavoratore, l’Operaio, non solo non è un soggetto ma un oggetto, non un uomo libero ma un essere coinvolto nella coazione, ma non è neppure un uomo pacifico essendo piuttosto produttore di violenza e al contempo sottoposto a violenza. La produzione è produzione di guerra, attuale o potenziale – come si legge in La mobilitazione totale (1930), il testo che prepara l’Arbeiter. L’Operaio è un Milite del Lavoro (come proponeva il giovane Cantimori).
Con intenti differenti e con altri strumenti concettuali anche Hannah Arendt (Vita activa, 1958) riconosce che il lavoro è inadeguato a fondare la sfera pubblica: tanto l’homo faber quanto l’animal laborans hanno perduto, nella loro ansia di dominare il mondo, la dimensione della politica come libero agire comune: della politica non come costruzione ma come azione. La politica divenuta produzione è il trionfo della tecnica sull’uomo che da dominatore diviene dominato. Come si vede qui il lavoro è alienante in quanto tale, se elevato a unica dimensione della vita collettiva; la critica del capitalismo è assorbita nella critica del lavoro. Certo, questa prospettiva si applica anche alla rinascita, dopo la fine della seconda guerra mondiale, dell’umanesimo moderno del lavoro – cioè al passaggio dallo Stato totale allo Stato sociale –. È una prospettiva radicale, che non crede che nel lavoro (la sfera della necessità) ci sia l’origine della politica come libertà.
Al contrario, la Costituzione italiana ricapitola la narrazione della modernità quando afferma che il soggetto costruisce se stesso, la società e la politica, attraverso il lavoro; dire che la Repubblica democratica è fondata sul lavoro significa che il lavoro è il luogo della formazione del sé, della società, dell’ordine politico. E anche che è la dimensione privilegiata della liberazione dal bisogno e dalla umiliazione della dignità personale – senza che vi sia, in questa prospettiva democratica e progressista, un esplicito discorso sulla liberazione dalla reificazione propriamente capitalistica, c’è certamente un’indicazione contro lo sfruttamento e la degradazione del lavoro e dei lavoratori –.
Dopo il «trentennio glorioso» – l’alleanza fra il capitalismo fordista e i partiti democratici di massa, che nel nostro Paese hanno garantito sviluppo economico e progresso civile e sociale – una nuova sfida ha minacciato l’idea (e la pratica) moderna che veda nel lavoro la chiave di comprensione e di costruzione del soggetto, della società, della politica. La nuova sfida è il neo-liberismo, le nuove forme del capitalismo – che in generale non è più ad alta intensità di lavoro ma richiede una bassa intensità di lavoro –, ora mosso da un’idea fondamentale: cioè che il soggetto non si forma attraverso il lavoro, e che l’economia è un sistema di equilibri nei quali si esprimono le preferenze di soggetti già fatti e finiti, capaci nello scambio e nella concorrenza di massimizzare la propria utilità individuale e di operare scelte razionali (queste tesi, riconducibili alla teoria della scelta razionale, derivano dal marginalismo austriaco e dalla sua critica radicale della teoria del valore-lavoro).
In realtà questa nuova individualizzazione del lavoro è al tempo stesso anche una nuova naturalizzazione: quel soggetto, infatti, intorno al quale ruota, nella teoria (nell’ideologia) la realtà del lavoro, è pensato come un soggetto astorico, naturale, esente da determinazioni materiali. Infatti, accanto alla naturale capacità di calcolare la propria utilità, di massimizzare il proprio profitto e la propria avidità, di quel soggetto il neoliberismo stimola anche (secondo le circostanze e le convenienze) il lato del piacere, sollecitando il suo egoismo – ma oltre a questo tono edonistico o sentimentale il discorso neoliberista si può servire anche di un mood penitenziale, adatto ai tempi di crisi e di sacrifici –. In generale, per il neoliberismo il lavoro è una faccenda privata, nel bene o nel male, nel successo o nella sconfitta: non dà forma né al soggetto, né alla società né alla sfera politica (dentro la quale, in ogni caso, lo Stato è un male, che va ridotto e tagliato).
Naturalmente questa narrazione è in sé non vera: è al servizio di poteri e di interessi che sanno bene quanto il lavoro sia in verità centrale, capace di formare lo spazio pubblico; e proprio per questo lo vogliono marginalizzato, subalterno, privatizzato, non garantito, appunto perché gli interessi che quella narrazione veicola possano trionfare. Infatti, il lavoro plasma ancora la vita del singolo e la forma della società e della politica: lo sanno coloro che cercano di lavorare, che lavorano e subiscono su di sé il dominio di poteri che neppure comprendono. Solo, mentre in passato quel dominio veniva concettualizzato in narrazioni che mettevano al centro il soggetto e la sua capacità di liberarsi attraverso il lavoro, di liberare il lavoro attraverso le contraddizioni del lavoro, oggi questo non avviene: del lavoro non si dice più che è centrale, che lo dovrebbe/potrebbe essere. Al più si dice che la sua attuale mancanza è un problema, che però la politica si guarda bene dall’affrontare direttamente, affidandone piuttosto la soluzione al mercato. Pensare al lavoro come problema, in questo modo, significa in realtà pensarlo come derivato.
Il lavoro non fa sistema: anzi, da una parte si nega che un sistema esista (che la stessa società esista), e dall’altra si afferma che le logiche del sistema sono tanto elastiche e al contempo tanto rigide da consentire ogni trasformazione del lavoro ma anche da impedire che esso divenga un problema politico. Insomma, innovazione e flessibilità sono le nuove forme della neutralizzazione della dialettica del lavoro. Quanto ciò sia compreso e condiviso dai lavoratori, o quanto a ciò essi si possano e vogliano opporre, e come, è un problema politico fondamentale.


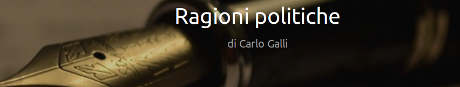





























Add comment