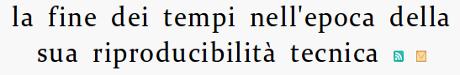
L’apocalisse neoliberista
di Raffaele Alberto Ventura
 La crisi economica assomiglia a una macchia di Rorschach. Ognuno la interpreta come vuole, ognuno ne attribuisce l’origine a una causa differente:
La crisi economica assomiglia a una macchia di Rorschach. Ognuno la interpreta come vuole, ognuno ne attribuisce l’origine a una causa differente:
– Una farfalla.
– Un uomo e una donna che fanno l’amore?
– La testa spaccata di un cerbiatto…
– Il neoliberismo!
Ecco, prendiamo il neoliberismo. Come ha scritto Francesco Costa sul giornale di Confindustria, affermare che in Italia siano state messe in pratica delle politiche neoliberiste è inesatto perché in questo caso si sarebbe “ridotto il peso dello Stato nella sua economia, abbattendo le tasse e la spesa, privatizzando le grandi aziende pubbliche, riducendo drasticamente la burocrazia, abolendo la contrattazione collettiva e gli ordini professionali, lasciando mano libera ai privati”: tutte cose che semplicemente non sono mai avvenute. E tuttavia del neoliberismo, per come viene descritto da chi ricorre al termine, si è verificato in tutto l’occidente l’effetto principale, ovvero il trionfo del capitale sul lavoro: in pratica, una progressiva diminuzione della remunerazione media negli ultimi venticinque anni, dopo trent’anni d’incremento.
Sembra dunque avere senso parlare di discontinuità, e dare un nome – “neoliberismo” – a questa discontinuità.
Si tratta di una scorciatoia linguistica che tuttavia lascia aperte alcune questioni fondamentali: primo, se siano effettivamente delle specifiche politiche economiche – reaganomics, thatcherismo… – la causa di questo fenomeno; secondo, se altrove l’applicazione di politiche differenti abbia generato effetti più soddisfacenti; terzo, se non sia piuttosto la coesistenza forzata tra politiche di segno opposto a produrre i più gravi effetti. Per tentare di chiarire questi punti è necessario partire da molto lontano, dall’alba della rivoluzione industriale…
Il capitalismo è un sistema economico in continua trasformazione, caratterizzato da alcune tendenze strutturali. Una di queste è la divisione sociale del lavoro, ovvero la frammentazione sempre più importante dei processi produttivi. Questa divisione, che garantisce l’incremento della produttività, nello stesso tempo erode la qualità del lavoro e quindi il suo costo. Il leggendario Ned Ludd fu il primo a prendere coscienza di questo fenomeno (leggermente più antico di qualsiasi svolta neoliberista) e reagì pigliando a spaccare macchine come un forsennato. Per giunta il capitale tende a concentrarsi in maniera monopolistica, annientando la concorrenza in ogni settore e riassorbendo in qualità di salariati le vittime della propria espansione. Insomma al movimento che imborghesisce i consumatori si associa un movimento che proletarizza i produttori. Ma il vero paradosso del capitalismo è ancora un altro: per effetto della libera concorrenza la produttività tende continuamente a scavalcare la domanda esistente, col rischio che la merce non trovi sbocco sul mercato e che il sistema si paralizzi. A dire il vero molti vorrebbero pure acquistarla questa merce, il problema è che – ricordate – Ned Ludd non ha più un soldo.
Sopraffatto dalle sue contraddizioni, il capitalismo industriale è sostanzialmente tragico. Fatta pace con questa spiacevole diagnosi, nel tempo che resta è possibile deliziarsi a inventare palliativi, narcotici e altri rimedi utili a rallentare o accelerare la catastrofe. Thomas Malthus ebbe un’intuizione: abbiamo bisogno di una classe di rentiers che si faccia carico di consumare l’eccesso di offerta. Non era già questa, fin dai tempi degli antichi sacrifici, la funzione dei sacerdoti, chiamati a distruggere un surplus di risorse che poteva perturbare l’equilibrio economico? John Maynard Keynes sviluppò l’idea malthusiana investendo un nuovo soggetto del sacro compito: lo Stato. Il potere pubblico non si limiterà a una funzione regolatrice, bensì dovrà trasformarsi in consumatore esso stesso. La sua missione sarà di produrre la principale delle risorse scarse ovvero la domanda. Così lo Stato keynesiano eredita dalla Chiesa il ruolo di potere che frena: katéchon che argina il flutto impetuoso dell’accumulazione capitalistica.
Insomma lo Stato faccia al capitalista quello che il capitalista fa al lavoratore. Da una parte preleverà una quota del profitto privato, dall’altra la spenderà per assorbire il surplus prodotto dagli incrementi di produttività. Tutto perfetto, se non fosse che non c’è limite agli incrementi, quindi non c’è limite alla ricchezza che deve essere consumata per inseguirli, quindi non c’è limite alla quota che deve essere prelevata… Ma in un contesto concorrenziale caratterizzato dalla corsa al ribasso dei prezzi – la famigerata competitività – questo inseguimento infinito non è possibile. C’è una soglia oltre la quale il prelievo fiscale incide sulla sostenibilità stessa delle attività economiche: una soglia, dunque, che segna l’inizio di una fase apocalittica in cui riemergono d’un tratto tutte le contraddizioni che erano state occultate.
Alla fine degli anni Sessanta, in effetti, l’oliato meccanismo comincia a incepparsi. La domanda ricomincia a scarseggiare e stimolarla risulta sempre più costoso. Disoccupazione e inflazione si presentano contemporaneamente, contraddicendo la logica keynesiana. Negli Stati Uniti vanno in crisi sia il modello di produzione fordista che gli strumenti politici di sostegno alla crescita. La bilancia commerciale entra in una fase deficitaria e, per non essere costretto a svuotare Fort Knox in cambio dei miliardi di verdoni sparsi per il mondo, Richard Nixon nel 1971 abolisce la convertibilità del dollaro in oro. Come se non bastasse, la crisi energetica del 1973 pone fine allo sfruttamento precapitalistico del petrolio. Certo, una nuova generazione di turbo-consumatori è stata formata dai “cattivi maestri” della controcultura libertaria, ma resta il problema di come finanziare tutto questo desiderio liberato.
C’è chi parla di crisi di accumulazione del capitale, ovvero di un’erosione della quota di profitto ottenuta dai capitalisti. Si tratta di un’interpretazione accettabile fintanto che non appiattisce l’economia sulla psicologia, attribuendo cioè all’avidità di una ristretta cerchia di capitalisti la responsabilità di fenomeni ben più profondi. Se il correttivo keynesiano aveva sanato definitivamente le contraddizioni del capitalismo, perché mai d’un tratto si sarebbe voluto infrangere quest’equilibrio? I capitalisti saranno pure dei lemming impazziti, ma qui c’è qualcosa che non torna. Il punto è che, ovviamente, le contraddizioni non erano state risolte; si erano segretamente accumulate. Il lavoro aveva continuato a dividersi e il capitale aveva continuano a concentrarsi. Non solo per il potere pubblico era diventato sempre più difficile correggere le disfunzioni generate da queste tendenze, ma inoltre lo sviluppo ipertrofico dello Stato aveva iniziato a produrre nuove disfunzioni.
Le politiche di Reagan e Thatcher – ispirate alla scuola neoliberista e integrate con altre politiche di segno opposto – furono l’ennesima manovra di correzione del capitalismo per garantirne la sopravvivenza. Si parla di privatizzazioni, lotta ai sindacati, lotta all’inflazione, tutte misure volte a sostenere la competitività dell’offerta da una parte compensando la caduta del saggio di profitto e d’altra parte recuperando sul costo del lavoro quello che si era ceduto e si continuava a cedere sul costo dello Stato. In effetti non si abbandonarono le misure di stimolo della domanda e la politica monetaria espansiva, che associata alla deregolamentazione dei mercati finanziari permise d’inondare il mercato di “soldi facili”. Lo sviluppo del commercio internazionale accentuò il processo di divisione mondiale del lavoro e nello stesso tempo aprì colossali sbocchi per l’esportazione del più tipico e apprezzato dei prodotti americani: il granoturco? No, il dollaro. L’intera economia americana si sarebbe fondata, negli anni a venire, su questa monocultura paradossale. E con tutto ciò, alla fine, si riuscì ancora una volta a rimandare l’apocalisse. La quale si ripresentò, puntale, allo scoppio della bolla finanziaria del 2008.
Tutto questo dovrebbe permettere di relativizzare la responsabilità del feticcio chiamato neoliberismo nelle amare faccende che affliggono la nostra vita quotidiana, e forse invitarci a riflettere in maniera più originale sulla maniera corretta di reagire. Le misure prese negli USA riassestarono la sovrastruttura normativa (la politica, il diritto) alla struttura materiale (l’economia). In questo senso l’effetto di discontinuità è puramente prospettico. Per anni abbiamo visto come in uno specchio, in maniera confusa: ora vediamo faccia a faccia. La presunta scossa neoliberista è il conto del boom, pagato tutto in una volta sola: dunque per analizzare obiettivamente questa fase bisognerebbe, come dire, calcolarne l’ammortamento su un periodo più lungo. Siamo costretti a giudicare l’economia secondo una duplice scala di valori (breve termine/ lungo termine) che produce una disciplina precisamente schizofrenica. Come ogni cosa che esiste in questo meraviglioso universo retto da regole deterministiche, quello che è accaduto era necessario. E come ogni ogni cosa che esiste in questo maledetto universo governato dall’entropia, si è trattato di un ulteriore passo verso il caos.
Come spesso accade in questi casi, il “neoliberismo reale” si realizzò violando una parte dei principi sostanziali della dottrina che lo ispirava. Lo stesso Reagan – al quale si attribuisce la battuta “We are all Keynesians now” – fu artefice di una politica deficitaria e giustificò la riduzione delle tasse con l’argomento che ciò avrebbe stimolato la domanda aggregata. L’attuale debito pubblico americano, in fin dei conti, non è altro che il risultato della coesistenza scoordinata tra una politica di spesa ambiziosa (in particolare sul versante militare) e una politica fiscale concentrata sulla competitività. Per non parlare del debito italiano, risultato dell’aggiustamento utopistico della spesa sul gettito virtuale fantasticato al netto di un’evasione fisiologica.
L’esame della situazione italiana è particolarmente interessante come contro-esempio dell’ipotesi neoliberista. Se oggi in Italia una quota importante della ricchezza prodotta, invece di remunerare il lavoro, viene prelevata e spartita da un’abnorme classe di funzionari, questo ha poco che vedere con il neoliberismo. Al contrario: è il rimedio keynesiano che ha iniziato a produrre danni iatrogeni. Se oggi in Italia esiste un gigantesco esercito di riserva di disoccupati e semi-occupati “presso me stesso” che tirano verso il basso il costo del lavoro divorando grosse fette di patrimonio familiare, questo ha poco a che vedere con il neoliberismo. Al contrario: è una lotta fratricida in seno alla classe media, a colpi di quattrini. Se oggi in Italia migliaia di africani e slavi vengono sfruttati nei campi e nei cantieri, fuori da qualsiasi giurisdizione e indipendentemente da qualsiasi normativa, questo ha poco a che vedere con il neoliberismo. Al contrario: è un segnale dello scollamento tra la realtà concreta e un ordinamento giuridico sempre più fantasioso. E se per difendere questo status quo tirate in ballo Keynes o Marx, ridotti a prestanome di un capitalismo di Stato clientelare, allora forse significa che vi fa comodo così.
Faceva comodo a tutti. Il problema è che non funziona più.































Add comment