Uno schema di ricerca su Operai e Capitale
di Lorenzo Serra
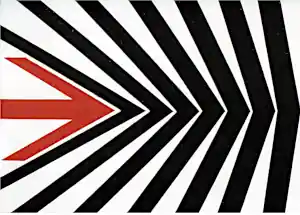 Non dovremmo più considerare Operai e capitale un testo di esclusivo attacco, puramente escatologico – ciò, infatti, continua-a-significare il fraintendimento non solo di quest’ormai classico dell’operaismo italiano, ma anche, e soprattutto, un equivoco dell’intera opera trontiana: del suo stile o carattere – o, per esprimersi in termini lukácsiani, del suo pensiero solo. Sì, Operai e capitale è stato anche questo: una possibilità esperita – un tentativo di offensiva da portare nel cuore del Capitale, che doveva esser esplorato fin dentro i suoi limiti. Ma è stato anche altro, quell’altro che costituisce, poi, la cifra stilistica del pensiero di Tronti, dai caratteri, mai abbandonati, del malinconico, della scissione, della crisi: e, cioè, un pensiero rivoluzionario, dai tratti anche eretici, che diffida di marce trionfali o progressiste – eppure, forse in virtù di questo, mantenutosi, nel profondo, sempre, comunista.
Non dovremmo più considerare Operai e capitale un testo di esclusivo attacco, puramente escatologico – ciò, infatti, continua-a-significare il fraintendimento non solo di quest’ormai classico dell’operaismo italiano, ma anche, e soprattutto, un equivoco dell’intera opera trontiana: del suo stile o carattere – o, per esprimersi in termini lukácsiani, del suo pensiero solo. Sì, Operai e capitale è stato anche questo: una possibilità esperita – un tentativo di offensiva da portare nel cuore del Capitale, che doveva esser esplorato fin dentro i suoi limiti. Ma è stato anche altro, quell’altro che costituisce, poi, la cifra stilistica del pensiero di Tronti, dai caratteri, mai abbandonati, del malinconico, della scissione, della crisi: e, cioè, un pensiero rivoluzionario, dai tratti anche eretici, che diffida di marce trionfali o progressiste – eppure, forse in virtù di questo, mantenutosi, nel profondo, sempre, comunista.
Operai e capitale, allora, si potrebbe leggere come quel momento in cui – anche grazie ad una differente Storia – queste sue differenti anime si sono avvicinate, fino a toccarsi: il carattere gioioso di un tentativo, pensiero vissuto insieme a compagni e compagne con cui non smetterà di dialogare anche in seguito, che non riesce – perché non vuole – mai, fino in fondo, a liberarsi di quel suo lato pessimista, o tragico. Una questione insieme esistenziale e storica: vi è, infatti, come vedremo, l’embrionale intuizione che siamo già alle soglie di una possibile fine, o quantomeno di un arresto, del sogno operaio, ma, al contempo, vi è anche un’altra questione, più difficile e liminare – e, cioè, il fatto che anche a rivoluzione compiuta il mondo, e la società, non avrebbero raggiunto alcun Senso definitivo, e, allora, si sarebbe dovuto continuare a camminare, insieme, impossibilitati ad abbandonare, una volta per tutte, quel mondo di malinconia.
Una malinconia che, tuttavia, non si tramuta mai in cinismo, e neanche in disperazione: piuttosto, un orizzonte di tacita fragilità che permette di vivere, solo in un apparente paradosso, la realtà innervandola dei caratteri di gioia e ironia.
Ecco cosa è stato, dunque, Operai e capitale: tentativo di lotta e di attacco, sperimentato fin alle sue estremità – anche, forse, oltre le proprie possibilità – che non si separa mai, definitivamente, da quel sottotesto che sarebbe, poi, esploso nell’opera matura. Ed ecco cosa interessa a noi oggi, e che costituisce anche il nostro programma di ricerca: interrogare quella traccia pessimista, o di crisi, che fa da sfondo ad Operai e capitale, non solamente perché messa al bando dall’interpretazione, ma anche perché è quella che, nell’attualità, può aiutare a riformulare nuovi scenari, o possibilità, di carattere rivoluzionario.
Potremmo dire che Mario Tronti ha elaborato, e sperimentato, una vera e propria filosofia del limite – alle soglie di una coincidentia oppositorum che costituisce, poi, quell’elemento discriminante tra la Weltanschauung dell’autore di Operai e capitale e le visioni differenti di coloro che, pur richiamandosi a questo testo, seguiranno tutt’altre vie e che, soprattutto, rende la sua esperienza operaista come un unicum, che si rifà sì a dei tratti comuni ma per plasmarli, fin quasi a slabbrarli, in uno stretto contatto con la propria filosofia dell’esistenza. Raccogliere, allora, il lascito del pensiero di Tronti non significa seguire i contenuti strictu sensu – anzi, probabilmente, è proprio questo ciò che egli avrebbe detestato – ma comprendere, innanzitutto, quella possibile modalità differente di esistere e, quindi, di pensare. Tramutare una strutturale malinconia in un formidabile motore rivoluzionario, la fragilità in un’arma da scagliare contro il Capitale e la sua, sempre più irredimibile, antropologia: bisogna custodire senso dell’equilibrio per sostare in questo limite – vivere, probabilmente, come scriveva Kierkegaard, alle soglie di una divina acrobazia, per riformulare, costantemente, differenti ordini e nuove simmetrie.
Ma in questo modo muta di significato anche quell’espressione “sconfitti dalla storia”, su cui egli si è interrogato, insistentemente, anche in età matura. Perché Tronti quella possibilità di esser sconfitti da un contesto l’aveva messa in conto sin dall’inizio, ma non – e qui si apre una parentesi fondamentale – perché egli, e la sua classe di riferimento (inscindibile per comprendere pensiero e opera), si siano mai crogiolati in uno stato di subordinazione, o di inferiorità: vi è sempre, infatti, stato il tentativo di costruire egemonia, rigettando quella veste di rivoluzionari romantici che preferiscono, tacitamente, rimanere ai margini. Il suo orizzonte, piuttosto, è sempre stato di lotta, o di guerra, contro il contesto dominante, tenendo fermo quel fine di riformulare una forma-mondo capovolta o, più semplicemente, di provare a esistere in modalità differenti da quelle che convenzionalmente viviamo. Eppure, questo moto sanguigno – e qui ritorniamo al punto iniziale – non era, mai, stupidamente trionfante, o saturo di se stesso: quello sfondo di sconfitta avrebbe, infatti, in qualche modo, accompagnato anche la più grande presa sul mondo. Tragico e rivoluzionario, nel suo pensiero, erano impossibili da scindere, o districare: indicazione, piuttosto, di un’altra via di esistenza, che tenta di accogliere, in modalità anticonvenzionali, la complessa molteplicità dell’essere umano.
Ecco, allora, come Operai e capitale non andrebbe considerato un universo a parte del corpus trontiano – in quelle differenti forme interpretative, al fondo complementari, di scritto cardine o scritto da scartare – bensì reinserita in quel pensiero solo, approfondendone la sua estrema specificità all’interno della sua opera. Per analogia, come nel pensiero maturo, apparentemente più pessimista o ritirato, dovremmo vedere quei formidabili spunti di offensiva, politica e antropologica, contro la nostra società, così, nella sua giovinezza storico-esistenziale, che sembrava alle soglie di un evento, o salto, dovremmo rintracciare quel tratto malinconico, seppur sfumato, che permea, in ogni caso, i suoi saggi. Accenneremo, ora, principalmente a due questioni di Operai e capitale, che andranno poi sviluppate analiticamente, in forme più precise, anche integrandole con altre importantissime tematiche, a cui, qui, potremmo fare solo brevissimi riferimenti: la relazione tra fabbrica e società; la questione del punto di vista.
Operai e capitale può esser letto, allora, retrospettivamente, come una formidabile intuizione di una condizione di tramonto – una retrodatazione di quella crisi che sarebbe, poi, esplosa negli anni seguenti. Infatti, il testo, dai caratteri anche violenti, individua sì in una specifica fase storica la possibilità di attacco, ma ci si deve interrogare su quali siano, poi, le forme che, effettivamente, assume quest’orizzonte di offensiva. E qui bisogna ritornare alla centralità della fabbrica – alla relazione tra la fabbrica e la società, come titola uno dei suoi saggi più importanti. Perché, infatti, solo in un apparente paradosso, in Operai e capitale più si spinge il piede sull’acceleratore, più ci si sembra porsi in una posizione di vigilanza, di custodia: la fabbrica, centro di irradiazione dell’offensiva da portare nel cuore del Capitale, assume così, già allora, le forme di un argine, o di una resistenza, quasi antropologica. Radicalizzando l’interpretazione dello studioso Damiano Palano, potremmo dunque dire: non fabbrica e società, bensì fabbrica vs società – il tentativo di attuare, cioè, quel difficilissimo passaggio dalla forma-mondo della fabbrica alla forma-mondo della società, mai il contrario.
Ecco l’intuizione fondamentale che qui si cela, seppur in forme non pienamente esplicite, e che costituirà, inoltre, una delle motivazioni della sua immediata presa di distanza da quel mondo che lo aveva formato, già a partire dallo stesso ’68: il fatto, cioè, che quella società, apparentemente in movimento, finanche interpretata come rivoluzionaria, cominciava, in realtà, già a esser assorbita da quell’incipiente, pasoliniana, società dei consumi, da quel solo orizzonte di borghesia come forma di vita, che diverrà uno dei nuclei centrali della sua opera matura. Dalla forma-mondo della società – o, meglio, da quella nuova società in formazione – difficilmente sarebbe potuto originarsi uno sbocco rivoluzionario: e, allora, più che cavalcare quel fermento, vi era la necessità di ritrovare degli argini, politico-esistenziali, per far continuare-a-vivere una tradizione. In Operai e capitale vi è, probabilmente, l’idea che quell’argine potesse divenire, in realtà, forma di attacco – che potesse, cioè, tramutarsi in Storia. Ma questo non esclude il fatto che in nuce si possa già ravvisare in questo testo un elemento di teologia politica (che poi Tronti, a partire dall’inizio degli anni Settanta, farà diventare il centro della sua intera ricerca), ovvero il tentativo di trattenere, o di frenare, un flusso sempre più accelerato, e di individuare nel mondo della fabbrica il luogo di questa resistenza.
E, quindi, a questo legato, vi è un’ulteriore problematica che Tronti non abbandonerà mai nel suo pensiero e che, già in Operai e capitale, assume una sua enunciazione esplicita: quella del punto di vista, concetto giovanile lukácsiano, che egli, anche in questo caso, rielabora in modalità estremamente peculiari. È qui che ritroviamo tutti gli embrioni di quella sua cultura anti-progressista, pessimistica – la critica, cioè, a una deterministica filosofia della storia che porterebbe, linearmente, a una liberazione della società. Punto di vista da intendere dunque come frattura dell’intero, pensiero della crisi: più nello specifico, il fatto che le classi non possono che osservare, e interpretare, il mondo a partire dalla propria parziale realtà – e da qui l’impossibilità di liquidare alcuna di esse nelle forme della sola ideologia. Il tentativo, piuttosto, è quello di comprenderne le ragioni – amare, in un certo senso, il proprio Nemico, anche al fine di combatterlo. Operai e capitale è così una critica di quella polarizzazione che si pone sulla linea di faglia tra verità e falsità, costituendosi, piuttosto, come un’opera che descrive sì una conflittualità, anche estrema, tra punti di vista opposti, che si scontrano – perché non possono che scontrarsi – riconoscendo, a ogni modo, la loro singolare parzialità.
Ma questo, da una prospettiva filosofico-politica, significa una cosa ben precisa: che già da questo testo giovanile affiora l’impossibilità di conoscere oggettivamente, o neutralmente, la totalità. Che quest’ultima, infatti, vive solo a partire da una conoscenza di parte, e quindi, radicalizzando il discorso, che ci si può relazionare all’intero solamente a partire dalla coscienza, o dalla soggettività, di una classe. Non esiste, di conseguenza, alcuna totalità oggettiva, al massimo soggettiva, e, quindi, non esiste alcuna totalità per come siamo abituati a intenderla: piuttosto, un conflitto tra parziali verità, che non possono che tentare di cogliere l’intero a partire dal loro specifico luogo di osservazione. In nuce, così, qui ritroviamo dei concetti fondamentali che accompagneranno, in altre forme, la sua opera matura – una dimensione di strutturale scissione (il contrario di una marcia deterministica che tenderebbe verso una lineare conciliazione), il pensiero della crisi, la messa in discussione del concetto di Verità e quindi, ancora, tracce di filosofia dell’esistenza: l’impossibilità, cioè, di interpretare e, quindi, esser-in-conflitto con il mondo se non partendo dal proprio sé, da ciò che si è, sulla scia di una certa linea del femminismo della differenza con cui egli, non a caso, entrerà in contatto negli anni seguenti – e quindi il fatto che solamente dalla propria specifica parte di osservazione, o modalità di esistenza, politica e antropologica, si possa interpretare, e combattere, l’esistente.






































