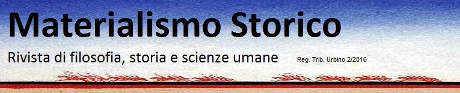Il capitale di Marx oggi
di Roberto Fineschi (Siena School for Liberal Arts)
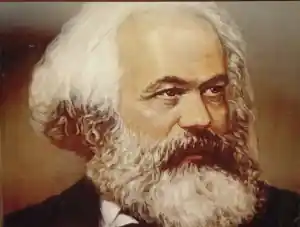 Buonasera a tutti. Grazie al prof. Azzarà per aver organizzato questo evento e a tutti i colleghi che si sono resi disponibili per venire a discuterne. Estendo i ringraziamenti ai presenti per la loro partecipazione.
Buonasera a tutti. Grazie al prof. Azzarà per aver organizzato questo evento e a tutti i colleghi che si sono resi disponibili per venire a discuterne. Estendo i ringraziamenti ai presenti per la loro partecipazione.
Iniziamo dal feticcio: il libro è editorialmente bellissimo, arricchito da stampe di dipinti otto-novecenteschi sulla storia del lavoro. Una prima nota da mettere in evidenza è che il volume è uscito nei Millenni di Einaudi, vale a dire un classico che resiste al tempo e che dura nei secoli. Qualcuno potrebbe interpretarla come una sorta di imbalsamazione, il bel monumento… ai caduti. Invece, almeno per i contatti che ho avuto io con la casa editrice, mi è parso che ci fosse l’idea di un contenuto politico, di politica culturale. Come se ci fosse una sorta di malessere anche all’interno della cultura ufficiale “borghese” nei confronti delle teorie predominanti. Probabilmente anche una borghesia diciamo moderatamente progressista e di vedute più ampie si rende conto che certi paradigmi mainstream, ahimè spiegano sempre meno e che quindi una strumentazione che parta da un paradigma diverso, anche senza volerlo abbracciare ovviamente in toto, può essere presa in considerazione; forse certe categorie non sono da buttar via. C’era anche una dimensione culturale, di politica culturale, per dare degli spunti contenutistici anche a un possibile movimento progressista in senso lato.
Veniamo più concretamente all’edizione. Innanzitutto è una ritraduzione completa, non solo mia; diamo onore ai miei collaboratori che sono Stefano Breda, Gabriele Schimmenti e Giovanni Sgro’. Abbiamo diviso in quattro eque parti e poi chiaramente è stato rimesso insieme, omogeneizzato dal sottoscritto.
Perché una nuova edizione, esistendone già diverse, sia storiche che più recenti. Le più diffuse sono l’edizione Cantimori e l’edizione Maffi. C’è anche l’edizione Sbardella della Newton. Le edizioni Cantimori e Maffi in particolare sono buone. Quindi: perché farne una nuova? Principalmente per la MEGA, cioè la nuova, la Marx-Engels-Gesamtausgabe, la nuova edizione storico-critica delle opere di Marx ed Engels.
In essa ora, sintetizzo per non stare ad annoiarvi troppo, Il capitale da tre volumi è passato a quindici se si includono i manoscritti che lo precedono e quelli successivi, su cui Engels poi ha curato l’edizione a stampa del secondo e del terzo. Uno dei manoscritti precedenti sono i famosi Grundrisse, ma in realtà di “Grundrisse” ce ne sono tre, tre corposi manoscritti in cui Marx ha riscritto più o meno tutto. Oltre a questi manoscritti hanno pubblicato anche le edizioni storiche, incluse le diverse edizioni che Marx ed Engels hanno pubblicato in vita del primo libro, l’unico che Marx ha effettivamente dato alle stampe. La prima volta nel 1867; una seconda edizione tedesca esce tra il 1872 e il 1873; l’edizione francese del 1872-75, tutte approvate da Marx. E poi ci sono due ulteriori edizioni tedesche, del 1883, e del 1890, curate da Engels e un’edizione inglese, anch’essa curata da Engels del 1887. Tra queste edizioni ci sono moltissime varianti.
Nella seconda edizione tedesca rispetto alla prima ci sono numerose varianti, viene addirittura cambiata l’intelaiatura del libro: da capitoli si passa a sezioni, ne vengono create di nuove, suddivisi i capitoli, ecc. Ha ripensato la struttura. Questo processo continua con l’edizione francese, tant’è che Marx stesso all’inizio del libro dice che è migliorativa rispetto alla seconda tedesca, al punto che anche il lettore tedesco doveva rifarsi a essa. Anche qui confrontando le varianti si capisce di che sta parlando: per esempio, sviluppa la parte sull’accumulazione in maniera sostanziale introducendo nuove categorie come composizione organica, distingue tra concentrazione e centralizzazione, ecc. Mette in due sezioni separate l’accumulazione cosiddetta originaria e quella propriamente capitalistica. Introduce il concetto di lavoratore complessivo, o collettivo anche come viene tradotto a volte, che per esempio è centrale anche in Gramsci. È insomma un’edizione che aggiunge molto. Marx non ha curato una terza edizione tedesca, che avrebbe rielaborato alla luce di quella francese, e questo ha creato tutta una serie di questioni editoriali che tuttora sono al centro della discussione. È per esempio uscita recentemente un’edizione inglese per Princeton University che adotta criteri diversi da quelli che abbiamo adottato noi. Perché? Cerco di spiegare il contesto. Qual è l’ultima versione che ha pubblicato Marx? La questione è che non c’è! Paradossalmente un libro che ha pubblicato tre volte in vita e che ha curato personalmente non ha una versione di ultima mano. Cronologicamente sarebbe la francese; ci sono delle migliorie, quindi perché non partire da quella? Perché non è una traduzione in senso moderno. Giusto per farvi l’esempio più clamoroso: non c’è “valorizzazione”. Non solo non c’è il termine valorizzazione, non c’è una traduzione coerente utilizzando coerentemente la stessa parola in tutto il volume. Chi ha un minimo di familiarità con la teoria del capitale sa che essa ne è proprio il cuore. Poi, per esempio, passi complessi vengono semplicemente omessi, mancano a volte righi interi. Soprattutto quello che viene meno è il lessico filosofico marxiano. La terminologia utilizzata in maniera massiccia da Marx nel tedesco, che ha insomma l’eredità storica della filosofia classica tedesca di Hegel e non solo, viene un po’ “annacquata”, appiattita. Ci sono motivi oggettivi insomma e anche molti studiosi francesi del dopoguerra hanno sollevato la questione concludendo che non si poteva considerarla una traduzione soddisfacente. In verità anche lo stesso Marx quando ha redatto dei progetti per la terza edizione tedesca non ha detto pubblichiamo la francese, ha indicato la seconda edizione tedesca e di modificare questo, quell’altro passaggio dalla francese; ci sono tre indici in cui lui dà delle indicazioni sui passaggi da sostituire. Poi ci sono le copie personali di Marx in cui pure aveva evidenziato dei passaggi. Nella terza edizione tedesca Engels, seguendo queste indicazioni, ha modificato il testo. Ora qual è il problema? È che non l’ha fatto completamente. Nella quarta edizione tedesca continua ad aggiungere altre cose che non aveva inserito nella terza, però di nuovo non lo fa completamente. Una delle cose che non ha fatto, ad esempio, è cambiare la struttura secondo cui Marx aveva risuddiviso l’edizione francese. La conseguenza è stata che chi studia Marx dal tedesco o dalle edizioni tradotte dal tedesco ha un indice; i francesi invece, siccome Marx aveva parlato bene dell’edizione di Roy, l’hanno riprodotta a oltranza con un indice diverso dalla tedesca. L’edizione inglese curata da Engels nel 1887 utilizza la struttura della francese, quindi l’edizione inglese ha l’indice della francese. Invece nella III e IV tedesca Engels ha mantenuto quello della seconda edizione. Insomma: francese e inglese hanno un indice diverso dalla tedesca e da chi ha tradotto da essa e quindi l’assurdo è che ai convegni citando ad es. il capitolo 17 non è detto che ci si riferisca allo stesso testo; bisogna chiarirsi su quale sia l’edizione di riferimento.
La nuova edizione Princeton, ma anche in passato quella messicana di Scaron che è una buona edizione, è basata sulla seconda edizione tedesca e rispetto a essa fornisce le varianti delle altre. Qual è il motivo di questa decisione? C’è una velata ideologia anti-engelsiana: dovendo scartare l’edizione francese per la traduzione, per averne una marxiana senza intervento engelsiano bisognava prendere la seconda tedesca. Quest’ultima edizione inglese per Princeton segue questo criterio. Si possono portare delle argomentazioni a favore di questa scelta, complessivamente ritengo però che sia sbagliata. Perché? Semplicemente perché abbiamo come varianti e non nel testo principale parti di testo che Marx non solo ha progettato, ma pubblicato nell’edizione francese come miglioramenti. Esse sono migliorative rispetto alla seconda edizione tedesca, ma il lettore che ha la seconda edizione tedesca se le trova come varianti e non nel testo principale.
I contenuti che un lettore trova nel testo pensa che costituiscano il pensiero più maturo dell’autore, non qualcosa di superato da miglioramenti successivi. Non è detto che il lettore generico vada a leggersi le varianti tanto meno che capisca che in esse si trovi il testo più maturo. Leggendo la seconda edizione tedesca non troviamo per es. la composizione organica. È una cosa incredibile. Diversi concetti fondamentali non li troverebbe solo perché sono stati inseriti nell’edizione francese. Partendo dalla seconda edizione tedesca li si colloca nelle varianti, quindi secondo me è una scelta scorretta nei confronti del lettore, perché il lettore, a meno che non sia un esperto, potrebbe non capire che nel testo principale trova delle categorie superate. Nella III e nella IV edizione c’è invece l’intervento di Engels. La soluzione perfetta non c’è a meno che non si faccia come nell’edizione critica in cui si pubblicano tutte le edizioni, operazione impensabile in traduzione.
Si trattava dunque di trovare una soluzione “diplomatica”, nella consapevolezza che quella perfetta non esiste. L’obiettivo era fornire una traduzione che rendesse il miglior Marx possibile e questo la seconda edizione tedesca non lo fa, perché appunto il testo più avanzato si trova nelle varianti. Per questa ragione abbiamo deciso di prendere come punto di riferimento la quarta edizione tedesca, cioè l’ultima curata da Engels dove più o meno è stato inserito quasi tutto, e rispetto ad essa abbiamo dato le principali varianti di tutte le edizioni precedenti: tre edizioni tedesche e l’edizione francese. Chiaramente, nell’introduzione si spiega quello che ho spiegato a voi, cioè che si tratta di una soluzione diplomatica e che il testo include l’intervento editoriale di Engels. Chi volesse leggere la seconda edizione tedesca, trova il testo nelle varianti.
Le varianti sono molte, da p. 790 fino a p. 1214. Oltre alle varianti in senso stretto, il testo include anche due manoscritti, uno ben noto, il cosiddetto Sesto capitolo inedito, che è stato ritradotto completamente seguendo gli stessi criteri di traduzione, e poi un manoscritto inedito, pubblicato per la prima volta nell’edizione critica, scritto da Marx tra il dicembre del 1871 gennaio del 1872, proprio nel corso della progettazione della seconda edizione tedesca, il primo capitolo in particolare, riscritto quasi completamente. Giusto per dare un’idea, nel primo capitolo del 1867 non c’è il paragrafo sul feticismo della merce, non uno a caso, uno dei capitoli più discussi nelle interpretazioni di Marx. In questo Manoscritto 1871-72 si vede letteralmente proprio la creazione del capitolo, come aggiunga dei paragrafi nuovi, poi inserisca il pezzo che nella prima edizione era a pagina x, ecc.; si vede proprio la costruzione. Anche per esempio per la forma di valore, che è uno dei temi più discussi nell’interpretazione, sempre in questo manoscritto c’è un ripensamento molto importante che getta luce anche su come leggere l’intera sezione. C’è una “divagazione” di 3-4 pagine in cui Marx riconsidera un po’ tutta la struttura della merce, della forma di valore eccetera e secondo me chiarisce in maniera netta come la pensa. Questi manoscritti sono inclusi in questo volume.
Il testo di riferimento è dunque la quarta edizione tedesca del primo libro del 1890 e include tutti i testi sopravvissuti che Marx ha vergato con l’intenzione di scrivere il primo libro, dunque a partire dal 1863 in poi, perché il progetto del capitale in tre libri viene sostanzialmente realizzato per la prima volta nel 1863-65. Prima il progetto si chiamava Per la critica dell’economia politica; adesso invece diventa sottotitolo. L’intenzione viene espressa nella famosa lettera a Kugelmann del dicembre del 1862. Nel manoscritto 1863-65 c’era una prima versione del primo libro del capitale, che però è andata perduta, a eccezione del cosiddetto sesto capitolo inedito.
Tutti questi testi sono stati tradotti con gli stessi criteri; questo è un grosso vantaggio dell’edizione. Alcuni di essi erano disponibili, però chiaramente non era la stessa traduzione di Cantimori, né di Maffi, quindi un confronto tra varianti era difficile da fare per uno che non potesse andarsi a vedere il tedesco, perché chiaramente ogni traduttore aveva adottato criteri diversi. Il vantaggio di questa edizione è che queste varianti sono confrontabili veramente come varianti perché noi abbiamo tradotto in maniera coerente attraverso tutto il testo.
L’idea fondamentale è di fornire uno strumento di lettura o ricerca a chi volesse di nuovo cimentarsi con Il capitale aggiornato allo stato attuale delle pubblicazioni scientifiche, uno strumento più efficace rispetto a quelli pur disponibili in commercio.
Le varianti, che si trovano in appendice, sono facilmente individuabili nel testo grazie a un sistema di note che le rende immediatamente visibili. Ci sono le note curatoriali per le quali ci siamo avvalsi del lavoro già fatto da altri in passato ma approfondendolo nei casi in cui ci sembrava necessario; rispetto alle vecchie edizioni soprattutto si sono messi in evidenza tutti i vari passaggi, tutte le varie citazioni implicite che Marx fa. Ci sono quelle esplicite a Dante, Shakespeare, Schiller, ecc. ma tante volte invece sono tacite e possono sfuggire anche al lettore colto. Colti come erano nell’Ottocento purtroppo noi non siamo più, quindi molti lettori, me incluso, hanno bisogno di andare a vedere di che sta parlando e quindi abbiamo cercato di aumentare questo apparato in particolare per esempio per i tantissimi passi biblici, ecc. e riferimenti a concetti come transustanziazione, parusia, ecc. Poi chiaramente i riferimenti ai classici, per esempio la famosa definizione della merce come oggetto sensibilmente-soprasensibile, sensorialmente-sovrasensoriale è una citazione dal Faust di Goethe.
Ultimo aspetto, ma non certo per importanza, è la traduzione. Quelle esistenti sono buone, sia Maffi che Cantimori. Noi abbiamo però cercato di affrontare alcuni problemi che secondo noi potevano essere trattati in maniera ancora più approfondita. Tutta una serie di termini, per esempio, hanno più lemmi in tedesco che in italiano, quindi l’italiano implicava possibili sovrapposizioni, l’utilizzazione di uno stesso termine per più termini tedeschi. In certi casi questo faceva proprio capir male quello che voleva dire il testo. Un buon esempio è “rappresentare”, soprattutto nei primi capitoli, una parola che c’è ogni due righe, continuamente. Nelle edizioni disponibili con rappresentare si traducono ben tre verbi tedeschi che al lettore italiano risultano indistinguibili: darstellen, vorstellen e repräsentieren, che nella logica dell’argomentazione marxiana sono molto significativi e chiaramente sono eco hegeliane. Darstellen si riferisce proprio alla Darstellungsweise, cioè il modo di esposizione o di presentazione di cui Marx parla nella postfazione alla seconda edizione tedesca, cioè quello che riprende il metodo hegeliano. Esso esprime l’articolazione categoriale dei concetti nella loro intrinseca logica: Marx mostra come dal concetto di merce necessariamente si passa al concetto di merci; come dal concetto di merci si passa al concetto di denaro, ecc., cioè secondo Marx c’è un’intrinseca logica, una necessità concettuale in queste categorie che porta all’articolazione della teoria. Invece la Vorstellung è la rappresentazione non nel senso dell’esposizione scientifica, ma dell’idea che i soggetti alla superficie della società si fanno del processo, quindi sostanzialmente l’ideologia. Semplificando all’estremo, è la distinzione tra scienza e ideologia. Tradurre quindi con la stessa parola non permette al lettore di percepire questa distinzione. Repräsentieren, o anche vertreten, vuol dire rappresentare nel senso di essere rappresentante, di stare lì per qualcos’altro. Non c’è spesso. C’è la famosa nota 101 in cui ci sono tutti e tre contemporaneamente e nelle vecchie edizioni era tutto reso con rappresentare, era dunque veramente difficile capire.
Anche il lettore che non si pone questi problemi assorbe il testo attraverso il lessico utilizzato. Avere una traduzione più precisa da questo punto di vista permette un’assimilazione inconsapevole migliore anche da parte del lettore “normale”, che non si occupa di questioni specialistiche.
Un altro caso sempre molto difficile è Ding e Sache; tutte e due vogliono dire cosa. Anche qui il problema è che in italiano c’è una parola per due tedesche. Siccome era impossibile trovare due parole diverse, abbiamo usato sempre cosa, ma quando c’è Sache tra parentesi quadre aggiungendo il tedesco di modo che anche qui il lettore possa capire che si tratta di due termini diversi. In Hegel sono due categorie nettamente diverse. In Marx la distinzione non è così precisa, però ci sono alcuni passaggi in cui invece secondo me richiama i concetti hegeliani e quindi sembrava opportuno rendere la differenza. Un ulteriore problema sono le forme aggettivali e avverbiali sachlich e dinglich, che sarebbero cosale o “cosalmente”, resa che ovviamente in italiano suona abbastanza strana, mentre in tedesco sono termini comuni. Qui abbiamo trovato delle piccole perifrasi come in forma di cosa, come cosa, anche qui con il tedesco tra parentesi. Nelle vecchie traduzioni spesso si perdeva il riferimento alla cosa. Soprattutto nel primo capitolo, dove c’è la teoria della reificazione, il riferimento alla parola cosa è cruciale perché è proprio lì che si produce questo processo di cosificazione/reificazione.
Per trasparenza, all’inizio del libro c’è tutta una nota del traduttore, in cui si spiegano tutte queste cose. Vi si dice per i termini più significativi quali sono state le scelte fatte e perché, di modo che anche se un lettore dissentisse con la traduzione, comunque sa che parola è stata tradotta. È stata un’operazione di trasparenza. Il lettore può pur dissentendo capire qual è il termine originariamente usato.
Vediamo due ultimi esempi. La distinzione Erscheinung/Schein, che spesso vengono tradotti con apparenza. C’è invece un’importante differenza perché l’Erscheinung è il fenomeno kantiano e hegeliano, il funzionamento delle leggi essenziali a livello della superficie, è quindi importante quanto l’essenza, è coessenziale. L’essenza si deve manifestare, apparire, quindi non è che è falsa. Invece Schein è confondere l’Erscheinung con il Wesen, cioè prendere la manifestazione fenomenica per l’essenza stessa. Il termine apparenza sembrava dunque ambiguo, si prestava un po’ a confondere le cose. Abbiamo dunque eliminato apparenza che ci sembrava un termine potenzialmente indeterminato e abbiamo usato manifestazione per Erscheinung e parvenza per Schein, di modo che sia più trasparente la differenza.
Ultima cosa la più spinosa: come tradurre Arbeiter. Significa sia lavoratore che operaio. Qui il problema era l’opposto di Sache e Ding; li avevamo più parole in tedesco e una parola in italiano, qui invece abbiamo una parola in tedesco e più parole in italiano. Questo poneva una grossa questione perché capite bene che tradurre con lavoratore od operaio cambia molto, anche perché la Arbeiterklasse è la classe operaia o la classe dei lavoratori? In tedesco è sempre Arbeiter. Il punto è questo, cioè che sia un operaio di fabbrica sia un servo della gleba, sia uno schiavo che lavora è un Arbeiter, perché il termine significa letteralmente colui che lavora. Dal verbo arbeiten con l’aggiunta del suffisso -er si ottiene il soggetto che compie l’azione del verbo, come la derivazione in italiano, da lavorare + -tore → lavoratore; è lo stesso meccanismo di generazione del sostantivo dal verbo. Come tradurre allora in italiano? Chiaramente in certi casi non è difficile: se si sta parlando di un individuo che lavora all’interno del sistema di macchine evidentemente è un operaio. Se invece si sta parlando di un servo della gleba che fa la corvée nel terreno del signore, evidentemente non può essere un operaio, quindi si va con il generico lavoratore. Oppure quando si tratta del processo lavorativo in astratto, chi è lì il soggetto che lavora? Be’, essendo in astratto, la dimensione storica è momentaneamente sospesa, quindi si sta considerando il lavorare in generale e quindi tradurre con un operaio sarebbe fuorviante, perché non sarebbe un concetto universale, ma particolarizzato. In tutti questi casi non era un problema gigantesco. Il problema dove sorge? In tutti i casi in cui Marx sviluppa non tanto delle descrizioni ma delle leggi di funzionamento. Per esempio la creazione dell’esercito industriale di riserva non funziona solo per l’operaio ma con tutte le dinamiche di sostituzione per automazione, di qualunque tipo di lavoro meccanizzabile, perché ora non è più solamente il tornio, ma raggiunge anche i livelli della lezione universitaria. Quindi questo processo non riguarda solo l’operaio, ma indica delle leggi di trasformazione del modo di lavorare. Se lì Marx dice Arbeiter, intende l’operaio o la trasformazione del lavorare più in generale? Intende tutti e due contemporaneamente e per lui non fa problema perché Arbeiter vuol dire tutte e due le cose. Nella traduzione, però, se in questo caso in cui si sviluppano proprio delle leggi specifiche per esempio, anche il calcolo del saggio del plusvalore non dipende dalla presenza dell’operaio – Marx usa l’esempio di un operaio, faccio bene a tradurre con questa parola? Sì, non sto sbagliando perché effettivamente sto parlando di operai, però secondo me in parte sto sbagliando perché cancello la dimensione generale, cioè quella per cui quella trasformazione riguarda la modalità di lavorare nel modo di produzione capitalistico che è più larga della modalità dell’operaio in fabbrica. In questi casi, secondo noi lavoratore era la soluzione migliore, perché si rende anche la dimensione generale senza cancellare quella particolare: anche quell’operaio è un lavoratore. Anche questi criteri vengono spiegati nella nota del traduttore e di nuovo, pur dissentendo con questa nostra interpretazione, il lettore può comunque sapere che c’è scritto Arbeiter.
Concludendo, qual è il senso dell’operazione nel suo complesso? È fornire a chi vuole leggere Il capitale uno strumento aggiornato di studio sia da un punto di vista di fattualità testuale molto più ricca, ci sono molti più testi sia a livello di traduzione più particolareggiata, in quanto permette meglio delle precedenti di cogliere le sfumature di tanti termini che, almeno in questi casi particolari, erano scomparse.