Post-industriale e iper-industriale. Note su un dibattito nei decenni smarriti
di Romano Alquati
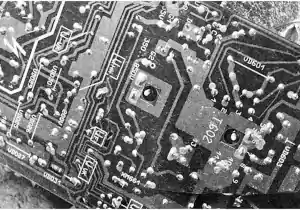 Apriamo l’esplorazione della rubrica Transuenze dedicata al lavoro nei «decenni smarriti» (cfr. https://www.machina-deriveapprodi.com/post/il-lavoro-nei-decenni-smarriti-una-bozza-di-programma) proponendo un contributo controcorrente di Romano Alquati sulla prima delle categorie sottoposte ad approfondimento, post-industriale. Nei decenni del «post», gli anni ’80 e ’90 del secolo scorso, il senso comune, ma anche la gran parte degli scienziati sociali e ancor più degli opinionisti, convergeva nel ritenere superati i tratti fondativi della società industriale, il cui sottostante più appariscente era il significativo spostamento dell’occupazione dal settore manifatturiero (da allora in costante ridimensionamento) alle attività di servizi variamente intesi (il «terziario»).
Apriamo l’esplorazione della rubrica Transuenze dedicata al lavoro nei «decenni smarriti» (cfr. https://www.machina-deriveapprodi.com/post/il-lavoro-nei-decenni-smarriti-una-bozza-di-programma) proponendo un contributo controcorrente di Romano Alquati sulla prima delle categorie sottoposte ad approfondimento, post-industriale. Nei decenni del «post», gli anni ’80 e ’90 del secolo scorso, il senso comune, ma anche la gran parte degli scienziati sociali e ancor più degli opinionisti, convergeva nel ritenere superati i tratti fondativi della società industriale, il cui sottostante più appariscente era il significativo spostamento dell’occupazione dal settore manifatturiero (da allora in costante ridimensionamento) alle attività di servizi variamente intesi (il «terziario»).
Su questo tema, in specifico, pubblichiamo alcuni frammenti tratti da due testi fuori catalogo o inediti di Romano Alquati, sociologo e militante già ampiamente utilizzato in queste pagine, da non richiedere ulteriori presentazioni (per eventuali approfondimenti introduttivi alla sua figura e al suo pensiero, si rinvia allo «scavi» curato da Maurizio Pentenero e Luca Perrone su questa rivista, https://www.machina-deriveapprodi.com/post/la-riproduzione-del-futuro, o ancora al volume collettivo «Un cane in chiesa», curato da Francesco Bedani e Francesca Ioannilli per Deriveapprodi).
La ricostruzione della carriera del concetto di «società post-industriale» condurrebbe questa introduzione lontano dai suoi circoscritti obiettivi di presentazione del contributo. Per quanto il primo utilizzo del termine sia comunemente attribuito a David Riesman nel 1958, gli autori cui si ricollegano le successive elaborazioni furono, da una parte, Alain Touraine (La société post-industrielle, 1969), dall’altra Daniel Bell (The coming of post-industrial society, 1973).
Autori diversi e con obiettivi conoscitivi e implicazioni socio-politiche differenti. Il testo di Bell, coerente con il suo itinerario, muoveva da una matrice orientata al pluralismo liberale e polemica verso le coeve rappresentazioni del potere delle élite (anzitutto, Wright Mills). L’ascesa della società postindustriale era anzitutto un tentativo di previsione degli scenari aperti dalla transizione da un’economia basata sul capitalismo organizzato delle big firm e delle macchine ad una basata sulla conoscenza e sulle nuove tecnologie dell’informazione. Il postindustriale era un costrutto analitico (un «tipo ideale») fondato sul passaggio all’economia dei servizi, sul predominio dei ceti professionali e tecnici, sul ruolo centrale delle tecnologie intelligenti, sull’affermarsi di mentalità e criteri valutativi orientati alla meritocrazia. Bell non descriveva un mondo ideale, beninteso, né mancava di porre in luce i possibili effetti negativi di un mondo basato sulla crescente autorità delle comunità scientifiche e sull’arbitraggio sociale operato dalle Università. Certamente, il suo sforzo predittivo influenzò e si fuse con successive o contemporanee analisi incentrate sulla teoria del capitale umano (Becker) e sull’età dell’informazione (Castells). Nella sua trattazione Alquati respinge decisamente le premesse e gli argomenti propri di questo filone, a cui semmai attribuisce rilevanza in quanto «ideologia» del nuovo capitalismo. Per contro, pur non condividendone il dominio semantico, Alquati individua più terreni ci confronto con il pensiero di Touraine, fino al punto di considerare «nominalistiche» più che sostanziali numerose apparenti differenze del suo modello rispetto a quello pubblicato dal sociologo francese del 1969, che certamente risentiva, in qualche misura, del clima del Maggio ’68 e della rivolta studentesca di quegli anni. L’analisi di Touraine era esplicitamente rivolta non tanto «al funzionamento del sistema sociale, ma la formazione dell’azione storica, il modo cioè in cui gli uomini fanno la storia». Da qui la centralità metodologica attribuita agli orientamenti sociali e culturali in trasformazione della società, nonché alla natura dei conflitti e al potere attraverso cui prendono forma. Touraine osservava il formarsi «sotto i nostri occhi [...] di società di tipo nuovo», che si sarebbero potute definire post-industriali, ma anche «tecnocratiche» o (focalizzando lo sguardo sul sistema produttivo) «programmate», termine che gli appariva addirittura più utile, a partire dalla natura dei conflitti e dalla composizione delle classi dominanti e dominate delle nuove società industriali.
Negli anni Ottanta Romano Alquati propose, pubblicandolo nella forma di Dispense del corso di Sociologia Industriale che teneva all’Università di Torino, un modello di società complessiva (che definiva «Modellone») stratificata per «livelli di realtà», strati interdipendenti volte a rappresentare l’articolazione gerarchica e verticale della società capitalistica. Si ipotizzava in queste pagine un passaggio del capitalismo ad una fase neo-moderna,caratterizzata dalla estensione dell’organizzazione industriale dalla fabbrica all’intera società e dal primato della dimensione psichica/mentale del lavoro (ciò che in breve definiva sub-maniera iper-industriale, in antitesi rispetto al senso comune dell’epoca, egemonizzato appunto dalla retorica del post-industriale). É utile sottolineare che in questa postura non erano affatto sminuite le rotture e le trasformazioni rispetto alla società industriale del ‘900, che Alquati definiva fase classica dell’Industria. Tali differenze erano tuttavia interpretate in modo originale, scavando in profondità sugli aspetti nuovi o emergenti (soprattutto a livello soggettivo e politico), quanto sul gioco tra continuità e rinnovamento dell’organizzazione industriale. Proponiamo ai lettori di Machina due frammenti, assemblati e rieditati dai curatori della rubrica dedicati proprio a questi temi. Il primo era contenuto nelle Dispense del corso di Sociologia Industriale del 1989, testo mai più ripubblicato. Il secondo nell’ultima versione delle stesse Dispense consegnataci dall’autore con il titolo Nella società industriale d’oggi, del 2000, e finora mai pubblicate. In questi scritti, la cui lettura (come sempre accade con i testi di questo autore) richiede attenzione e una certa consuetudine con le sue categorie (che i redattori hanno cercato di agevolare con alcune note a piè pagina), Alquati pone in luce soprattutto le continuità del metodo e della maniera industriale applicati a nuovi campi di valorizzazione capitalistica (i servizi, la riproduzione, i consumi), non rinunciando a porsi ipoteticamente interrogativi sulla appropriabilità delle risorse dell’industrialità per scopi non capitalistici.
Queste tesi, in parte per la relativa marginalità dei canali di diffusione e del posizionamento di Alquati all’interno delle stessa accademia, in parte poiché quasi estranee sia al senso comune (anche a quello dei «movimenti») sia a quello della sinistra più conservatrice (che tendeva a liquidare il dibattito come mera ideologia, rimanendo nell’alveo di una visione tutta «manifatturiera» e «muscolare», invero allora ampiamente declinante – almeno in Occidente – dell’industrialità), non esercitarono alcuna influenza all’epoca della loro pubblicazione, se non su ristrette cerchie di follower. Come è stato osservato dalle pubblicazioni recentemente dedicate al pensiero di questo autore, i suoi argomenti disegnavano tuttavia un orizzonte ben più ampio di molte coeve e ingenue rappresentazioni della società postindustriale, fornendo strumenti utili anche per decodificare fenomeni sociali ben più recenti (dal «capitalismo delle piattaforme» a Industry 4.0, per citare due categorie dei nostri anni).
* * * *
[...] L'Industria forse è nata nelle piantagioni o in certi segmenti della circolazione, poi però, storicamente, lo sviluppo più massiccio e vistoso del «Modo industriale» è stato realizzato nel Secondario, in passato considerato, appunto, «industriale» per antonomasia. Nella fase Classica dell'epoca capitalistica l'industrializzazione e il «Modo industriale» sono rimasti abbastanza a lungo limitati alla «fabbrica», sia nel significato peculiare di luogo funzionale della produzione «specifica» del Capitale che do a questa parola chiave in questo modello,[1] sia in quello del senso comune. Per quanto concerne la Forma di tale «Modo», il settore strategico era il metalmeccanico, per varie ragioni; fra le quali l'ancora alta intensità di lavoro nell'elevata complessità dei suoi beni, intermedi e finali, che hanno cambiato le condizioni di lavoro di tutti gli altri settori e la vita di tutti e in cui erano concentrate, articolate e combinate masse enormi di operai e lavoratori di diverso profilo, provenienza e capacità, socializzati nella cooperazione, nel conflitto e nella lotta. Qui in periodi diversi e successivi si è mossa l'avanguardia storica della lotta di classe operaia, in modi anche molto politicizzati. [In precedenza ndr] Ho schematicamente considerato la razionalizzazione e organizzazione scientifica della fabbricazione di massa nelle aziende metalmeccaniche, e il rapporto fra scienza, tecnologia e macchinario nella meccanizzazione spinta ad alti livelli di automatismo, come condizione lavorativa e base di lotta («per se stessi», come era corretto dire...) per milioni di lavoratori in situazione proletaria. É stato comunque nel Centro di ieri, nella fabbricazione di beni tangibili, che, dispiegandosi e affinandosi, si è palesato agli occhi o nell'esperienza dei più il «Modo industriale»; e da lì ieri è stata lanciata la stagione classica delle lotte di classe. Adesso le cose cambiano abbastanza, e in vari sensi. [...] la neo-fabbrichizzazione oggi si è estesa molto, in tutti i settori, anche in quelli di produzione di servizi, di merci intangibili, psichiche e intellettuali, divorandosi una parte del suo vecchio contesto e incorporandosela, e riducendo il mondo esterno ... [...] La fabbrichizzazione è stata spesso anticipata dall'(iper)Industrializzazione di molte attività, e una volta fabbrichizzate e quindi diventate luoghi di produzione di Sovrappiù, [dunque ndr] imprese, molte aziende sono state industrializzate e iper-industrializzate, diventando «Fabbriche effettive»[2].
Ciò è avvenuto anche grazie alla crescita di domanda, alla standardizzazione di prodotti vecchi e nuovi, a nuove tecnologie, all’informatica, al rivoluzionamento delle comunicazioni che ha superato la spazialità, a nuove risorse dell'organizzazione scientifica, allo sviluppo della conoscenza scientifica applicabile, eccetera; e poi anche a cambiamenti nella cultura, nel costume, nella concezione e nelle condizioni della vita, nel reddito, ecc.; cambiamenti spinti e acquisiti anche dalle precedenti lotte della classe operaia e dai movimenti sociali che le avevano affiancate e seguite. La Neo-fabbrica, intesa sempre come luogo funzionale della Produzione di Capitale, si è diffusa nel Terziario (e Quaternario), in quanto contenitore dell'Azienda, di processi attivi utili, particolarmente significativi, ed è diventata sede di lavoro prevalentemente psichico e intellettuale (anche per la standardizzazione che le alte scale hanno consentito ovunque). Uscendo dal Secondario, la Meta-fabbrica si è portata appresso il «Modo industriale» ulteriormente affinato e dispiegato, nella sua nuova maniera che chiamo «iper-industriale», secondo le caratteristiche tecnologiche e tecniche di settori che fabbricano prevalentemente beni intangibili come merci, analogamente al grande comparto Terziario.
[...] come sappiamo, questo «Modo» di lavoro e di attività è uscito e straripato oltre la produzione specifica del Capitale, separandosi ormai dalla stessa impresa, trasformando e industrializzando il contesto di quest'ultima, invadendo anche il sistema Esterno[3], sussumendo quindi attività di produttività molto indiretta, attività riproduttive, improduttive e financo distruttive; e in esse si richiede risparmio di capitale, di lavoro e di attività prima ancora della loro sussunzione diretta al Capitale stesso. Però, al contempo, intrecciato con questi cambiamenti e oltre essi, il mutamento soggettivo, di costume e di maniera di vivere (ben oltre il consumismo precedente) ha dislocato la conflittualità, uscita a sua volta dagli stabilimenti.
Iper-industriale. Dunque, questo affinarsi e dispiegarsi del Modo industriale uscito dalla produzione dei manufatti che pure si estende molto a sua volta, andando oltre la fabbricazione dei beni tangibili, mi induce a respingere la denominazione «post-industriale» che molti oggi danno al lavoro, alla società e al periodo attuale, e mi suggerisce piuttosto di chiamare «Iper-industriale» questa che considero una nuova fase e una nuova determinazione del «Modo industriale» stesso. Dirò che l'iper-industriale è un sub-modo, e così qualche volta lo chiamerò. Non è (infatti ndr) solo questione di nomi. Nell'Iper-industriale si accentuano, si approfondiscono, divengono più evidenti, visibili, e talora anche vistose, e si diffondono ovunque, le caratteristiche del «Modo industriale» che già si erano venute manifestando nella fase precedente, Classica, che ho accennato dianzi (da qualcuno distinta nei tre periodi della manifattura, grande industria e grande impresa «fordista»), malgrado si siano verificate importanti novità nei suoi dintorni. Dunque assumo come Iper-industriale il «Modo industriale» di lavorare e di agire proprio della Fase neo-moderna dell'Epoca capitalistica. Nell'ipoteticità di tutto quanto ho detto finora, pongo quindi l’ipotesi che oggi noi non assistiamo all'avvento del «post-industriale» ma a un nuovo determinarsi dell'industriale. Quindi respingo l'affermazione sensazionalistica secondo la quale oggi il modo di lavorare e di agire è radicalmente cambiato rispetto a quello della fase industriale classica.
[...] La cosiddetta società postindustriale di cui ha parlato per primo Touraine, qualificandola fra l’altro come «società programmata», è un fenomeno macroscopico che parte però da molto lontano e non concerne tanto o solo il modo di lavorare, e comunque mi sembra consista proprio nell'estensione a tutte o quasi le Attività del sistema, nostro odierno, del «Modo di lavoro industriale». Come respingo le definizioni settoriali di Industriale altrettanto respingo le definizioni settoriali di post, neo e iper industriale, innanzitutto la definizione derivata da Daniel Bell del «post-industriale» come settore in cui prevalgono i Servizi; scarto quest'ultima proprio per la ovvia ragione che i Servizi e il Terziario si espandono (Iper)industrializzandosi! L'industria come «Modo» cresce e si affina proprio con e nella crescita del Terziario e dei Servizi. Quella del post-industriale è un'ideologia, e come tale è importante. Altrettanto si può dire del «post-moderno»: infatti affermando che la Fase attuale continua e affina quella moderna «classica» non dico che allora il «Post-moderno» non esiste; bensì che è la cultura esplicita della Neomodernità già in embrione nella Modernità classica; e il «post-modernismo» è un'ideologia importante. [...] Pertanto è sociologicamente assai reale e significativo. Altrettanto, ma diversamente, è significativa l'ideologia post-industrialista.
[testo tratto da Dispense di Sociologia Industriale, Volume III, Tomo 2, Il Segnalibro, Torino, 1989, pagg. 9-12]
[Definisco ndr] «Industria» una maniera organizzativa trasversale del lavorare in reti, pure telematiche, sia distribuite sia a forma di piramidi di comando centrale, di rapporti psichici e neo-artigianali, in cui questo lavoro cooperante è pre-scomposto e ridistribuito mediante un piano informatizzato (e digitalizzato, ecc.) che lo pre-reintegra segnicamente secondo una razionalità scientifica flessibile e rivolta al risparmio di capacità-umana-vivente, tempo e capitale, e tesa all’innovazione risparmiatrice. Quindi procede [...] per alte scale di standardizzazione, in maniera pianificata e programmata in continua rettifica (mediante controllo in tempo reale), e sboccante nello sviluppo qualitativo del macchinario intangibile, verso nuovi e più potenti sistemi uomo-macchina.
[...] Non c’è ancora all’inizio del nuovo millennio il post-industriale. Non siamo ancora giunti a dopo l’industria! Bensì, al contrario, ho già ripetuto che ritengo che nell'attuale fase adesso appena iniziata della civiltà-capitalistica si abbia «solo» un affinamento dell'industrialità stessa (che si mischia con certo neo-artigianesco): nel solco e nella traiettoria dell’industrialità classica. [...] L’idea di post-industrialità, che respingo, mi pare che oggi più che dalle nuove tecnologie e dall’impercepibilità, che pure contano molto, potrebbe essere originata e amplificata per chi ce l’ha, in base a certi settori, ad esempio da fenomeni (da approfondire) come l’importante inatteso ritorno d’artigianesco all’interno dell’iper-industrialità stessa, e così pure il ritorno non meno inaspettato, e paradossale se non scandaloso, d’altre modalità ritenute a torto proto-capitalistiche di agire-lavorare, che si sposano bene con le tecnologie odierne anche più nuove e avanzate (il lavoro formalmente autonomo, innanzi tutto, e la servitù, la schiavitù ecc.), e poi dalle reti telematiche e dalla digitalità degli algoritmi che rappresentano i processi. Ma anche da certe nuove tecnologie, delle quali le più importanti sono le biotecnologie (e le nano-tecnologie). E soprattutto dal primato dei servizi e dell’intangibile. [...] La mia ipotesi è che la caratteristica più vistosa dell'agire-umano iperindustriale sia la sua «psichicità»; ossia che questo sia diventato tanto astratto e mentale da avere perso la gran parte della sua ieri prevalente «muscolarità»; e da impegnare sempre più quasi solo la sfera affettivo/emotiva e quella cognitiva/intellettuale del lavorante. Inoltre, poiché associata a ciò, la caratteristica di sviluppare le attività invisibili, impercepibili. E quindi poi pure le biotecnologie e le nanotecnologie che hanno a che fare ancora con la tangibilità: una tangibilità pure cellulare, molecolare, atomica e subatomica: infinitesimale. Ma sempre restando nel solco dell'industrialità prima definita e affinandola.
Mentre la maniera più tipica dell’industrialità classica è stata il cosiddetto «taylorismo classico», quella più tipica dell’iper-industrialità è forse finora, e siamo solo ai suoi inizi, il cosiddetto «toyotismo», o meglio il «taylorismo-toyotista». Nel quale appunto il taylorismo come paradigma, che (ripeto, ha il suo clou nell’applicazione della scienza all’organizzazione dell’agire/lavorare) si rinnova nella sub-maniera toyotista d’agire/lavorare e nella one best way scientifica, come si stanno riproponendo oggi. Questo ricorrere indica proprio il nucleo essenziale e definitorio di questa «maniera» che si scompone, in una pluralità di sub-sub-maniere incluse, interne. La «sub-maniera toyotista» ipotizzo che si basi su una riorganizzazione, la quale fra l’altro rilancia la comunicazione (e telecomunicazione) nella cooperazione (in équipe e in tele-équipe). E si attua in un certo ri-allargamento delle mansioni che fa un poco appello ad una certa creatività, e quindi ridà un poco di discrezionalità, di complessità e autocontrollo all’attore/lavoratore-umano. Così, alzando la qualità dell’agire/lavorare, rivalorizza la formazione. La quale ridiventa pure un pochino endogena, però nella permanenza del prevalere di quella classica ed esogena-scientifica, in cui ci sono momenti importanti di pluri-standardizzazione (le quali intercombinate preparano l’avvento di un nuovo macchinario flessibile). Onde in sintesi nei suoi contenuti l’iper-industriale, come ho già ripetuto, si qualifica come il più volte suddetto ritorno di momenti artigianeschi, ma dentro un alto livello di mezzificazione e automatismo del macchinario sviluppatissimo (mediante scienza) e di mercificazione della capacità riallargata e così almeno un poco de-impoverita: sulla base di un’ulteriore scientifizzazione (a sua volta più flessibile e neo-paradigmica) soprattutto dell’organizzazione dell’agire. Dove però l’attore/lavoratore-umano (un poco più capace, almeno all’inizio, sia singolarmente sia collettivamente) rimane quanto mai subalterno ai mezzi, alla tecnologia scientifica, e anche al macchinario (scientifico per sua natura), magari più «amichevole» in specie nell’interfaccia, eppure ancora ostile, quand’anche nell’ambivalenza[4]. Nel cui sviluppo e moltiplicazione tutto sempre più sbocca. Il che, come ho già detto, implica sì anche il superamento di certi momenti del fordismo, ma al contempo un incremento di certi altri. Quindi affermo che siamo sempre nel solco del taylorismo come maniera più tipica dell’industrialità dell’agire-lavorizzato-umano e peculiare forma dell’organizzazione scientifica: taylorismo-toyotista, organizzazione scientifica toyotista del lavorare e del cooperare.
[...] In queste brevi note è già affiorata più volte la prima grande questione sulla quale sempre io m’interrogo pure qui: c’è ambivalenza nell’industria? (e nell’iper-industria?). Ho appena risposto ipoteticamente di sì. Ho detto prima che la mia ipotesi è che, magari con alcune correzioni, almeno ai livelli di realtà bassi, questa maniera potrebbe forse ricollegarsi, ricondursi, anche a fini diversi dai meta-fini del capitalismo che finora essa ha prevalentemente servito, pure secondo altri modelli, non solo di sviluppo… (perfino) contraddicendoli. E ho affermato che le condizioni perché questo avvenga siano piuttosto soggettive. Bisogna dunque guardare parecchio ai fini: industrialità e fini. Certo fino ad oggi l’iper-industrialità è stata notevolmente funzionale agli scopi capitalistici, la maniera industriale s’è sviluppata benissimo nella «fabbrica di capitale» e nel «modo capitalistico», e viceversa. Si è raramente verificata finora l’ipotesi di alcuni che la tecnologia e con questa l’industrialità in fondo siano in contrasto col capitalismo, e che il capitalista collettivo abbia preferito soluzioni in contrasto col progresso tecnico e tecnicamente regressive; anche se talvolta in condizioni d’emergenza «politica», più che economica, l’ha fatto[5]. Così crescendo dentro la fabbrica l’industrialità come noi la conosciamo ed esperiamo (pur sviluppandosi rapidamente ed evolvendo) ha subito o accettato [...] una curvatura su questi fini capitalistici che ci fa apparire molto arduo il suo raddrizzamento, per curvarla su dei fini diversi. Eppure ipotizzo non solo questo sia tuttora possibile, ma quando certi grandi e significativi movimenti di lotta sul terreno dell’industrialità ci sono stati, ai livelli bassi e poi finanche medio bassi[6], cambiamenti sottostanti significativi nell’industrialità, al suo interno, ci sono stati; e alcuni tengono tuttora. Ed io ipotizzo che potenzialità di ciò esistano ancora. Però nego subito che si tratti di rovesciare la composizione tecnica in composizione politica, la professionalità più o meno esecutiva in consapevolezza o anche coscienza politica, come fanno ad esempio i molto tardivi scopritori del General Intellect … Le condizioni di questo ipotizzo siano soprattutto soggettive. Ma c’è uno spazio qui pel «vero» riformismo. Sebbene esso raramente si sia avventurato da queste parti e oggi, se esso esiste, ancora non si fa certo vedere qui intorno: a modificare nella sua qualità, spesso negativa per noi, una maniera d’attività-lavorativa che, con la sua ambivalenza almeno potenziale, va proprio dappertutto! [...] L’industrialità finora dando soprattutto potenza al lavoro trasversale e alla capacità dei lavoranti non si è curata tanto della ricchezza della capacità umana, ma anzi l’ha piuttosto ridotta; così ha molto contribuito a che il saldo di lungo periodo nella qualità della nostra capacità e forza-attiva dal «nostro» punto di vista sia relativamente negativo. Si tratta però di capire meglio cosa significa questo «nostro»[7]; e come valutano l’andamento gli iper-proletari. Nondimeno ipotizzo: abbiamo potenziamento nell’impoverimento: nell’ipotesi ulteriore che il primo giovi più al padrone collettivo, e combattere il secondo serva più a noi. Questo per me è uno dei criteri decisivi di valutazione; ed è evidente che in questo nodo c’è moltissimo da approfondire.
[Nella società industriale d’oggi, Torino, 2000]
































Add comment