Natura, Materialismo, Socialismo. Il Marx verde di Foster
di Collettivo le Gauche
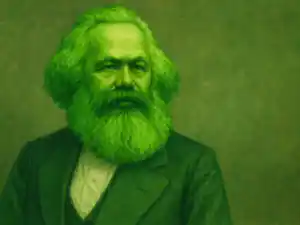 John Bellamy Foster in Marx’s Ecology: Materialism and Nature si propone di esplorare le radici del pensiero ecologico moderno attraverso un’analisi del materialismo scientifico sviluppatosi tra il XVII e il XIX secolo, con particolare attenzione alle figure di Charles Darwin e Karl Marx. Contrariamente alle interpretazioni ambientaliste contemporanee che spesso vedono il materialismo e la scienza come forze antagoniste rispetto a una presunta armonia premoderna con la natura, Foster sostiene che furono proprio il materialismo e il progresso scientifico a rendere possibile una visione ecologica della realtà. Il nucleo dell’argomentazione ruota attorno alla concezione marxiana della relazione tra uomo e natura che non è un dato immutabile ma il prodotto di un processo storico, caratterizzato da contraddizioni e alienazione. Marx, influenzato dalla filosofia materialista di Epicuro, sviluppò una critica radicale alla separazione tra l’uomo e le condizioni naturali della sua esistenza, una separazione che raggiunge la sua massima espressione nel capitalismo, dove il lavoro salariato e il dominio del capitale trasformano la natura in una mera risorsa da sfruttare. A differenza dell’idealismo hegeliano, che subordinava la materia allo sviluppo dello Spirito, Marx elaborò un materialismo dialettico che riconosceva la priorità ontologica della natura ma ne sottolineava anche la trasformazione attraverso la prassi umana. Questo approccio gli permise di superare sia il determinismo meccanicistico sia le astrazioni spiritualiste, proponendo invece una visione dinamica in cui l’uomo, pur essendo parte della natura, la modifica attraverso il lavoro e l’organizzazione sociale. Un aspetto cruciale del pensiero di Marx è la sua insistenza sul metabolismo sociale, ovvero lo scambio organico tra l’uomo e l’ambiente, che nel capitalismo viene interrotto da un rapporto di sfruttamento e degradazione. Questa intuizione, sviluppata attraverso lo studio di scienziati come Justus von Liebig (pioniere della chimica agraria) e Charles Darwin (la cui teoria evoluzionista fornì a Marx una base naturalistica per la sua critica storica), anticipa temi centrali dell’ecologia moderna, come la sostenibilità e l’interdipendenza degli ecosistemi. Nonostante ciò Marx è stato spesso accusato di prometeismo tecnologico, ovvero di aver celebrato il dominio umano sulla natura senza considerarne i limiti.
John Bellamy Foster in Marx’s Ecology: Materialism and Nature si propone di esplorare le radici del pensiero ecologico moderno attraverso un’analisi del materialismo scientifico sviluppatosi tra il XVII e il XIX secolo, con particolare attenzione alle figure di Charles Darwin e Karl Marx. Contrariamente alle interpretazioni ambientaliste contemporanee che spesso vedono il materialismo e la scienza come forze antagoniste rispetto a una presunta armonia premoderna con la natura, Foster sostiene che furono proprio il materialismo e il progresso scientifico a rendere possibile una visione ecologica della realtà. Il nucleo dell’argomentazione ruota attorno alla concezione marxiana della relazione tra uomo e natura che non è un dato immutabile ma il prodotto di un processo storico, caratterizzato da contraddizioni e alienazione. Marx, influenzato dalla filosofia materialista di Epicuro, sviluppò una critica radicale alla separazione tra l’uomo e le condizioni naturali della sua esistenza, una separazione che raggiunge la sua massima espressione nel capitalismo, dove il lavoro salariato e il dominio del capitale trasformano la natura in una mera risorsa da sfruttare. A differenza dell’idealismo hegeliano, che subordinava la materia allo sviluppo dello Spirito, Marx elaborò un materialismo dialettico che riconosceva la priorità ontologica della natura ma ne sottolineava anche la trasformazione attraverso la prassi umana. Questo approccio gli permise di superare sia il determinismo meccanicistico sia le astrazioni spiritualiste, proponendo invece una visione dinamica in cui l’uomo, pur essendo parte della natura, la modifica attraverso il lavoro e l’organizzazione sociale. Un aspetto cruciale del pensiero di Marx è la sua insistenza sul metabolismo sociale, ovvero lo scambio organico tra l’uomo e l’ambiente, che nel capitalismo viene interrotto da un rapporto di sfruttamento e degradazione. Questa intuizione, sviluppata attraverso lo studio di scienziati come Justus von Liebig (pioniere della chimica agraria) e Charles Darwin (la cui teoria evoluzionista fornì a Marx una base naturalistica per la sua critica storica), anticipa temi centrali dell’ecologia moderna, come la sostenibilità e l’interdipendenza degli ecosistemi. Nonostante ciò Marx è stato spesso accusato di prometeismo tecnologico, ovvero di aver celebrato il dominio umano sulla natura senza considerarne i limiti.



 Il seguente testo è solo una parte di un lungo saggio di Robert Kurz dal titolo Geld ohne Wert [it: “Denaro senza valore”] (Horlemann Verlag, 2012). Esso rappresenta il lascito teorico e l’ultimo contributo organico dell’autore nella direzione di un notevole tentativo (iniziato già a metà degli anni Ottanta) di ricostruire la critica dell’economia politica e di formulare una teoria radicale della crisi del capitalismo. Ci limitiamo qui a fornire alcune succinte coordinate.
Il seguente testo è solo una parte di un lungo saggio di Robert Kurz dal titolo Geld ohne Wert [it: “Denaro senza valore”] (Horlemann Verlag, 2012). Esso rappresenta il lascito teorico e l’ultimo contributo organico dell’autore nella direzione di un notevole tentativo (iniziato già a metà degli anni Ottanta) di ricostruire la critica dell’economia politica e di formulare una teoria radicale della crisi del capitalismo. Ci limitiamo qui a fornire alcune succinte coordinate.


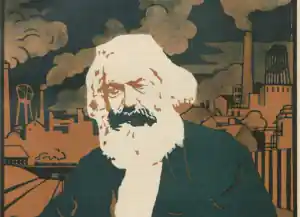 Nel 1875, Karl Marx scrisse un documento unico. Non si trattava di un trattato filosofico o di un saggio giornalistico,bensì di una critica approfondita, chirurgica, schietta e, ancora oggi, rimasta spesso trascurata. Mi riferisco alla "Critica del programma di Gotha", scritta come fosse una lettera-commento al progetto di unificazione, dei socialisti tedeschi, attorno a un programma comune. A prima vista, potrebbe sembrare quasi un episodio minore nella traiettoria del pensiero marxiano. Tuttavia, come sostiene il marxista indiano Paresh Chattopadhyay, si tratta di un vero e proprio «secondo Manifesto del Partito Comunista»: più maturo, meno pamphlet, ma non per questo meno rivoluzionario. Per comprendere la portata di questa formulazione, è necessario tornare al contesto. Nel 1875, i seguaci di Marx e i seguaci di Ferdinand Lassalle - una figura centrale dello Stato tedesco e del socialismo riformista - cercarono di fondere le loro organizzazioni nel neonato Partito Socialista Operaio di Germania (in seguito SPD, acronimo di Partito Socialdemocratico di Germania). Il programma che avrebbe sintetizzato questa fusione, era stato scritto per lo più da dei lassalliani, e recava in sé profondi segni di un socialismo statalista, legalista e conciliante. Marx, dopo aver letto il testo, rispose con la "Critica del programma di Gotha", inviato tramite una lettera a Wilhelm Bracke, ma che non venne mai pubblicato integralmente per tutto il corso della sua vita, e venne reso noto pubblicamente soltanto nel 1891. Ciò che Marx offriva in quel testo, non era solo una critica congiunturale.
Nel 1875, Karl Marx scrisse un documento unico. Non si trattava di un trattato filosofico o di un saggio giornalistico,bensì di una critica approfondita, chirurgica, schietta e, ancora oggi, rimasta spesso trascurata. Mi riferisco alla "Critica del programma di Gotha", scritta come fosse una lettera-commento al progetto di unificazione, dei socialisti tedeschi, attorno a un programma comune. A prima vista, potrebbe sembrare quasi un episodio minore nella traiettoria del pensiero marxiano. Tuttavia, come sostiene il marxista indiano Paresh Chattopadhyay, si tratta di un vero e proprio «secondo Manifesto del Partito Comunista»: più maturo, meno pamphlet, ma non per questo meno rivoluzionario. Per comprendere la portata di questa formulazione, è necessario tornare al contesto. Nel 1875, i seguaci di Marx e i seguaci di Ferdinand Lassalle - una figura centrale dello Stato tedesco e del socialismo riformista - cercarono di fondere le loro organizzazioni nel neonato Partito Socialista Operaio di Germania (in seguito SPD, acronimo di Partito Socialdemocratico di Germania). Il programma che avrebbe sintetizzato questa fusione, era stato scritto per lo più da dei lassalliani, e recava in sé profondi segni di un socialismo statalista, legalista e conciliante. Marx, dopo aver letto il testo, rispose con la "Critica del programma di Gotha", inviato tramite una lettera a Wilhelm Bracke, ma che non venne mai pubblicato integralmente per tutto il corso della sua vita, e venne reso noto pubblicamente soltanto nel 1891. Ciò che Marx offriva in quel testo, non era solo una critica congiunturale.
 «Quando una comune socialista è antimperialista?» La risposta di Chris Gilbert a questa domanda segue la linea di pensiero di Karl Marx, esaminando il suo approccio alla 'comune': dai
«Quando una comune socialista è antimperialista?» La risposta di Chris Gilbert a questa domanda segue la linea di pensiero di Karl Marx, esaminando il suo approccio alla 'comune': dai 
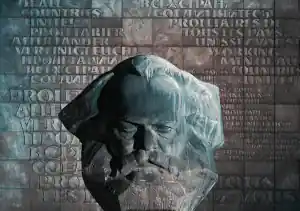 Sembrava una vittoria storica quella del “Forum serale Marxista per la politica e la cultura”, abbreviato Masch, nei confronti dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione, ma le motivazioni della sentenza del Tribunale di Amburgo hanno spazzato via il già molto cauto ottimismo. L’8 Marzo scorso l’associazione, che aveva citato in giudizio lo Stato per essere stata classificata come associazione di “estrema sinistra”, togliendole lo status di organizzazione no profit, ha ottenuto la riabilitazione e il proprio status. In un clima così fortemente anticomunista, questa sembrava davvero una bella notizia per le associazioni e le organizzazioni marxiste tedesche.
Sembrava una vittoria storica quella del “Forum serale Marxista per la politica e la cultura”, abbreviato Masch, nei confronti dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione, ma le motivazioni della sentenza del Tribunale di Amburgo hanno spazzato via il già molto cauto ottimismo. L’8 Marzo scorso l’associazione, che aveva citato in giudizio lo Stato per essere stata classificata come associazione di “estrema sinistra”, togliendole lo status di organizzazione no profit, ha ottenuto la riabilitazione e il proprio status. In un clima così fortemente anticomunista, questa sembrava davvero una bella notizia per le associazioni e le organizzazioni marxiste tedesche. Ci sono testi che svelano e rilevano in modo indiretto il problema onto-metafisico in cui siamo implicati. Uomini senza passione governano il pianeta, il potere e il senso di onnipotenza con operazioni di guerra valutate in modo autoreferenziale ”spettacolari” (Trump) sono il segno del vuoto di senso dell’Occidente. Lo spettacolo minaccia di condurci verso uno scontro atomico senza ritorno, nel frattempo circa un migliaio di esseri umani hanno perso la vita nello scontro tra Israele-USA e Iran, mente a Gaza il genocidio continua a consumarsi nel silenzio mediatico abbagliato, è il caso di dire, dalle operazioni militari in Iran. La politica, passione sociale ed etica, è stata sostituita con il suo surrogato più squallido: la logica del dominio che diventa aggressività nichilistica incapace di “pensare le conseguenze” sociali, politiche e ambientali della guerra divenuta “spettacolo”. Non c’è progettualità e dinanzi alla fine della potenza economica capitalistica si reagisce con la violenza, in quanto la dimensione della politica si è inabissata nell’irrazionalità del pan-economicismo oligarchico. Uomini senza passione per l’umano e senza amore per il proprio popolo governano il pianeta. A questi uomini che Nietzsche definì “ultimi uomini”, si contrappone la resistenza silenziosa degli uomini dalla “passione durevole”. Costanzo Preve ne fu un esempio intramontabile. Egli dedicò un testo alla Passione durevole, che non è un semplice testo, ma è l’oggettivazione della vita nel senso alto e nobile della parola.
Ci sono testi che svelano e rilevano in modo indiretto il problema onto-metafisico in cui siamo implicati. Uomini senza passione governano il pianeta, il potere e il senso di onnipotenza con operazioni di guerra valutate in modo autoreferenziale ”spettacolari” (Trump) sono il segno del vuoto di senso dell’Occidente. Lo spettacolo minaccia di condurci verso uno scontro atomico senza ritorno, nel frattempo circa un migliaio di esseri umani hanno perso la vita nello scontro tra Israele-USA e Iran, mente a Gaza il genocidio continua a consumarsi nel silenzio mediatico abbagliato, è il caso di dire, dalle operazioni militari in Iran. La politica, passione sociale ed etica, è stata sostituita con il suo surrogato più squallido: la logica del dominio che diventa aggressività nichilistica incapace di “pensare le conseguenze” sociali, politiche e ambientali della guerra divenuta “spettacolo”. Non c’è progettualità e dinanzi alla fine della potenza economica capitalistica si reagisce con la violenza, in quanto la dimensione della politica si è inabissata nell’irrazionalità del pan-economicismo oligarchico. Uomini senza passione per l’umano e senza amore per il proprio popolo governano il pianeta. A questi uomini che Nietzsche definì “ultimi uomini”, si contrappone la resistenza silenziosa degli uomini dalla “passione durevole”. Costanzo Preve ne fu un esempio intramontabile. Egli dedicò un testo alla Passione durevole, che non è un semplice testo, ma è l’oggettivazione della vita nel senso alto e nobile della parola. «In definitiva, il comunismo è l'unica cosa importante del pensiero di [Karl] Marx», osservava nel 1983 il teorico politico ungherese R. N. Berki.[1] Anche se si trattava di un'esagerazione, è innegabile che l'ampia concezione di Marx della società comunitaria/comunismo costituisse la base della sua intera critica della società divisa in classi e della sua visione di un futuro sostenibile per l'umanità. Tuttavia, ci sono stati pochi tentativi di affrontare sistematicamente lo sviluppo di questo aspetto del pensiero di Marx, così come è emerso nel corso della sua vita, a causa della complessità del suo approccio alla questione della produzione comunitaria nella storia, e delle sfide filosofiche, antropologiche e politico-economiche che questo ha presentato fino ai nostri giorni. Tuttavia, l'approccio di Marx alla società comunitaria è di reale importanza non solo per comprendere complessivamente il suo pensiero, ma anche per aiutare l'umanità a superare la gabbia d'acciaio della società capitalista. Oltre a presentare un'antropologia filosofica del comunismo, Marx ha approfondito la storia e l'etnologia delle attuali formazioni sociali comunitarie. Ciò ha portato a indagini concrete sulla produzione e sullo scambio comunitari. Tutto ciò ha contribuito alla sua concezione del comunismo del futuro come società di produttori associati.[2]
«In definitiva, il comunismo è l'unica cosa importante del pensiero di [Karl] Marx», osservava nel 1983 il teorico politico ungherese R. N. Berki.[1] Anche se si trattava di un'esagerazione, è innegabile che l'ampia concezione di Marx della società comunitaria/comunismo costituisse la base della sua intera critica della società divisa in classi e della sua visione di un futuro sostenibile per l'umanità. Tuttavia, ci sono stati pochi tentativi di affrontare sistematicamente lo sviluppo di questo aspetto del pensiero di Marx, così come è emerso nel corso della sua vita, a causa della complessità del suo approccio alla questione della produzione comunitaria nella storia, e delle sfide filosofiche, antropologiche e politico-economiche che questo ha presentato fino ai nostri giorni. Tuttavia, l'approccio di Marx alla società comunitaria è di reale importanza non solo per comprendere complessivamente il suo pensiero, ma anche per aiutare l'umanità a superare la gabbia d'acciaio della società capitalista. Oltre a presentare un'antropologia filosofica del comunismo, Marx ha approfondito la storia e l'etnologia delle attuali formazioni sociali comunitarie. Ciò ha portato a indagini concrete sulla produzione e sullo scambio comunitari. Tutto ciò ha contribuito alla sua concezione del comunismo del futuro come società di produttori associati.[2]

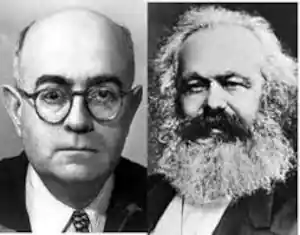
 Khoei Saito in Il capitale nell’Antropocene critica duramente gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite paragonandoli all’oppio dei popoli di marxiana memoria poiché distolgono l’attenzione dalla reale crisi climatica con soluzioni superficiali come l’uso di borse riutilizzabili o borracce che fungono da greenwashing senza affrontare il problema alla radice. Saito sostiene che queste azioni individuali, sebbene ben intenzionate, rischiano di assolvere la coscienza delle persone, impedendo un cambiamento radicale necessario per contrastare il riscaldamento globale. La situazione ambientale è descritta come irreparabile, con l’uomo che ha alterato profondamente il pianeta, tanto da far coniare il termine Antropocene per indicare l’era geologica dominata dall’impatto umano. Viene citato Paul Crutzen, premio Nobel per la Chimica, per sottolineare come le attività economiche abbiano modificato l’ambiente, con un’enorme diffusione di microplastiche negli oceani e un aumento senza precedenti della CO₂ atmosferica, passata da 280 ppm prima della Rivoluzione Industriale a oltre 400 ppm nel 2016. Questo incremento, paragonabile a livelli risalenti a quattro milioni di anni fa, potrebbe portare a un innalzamento catastrofico del livello dei mari e a un clima simile a quello del Pliocene. La crisi climatica minaccia la sopravvivenza stessa della civiltà umana, con le disuguaglianze sociali che si acuiscono. I ricchi potrebbero mantenere il loro stile di vita ma la maggior parte della popolazione sarà costretta a lottare per la sopravvivenza. Per Saito la vera causa della crisi climatica è nel capitalismo stesso, il cui sviluppo dalla Rivoluzione Industriale ha coinciso con l’aumento delle emissioni di CO₂. Per trovare una via d’uscita propone di rileggere Marx in modo innovativo, analizzando le connessioni tra capitale, società e natura nell’Antropocene non per riproporre un marxismo dogmatico ma per riscoprire aspetti del suo pensiero finora trascurati, nella speranza di immaginare una società più giusta e sostenibile.
Khoei Saito in Il capitale nell’Antropocene critica duramente gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite paragonandoli all’oppio dei popoli di marxiana memoria poiché distolgono l’attenzione dalla reale crisi climatica con soluzioni superficiali come l’uso di borse riutilizzabili o borracce che fungono da greenwashing senza affrontare il problema alla radice. Saito sostiene che queste azioni individuali, sebbene ben intenzionate, rischiano di assolvere la coscienza delle persone, impedendo un cambiamento radicale necessario per contrastare il riscaldamento globale. La situazione ambientale è descritta come irreparabile, con l’uomo che ha alterato profondamente il pianeta, tanto da far coniare il termine Antropocene per indicare l’era geologica dominata dall’impatto umano. Viene citato Paul Crutzen, premio Nobel per la Chimica, per sottolineare come le attività economiche abbiano modificato l’ambiente, con un’enorme diffusione di microplastiche negli oceani e un aumento senza precedenti della CO₂ atmosferica, passata da 280 ppm prima della Rivoluzione Industriale a oltre 400 ppm nel 2016. Questo incremento, paragonabile a livelli risalenti a quattro milioni di anni fa, potrebbe portare a un innalzamento catastrofico del livello dei mari e a un clima simile a quello del Pliocene. La crisi climatica minaccia la sopravvivenza stessa della civiltà umana, con le disuguaglianze sociali che si acuiscono. I ricchi potrebbero mantenere il loro stile di vita ma la maggior parte della popolazione sarà costretta a lottare per la sopravvivenza. Per Saito la vera causa della crisi climatica è nel capitalismo stesso, il cui sviluppo dalla Rivoluzione Industriale ha coinciso con l’aumento delle emissioni di CO₂. Per trovare una via d’uscita propone di rileggere Marx in modo innovativo, analizzando le connessioni tra capitale, società e natura nell’Antropocene non per riproporre un marxismo dogmatico ma per riscoprire aspetti del suo pensiero finora trascurati, nella speranza di immaginare una società più giusta e sostenibile.

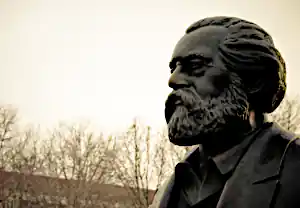 L’obbiettivo del presente intervento è quello di portare a tema la questione della programmazione ecologica in Marx (accennando in apertura anche alla concezione di Engels). All’interno del primo (1867) e del terzo libro del Capitale (1894) Marx va elaborando una risposta al tema della distruzione capitalistica della natura umana ed extra umana, a partire dal governo razionale e pianificato dello Stoffwechsel (metabolismo) tra uomo e natura. In Engels il tema della programmazione economica è affrontato nell’opera Antidüring (1878), dove sulla scia di Marx, egli allude al piano come una forma di produzione sociale in cui i lavori privati divengono immediatamente sociali e in cui viene superato il sistema di produzione basato sulla merce, sulla logica del valore e del lavoro astratto
L’obbiettivo del presente intervento è quello di portare a tema la questione della programmazione ecologica in Marx (accennando in apertura anche alla concezione di Engels). All’interno del primo (1867) e del terzo libro del Capitale (1894) Marx va elaborando una risposta al tema della distruzione capitalistica della natura umana ed extra umana, a partire dal governo razionale e pianificato dello Stoffwechsel (metabolismo) tra uomo e natura. In Engels il tema della programmazione economica è affrontato nell’opera Antidüring (1878), dove sulla scia di Marx, egli allude al piano come una forma di produzione sociale in cui i lavori privati divengono immediatamente sociali e in cui viene superato il sistema di produzione basato sulla merce, sulla logica del valore e del lavoro astratto 





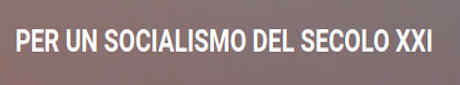
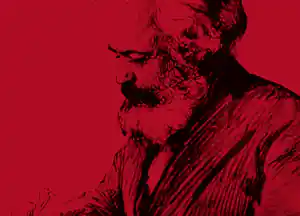
 F. Engels nel 1845, a soli 24 anni, descrisse la condizione di sfruttamento della classe operaia in Inghilterra con un testo La situazione della classe operaia in Inghilterra che nel nostro tempo andrebbe riletto per la sua attualità. L’indagine empirica e razionale coniuga l’oggettività dei dati con il giudizio etico. L’indagine di Engels è oggi, ancora viva e vera, poiché lo sfruttamento generalizzato è tornato a essere l’ordinaria normalità del nostro quotidiano. Il capitalismo neoliberale, mentre volge lo sguardo verso il transumanesimo e l’I.A, mostra il “suo cuore di pietra”, senza equivoci e fraintendimenti come nell’Ottocento. Lo sguardo libero dagli abbagli degli slogan ci restituisce la verità sulla condizione lavorativa e umana di tanti. Contingenze storiche e una sinistra liberale complice consentono al capitale di mostrarsi nella sua verità regressiva e disumana senza infingimenti: lo sfruttamento è diventato un “dato di fatto” ormai naturalizzato, per cui lo si accetta al punto che, malgrado la sua evidenza, non pochi lo ignorano. Vi è un nucleo del capitalismo che resta sempre eguale nella sua lunga storia, esso resta inalterato, poiché è la sostanza che lo muove e lo nutre. La descrizione-denuncia di Engels lo mostra con rara chiarezza e, pertanto, il tempo che ci separa dal pensatore tedesco, ci permette di ritrovare ciò che nel nostro tempo il capitale in modo sempre più manifesto produce con i suoi effetti letali. Il capitalismo non è semplice sfruttamento, ma esso disumanizza lo sfruttato riducendolo a mezzo per la produzione del plusvalore. Allora come oggi i nuovi proletari vivono processi di alienazione che li offendono nella psiche come nel corpo. La violenza è il carattere dominante ed eterno del capitalismo; è la sua verità che Engels visse e denunciò , ed è ancora fra noi in forme antiche e nuove. Allo sfruttamento di tanti corrisponde una ristretta oligarchia che governa con la violenza legalizzata. La legalità scissa dalla giustizia è il volto “legale” del capitalismo che convive con forme di illegalità, sempre più diffuse e ignorate, orientate verso il “consumo di esseri umani e di risorse”:
F. Engels nel 1845, a soli 24 anni, descrisse la condizione di sfruttamento della classe operaia in Inghilterra con un testo La situazione della classe operaia in Inghilterra che nel nostro tempo andrebbe riletto per la sua attualità. L’indagine empirica e razionale coniuga l’oggettività dei dati con il giudizio etico. L’indagine di Engels è oggi, ancora viva e vera, poiché lo sfruttamento generalizzato è tornato a essere l’ordinaria normalità del nostro quotidiano. Il capitalismo neoliberale, mentre volge lo sguardo verso il transumanesimo e l’I.A, mostra il “suo cuore di pietra”, senza equivoci e fraintendimenti come nell’Ottocento. Lo sguardo libero dagli abbagli degli slogan ci restituisce la verità sulla condizione lavorativa e umana di tanti. Contingenze storiche e una sinistra liberale complice consentono al capitale di mostrarsi nella sua verità regressiva e disumana senza infingimenti: lo sfruttamento è diventato un “dato di fatto” ormai naturalizzato, per cui lo si accetta al punto che, malgrado la sua evidenza, non pochi lo ignorano. Vi è un nucleo del capitalismo che resta sempre eguale nella sua lunga storia, esso resta inalterato, poiché è la sostanza che lo muove e lo nutre. La descrizione-denuncia di Engels lo mostra con rara chiarezza e, pertanto, il tempo che ci separa dal pensatore tedesco, ci permette di ritrovare ciò che nel nostro tempo il capitale in modo sempre più manifesto produce con i suoi effetti letali. Il capitalismo non è semplice sfruttamento, ma esso disumanizza lo sfruttato riducendolo a mezzo per la produzione del plusvalore. Allora come oggi i nuovi proletari vivono processi di alienazione che li offendono nella psiche come nel corpo. La violenza è il carattere dominante ed eterno del capitalismo; è la sua verità che Engels visse e denunciò , ed è ancora fra noi in forme antiche e nuove. Allo sfruttamento di tanti corrisponde una ristretta oligarchia che governa con la violenza legalizzata. La legalità scissa dalla giustizia è il volto “legale” del capitalismo che convive con forme di illegalità, sempre più diffuse e ignorate, orientate verso il “consumo di esseri umani e di risorse”:
 I Prolegomeni all’Ontologia dell’essere sociale possiedono il valore di un testamento, per il fatto di essere l’ultimo grande testo filosofico di Lukács. Vennero infatti redatti poco prima della sua morte.
I Prolegomeni all’Ontologia dell’essere sociale possiedono il valore di un testamento, per il fatto di essere l’ultimo grande testo filosofico di Lukács. Vennero infatti redatti poco prima della sua morte.



































