L’Economist e il mito del libero mercato
Grace Blakeley intervista Alexander Zevin
La storia del giornale liberista per eccellenza racconta il modo in cui il pensiero liberale si adatta ai diversi contesti. Ed evidenzia la sua eterna tensione con la democrazia
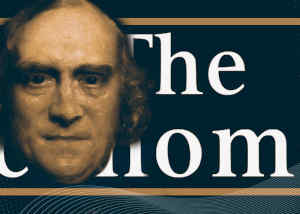 Marx una volta definì l’Economist «la tribuna dell’aristocrazia della finanza». In qualità di rivista dominante del liberalismo d’élite, ha svolto un ruolo importante nel plasmare e promuovere l’ideologia liberale, attraverso i suoi cambiamenti e continuità, dalla sua fondazione nel 1843 ad oggi.
Marx una volta definì l’Economist «la tribuna dell’aristocrazia della finanza». In qualità di rivista dominante del liberalismo d’élite, ha svolto un ruolo importante nel plasmare e promuovere l’ideologia liberale, attraverso i suoi cambiamenti e continuità, dalla sua fondazione nel 1843 ad oggi.
Alexander Zevin, assistente professore di storia alla City University di New York e redattore della New Left Review, ha recentemente pubblicato un nuovo libro, Liberalism at Large: The World According to the Economist, che approfondisce la storia del liberalismo attraverso la lente di osservazione dell’Economist.
In una puntata del podcast di Tribune, A World To Win, Grace Blakeley di Tribune ha discusso con Zevin della storia dell’ideologia liberale, se è in crisi e come evolverà dopo aver plasmato l’ordine mondiale.
* * * *
Che cos’è il liberalismo?
Il mio libro scarta alcune idee su cosa sia il liberalismo per arrivare a una definizione migliore. Mi riferisco alle analisi secondo cui il liberalismo inizia nel diciassettesimo secolo con John Locke e le sue idee e teorie politiche o con Adam Smith nel diciottesimo secolo con La ricchezza delle nazioni e cose del genere. Io sostengo che il liberalismo emerge davvero e deve essere compreso nel suo contesto storico nel periodo sulla scia delle guerre napoleoniche: questo è il momento in Europa, Spagna e poi in Francia, in cui le persone si descrivono per la prima volta come liberali.
Dobbiamo discutere di cosa sia il liberalismo in virtù di questa autodefinizione. Se prendiamo le mosse da quel momento, vediamo molto chiaramente che è una reazione a diversi sviluppi, uno dei quali è il crollo dei vecchi regimi in Europa in modo da far emergere una nuova forma della politica borghese. Da un lato, è contro l’assolutismo, vuole un governo responsabile, vuole le elezioni, almeno in un certo senso per alcune persone, e vuole i diritti costituzionali e cose del genere. Ma d’altra parte, si spaventa molto presto delle mobilitazioni di massa della plebe. Quella sorta di spazio intermedio è il punto in cui inizia il liberalismo.
È anche il momento in cui il capitalismo industriale prende davvero il sopravvento. Sono le cose a cui la gente pensa quando si tratta di regolazione, controlli e contrappesi e governo responsabile, ma è anche questo fenomeno che può davvero emergere solo all’inizio del diciannovesimo secolo quando i liberali affrontano sfide come la richiesta del voto da parte dei cittadini comuni e la diffusione del capitalismo e cosa questo significa per la governance e l’economia.
Da quel punto di vista, l’argomento secondo cui i neoliberisti negli anni Ottanta vedevano la democrazia come impedimento all’introduzione delle politiche economiche che auspicavano è in realtà una tensione che è insita nel liberalismo sin dal suo inizio: la tensione tra democrazia, rappresentanza democratica e gli interessi del capitale. Giusto?
Sì, assolutamente. Una delle cose che è stata oscurata durante la Guerra Fredda e anche oggi, è l’idea che liberalismo e democrazia vadano insieme, che ci siano queste cose chiamate democrazie liberali, che noi viviamo in questo contesto e che sia impossibile che queste due cose vengano separate. Storicamente, i liberali non erano democratici. Hanno escogitato molte strategie diverse per cercare di limitare il voto a coloro che hanno un’istruzione o a coloro che percepivano una certa quantità d reddito o pagavano un’imposta sulla proprietà: strumenti ingegnosi per porre dei limiti costituzionali alla possibilità della classe operaia – della plebaglia – di votare. La cosa interessante è che i neoliberisti affrontano in un contesto nuovo un problema a cui i liberali hanno pensato fin dagli albori del liberalismo. In un certo senso, le democrazie rimangono anche quando i neoliberisti vanno al potere – all’inizio degli anni Ottanta – ma ci sono nuovi modi e nuovi mezzi a loro disposizione per cercare di affrontare questo problema di redistribuzione, di richieste di diritti economici che possono interferire con il libero funzionamento del mercato e il meccanismo dei prezzi che ritengono fondamentale per garantire la libertà individuale e il buon funzionamento del capitalismo.
Il titolo completo del tuo libro è Liberalism at Large: The World According to the Economist. Perché studiare il liberalismo dal punto di vista di un giornale?
È una strana impresa, quella in cui mi sono imbarcato. Uno dei motivi per cui l’ho fatto è stato cercare di rompere i modi classici di parlare di liberalismo. Invece di guardare il canone – Locke, Mill, Rawls, i famosi liberali – mi è apparso chiaro che osservando una rivista, che è uno sforzo collettivo, che esce ogni settimana, che è stata effettivamente al centro degli eventi, i cui redattori sono anonimi ma hanno ricoperto ruoli di spicco nel Tesoro, nel Ministero degli Esteri, come primi ministri, come governatori della Banca d’Inghilterra, si sarebbe potuta raccontare una storia del liberalismo in grado di includere il concetto di cambiamento e trasformazione.
Il liberalismo non è sempre stato la stessa cosa, perché ha continuato a rispondere a nuove sfide, nuove minacce, nuovi eventi: l’Economist ha dovuto affrontare gli eventi di ogni settimana per oltre 175 anni. Era un modo per cercare di creare una definizione di liberalismo che fosse molto più flessibile e anche più contestualizzata. Sento che c’è qualcosa di terribile o noioso nei libri sui giornali, ma non è un libro noioso, non credo. Questo perché non cerca davvero di fare una biografia di un giornale in modo tradizionale. La vede come un nesso per un dare e avere, avanti e indietro, una serie di sfide, crisi, dibattiti che si verificano all’interno della carta e tra la carta e altri pensatori.
In ogni capitolo, dal 1840 fino a oggi, colloco sempre ciò che accade all’interno dell’Economist, le sue differenti posizioni, nei confronti dei pensatori chiave di sinistra o di destra del liberalismo. Negli anni Cinquanta, Sessanta, Settanta dell’Ottocento è un dibattito con John Stuart Mill. Negli anni Venti, Trenta e Quaranta del Novecento è un dibattito con John Maynard Keynes. Si tratta di qualcosa di insolito e divertente più di quanto possa sembrare la storia di un giornale.
È interessante il modo in cui studi il liberalismo dal punto di vista particolare di un giornale. Se dovessi studiare il liberalismo, come abbiamo fatto io e molti altri nei nostri corsi universitari di politica, ti troveresti Locke e Mill, e poi Rawls e guarderesti lo sviluppo del pensiero liberale. Ma quando osservi come viene applicato concretamente, come sempre accade con l’applicazione di qualsiasi teoria, è diverso da ciò che suggerirebbe il canone ideologico. Tu interpreti e guardi quelle tensioni in modi diversi, per un periodo di tempo molto lungo, usando prove eccezionalmente interessanti provenienti da archivi e un sacco di fonti diverse. Se potessimo passare attraverso alcuni di questi esempi di divisioni all’interno del liberalismo – tra la pratica e la teoria del liberalismo – il primo ovviamente sarebbe il libero scambio. Nella mitologia del liberalismo, il libero scambio dovrebbe essere la cosa che gli ha permesso di emergere come ideologia separata e ciò che i partiti liberali stavano difendendo diversi secoli fa. Ma c’erano più divisioni di quante si possa pensare sul modo in cui si sarebbe dovuto realizzare il libero scambio, in particolare nel contesto dell’impero.
La teoria del libero scambio era presumibilmente una teoria della pace e della buona volontà: se ci sono più commerci hai anche interazioni più pacifiche. C’è un’idea illuminante: il commercio affina le buone maniere e porta diversi tipi di persone a intessere rapporti, quindi imparano a comportarsi e agire bene l’uno con l’altro. Questa è la teoria di Richard Cobden, uno degli eroi dell’Anti-Corn Law League, soggetto che emerge negli anni Trenta e Quaranta dell’Ottocento in Inghilterra nel corso della lotta contro le Corn Laws, che erano classicamente mercantilistiche e mantenevano alti i prezzi del grano dopo le guerre napoleoniche. Erano viste dalla classe media come un residuo del privilegio aristocratico dei proprietari terrieri. Insieme a quell’idea – se abolisci le leggi sul grano, ci sarà una maggiore prosperità – si diffonde anche l’idea che questo eliminerà la guerra. Si pensava che la guerra fosse un vizio tipico della classe aristocratica con una mentalità da ancien régime, il che fu molto importante per la teoria del commercio.
Il fondatore dell’Economist James Wilson non è molto noto, ma è una figura affascinante, di origine scozzese, figlio di un produttore tessile. Anche lui sostenne queste posizioni. Negli anni Cinquanta dell’Ottocento c’è una spaccatura molto radicale tra James Wilson e Richard Cobden e John Bright, che non è considerata dalla letteratura sul libero scambio o sul’Economist. Ma è davvero fondamentale cogliere il ceppo dominante del liberalismo così come emerge negli anni Cinquanta dell’Ottocento. Per l’Economist, diventa abbastanza chiaro che entro il 1850 il fatto che il libero scambio diventi effettivamente la struttura ordinatrice dell’economia mondiale, come avevano sperato, non è una cosa semplice legata al commercio. Devi costringere le persone a commerciare liberamente, per così dire. C’è una serie di conflitti nel 1800, a partire dalla guerra di Crimea, che si estende poi in Cina, e poi anche la rivolta e la ribellione indiana, che vedono l’Economist prendere posizioni che sostengono l’uso della forza per «rompere la consuetudine» e forzare quella che consideravano «resistenza asiatica» al libero scambio e al progresso.
C’è una dimensione morale ed economica in questi concetti: ciò richiederà l’uso della Royal Navy, truppe sul campo e collaborazione con altre potenze come la Francia per aprire il campo all’economia mondiale. James Wilson denuncia Richard Cobden e John Bright in Parlamento perché a quel punto sta prestando servizio nel Tesoro, influenzando la politica del governo e prendendo prestiti per combattere queste guerre. Il ruolo dell’Economist all’interno della Gran Bretagna e della politica britannica in questo cambiamento all’insegna di un atteggiamento aggressivo molto più liberale-imperialista è una delle scoperte del libro.
Un’altra grande rottura all’interno del liberalismo è stata la nascita del keynesismo. A livello interno il sostegno a un maggiore intervento dello stato e a livello internazionale la nascita delle istituzioni di Bretton Woods è stata presentata come la grande transizione che ha diviso il liberalismo e i liberali tra sinistra e destra, e il declino dei veri movimenti socialisti negli ultimi quarant’anni circa ci ha lasciato con questo asse che definisce sinistra e destra in base al fatto che si pensi o meno che lo stato dovrebbe intervenire nell’economia. In che misura ha rappresentato una cesura l’avvento del keynesismo, la politica economica keynesiana e ciò che viene spesso definito nel Regno Unito il consenso del dopoguerra, rispetto al liberalismo laissez-faire precedente, e come viene visto dall’Economist?
Ho raccolto il dibattito tra Keynes e l’Economist, e guardando quel dibattito osserviamo Keynes cambiare idea. Lo vediamo litigare con sé stesso perché incarna tanti dei valori dell’Economist. È uno studente di Alfred Marshall, il decano dell’economia neoclassica in Gran Bretagna, che più di chiunque altro ha generato lo studio dell’economia in Gran Bretagna in senso moderno e scientifico, a Cambridge. Ed è uno studente di Walter Layton, che diventa direttore dell’Economist e lavora con lui nel governo durante entrambe le guerre mondiali. C’è un vero dialogo personale tra loro. C’è anche una famosa frase in Le Conseguenze Economiche della Pace in cui Keynes parla del mondo pre-1914 e descrive sé stesso sdraiato a letto a leggere i prezzi delle azioni con la consapevolezza che la sterlina che ha in tasca, in quanto sostenuta dall’oro, vale ovunque allo stesso modo. Non è necessario il passaporto per viaggiare. Ho la sensazione che questa famosa frase, così evocativa su com’era il mondo globalizzato edoardiano nell’epoca precedente alla sua distruzione che arriva con la Prima guerra mondiale, era la reale rappresentazione di Keynes che legge l’Economist a letto. L’Economist era quella finestra sul mondo dell’alta finanza e del capitale globalizzato in quel periodo prima del 1914.
Nel 1925, la Gran Bretagna torna al gold standard, alla parità con il dollaro Usa, imponendo sostanzialmente una dura austerità deflazionistica mentre l’austerità c’era già stata per diversi anni. Dopo il 1925, l’Economist e Keynes iniziano a darsi battaglia. Keynes cominciò a mettere in discussione molte delle ipotesi sul libero scambio che aveva sostenuto fino a quel momento, e iniziò a sperimentare idee su un gold standard flessibile o uno scambio flessibile, e analisi sulle tasse sui ricavi e altre cose del genere. Tuttavia fino al 1925 – ma anche dopo – l’Economist e Keynes condividono alcuni presupposti, in particolare relativi all’importanza della City di Londra per la posizione della Gran Bretagna come potenza globale nel mondo, e l’idea della sterlina come importante valuta di riserva.
Nel mio racconto sostengo che ci sono disaccordi fondamentali tra l’Economist e Keynes e che diventano molto acuti all’inizio degli anni Trenta. Keynes inizia a sostenere che è necessaria la spesa in deficit e la creazione di un certo livello di inflazione. Sebbene molti redattori dell’Economist siano ormai studenti di Keynes e stiano discutendo le sue idee, la rivista è molto resistente alle sue nuove nozioni, in parte perché hanno paura di ciò che la City di Londra dirà su questa idea che le decisioni di investimento non dipendano più dalla borsa. Ho cercato di porre una serie di domande, dibattiti, discussioni tra Keynes e la City di Londra e alcune idee sulla finanza, la Gran Bretagna e il mondo.
Anche qui c’è una domanda più ampia sul legame tra l’economia come disciplina e il liberalismo. Molti dei primi liberali erano ovviamente economisti. Le grandi domande vertevano sul commercio, l’interesse nazionale, le politiche sovrane. Intorno agli anni Sessanta, c’è l’ascesa del keynesismo. Negli anni Sessanta e Settanta c’è anche la nascita dell’economia neoclassica, la sintesi keynesiana che riunisce parte della prima economia politica e il pensiero sui marginalisti alle intuizioni di Keynes, nonché l’ascesa della microeconomia e dei modelli matematici. Ciò procede insieme alla transizione verso il neoliberismo. Queste tendenze politiche sembrano andare di pari passo con le tendenze economiche. Qual è secondo te il legame tra i due?
In virtù del fatto che sto pensando al liberalismo, piuttosto che al neo, all’ordo e ad altre varianti che emergono in questi decenni in cui l’economia mondiale cambia e nascono nuove scuole, vedo continuità dove altri vedono rottura. Con David Edgerton, che ha scritto un libro intitolato The Rise and Fall of the British Nation, ho avuto uno scambio produttivo su quanto il 1945 ha rappresentato un cambiamento fondamentale nell’economia politica della Gran Bretagna, e in che misura sosteniamo che il 1979 rappresenti un’altra rottura. Certamente l’elezione del governo laburista nel 1945 e il tipo di cambiamenti che ha apportato allo stato sociale, e poi, al contrario, l’elezione della Thatcher e il capovolgimento di quelle riforme, sono momenti di rottura. Ma c’è molta continuità liberale in tutto questo. Ciò ha a che fare con la mancanza di riflessione su ciò che la City di Londra e il controllo privato della funzione di investimento fanno all’economia britannica e con l’importanza costante di una certa concezione del libero scambio, sia all’interno della destra che della sinistra del Partito laburista. A volte, nuove soluzioni e compromessi nascono perché il movimento operaio è forte, o perché la Seconda guerra mondiale mostra che lo stato può svolgere un ruolo più attivo nell’economia, e gli avvertimenti di Hayek in La Via della Schiavitù sembrano un po’ esagerati. Ma è difficile spiegare come si arriva al 1979 e a Thatcher.
Thatcher non è venuta fuori dal nulla. Non ha ribaltato una forma di socialdemocrazia pienamente funzionale, non attraversata dalla crisi e non contraddittoria. Ha sfruttato quelle contraddizioni. Ha sfruttato il disorientamento tra i socialdemocratici all’interno del Partito laburista. Tieni presente che James Callaghan, che divenne il leader del Partito laburista e primo ministro alla fine degli anni Settanta, aveva già adottato una forma di monetarismo e aveva accettato i prestiti di austerità del Fmi. Ritengo che questi cambiamenti siano avvenenuti in modo più graduale, perché il liberalismo non scompare mai. La forma di liberalismo dell’Economist incontra mutamenti e cambiamenti in tutti i modi nel corso degli anni Quaranta dell’Ottocento fino ai Quaranta del Novecento, ma alcuni elementi di quella storia sono presenti durante quelle transizioni all’interno dello studio dell’economia.
Porrò questa domanda in termini provocatoriamente semplicistici. Il punto sulla continuità contro la rottura è davvero interessante. Potresti tornare indietro e dire che se vedi il liberalismo come l’ideologia generalmente sostenuta dalla classe dominante capitalista – che discute su come questa ideologia dovrebbe essere interpretata e implementata sulle pagine dell’Economist – allora puoi riconoscere molti dei cambiamenti che si verificano nell’ideologia liberale come risposte ai mutamenti materiali in atto che richiedono innovazione per facilitare l’accumulazione di capitale. Forse significa concentrarsi un po’ troppo sulla base economica, ma fino a che punto pensi che ci sia qualcosa che spieghi parte della continuità ma anche degli innegabili cambiamenti che abbiamo visto nell’ideologia liberale negli ultimi cento anni?
Non lo considero provocatorio. Da rozzo materialista o volgare marxista, accetto quest’idea. Quello che vediamo è che alcune domande simili vengono fatte in questi due secoli dai liberali, ma le risposte cambiano in base alle circostanze e al contesto storico. Come reagire all’irruzione della classe operaia sulla scena della politica? Come arginarla? Limitando il suffragio? Accettando il suffragio universale ma mettendo dei vincoli alle prerogative dei parlamenti? Si tratta di consegnare il controllo degli scambi e della politica monetaria a una banca centrale in modo che quel tipo di questioni così fondamentali per l’accumulazione di capitale siano fuori dalle mani dei legislatori? Le risposte a queste domande cambiano a seconda di cosa è possibile fare in un dato momento. Ma le domande sono piuttosto costanti nella storia del liberalismo.
Sottolineo il modo in cui cambia il liberalismo, ma non discuto tanto quanto potrei quel punto di svolta negli anni Ottanta, l’inizio, come dice David Harvey, «della lunga marcia attraverso le istituzioni dei neoliberisti». Stavano aspettando il loro momento negli anni Venti e Trenta, e negli anni Ottanta quel momento è arrivato. In un certo senso è innegabile che questa storia sia vera. La cosa interessante per me, però, è che i giornalisti dell’Economist non si definiscono neoliberisti. In effetti, guardando negli archivi del giornale, ho visto che il termine «neoliberista» in realtà viene utilizzato solo tra virgolette per citare il modo in cui la sinistra latinoamericana descrive una serie di politiche applicate nei loro paesi all’indomani del colpo di stato in Cile. Non è visto come un aggettivo utile a descrivere una visione politico-economica del mondo, per non parlare di quella che l’Economist adotterebbe. E questo nonostante il fatto che alla fine degli anni Ottanta l’Economist sia giustamente visto come un baluardo del pensiero del libero mercato. Reagan e Thatcher sono stati beatificati sulle pagine dell’Economist e sempre su quelle pagine si difende una versione della globalizzazione a oltranza. Il termine «neoliberista» non appare sul Financial Times, sull’Economist o su altri giornali economici. Il Fmi non pareva disposto a riconoscere che esistesse fino a poco tempo fa. Ciò che indica che questa transizione da liberalismo a neoliberismo dal punto di vista di coloro che l’hanno messa in pratica non è poi così netto. Il neoliberismo viene messo in pratica con un insieme di politiche, che si tratti di austerità, deregolamentazione o privatizzazione, ma ciò avviene attraverso persone che si considerano liberali classici o addirittura liberali di centrosinistra. Questa è la chiave per comprendere il modo in cui avviene la transizione.
Oggi c’è un cambiamento nel buon senso economico, penso alla reazione contro l’austerità in alcune delle grandi istituzioni economiche internazionali o alle politiche economiche più dirigiste che vengono attuate in risposta alla pandemia. Tutto questo sta avvenendo in risposta alle mutevoli esigenze del capitale. Pensi che si rifletterà in un nuovo cambiamento dell’ideologia liberale? Se si tratterà di un tentativo di tornare a un modello più socialdemocratico per cercare di reintegrare i mercati in un contesto nazionale potrà funzionare?
Gli Stati uniti, la Gran Bretagna e molti altri paesi hanno aperto i rubinetti e speso abbastanza generosamente per sostenere l’economia durante la pandemia, per fornire alle persone sussidi contro la disoccupazione e ogni sorta di altre cose alle imprese per sopportare i mutamenti economia. Quando Biden è arrivato, all’inizio c’era la sensazione che avrebbe utilizzato un volume di spesa maggiore di quanto molti avessero immaginato a sinistra. Certamente, c’era questo pacchetto una tantum che estendeva la spesa che Trump aveva già implementato, così come alcuni aiuti agli stati, in modo da evitare parte dell’austerità a livello statale post-2008 (Gli stati non possono fare deficit negli Usa e molti comuni, come quello in cui mi trovo a New York City, sono stati devastati dal Covid, visto che l’economia qui è dipendente dal turismo). Ma ora, mentre Biden inizia a incontrare all’interno del Partito democratico una vera resistenza alla sua agenda, oltre che da parte dei repubblicani, all’aumento delle aliquote fiscali sulle aziende, all’attuazione concreta di un piano infrastrutturale, si è aperto il dibattito su che tipo di rottura ci sarà, anche nella misura in cui ciò equivale a un ritorno a qualcosa di simile a una concezione keynesiana del pompaggio di liquidità, e così via.
In assenza di una reale resistenza da parte del lavoro organizzato e della sinistra, mi chiedo fino a che punto basti che lo stato spenda soldi e accumuli deficit con i tassi di interesse bassi per portare un cambiamento duraturo all’economia politica. Non ho una risposta chiara al riguardo, le cose stanno cambiando molto rapidamente in questo momento in risposta a una crisi totalmente senza precedenti. Cédric Durand ha scritto molto bene su questo per la rubrica Sidecar di New Left Review, e ha posto alcune domande molto interessanti su cosa sia questa nuova fase che stiamo vivendo. Il neoliberismo non è più la descrizione giusta. Qual è? Ho un po’ di scetticismo sull’entità di quella rottura, ma in realtà sono piuttosto curioso di sapere cosa ne pensi.
I punti che hai sollevato prima sulle tensioni tra liberalismo e democrazia sin dal suo inizio sono davvero importanti. Penso che lo stiamo vedendo riemergere. La visione tradizionale della sinistra sul motivo per cui uno stato capitalista potrebbe semplicemente incrementare continuamente la spesa come hanno fatto alcuni paesi durante la pandemia coinciderebbe con una specie di visione kaletskyana, per cui si darà più potere ai lavoratori e l’accumulazione di capitale verrà interrotta in favore del lavoro, che è leggermente diverso dall’attacco al movimento operaio degli ultimi quarant’anni, visto anche il ruolo enorme che già era svolto dallo stato all’interno dell’accumulazione di capitale. La grande bugia del neoliberismo, che è stata smentita molte volte, è che ha comportato il restringimento dello stato, cosa che ovviamente non è avvenuta. Ha solo comportato un riorientamento dello stato e uno spostamento verso la definizione delle regole del gioco, verso un massiccio aumento della regolamentazione, in particolare nel settore finanziario, necessaria a sostenere la grande bolla speculativa. Non c’era meno stato, c’era un tipo di stato differente. Si trattava dell’erosione del potere dei lavoratori e dell’uso dello stato per aumentare il potere del capitale. Ma a tutto ciò si è unito anche il fatto che lo stato è più visibile e si è trovato in tanti ambiti della vita. La sfida oggi non deriva necessariamente dal fatto che se spendi più soldi c’è maggiore occupazione, facendo pendere così la bilancia a favore del lavoro. Oggi uno stato che sta facendo molte cose deve giustificare il motivo per cui sta facendo alcune cose e non altre. Deve essere in grado di giustificarlo a una popolazione che, soprattutto nei luoghi in cui il neoliberismo è stato più forte, è sempre più insicura, precaria, sottopagata e alle prese con servizi pubblici spaventosi. Stiamo assistendo anche a dimostrazioni molto evidenti e massicce del potere del capitale nei confronti dello stato, che si tratti di tagli alle tasse, sussidi o altro.
La sfida cui assistiamo, la corda tesa sulla quale molti politici liberali stanno camminando, è tra essere in grado di soddisfare i bisogni del capitale e usare lo stato per soddisfare i bisogni del capitale, pur dicendo che hanno tracciato un solco da qualche parte. Se siamo in un sistema democratico, devono dire che ci sono cose che non puoi chiedere. Non puoi chiedere loro di invertire la privatizzazione, o invertire le leggi antisindacali, o sottrarre alcune delle cose di cui hai bisogno per sopravvivere dalla logica del mercato, o concedere più case popolari. Questa sarà l’interessante domanda di legittimazione che questi liberali dovranno affrontare ora. Per la sinistra, la cosa più importante sarà chiedersi come affermiamo la democrazia e il nostro diritto di dire «no», in che modo possiamo effettivamente chiedere queste cose, reclamare e fare campagna per queste cose. Questo ci riporta di nuovo alla tensione tra liberalismo e democrazia.
Sembra che ci sia stato un momento durante la pandemia in cui sono sorte domande su equità, giustizia e su chi ottiene cosa in modo molto chiaro. Per la sinistra, si tratta di estendere quel regno della politicizzazione intorno alle domande su chi fa cosa, su quali forme di compenso ricevono, su come vengono classificati, su chi è essenziale e su chi e come può rispondere a queste richieste.
Probabilmente, una sfida più grande per il liberalismo a lungo termine e a parte il Covid è l’ascesa della Cina. Al momento, vediamo Joe Biden tentare di costruire l’asse anti-cinese. Probabilmente, molte delle concessioni che ha fatto, finalmente, sul fatto che ha bisogno di lavorare con l’Europa per reprimere l’elusione fiscale – principalmente a vantaggio dei giganti tecnologici statunitensi – hanno a che fare con il tentativo di incoraggiare i paesi europei a essere più assertivi sulla resistenza all’ascesa della Cina. Quali saranno le implicazioni per quello che alcuni chiamano l’ordine mondiale liberale? Chiaramente, questa crisi non è iniziata e finita con Trump. È qualcosa di molto più strutturale. Come reagiranno e risponderanno i liberali?
Chiaramente il modo in cui Trump ha proposto America First e la retorica di una nuova Guerra Fredda con la Cina c’erano già sotto la presidenza Obama. Sulla base del programma di Biden finora, e sulla base di questa incredibile intervista rilasciata da Hillary Clinton in cui ha parlato dell’ascesa della Cina e dei mezzi di produzione, Trump lo ha utilizzato in modo molto efficace come strumento retorico e di mobilitazione, ed è chiaro che Biden lo ha adottato. Un certo numero di misure di stimolo sono formulate dalla necessità di competere con la Cina: produzione di semiconduttori on-shoring o impedire che della tecnologia si approprino i cinesi, tutela della proprietà intellettuale, bisogno di una forza lavoro in grado di essere riqualificata e competitiva nei settori di maggior valore e così via. Tutto questo linguaggio sull’industria negli Stati uniti, il suo declino e il suo rilancio, viene codificato dalla retorica anti-cinese che sembra un manuale letteralmente distribuito ai leader dei Democratici al Senato, al Congresso e alla Casa Bianca.
Penso che sia qualcosa destinato a durare, e non lo vedo come uno sviluppo positivo, a differenza di alcuni a sinistra, che potrebbero pensare che sia un modo intelligente per ottenere priorità progressiste all’interno di vari atti legislativi. Mi pare piuttosto caratteristico del modo in cui il liberalismo può impiegare e utilizzare il nazionalismo. Il liberalismo non è sempre stato storicamente una dottrina cosmopolita senza radici: molto spesso impiega il nazionalismo in certi modi per ottenere risultati o per raggiungere il potere. Per pensare al caso britannico, gli imperialisti liberali erano una fazione numerosa nel Partito liberale all’inizio del ventesimo secolo. Hanno enfatizzato quest’idea di efficienza all’indomani della seconda guerra boera. La classe operaia che andò a combattere in quella guerra era malnutrita, considerata troppo bassa, e così via. Ci sono state ogni sorta di lamentele sul «ceppo razziale» del popolo britannico, che ha portato a provvedimenti di legislazione sociale progressista per assicurarsi che ci fossero controlli sanitari a scuola, o che cibo e latte fossero distribuiti. Questo è solo un esempio del modo in cui l’idea di efficienza e l’idea di impero possono essere uno sprone all’interno del liberalismo verso una legislazione sociale più progressista in patria. Il copione in uso con l’ascesa della Cina sembra abbastanza coerente, da un lato, con l’ottenimento di riforme sociali e, dall’altro, con le intenzioni imperiali. Nella storia del liberalismo spesso vanno di pari passo.
Semplicemente non c’è motivo di accettare quest’idea ipocrita da parte dell’Occidente, che è la fazione più potente. Un’altra questione importante da considerare in queste discussioni sulla politica estera è chi ha più da guadagnare da questo moralismo intorno all’idea di democrazia e diritti umani. Da Carter, al più tardi, sono gli Stati uniti. Se fossimo più specifici, potremmo parlare di come viene utilizzato nei differenti contesti: l’Iran, che è interamente circondato da basi militari statunitensi, come la Corea del Nord, così come la Cina o Cuba. Cuba ha ora sviluppato due vaccini basati su un settore delle biotecnologie che è uno dei più forti al mondo, con un embargo, a novanta miglia dalla costa della Florida, ma non possono avere le siringhe e le attrezzature tecniche di cui hanno bisogno. È un crimine e non ha nulla a che fare con le qualità morali di quel regime. La questione della politica estera e dell’imperialismo liberale è fondamentale per comprendere l’orientamento della sinistra. Corbyn rappresentava davvero una rottura con un Partito laburista che storicamente è sempre stato piuttosto nazionalista. Certo, questa era una delle cose più scandalose, e uno dei motivi per cui la destra laburista ha fatto di tutto per annullarlo.
Infine, perché non c’è un Economist di sinistra, e possiamo farne uno?
Leggendo l’Economist, e i suoi archivi, è abbastanza chiaro che la sinistra ne è sempre stata interessata. Marx leggeva l’Economist alla British Library negli anni Quaranta e Cinquanta per cercare di capire perché le rivoluzioni del 1848 erano svanite. A suo avviso, era dovuto in parte al miglioramento delle condizioni economiche, come ha dimostrato leggendo i prezzi, le quotazioni e gli indici sull’Economist. Isaac Deutscher, il grande biografo di Trotsky e storico della rivoluzione russa, scrisse per l’Economist e ne fu corrispondente durante la Seconda guerra mondiale su quanto stava accadendo nell’Europa orientale e in Russia. La sinistra è sempre stata affascinata dall’Economist, quindi mi vedo parte di quella tradizione che lo guarda come una tribuna della classe dirigente liberale, dell’aristocrazia finanziaria – così la chiamava Marx, «la tribuna dell’aristocrazia della finanza» – per comprendere l’orientamento politico di questi leader e mercati, come cambiano e come si spostano.
L’Economist svolge una funzione particolare per la classe dirigente globale. Ha sempre avuto un orientamento internazionale ed è sempre stato inviato all’estero a Buenos Aires, a Parigi, in tutte le città del mondo interessate al commercio e agli investimenti di capitali esteri. Strutturalmente, la sinistra, che è di opposizione, non egemonica e sta tentando di creare una nuova modalità politica, non avrebbe potuto creare organicamente qualcosa come l’Economist perché non può permettersi uno specchio del capitale come fa l’Economist. È forse un obiettivo della sinistra essere così comprensiva e totalizzante come l’Economist sia nel coprire il mondo intero, nel pensare ai modi in cui la politica interna e quella estera sono collegate, e nell’essere abbastanza esperta e chiara nei modi in cui l’emergere dei nuovi movimenti politici di sinistra in posti come il Messico o il Brasile non sfideranno solo i capitalisti nazionali, ma anche i capitalisti internazionali.
Non ho una risposta al motivo per cui la sinistra non ha un proprio Economist, ma sembra abbastanza strutturale per i modi in cui funzionano la sinistra e la classe dominante. Leggendo l’Economist, la sinistra ha trovato uno strumento per capire il capitale in modo chiaro. David Singer, un giornalista di sinistra che ha lavorato per l’Economist, una volta ha detto: «Nell’Economist puoi sentire la classe dirigente parlare e farlo abbastanza chiaramente». Forse la domanda non è esattamente perché la sinistra non ha un Economist, ma come la sinistra, leggendo l’Economist e prendendolo sul serio assieme alla sua visione del mondo, può rafforzarsi e impossessarsi del mondo che vuole ribaltare.
































Add comment