‘La nostra vita all’ombra delle stelle e strisce’
A. Aresu e L. Caracciolo intervistano Pietro Craveri
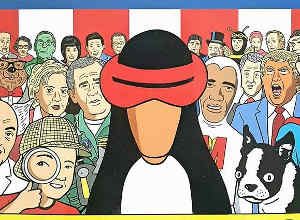 LIMES La Prima Repubblica nasce e muore con la guerra fredda. In quella fase, l’Italia è un semiprotettorato americano. Condivide questo giudizio?
LIMES La Prima Repubblica nasce e muore con la guerra fredda. In quella fase, l’Italia è un semiprotettorato americano. Condivide questo giudizio?
CRAVERI Francesco Cossiga è stato il primo a formulare il giudizio di un’Italia «semiservente». Un giudizio radicale giunto alla fine della guerra fredda come contraccolpo alla situazione interna, politicamente sempre più debole. È difficile non condividerlo. Nel corso della Prima Repubblica, dal 1946 al 1992 l’Italia è parte integrante della sfera d’influenza americana, cercando tuttavia di ritagliarsi i suoi spazi, di difendere i suoi interessi. Talvolta con successo.
LIMES L’Italia esce dalla seconda guerra mondiale sconfitta e umiliata. La sua costituzione geopolitica è il trattato di pace del 1947, che sancisce la catastrofe, malgrado la retorica pubblica che ci vorrebbe riscattati agli occhi dei vincitori dalla Resistenza.
CRAVERI Infatti il problema di Alcide De Gasperi e del suo ministro degli Esteri Carlo Sforza è mitigare le conseguenze del trattato di pace, che segna la condizione geopolitica di partenza della Prima Repubblica. Al Congresso di Parigi del 1946, De Gasperi riesce a chiudere solo la questione altoatesina, perché aiutato dal ministro degli Esteri sovietico Molotov. I sovietici avevano problemi in Austria, dove si trovavano di fronte un governo filo-occidentale. Su tutti gli altri fronti, nel dopoguerra immediato l’Italia è isolata: dagli inglesi filo-jugoslavi sull’Istria, ai francesi che non ci aiutano affatto, anzi cercano di sottrarci dei territori.
Gli americani sono ancora alle prese con un’opinione pubblica isolazionista. Ma l’unico che a Parigi si alza e stringe la mano a De Gasperi, dopo il suo discorso, aperto dalla constatazione che «tutto tranne la vostra personale cortesia è contro di me», è il segretario di Stato americano James Byrnes.
L’Italia sarà costretta a ripartire da una condizione molto dura. Dal punto di vista territoriale, oltre a parti rilevanti del nostro spazio storico, perdiamo tutti i possedimenti coloniali oltremare.
LIMES In quel frangente, è interessante osservare come De Gasperi fosse convinto della possibilità di conservare alcune colonie prefasciste, specie la Tripolitania. Non si rende conto che abbiamo straperso la guerra?
CRAVERI C’è un’effettiva insistenza da parte italiana sul problema coloniale che contrasta col buon senso e col gioco delle potenze europee. Siamo interessati a mantenere un piede in Libia, o in parti di essa. Con l’accordo Bevin-Sforza del 1949 gli inglesi avrebbero preso la Tripolitania, dove fra l’altro avevano trovato il petrolio. I francesi puntano sul Fezzan, loro frontiera imperiale in Nordafrica, all’Italia sarebbe stata restituita la Cirenaica. Quanto alle altre colonie italiane, gli inglesi hanno il progetto della Grande Somalia ma sono più morbidi sull’Eritrea. Gli spazi di manovra italiani risultano davvero minimi. Infine producono solo il mandato fiduciario sulla Somalia fino al 1960. Nella parte più avvertita delle classi dirigenti comunque la consapevolezza dell’inevitabilità della decolonizzazione è profonda. Per esempio, da Parigi l’ambasciatore Quaroni subito avverte dell’inevitabile ascesa del panarabismo.
Nell’opinione pubblica invece l’eredità coloniale è sentita. Fa parte di un’immagine consolidata, da non scalfire più di tanto. Lavorando per la biografia di De Gasperi, ho notato che egli scrive spesso i suoi appunti su carta intestata del ministero delle Colonie, di cui peraltro ha la delega come presidente del Consiglio. Il tema coloniale si trascina fino ai primi anni Cinquanta, persino dopo l’adesione alla Nato. Per la ragione di fondo, che anche a De Gasperi e a Sforza si pone come cogente la necessità di dare risposte a una rilevante quota dell’opinione pubblica italiana, moderata e tendenzialmente di destra, cresciuta nel mito della Grande Italia. Sono consapevoli della velleità di un futuro ancora coloniale, ma non vogliono perdere su questo punto, che ritengono sensibile, il consenso di una grande massa di elettorato che deve restare appannaggio della Democrazia cristiana e dei suoi alleati.
LIMES Nella trattativa sul trattato di pace si sarebbe potuto fare meglio o no?
CRAVERI No. De Gasperi è stato ingiustamente accusato di aver scelto l’Alto Adige a discapito di Trieste, ma la scelta non dipese da lui. Su l’Istria trovò un vero muro. Gli americani reagirono solo dopo l’occupazione di Trieste da parte delle truppe di Tito. Per un motivo strategico: non volevano che il porto finisse nelle mani dei russi, che attraverso la Jugoslavia stanno praticamente sul confine italiano. La rottura sovietica con Belgrado nel 1948 sposta il confine Est-Ovest, cambia lo scenario europeo. La cortina di ferro slitta verso est, sulla Drava. Di fatto la Jugoslavia entra nel sistema difensivo dell’Occidente, ne diventa il primo argine. E così riduce il valore strategico dell’Italia.
LIMES De Gasperi è consapevole delle forti limitazioni di sovranità imposte dal trattato? Come si muove per salvare i margini di manovra del nostro paese sulla scena internazionale?
CRAVERI Per dirla brutalmente, ci sono due carte che gli italiani possono giocare. Una è quella usata da tutti i principali partiti: c’è stata la Resistenza, e l’Italia è stata cobelligerante. Corrisponde a un’immagine fallace, costruita a fini propagandistici e diplomatici, irrealistica. Nelle memorie del segretario di Stato Usa, Dean Acheson, uno dei «saggi» che hanno disegnato la strategia americana nella guerra fredda, c’è un brano che riprende un incontro con i negoziatori italiani sulla Nato. Acheson commenta di aver capito come sono fatti gli italiani: credono di poter far passare l’idea di aver cancellato la sconfitta grazie ai combattenti partigiani e alla cobelligeranza. Ma questa nostra narrazione non è condivisa dagli Usa, tantomeno da inglesi e francesi. Anche i sovietici non la tengono in alcun conto nei rapporti diplomatici.
L’unica carta concreta in mano al nostro governo nell’immediato dopoguerra è dunque, col maturare della guerra fredda, l’anticomunismo, quasi ingiocabile al tempo del negoziato sul trattato di pace, quando il Pci, insieme al Psi allora ancora filosovietico, partecipavano alla guida del paese. Questa carta acquista peso negli anni successivi. De Gasperi e Sforza si muovono consapevoli di questo scenario e delle reali forze in campo. Sforza fra l’altro conosce bene gli americani, anche per i suoi probabili legami con la massoneria americana.
LIMES Qual è l’approccio americano alla nascente Repubblica Italiana, nel contesto della guerra fredda?
CRAVERI Tra il 1947 e il 1950 si costruisce l’impero americano in Europa. Ciò avviene attraverso una svolta nella geopolitica statunitense, profonda ma lenta, perché sconta un’opinione pubblica ancora isolazionista. Negli apparati governativi di Washington questo si traduce, prima della fondazione della Nato, nella tentazione di controllare l’Italia e l’Europa occidentale dall’esterno, senza impegnarvi larghi contingenti militari.
Se vogliamo tornare al ruolo più o meno servente dell’Italia nell’impero americano, dobbiamo ricordare per sommi capi la nostra parabola dal trattato di pace alla fallita costruzione di una difesa europea (1947-54).
Il Piano Marshall esprime nel 1947 la consapevolezza americana di dover intervenire urgentemente sul piano economico per impedire che in Europa occidentale penetri l’influenza comunista. Il problema dell’Europa è anzitutto, come sempre, il cosa fare della Germania. Su questo gli americani non hanno idee chiare e definitive. Pensiamo solo alle tesi di Henry Morgenthau sull’annientamento del Reich, da demilitarizzare e deindustrializzare radicalmente.

L’immediato dopoguerra è drammatico per tutti gli europei, vincitori inclusi. Si fa la fame, le capacità produttive sono drasticamente ridotte, milioni di profughi e sbandati sono in movimento. Serve l’aiuto americano. De Gasperi ne è perfettamente consapevole e si muove di conseguenza. Non solo con Truman, anche con i più influenti leader dell’opposizione repubblicana. Negli Usa uno dei colloqui più importanti lo ha con il leader repubblicano del Senato, Arthur Vandenberg, e si sente dire: «Noi vi diamo gli aiuti, ma un domani l’Italia con chi starà?».
E soprattutto, della drammatica crisi europea si rende conto la classe dirigente americana, rappresentata al meglio nell’amministrazione Truman dagli wise men, Marshall e Acheson su tutti. L’alto commissario per la Germania, McCloy, capisce l’urgenza di far ripartire l’economia tedesca. Questa visione prevale sui sospetti e sulle riserve inglesi e francesi, segnate dalla paura del risorgere della potenza tedesca. La consapevolezza di dover salvare la Germania dal comunismo, e con essa l’Italia e il resto dell’Europa non occupata dall’Armata Rossa, è la ragione costitutiva dell’idea americana di unificare il mercato europeo occidentale. È notevole che questo resti, settant’anni dopo, l’unico vero successo dell’europeismo, mentre sono falliti i tentativi di formare una difesa comune (Ced) o addirittura di forgiare una terza forza europea, polo più o meno autonomo fra Usa e Urss.
Sul modo di difendere la loro Europa gli Stati Uniti restano a lungo indecisi, quasi fino all’elezione di Truman, nel 1948, che al loro interno è l’ultimo passaggio necessario. La concezione e la strutturazione della Nato cominciano dopo il lancio del Piano Marshall. Processo distinto quindi dal programma economico, anche se strategicamente connesso. In questa fase è importante tenere conto del trattato di Bruxelles (1948), primo abbozzo di difesa euroccidentale, sul quale il nostro governo fu piuttosto scettico. È iniziativa inglese: Bevin si ritira dal Mediterraneo, smantella l’impero, punta ad affermarsi come capofila in Europa. I francesi non ci stanno. Per questo coltivano un europeismo strumentale, in chiave antitedesca e di supremazia rispetto agli inglesi.
LIMES Nel 1949 però i francesi sono decisivi per farci entrare nella Nato.
CRAVERI Certo. Il punto è che le potenze europee uscite più che ridimensionate dalla guerra si rendono conto che senza tirar dentro gli americani è inutile parlare sul serio di difesa comune. Questo ci porta alla Nato, fondata nell’aprile 1949. Gli americani non hanno grande interesse a farci entrare. Ci aiutano quanto a forniture militari, come fanno con la Turchia e la Grecia, ma non ci vedono subito nell’Alleanza Atlantica. Gli inglesi sono fortemente contrari. È vero: ci aiutano i francesi. I quali hanno l’Algeria da difendere, quindi hanno bisogno dell’Italia come testa di ponte del territorio algerino, che considerano metropolitano.
L’adesione dell’Italia alla Nato non è affatto scontata. Abbiamo seri problemi interni. L’opposizione non è solo delle sinistre, ma anche nel mondo cattolico. La dissociazione di Giuseppe Dossetti, contrario al vincolo atlantico, è il caso più evidente. Senza il discorso natalizio di Pio XII nel 1948, che chiama gli occidentali a difendere la cristianità contro l’ateismo comunista, non saremmo entrati nella Nato dall’inizio. La Santa Sede capisce che l’alternativa è tra essere protetti e non esserlo. Lo schieramento di Pio XII per l’America, contro il parere di diversi esponenti della Chiesa italiana, è decisivo. Papa Pacelli dimostra in questo come in altri casi grande lucidità geopolitica, rara consapevolezza dello scacchiere globale e di come difendere la Santa Sede nella contrapposizione fra Occidente ed Oriente comunista.
LIMES Il latente neutralismo italiano, confermato anche dopo l’adesione alla Nato, ha avuto conseguenze sugli assetti interni e internazionali?
CRAVERI Sugli assetti internazionali, un effetto molto relativo. L’Italia nella guerra fredda è presa per quello che è, in base alla valutazione realistica degli altri attori. Vale per la sua collocazione geografica e geopolitica, malgrado i suoi limiti interni. Questi limiti diventano ancora più evidente con la guerra di Corea (1950-53), che fa compiere un salto ulteriore nella dinamica della guerra fredda.
Sugli assetti interni c’è un aspetto poco indagato nel quale De Gasperi si cimenta. L’Italia non ha allora, né credo abbia adesso, una legislazione di guerra. Lo statista trentino tenta di produrre alcune leggi in materia, come la così detta «polivalente», di cui sopravvive solo la legge Scelba, che vieta la ricostituzione del partito fascista. Ma il vero problema non è la rinascita del fascismo, è la presenza nascosta nel nostro paese di un apparato militare comunista agli ordini di Mosca. Quello che De Gasperi designa come la «quinta colonna interna». Su questo la controversia storiografica è ancora molto vivace. A partire da una certezza: nel dopoguerra l’apparato militare del Pci, guidato da Secchia, esiste eccome. Ed è ben organizzato, piuttosto potente. Certo, non ne conosciamo la forza effettiva. Abbiamo però al riguardo copiosi documenti americani e italiani, nonché sovietici, ripresi nei loro libri da Viktor Zaslavskij e Elena Aga Rossi. Vi si riportano gli incontri dell’ambasciatore sovietico con Secchia, nel marzo del 1948, alla vigilia delle elezioni politiche più importanti della nostra storia, in cui si sfidano lo schieramento moderato imperniato sulla Dc e il fronte social-comunista. L’esito è incerto fino all’ultimo. Secchia afferma di poter bloccare in una settimana la Linea Gotica. Da documenti russi si ha poi notizia di un incontro segreto fra l’ambasciatore sovietico con Togliatti, sul lago di Nemi. Il capo del Pci vuole sapere da Mosca che cosa fare in caso di vittoria. La sconfitta elettorale indebolirà moltissimo l’apparato e l’eventuale opzione insurrezionale affidata da Stalin, non a Togliatti, ma a Secchia. Negli anni Cinquanta il «braccio armato» che aveva costituito e di cui si fa cenno nei verbali pubblicati da Silvio Pons sugli incontri di Secchia a Mosca, viene liquidato, anche se restano ancora alcuni depositi di armi, per lo più progressivamente liquidati dopo il 1952.
LIMES Abbiamo inquadrato il nesso inziale fra Prima Repubblica e guerra fredda, quasi due facce della stessa medaglia. Non stupisce quindi che i due assetti, interno e internazionale, stiano e muoiano insieme, quarant’anni dopo. Concorda sul fatto che anche la nostra adesione a Maastricht abbia profondamente contribuito alla fine di quell’assetto interno? Ci siamo suicidati?
CRAVERI Guido Carli, allora ministro del Tesoro, figura assolutamente centrale lungo le vicende attraversate dal nostro paese durante la Prima Repubblica (gli americani e gli europei avevano grande considerazione della sua competenza) ha posto la questione nei termini più chiari e brutali: fuori da Maastricht, noi non saremmo stati in grado di amministrarci. Era convinto che solo uno stretto vincolo esterno poteva frenare la dissennatezza delle nostre politiche del bilancio. Infatti, mentre Carli è impegnato nella trattativa che avrebbe condotto alla camicia di forza di Maastricht, a Roma gli gonfiavano il bilancio pubblico in modo spaventoso. Maastricht è l’atto conclusivo della politica europea della Prima Repubblica ed anche quello che più contribuisce a determinarne la fine. Mentre si allentavano i legami con gli americani e le coperture che comportavano, si stringono più forte quelli europei, senza la piena consapevolezza di ciò che avrebbero determinato.
LIMES Carli era consapevole delle implicazioni di Maastricht in termini di sovranità nazionale. Ma il resto della classe politica lo era?
CRAVERI Non come Carli. Solo Ugo La Malfa e pochi altri lo erano stati, come poi, negli anni Ottanta, i repubblicani e ad esempio Andreatta. Ho consultato nelle carte di Andreotti la cartella «Maastricht». C’è una noticina a mano in cui dice: sarà duro, ci complicherà la vita, sono le cose che avremmo dovuto fare con l’articolo 81 della costituzione, e adesso bisognerà farle per forza a causa del vincolo europeo.
Ma non è solo la politica economica. Maastricht cambia il quadro geopolitico continentale. È rottura totale dell’idea di un’Europa federale, celata dietro al funzionalismo economicistico di Jean Monnet, di cui Jacques Delors, con l’Atto Unico, realizzò l’ultima grande espressione. La bussola si sposta dall’orizzonte sovranazionale, potenzialmente federale, a quello intergovernativo, che può comportare soltanto un esito confederale. Non capisco questa improvvisa scoperta del cosiddetto «sovranismo». È Maastricht che fonda il «sovranismo», o meglio la prevalenza dei rapporti di forza fra Stati nazionali nell’ambito comunitario.
Quanto alla nostra politica economica, la verità è che noi propriamente non ne avevamo alcuna. Gli anni Ottanta del Novecento passano per un periodo di grande sviluppo. Ma dobbiamo saper guardare oltre l’euforia del «sorpasso» sulla Gran Bretagna. Il punto è che alla fine di quel decennio comincia a crollare la nostra grande industria, quella che oggi non abbiamo più, escluso il poco rimasto del vecchio nucleo dell’economia mista. Oggi siamo un paese manifatturiero privo ormai di struttura nazionale. Quel passaggio comincia allora. Alla crisi spaventosa delle partecipazioni statali corrisponde la loro liquidazione dissennata, di cui pochi, tra cui Giuseppe Guarino, si resero conto.
In ogni caso, la Prima Repubblica non può reggere per via dell’enorme fragilità della struttura economica e dello Stato italiano. Mancano, o almeno vanno drasticamente riducendosi la protezione americana determinata dalla guerra fredda e così non si poteva che aprire una fase di incertezza e declino. Pensiamo a Mani Pulite: la magistratura si sarebbe forse sentita così libera di muoversi, in un’altra fase? Gli americani non glielo avrebbero permesso, anche se non è ben chiaro a quale gioco giocassero in quella congiuntura.
LIMES Ma quanto ha contato davvero l’America nella fine della Prima Repubblica?
CRAVERI Credo abbia contato molto. Dei diversi fattori che si possono portare, faccio due esempi che riguardano i socialisti e Craxi: un passaggio chiave della crisi della Prima Repubblica è stato lo scandalo Eni-Petromin. In quel caso, chi diede le carte a Leonardo Di Donna, dirigente dell’Eni, che poi le passò ai socialisti vicini a Craxi, sono sicuramente gli americani. Quando i giudici di Milano mandarono la Guardia di Finanza a Villa Wanda, tra le carte di Gelli viene ritrovato l’appunto del conto «Protezione», che sarà uno dei maggiori capi di accusa di Mani Pulite, su cui, già allora, dalla procura di Milano viene richiesta la documentazione alla magistratura di Lugano, che non manda nulla. Finché, dieci anni dopo, non interviene il magistrato elvetico Carla Del Ponte, che poi svolgerà un’importante carriera da funzionario internazionale.
Altro esempio sulla fine di Craxi. Prima di Sigonella, il ruolo del leader socialista nella politica estera italiana è marcato dalla sua capacità di stabilire un rapporto diretto con Washington, persino migliore di quello acquisito dai democristiani. Questo primato gli deriva dalla scelta sugli euromissili. Senza la disponibilità di Craxi a schierare i missili Cruise a Comiso, la Germania non li avrebbe accettati sul proprio territorio, perché esigeva una diversificazione del rischio. L’Italia di Craxi è la chiave in questa vicenda decisiva per la vittoria dell’Occidente nella guerra fredda.
Poi, Sigonella cambia tutto. Craxi voleva rimandare indietro Abu Abbas, il terrorista palestinese protagonista nel 1985 del sequestro della Achille Lauro e dell’assassinio del cittadino americano Leon Klinghoffer. Nella notte Reagan telefona a Craxi. Da interprete funge Michael Ledeen, agente dell’intelligence americana. La traduzione errata che egli fa, induce Reagan a credere che Craxi riconsegnerà agli americani Abu Abbas. Quando il nostro presidente del Consiglio, dopo aver schierato i carabinieri a Sigonella per impedire che gli americani portino via Abu Abbas, libera quest’ultimo, a Washington sono furiosi. Per la cosa in sé e perché Craxi avrebbe mentito al presidente. Craxi tiene duro. A quel punto gli americani rivedono la traduzione – avevano registrato la telefonata, cosa che gli italiani incautamente non avevano fatto – e danno atto a Craxi della correttezza formale del suo comportamento, tanto da fornirgli un «telefono rosso», come quello di Mosca, Londra, Berlino e Parigi, che resterà eredità permanente dei nostri presidenti del Consiglio.
La ferita di Sigonella, e la fermezza con cui Craxi si è opposto alla volontà degli Stati Uniti, probabilmente non è stata mai del tutto risanata. Come si sa bene i comportamenti dell’amministrazione americana non derivano da un solo centro di potere, seguono gli indirizzi politici del presidente, ma restano molteplici e diversificati nella visione dei problemi e nella determinazione degli obiettivi. Col mutare delle circostanze – e la fine della guerra fredda non ha costituito un passaggio marginale – mutano gli orientamenti, compaiono sulla scena nuovi obiettivi e tornano anche opinioni già consolidate. Gli storici del futuro potranno forse stabilire quanto e come quell’episodio abbia poi in parte contribuito al crollo della Prima Repubblica. Ma negli anni Novanta non torna in gioco soltanto l’episodio di Sigonella, c’è altro da parte americana. Certamente sono venuti meno molti di quei fattori di controllo e copertura, nella politica internazionale ed anche in quella interna, con cui solo gli americani allora potevano garantire la classe politica italiana. Questo mutamento di inclinazione dell’attenzione americana verso l’Italia non è stato elemento determinante nel crollo della Prima Repubblica, ma ha avuto certamente il suo peso.

































Add comment