Invito a ragionare
di Pierluigi Fagan
 Dopo il festival di Sanremo ma prima del festival di Cannes, si terrà a Roma, nel secondo week end di maggio, l’inaugurazione della decima edizione del Festival della complessità. Gli amici del comitato promotore a cui quest’anno do una mano, mi hanno chiesto di tenere per un mesetto il blog collegato all’iniziativa che durerà poi tutta l’estate con molti incontri organizzati in tutta Italia.
Dopo il festival di Sanremo ma prima del festival di Cannes, si terrà a Roma, nel secondo week end di maggio, l’inaugurazione della decima edizione del Festival della complessità. Gli amici del comitato promotore a cui quest’anno do una mano, mi hanno chiesto di tenere per un mesetto il blog collegato all’iniziativa che durerà poi tutta l’estate con molti incontri organizzati in tutta Italia.
Apriamo quindi il percorso di avvicinamento a quel primo incontro con questo post che verte su una cruciale questione relativa non a questo o quel pensiero o sistema di pensiero, ma su come componiamo i pensieri in genere. Pensare è sempre pensare a qualcosa ed è attività talmente istintiva che pensiamo tutti di poterlo e saperlo fare, siamo tutti esperti nel pensare ricevendo in eredità la funzione dalla lunga storia del nostro genere Homo, viepiù se sapiens.
Pensare a come pensiamo è una di quelle situazioni riflessive (la cosa applicata a se stessa che comincia dalla coscienza di avere coscienza) che apre un mondo diverso, non quello che vede noi alle prese con le cose del mondo, ma noi alle prese con noi stessi. E’ attività poco divertente o meno divertente che non pensare a questo o quello e poi buttarsi a capofitto nella polemica con chi la pensa diversamente, un po’ come la scuola guida rispetto al viaggiare verso una meta.
Alle volte però è necessario perché non sempre come facciamo le cose produce di per sé la miglior soluzione. Apriamo dunque con l’invito a pensare le cose “nel loro complesso”. Ma cosa significa pensar la cosa nel suo complesso?
Eccovi l’articolo sul sito del festival: qui.
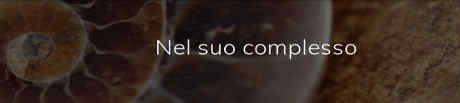
Stavo leggendo in questi giorni un vecchio e molto citato saggio addirittura del 1917, forse più citato che letto, di fisica-biologica: “Crescita e forma” di D’Arcy W.Thompson[1]. D’Arcy è, a volte, citato in letteratura della complessità poiché tende a leggere cose biologiche in senso morfologico evidenziando i vincoli di quella struttura che poi è l’organizzazione di un sistema. Egli stesso è il fondatore della morfogenesi poi molto influente per il successivo sviluppo della biologia dello sviluppo e quindi degli sviluppi “evo-devo” (Evolutionary Developmental Biology) dell’evoluzionismo. Vi sono gradi di parentela tra morfogeni, teoria dello sviluppo e teoria delle catastrofi di René Thom, una delle teorie ausiliarie del programma di ricerca del pensiero complesso. L’opera di D’Arcy, ha sollecitato dai biologi J.Huxley e C.H.Waddington (epigenetica) ad Alan Turing, dallo strutturalista C. Levy-Strauss a molti architetti ma anche il paleontologo S. Jay Gould e la sua idea degli equilibri punteggiati. Da ultimo l’ho trovato ampiamente citato in “Scala”, Il libro di Geoffrey West a lungo direttore del Santa Fe Institute[2], fucina del pensiero complesso di taglio scientifico, che tenta il varo di una nuova scienza “della crescita, dell’innovazione, della sostenibilità” degli “organismi, delle città, dell’economia e delle aziende”, programma tipicamente inter-disciplinare, quindi complesso.
Per certi versi, D’Arcy, potrebbe esser scambiato per un riduzionista poiché sembra disinteressato a gli specifici della chimica e di buona parte della successiva biologia o degli apporti altrettanto limitanti della stessa termodinamica, riducendo molto del biologico alla fisica con corredo di geometria e matematica. Per questa sua tendenziale riduzione, D’Arcy è anche andato in parziale conflitto con molti darwinisti poiché nei suoi casi di studio sembra dire che molto delle forme e dei loro cambiamenti, nel vivente, sottostanno in primis a semplici leggi fisiche, sono cioè vincolati. Ci sarà poi pure adattamento, eredità ed evoluzione, ma dentro confini di possibilità ben definiti. Evidenziando vincoli di struttura, in effetti non nega un ruolo successivo delle dinamiche classiche dell’evoluzionismo, sottrae però a queste l’onnipotenza descrittiva ed esplicativa. Non è quindi esattamente un riduzionista, semmai svolge dialetticamente un ruolo di ampliamento del riduzionismo genetico che tutt’oggi ha una certa diffusione.
Nel penultimo capitolo dove s’avvia ad andare più vicino alla polemica con i “darwinisti ortodossi”, il penultimo paragrafo ha il semplice titolo: “L’animale nel suo complesso”. Sarà che stavo proprio scrivendo di complessità per un nuovo libro, ma questa semplice espressione “nel suo complesso” mi è sembrata illuminante, espressione che è tutt’altro che strana usandola noi tutti nel linguaggio comune. Eppure, quante volte davvero pensiamo l’oggetto, il fatto, la relazione tra testo e contesto, nel “loro complesso”?
D’Arcy ha gioco facile a ricordare a gli evoluzionisti che “Quando analizziamo una cosa inparti separate, tendiamo a dare a queste una eccessiva importanza, esagerandone l’apparente indipendenza, nascondendo a noi stessi (almeno per il momento) l’integrità essenziale dell’insieme composto”[3]. Si noti il linguaggio molto razionale e tutt’altro che mistico, non si tratta di un appello di principio all’olismo, si tratta di nudo realismo. Quel “Esagerare l’indipendenza”, ad esempio, è isolare singoli fatti o singoli temi letti da singole discipline e poi imbastire quelle tanto assurde quanto voluminose polemiche da dibattito pubblico o specialistico in cui non stiamo discutendo le cose ma solo il come ragiona il nostro avversario. Dargli “troppa importanza” e non mediarli nelle relazioni ontologiche che hanno, è descrivere cose senza le relazioni, nascondere a noi stessi la complessità intrinseca delle cose anche se solo “per il momento”. Ma questa riduzione momentanea, purtroppo poi diventa definitiva. In fondo lo sappiamo che stiamo ritagliando un batuffolo da una nuvola, ma poi ci dimentichiamo colpevolmente di questo atto di ritaglio e pensiamo davvero esistano i batuffoli.
Aggiunge D’Arcy: “Dividiamo il corpo in organi, lo scheletro nelle ossa …” e tra l’altro l’autore aveva da poco dato una efficace descrizione scientifica di come le singole ossa non possono comprendersi per forma e generazione se non collegate nel sistema scheletrico, ma precedentemente aveva anche dato una efficace immagine di straniamento che lui provava quando, nei musei di storia naturale, vedeva gli scheletri degli antichi animali ricostruiti tutti assieme ma senza i muscoli. Nessuno scheletro si terrebbe in piedi o si muoverebbe o mai sarebbe neanche esistito se non in accoppiamento ai suoi muscoli. La stessa logica della lunghezza delle ossa, il loro connettersi a tondeggiarsi, il loro frazionarsi in segmenti minuti, non può esser compresa come fossero pezzi di puzzle creati prima del puzzle stesso.
Ed ancora ed a proposito della, allora da non molto nata, psicologia “… sappiamo benissimo che giudizio e conoscenza, coraggio o gentilezza, amore o paura non hanno esistenza separata ma sono in qualche modo manifestazioni o coefficienti immaginari di una totalità estremamente complessa”[4]. Vengono in mente certe assurde trattazioni della prima sociobiologia o di certi autori best-seller di psicobiologia. Allora perché lo facciamo, se “… il ponte viene smontato non è più un ponte e tutta la sua forza è finita”, quindi perdiamo la sua stessa ragion d’essere? Perché lo facciamo se la sua stessa “utilità” derivata dalla forma nel suo complesso, ci diventa incomprensibile?
Secondo D’Arcy Thompson i singoli aspetti, le parti, “Possiamo studiarli separatamente, ma è una concessione alla nostra debolezza e ristrettezza di visione delle nostre menti” ed ancora “sono entità separate soltanto nel senso che sono parti di un tutto che quando perde la sua integrità composita cessa di esistere”. Lo scozzese poi cita Aristotele[5] che molti ignorano essere l’origine di quel pensiero attribuito poi a Christian von Ehrenfels, padre della psicologia della Gestalt, che recita: “Il tutto è maggiore della somma delle parti” (1890), per molti versi il manifesto di sviluppo dell’intera cultura della complessità.
Ecco il punto, sapere di non sapere è sapere che l’oggetto travalica di molti gradi le nostre capacità mentali, è una lezione di modestia (o quantomeno contenimento della hybris) ma anche di realismo conoscitivo che tanto più accettiamo tanto più ci apre ad un futuro sviluppo del pensiero complesso. A volte questo problema del tanto da conoscere in rapporto problematico al poco delle nostre facoltà conoscitive, prende la stereotipata forma del realismo delle cose che ci sono pragmaticamente da fare. Conflitto tra un presunto realismo che si accontenta di una qualsiasi riduzione pur di portar risultati concreti ed un vago idealismo della conoscenza perfetta che preme per aumentare a dismisura i livelli di conoscenza inseguendo l’indomabile complessità. Ma non è così, “adeguare intelletto e cose”, per molti casi che non quelli relativamente più semplici che abbiamo selezionato nei primi quattrocento anni della nostra avventura scientifica, tecnica e più in generale conoscitiva moderna, è capire la cosa nella sua realtà e la sua realtà è la sua completezza.
La cultura della complessità, classicamente, denuncia questa riduzione che nasce provvisoria e diciamo con limitati intenti “operativi”, ma che poi -per necessità cognitive, ma anche per precise scelte culturali- scambia l’oggetto irrelato per l’oggetto in sé, e lo fa proprio in tradizione con queste idee che D’Arcy sottolineava del 1917, un secolo fa. Prima lo aveva fatto von Ehrenfels nel 1890, poco prima anche l’ontologo Alexius Meinong a cui si deve il termini “complessione”, allievo come von Ehrenfels , Husserl, i primi logici polacchi[6] e lo stesso Freud, del filosofo e psicologo Franz Brentano, strenuo aristotelico ontologico. Ma si potrebbe anche retrocedere al Goethe di “E’ possibile scomporre il vivente nei suoi elementi, ma non ricomporlo da questi e ricreare la vita” e forse ancor prima, poiché questa era obiezione già posta da G. B. Vico a Cartesio.
= = =
Passando dall’archeologia dei concetti all’attualità, chi come noi opera dentro e per losviluppo di una cultura della complessità che unisca gli apporti scientifici a quelli umanistici ripristinando una teoria della conoscenza[7] generale che non sia solo epistemologia e che parta da una ontologia sistemica, dovrebbe farsi carico di questi problematici aspetti della riduzione. Lo sviluppo delle scienze cognitive, ci dice che quella riduzione ha ragioni oggettive per tentar di far entrare il vasto mondo o gli oggetti e i fenomeni nel “loro complesso” nella nostra singola, ristretta mente. I tavoli inter-multi-intra disciplinari, già tradizione di questa cultura ai tempi della Conferenze Macy (anni ’50) o dei tentativi di von Bertallanfy di istituire cattedre inter-disciplinari nelle università canadesi, possono espandere questa ristretta riduzione ma rimane il problema che un gruppo umano non è dotato di un singolo “Io penso” in grado di produrre un sintetico pensiero intenzionale. Come dicono gli inglesi, “un cammello è un cavallo disegnato da un comitato”, va bene il sistema pensante auto-organizzato ma dovremmo anche evolvere quel sistema nelle singole menti, pur nei limiti delle nostre limitate facoltà pensanti. La riduzione nonn va solo denunciata, è un problema oggettivo da risolvere.
Per far questo, occorrerebbe quindi inoltrarci più a fondo sulla strada delle sintesi, delle sintesi di sintesi, della produzione funzionale e non esibizionistica di nuovi concetti (evitando i “post” e l’ultra-aggettivazione), di metodi plurali che tuttavia -alla fine- pervengono ad una forma di pensiero singolare, una per ogni pensante e quindi di nuovo plurale da sintetizzare ancora in un processo ricorsivo che non ha limite finale. La “sfida della complessità” è la sfida alle nostre facoltà e modalità conoscitive, a volte un po’ troppo sazie e celebrate a seguito dei primi successi di questi ultimi quattro secoli. All’inizio le cose sono sempre più semplici, e quando ci si inoltra nella “selva oscura” dell’intessuto assieme, che si smarrisce la diritta via e noi -oggi- siamo proprio alla soglia di quell’inferno.
Proprio di questi confusi tempi in cui sembra che il nostro mondo stia affogando in un inquieto oceano mosso di complessità crescente, dovremmo farci carico di tornare a pensare a come pensiamo, più che partecipare alla rissa quotidiana delle opinioni estreme che agita il dibattito pubblico, a volte anche quello specialistico, più per nevrosi che per costrutto. Cosa ci serve per sviluppare modi di pensare che trattino cose e fenomeni “nel loro complesso”? Apriamo il dibattito in vista della decima edizione del nostro Festival di maggio.
































Comments
Ebbene, il considerare questo continuo affluire di segni, espressioni artistico-letterarie, strutture logico-formali embrionali che si evolvevano fino a visioni del mondo compiute e a loro volta in continua trasformazione e interscambio, eventi storici, scoperte e tappe parallele di un progresso scientifico-tecnologico e di cultura materiale parallelo al nostro, all'interno dell'unica scienza, la scienza della storia, mi è servito ENORMEMENTE. Così come mi è servito enormemente il tirocinio pluriennale presso gli immigrati cinesi, indiani, pachistani, bengalesi: imparavo più io da loro che loro da me.
Anche in questo caso, studiato e vissuto, teoria e prassi, mi aiutavano a mettere sempre più a punto caselle piene e a riempire caselle vuote, piuttosto che a mettere in discussione concetti che davo per assodati, anche in modo radicale, oltre che a individuare fra componenti vicini e lontani utili nessi, passaggi sincronici e diacronici, scorciatoie logiche, ipotesi di lavoro e primi abbozzi di tesi da vagliare con lo stesso rigore metodologico con cui avevo fino a quel momento costruito un bagaglio sempre più solido e coerente. Aggiungere capitoli sempre nuovi e avvincenti, come quello degli studi slavistici e dell'Asia Centrale, con puntate in Turchia e Persia, è stato per me null'altro che un proseguire, meglio, un seguire tracce, triangolare elementi già in mio possesso con altri assolutamente estranei fino ad allora; usando sempre l'analogia a me cara della Montagna, attaccando nuove pareti di roccia, picchettando, arrampicandomi ulteriormente, e guardando la visione d'insieme da una prospettiva sempre più ampia.
Certo, un nipponista vero mi dà la paga, così come uno slavista, e via discorrendo. Il mio è un sapere tutt'altro che enciclopedico, anzi, con innumerevoli lacune. Tuttavia, un metodo di studio fondato su una solida mappa mentale, frutto di un'applicazione rigorosa del principio sopra elencato, che poi altro non è che quello del materialismo storico, nel tempo e nello spazio, lungo tutti i flussi e le direttrici parallele socialmente e storicamente date, mi consente presto di trovare le coordinate per approfondire ciò che mi interessa, agganciarlo a quanto già consolidato (o correggendolo, in toto o in parte), e continuare a triangolare, puntellare, ampliare la vista d'insieme, e via discorrendo, ampliando sempre più quell'edificio della conoscenza e del sapere che è il primo segno di liberazione.
Questo se mi fossi dedicato, per esempio, anima e corpo allo studio del teatro No, ovvero avendo ciò come unico orizzonte di ricerca e specializzazione, chiudendo i passaggi verso tutti gli altri compartimenti, in quanto "perdita inutile di tempo e di risorse", con tutto rispetto per chi pratica, ad altissimi livelli, lo studio questa disciplina, non sarebbe stato possibile.
Allo stesso modo, e peggio ancora, non sarebbe stato possibile se avessi iniziato a vagare da una disciplina all'altra, un po' di qui, un po' di la, costruendomi una specie di baracca traballante entro cui rifugiarmi e da cui, peggio ancora, cominciare a diffondere eventuali "scoperte", affermando tutto e il contrario di tutto, magari secondo la mia convenienza opportunistica di turno (molti "guru" di ogni tempo e "stelle", di fatto, hanno fatto e fanno così).
La complessità non è una sfida: è un traguardo da raggiungere, passo dopo passo, mattone su mattone, giorno dopo giorno, lungo una vita intera. E, quando si pensa di averlo raggiunto, ci si rende conto che si è solo all'inizio, come nello studio delle arti marziali, dove dopo la cintura nera c'è ancora la cintura bianca, ovvero quella con cui lo studente entra per la prima volta nel dōjō (道場).
Paolo Selmi