Fai una donazione
Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________
- Details
- Hits: 3444

Un teorico ribelle alla gabbia della realtà
Roberto Ciccarelli
Il volume di Marcello Musto da poco pubblicato da Carocci è una cartografia puntuale sulla riflessione e il progetto di ripubblicare tutte le opere di Karl Marx. Con l'obiettivo di sottrarre l'autore del «Capitale» a una lettura accademica
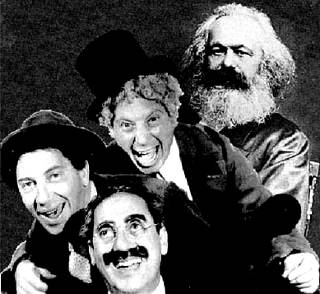 Praticare la chirurgia dei tagli su Marx - ha scritto Maximilien Rubel - significa effettuare l'ablazione di ciò che nel suo pensiero si oppone a ogni marxismo inquisitorio e a ogni comodo liberalismo. In questo assunto, collocato da Marcello Musto in esergo al suo volume Ripensare Marx e i marxismi (Carocci, pp.373, euro 33), possono essere riassunte le vicende editoriali, filologiche e politiche che hanno visto protagoniste - per oltre un secolo - le pagine parzialmente edite, o del tutto inedite, dell'opera marxiana. Finalmente sottratto alla conoscenza approssimativa di un testo, di cui a lungo si è conosciuto solo il mito ma non la lettera, oggi Marx sembra tornare a parlare in prima persona.
Praticare la chirurgia dei tagli su Marx - ha scritto Maximilien Rubel - significa effettuare l'ablazione di ciò che nel suo pensiero si oppone a ogni marxismo inquisitorio e a ogni comodo liberalismo. In questo assunto, collocato da Marcello Musto in esergo al suo volume Ripensare Marx e i marxismi (Carocci, pp.373, euro 33), possono essere riassunte le vicende editoriali, filologiche e politiche che hanno visto protagoniste - per oltre un secolo - le pagine parzialmente edite, o del tutto inedite, dell'opera marxiana. Finalmente sottratto alla conoscenza approssimativa di un testo, di cui a lungo si è conosciuto solo il mito ma non la lettera, oggi Marx sembra tornare a parlare in prima persona.Musto ne ripercorre l'avventurosa genesi alla luce della nuova edizione delle opere complete - la cosiddetta «Mega 2» che prevede la pubblicazione di 114 volumi. Tra i molti Marx che continuano ad essere indispensabili, ne segnala almeno tre. Quello ossessionato dalla miseria economica, dalle tragedie familiari e dalle tumultuose vicende politiche che videro la nascita della Prima internazionale, insomma il vissuto storico che molti anni fa nutrì un'enorme quantità di biografie e storie politiche. Oggi questi libri è difficile trovarli persino sulle bancarelle dell'usato.
Musto si sofferma anche sul Marx critico del modo di produzione capitalistico, ricercatore enciclopedico che ne intuì la capacità di sviluppo a livello mondiale, meglio di qualunque altro studioso della sua epoca. E, infine, c'è il Marx teorico del socialismo che, sopresa, aveva tempestivamente ripudiato la possibilità di un «socialismo di Stato» propugnata da Lassalle e da Rodbertus.
- Details
- Hits: 2281

La Repubblica fondata sul profitto
di Alessandra Algostino
«Ogniqualvolta un notabile di Coketown si sentiva maltrattato – vale a dire, ogni volta
che non gli si permetteva di fare il comodo suo e si avanzava l’ipotesi che potesse essere
responsabile delle conseguenze dei suoi atti – si poteva star certi che costui se ne sarebbe
uscito con la terribile minaccia che, piuttosto, avrebbe “gettato tutti i suoi beni nell’Atlantico”»
C. Dickens, Hard Times. For These Times, 1854
 Il conflitto capitale-lavoro e la scelta della Costituzione
Il conflitto capitale-lavoro e la scelta della Costituzione
La storia della destrutturazione dei rapporti di lavoro è ormai lunga, dalle prime leggi sulla flessibilità al c.d. collegato lavoro, dalle concertazioni sul welfare agli “accordi” di Pomigliano e Mirafiori. Il lavoro, che la Costituzione disegna come strumento di dignità della persona e mezzo di emancipazione sociale, come fondamento della «Repubblica democratica» e trait d’union fra democrazia politica e democrazia economica, è sempre più solo merce. Il diritto dei lavoratori, che evoca diritti e garanzie, che ha come soggetto non la vendita di mano d’opera quanto la vita delle persone, è mistificato nella retorica dei lavori, della competitività, della “libertà” contrattuale del singolo lavoratore. La precarietà si ammanta e diviene flessibilità, quando non vuole essere ancor più affascinante e si fa flexicurity. La piena occupazione è sostituita dalla «propensione ad assumere» che, nel quadro dell’«efficientamento del mercato del lavoro», passa «attraverso una nuova [de-]regolazione dei licenziamenti» (così nella Lettera inviata dal governo italiano all’Unione europea, 26 ottobre 2011). Datori di lavoro e sindacati (nelle loro sigle maggiormente rappresentative a livello nazionale) concordano nel centrare le relazioni industriali sul profitto delle imprese (la loro competitività e produttività), nella prospettiva ordoliberale che da ciò possano discendere benefici per l’occupazione e le retribuzioni (per tutti, da ultimo, l’Accordo siglato il 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil).
- Details
- Hits: 2184

Chi decide?
di Augusto Illuminati
 Chi decide? è il titolo del miglior testo di filosofia politica che ha aperto il secondo decennio del secolo e che ben si attaglia all’esperienza italiana fra collasso del berlusconismo e incerto varo del governo “tecnico” Monti nella bufera della crisi. Massimiliano Guareschi e Federico Rahola, dopo aver decostruito con grande acume la mitologia dello stato d’eccezione che, a partire da una breve e abbandonata infatuazione schmittiana è diventato un tormentone del radicalismo chic italiano, finiscono per misurarsi problematicamente con le concezioni foucaultiane del potere e della soggettivazione, da cui comunque estraggono alcuni assunti decisivi sulla segmentazione post-sovrana della governance e l’opacità impersonale dei dispositivi discrezionali dell’amministrazione e della finanza. Quello che però più ci interessa del libro è la luce che getta sui meccanismo politici che abbiamo in funzione adesso. Faccio qui degli esempi, a titolo del tutto personale.
Chi decide? è il titolo del miglior testo di filosofia politica che ha aperto il secondo decennio del secolo e che ben si attaglia all’esperienza italiana fra collasso del berlusconismo e incerto varo del governo “tecnico” Monti nella bufera della crisi. Massimiliano Guareschi e Federico Rahola, dopo aver decostruito con grande acume la mitologia dello stato d’eccezione che, a partire da una breve e abbandonata infatuazione schmittiana è diventato un tormentone del radicalismo chic italiano, finiscono per misurarsi problematicamente con le concezioni foucaultiane del potere e della soggettivazione, da cui comunque estraggono alcuni assunti decisivi sulla segmentazione post-sovrana della governance e l’opacità impersonale dei dispositivi discrezionali dell’amministrazione e della finanza. Quello che però più ci interessa del libro è la luce che getta sui meccanismo politici che abbiamo in funzione adesso. Faccio qui degli esempi, a titolo del tutto personale.
Primo, la favola della personalizzazione, di un uomo solo al comando, come hanno auspicato i leader italiani da Craxi a Berlusconi, in genere lagnandosi che qualcuno glielo impediva. Oggi, guardandoci indietro dalla prospettiva della “sobrietà” montiana, ci sembra una grande mistificazione, che ha coperto in maniera spettacolare (degradando da Re Lear al Bagaglino) la transizione dalla crisi dello Stato dei partiti al dominio diretto e anonimo degli apparati finanziari globali. La coppia catastrofe-comandante salvifico ha funzionato male, a Palazzo Chigi come nella plancia della Costa Concordia e i capitani coraggiosi hanno salvato per primi se stessi: ad Hammamet, a Villa Certosa, sugli scogli del Giglio. La recita decisionista si è spompata nella frammentazione del processo decisionale, nella zona grigia degli effetti dispersi di sovranità.
- Details
- Hits: 5394
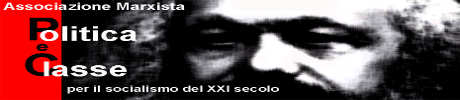
La grande crisi dei debiti sovrani (2011-2012)
Giorgio Gattei
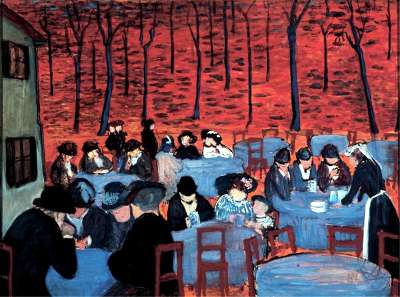 1.Tutti i debiti del mondo.
1.Tutti i debiti del mondo.
C’era un tempo in cui si teorizzava (sto esagerando, ma non di molto) che con il salario i lavoratori dovevano alimentare i consumi, i capitalisti volgere tutto il profitto a risparmio per l’investimento, le banche essere appena intermediarie tra l’investimento e il risparmio e lo Stato intervenire al minimo (al limite zero) negli affari economici, così che per:
(reddito) Y = W (salari) + Sc (risparmio dei capitalisti)
W = C (consumi)
Sc = I (investimento)
(spesa pubblica) G = 0
Nel Novecento questa rappresentazione ideale è stata sconvolta dall’avvento del credito bancario quale elemento nuovo di finanziamento delle imprese, così che nell’ipotesi estrema che tutto l’investimento venisse assicurato dalle banche, il profitto risparmiato poteva essere intercettato dallo Stato per finanziare la spesa pubblica con un proprio debito sovrano:
I = Fi (finanziamento alle imprese)
Sc = Ds (debito sovrano)
Ds = G > 0
A fronte dei due nuovi “motori” della produzione del reddito: l’indebitamento delle imprese verso le banche e l’indebitamento dello Stato verso i capitalisti, nella seconda metà del secolo è venuta a mutare anche la posizione finanziaria dei lavoratori perchè da un lato gli alti salari della produzione “fordista” hanno permesso di renderli anch’essi risparmiatori facendoli partecipare all’indebitamento dello Stato:
- Details
- Hits: 2047

... e un utile memorandum di quindici anni fa
Isidoro Mortellaro
Una rilettura sulle radici del governo Monti e per ragionare su come opporvisi
 ... a toglier l’ultimo velo alla finzione del mercato come legge naturale provvede, dall’alto del suo scranno di commissario della Commissione europea, il più conseguente dei sacerdoti del vincolo esterno. Mario Monti inizia il suo volo là dove è giunto Padoa-Schioppa, quando ha rilevato che di fatto, i criteri di Maastricht dal 1992 «sono divenuti il catalizzatore della politica economica, in Italia come in altri paesi». Nel mettere in evidenza come l’euro abbia rappresentato la «più grande applicazione di Supply Side Economics, economia dell’offerta, mai realizzata, la più grande spinta alla liberalizzazione ed alla privatizzazione», Monti sottolinea come l’ingresso nell’euro abbia sanato solo alcuni mali dell’economia italiana, ma non l’abbia resa competitiva. Per conquistare il prescritto stato di grazia e mantenerlo, per dotarsi di una struttura economica e sociale capace, senza più l’ammortizzatore della moneta e del suo cambio, di rispondere positivamente agli shock che l’esposizione ad un mercato ipercompetitivo produrrà, v’è bisogno di un «Piano per lo smantellamento delle rigidità, per un'Italia competitiva, con scadenze e meccanismi di verifica», un piano di liberalizzazione, di smantellamento delle rigidità del sistema, del mercato del lavoro, come degli aiuti di Stato, insomma dei vincoli all'economia. Oggi abbiamo bisogno di una «programmazione che dovrebbe distruggere i pezzi di socialismo e di statalismo che ancora ingessano l'Italia»: è proprio il «vincolo esterno», adesso in gran parte rappresentato dal patto di stabilità, che adesso si costituisce in «obbligo internazionale a fare le riforme».
... a toglier l’ultimo velo alla finzione del mercato come legge naturale provvede, dall’alto del suo scranno di commissario della Commissione europea, il più conseguente dei sacerdoti del vincolo esterno. Mario Monti inizia il suo volo là dove è giunto Padoa-Schioppa, quando ha rilevato che di fatto, i criteri di Maastricht dal 1992 «sono divenuti il catalizzatore della politica economica, in Italia come in altri paesi». Nel mettere in evidenza come l’euro abbia rappresentato la «più grande applicazione di Supply Side Economics, economia dell’offerta, mai realizzata, la più grande spinta alla liberalizzazione ed alla privatizzazione», Monti sottolinea come l’ingresso nell’euro abbia sanato solo alcuni mali dell’economia italiana, ma non l’abbia resa competitiva. Per conquistare il prescritto stato di grazia e mantenerlo, per dotarsi di una struttura economica e sociale capace, senza più l’ammortizzatore della moneta e del suo cambio, di rispondere positivamente agli shock che l’esposizione ad un mercato ipercompetitivo produrrà, v’è bisogno di un «Piano per lo smantellamento delle rigidità, per un'Italia competitiva, con scadenze e meccanismi di verifica», un piano di liberalizzazione, di smantellamento delle rigidità del sistema, del mercato del lavoro, come degli aiuti di Stato, insomma dei vincoli all'economia. Oggi abbiamo bisogno di una «programmazione che dovrebbe distruggere i pezzi di socialismo e di statalismo che ancora ingessano l'Italia»: è proprio il «vincolo esterno», adesso in gran parte rappresentato dal patto di stabilità, che adesso si costituisce in «obbligo internazionale a fare le riforme».
Il dado è tratto.
- Details
- Hits: 2500

Perchè gli Stati Uniti distruggono il loro sistema scolastico
di Chris Hedges
.jpg) Una nazione che distrugge il proprio sistema educativo, degrada la sua informazione pubblica, sbudella le proprie librerie pubbliche e trasforma le proprie frequenze in veicoli di svago ripetitivo a buon mercato, diventa cieca, sorda e muta. Apprezza i punteggi nei test più del pensiero critico e dell’istruzione. Celebra l’addestramento meccanico al lavoro e la singola, amorale abilità nel far soldi. Sforna prodotti umani rachitici, privi della capacità e del vocabolario per contrastare gli assiomi e le strutture dello stato delle imprese. Li incanala in un sistema castale di gestori di droni e di sistemi. Trasforma uno stato democratico in un sistema feudale di padroni e servi delle imprese.
Una nazione che distrugge il proprio sistema educativo, degrada la sua informazione pubblica, sbudella le proprie librerie pubbliche e trasforma le proprie frequenze in veicoli di svago ripetitivo a buon mercato, diventa cieca, sorda e muta. Apprezza i punteggi nei test più del pensiero critico e dell’istruzione. Celebra l’addestramento meccanico al lavoro e la singola, amorale abilità nel far soldi. Sforna prodotti umani rachitici, privi della capacità e del vocabolario per contrastare gli assiomi e le strutture dello stato delle imprese. Li incanala in un sistema castale di gestori di droni e di sistemi. Trasforma uno stato democratico in un sistema feudale di padroni e servi delle imprese.
Gli insegnanti, con i loro sindacati sotto attacco, stanno diventando altrettanto sostituibili che i dipendenti a paga minima di Burger King. Disprezziamo gli insegnanti veri – quelli con la capacità di ispirare i bambini a pensare, quelli che aiutano i giovani a scoprire i propri doni e potenziali – e li sostituiamo con istruttori che insegnano in funzione di test stupidi e standardizzati. Questi istruttori obbediscono. Insegnano ai bambini a obbedire. E questo è il punto. Il programma ‘Nessun Bambino Lasciato Indietro’, sul modello del “Miracolo Texano”, è una truffa. Non ha funzionato meglio del nostro sistema finanziario deregolamentato. Ma quando si esclude il dibattito, queste idee morte si autoperpetuano.
- Details
- Hits: 2842

Informazioni di Parte
Silvano Cacciari
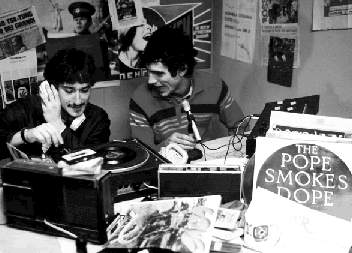 Pubblichiamo la trascrizione dell’intervento di Silvano Cacciari – Docente all’Università di Firenze ed animatore del portale di controinformazione Senza Soste – durante il ciclo di incontri “Informazioni di Parte. Per un nuovo mediattivismo tra disordine globale e narrazioni insorgenti”, nel dibattito tenutosi lo scorso maggio presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna.
Pubblichiamo la trascrizione dell’intervento di Silvano Cacciari – Docente all’Università di Firenze ed animatore del portale di controinformazione Senza Soste – durante il ciclo di incontri “Informazioni di Parte. Per un nuovo mediattivismo tra disordine globale e narrazioni insorgenti”, nel dibattito tenutosi lo scorso maggio presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna.
Vi si delineano importanti nodi teorici e pratici da sciogliere per un discorso ed una pratica antagonista di contropotere mediale.
Quali sono le radici storiche del discorso egemonico mediale delle classi dominanti? Quali limiti della sinistra istituzionale e di movimento rispetto alla comunicazione mediale hanno permesso il radicarsi di quest’egemonia? Attraverso quali forme si esprime, e come riesce a connettere ed a presidiare il tessuto delle società contemporanee?
Nelle prossime settimane proseguiremo la pubblicazione degli interventi degli altri relatori, Carlo Formenti e Federico Montanari.
Il passaggio del testimone dell’egemonia contemporanea
Per costruire il filo di narrazione della relazione di oggi bisogna che vada ad un paio di aneddoti che riguardano la giornata di ieri. Ieri per motivi di lavoro ho dovuto presenziare ad un convegno “letale” che era sulla figura di una pedagogista toscana del PCI, purtroppo morta prematuramente […] Il puntino interrogativo che questi pedagogisti (che si occupano sostanzialmente di formazione dalla primaria alla secondaria) non riuscivano a risolvere, era questo: noi avevamo quell’egemonia sui comportamenti microfisici della società italiana durante gli anni ’60 e ’70, poi contavamo come operatori della formazione, avevamo un ruolo politico che aveva una centralità;
- Details
- Hits: 3022

Eurocrisi, la Germania vittima della propria austerità
di Sergio Cesaratto
 Hans-Werner Sinn è senza dubbio il più influente economista tedesco con un ineccepibile, sebbene assai conformista, curriculum. Ossequiato dai suoi altrettanto benpensanti colleghi, presiede il Cesifo, un potente gruppo di istituti di ricerca in un paese in cui gli economisti sono tradizionalmente ascoltati dai governi. Le opinioni di questo potente economista sono quanto di più pro-germanico possa immaginarsi, ma anche questa è una vecchia tradizione degli economisti tedeschi più influenti.
Hans-Werner Sinn è senza dubbio il più influente economista tedesco con un ineccepibile, sebbene assai conformista, curriculum. Ossequiato dai suoi altrettanto benpensanti colleghi, presiede il Cesifo, un potente gruppo di istituti di ricerca in un paese in cui gli economisti sono tradizionalmente ascoltati dai governi. Le opinioni di questo potente economista sono quanto di più pro-germanico possa immaginarsi, ma anche questa è una vecchia tradizione degli economisti tedeschi più influenti.
Nella crisi europea è, naturalmente, generico accusare questo o quel paese. Le classi dominanti di ciascun paese han fatto le loro scelte, e ciascun paese ha le sue proprie problematiche, virtù e difetti e portare i (presunti) virtuosi ad esempio per i (presunti) più indisciplinati ha la medesima improbabile efficacia di quando lo facciamo coi nostri figli. Nella costruzione dell’Unione Monetaria Europea (UME) ciascuna classe dirigente ha ritenuto di trovare una convenienza per il proprio paese o perlomeno per i ceti che essa rappresentava. Se il disegno è collettivamente semi-fallito, almeno nei termini in cui si è dispiegato, la responsabilità non è di un paese in particolare: tutti sapevano o dovevano sapere a cosa si andava incontro, che l’Eurozona non è ciò che gli economisti chiamano un’area valutaria ottimale, e che il disastro era nelle cose [1].
Siccome la storia non si può fare coi se o con i ma, allora domandarsi come sarebbe andata a finire senza l’UME è esercizio ozioso. Vale la pena però cercare di ricostruire come sono andate le cose, anche per vedere se si può cambiare qualcosa. E qui la storia che Sinn racconta è assai parziale e questo non aiuta perché avvalora la narrazione della vicenda europea su cui i politici tedeschi – soprattutto, ma non esclusivamente, del centro-destra – basano le politiche che impongono all’Eurozona. Tale narrazione è anche quella che viene somministrata all’opinione pubblica di quel paese e che fa da sostrato all’idea del centro virtuoso e della periferia scapestrata.
- Details
- Hits: 6491

Il manifesto manifesta
di Alberto Bagnai
.jpg) Ci risiamo. Sul Manifesto di ieri leggiamo il periodico “accorato appello” del direttore Parlato: ci stanno togliendo i soldi, la decisione è stata presa dagli Uffici della Camera (i politici non ci si sono nemmeno sprecati), che si sono battuti il belino degli appelli del Presidente della Repubblica (liberté, égalité, fraternité), siamo stati condannati, sarà disoccupazione per migliaia di addetti al settore, saremo costretti a chiudere, dopo quarant’anni di lotte per le libertà, gli abbonamenti stanno calando...
Ci risiamo. Sul Manifesto di ieri leggiamo il periodico “accorato appello” del direttore Parlato: ci stanno togliendo i soldi, la decisione è stata presa dagli Uffici della Camera (i politici non ci si sono nemmeno sprecati), che si sono battuti il belino degli appelli del Presidente della Repubblica (liberté, égalité, fraternité), siamo stati condannati, sarà disoccupazione per migliaia di addetti al settore, saremo costretti a chiudere, dopo quarant’anni di lotte per le libertà, gli abbonamenti stanno calando...
Ecco: ferma tutto: gli abbonamenti... Una volta, a sinistra, esisteva un valore che mi sembra definitivamente tramontato: l’autocritica. Forse sarebbe il caso di chiedersi perché gli abbonamenti stanno diminuendo, no? Avrete fatto le vostre analisi. Vi regalo la mia.
Quest’estate il Manifesto ha lanciato un dibattito sulla Rotta d’Europa con un articolo abbastanza fumoso nel quale Rossana Rossanda, fingendo di fare delle domande, dava delle risposte, le risposte che erano dentro di lei, e che, purtroppo, erano per lo più sbagliate. Come si dice a Roma, ci hanno imboccato tutti: una bella passerella di articoli che seguivo distrattamente andando da un rifugio all’altro in Alto Adige, fino a che mi è venuto un travaso di bile a fronte del Vajont di banalità, di “neismo” (neocapitalismo neoliberismo neofinaziarizzazione della neoeconomia), e di ossequio ai mantra della finanza, malamente camuffato da voce critica e di sinistra.
Ossequio che raggiunse il culmine nella stomachevole intervista di Rossanda ad Amato. Chi non l’ha letta se la vada a rileggere (consiglio la versione apparsa sul forum amatoriale piuttosto che quella del Manifesto, perché sul Manifesto prudentemente non vennero consentiti commenti dei lettori).
- Details
- Hits: 12541

La conricerca contro l’industrializzazione dell’umano
di Emiliana Armano e Devi Sacchetto
Breve nota sul convegno: “Romano Alquati. Immagini e percorsi soggettivi e collettivi di una ricerca”
 Romano Alquati, instancabile ricercatore scalzo, attivista politico e intellettuale, analista della soggettività, dei processi di soggettivazione e della composizione di classe, esponente di spicco del pensiero operaista è morto a Torino il 3 aprile del 2010. Una giornata di convegno,[1] a un anno circa dalla sua scomparsa, è stato organizzato da compagni, amici e colleghi, insieme al “Cantiere per l’autoformazione”, una struttura composta da dottorandi e studenti dell’Università di Torino. Il convegno è stato l’occasione per riflettere tra i protagonisti di una storia e di una esperienza collettiva, ma anche per indagare che cosa essa può offrire ai giovani studenti e operai.
Romano Alquati, instancabile ricercatore scalzo, attivista politico e intellettuale, analista della soggettività, dei processi di soggettivazione e della composizione di classe, esponente di spicco del pensiero operaista è morto a Torino il 3 aprile del 2010. Una giornata di convegno,[1] a un anno circa dalla sua scomparsa, è stato organizzato da compagni, amici e colleghi, insieme al “Cantiere per l’autoformazione”, una struttura composta da dottorandi e studenti dell’Università di Torino. Il convegno è stato l’occasione per riflettere tra i protagonisti di una storia e di una esperienza collettiva, ma anche per indagare che cosa essa può offrire ai giovani studenti e operai.L’itinerario personale, politico e intellettuale di Romano Alquati si intreccia indissolubilmente con la storia del secondo dopoguerra, quando una generazione di militanti misero in secondo piano l’importanza della propria professione e per sopravvivere cercarono occupazioni in grado di “servirci anche per la nostra militanza politica!”. Essi diedero vita a una modalità nuova di fare politica che fece da spartiacque anche per le successive generazioni, sino a oggi.[2]
L’intento degli organizzatori non era di proporre una visione unitaria, coesa delle categorie alquatiane, ma al contrario di dare spazio ai piani molteplici del discorso: politico, teorico, emotivo ed esistenziale. Nell'incontro è prevalso un taglio biografico e narrativo, affrontando anche alcune delle tematiche teoriche che Alquati aveva caparbiamente portato alla luce.[3] La potenza della macchina narrativa ha consentito una riappropriazione collettiva della storia che i convenuti avevano vissuto e sulla quale, anche individualmente, avevano riflettuto.
- Details
- Hits: 2357

Oltre l’indignazione
Crisi del neoliberismo e giovani intellettuali
Leo Goretti
 I “giovani” sono in stato di ribellione permanente, perché persistono le cause profonde di essa, senza che ne sia permessa l’analisi, la critica e il superamento (non concettuale e astratto, ma storico e reale); gli “anziani” dominano di fatto ma … non riescono a educare i giovani, a prepararli alla successione.
I “giovani” sono in stato di ribellione permanente, perché persistono le cause profonde di essa, senza che ne sia permessa l’analisi, la critica e il superamento (non concettuale e astratto, ma storico e reale); gli “anziani” dominano di fatto ma … non riescono a educare i giovani, a prepararli alla successione.
Era così che Antonio Gramsci discuteva la “quistione dei giovani” nei suoi Quaderni del carcere. Pur scaturendo dal contesto del primo dopoguerra, l’analisi di Gramsci offre degli spunti per descrivere la situazione politica contemporanea. La difficoltà, in un periodo di “crisi”, nel ricambio generazionale della classe dirigente è un elemento chiave per capire il prepotente ritorno dei giovani sulla scena pubblica europea, e perché questo protagonismo giovanile si è espresso prevalentemente in forme “oppositive”.
Utilizzando categorie gramsciane, cercherò di tracciare un profilo della “generazione della crisi” – quei nuclei di giovani che si sono venuti politicizzando dal 2008 in avanti; quindi analizzerò alcune delle ragioni per cui ritengo possibile una mobilitazione radicale dei giovani, e alcuni dei fattori che invece la ostacolano; infine, cercherò di delineare un programma d’azione per i giovani d’inizio ventunesimo secolo.
La “generazione della crisi”
Negli ultimi tre anni, il mondo occidentale è entrato in una fase di profonda crisi. Tutto è cominciato con la bolla finanziaria esplosa nel 2007-2008, cui è seguita una fase di recessione economica, a causa delle politiche di austerity adottate dai governi occidentali.
- Details
- Hits: 3455

A che punto è la crisi?
di Rino Malinconico
 A che punto è la crisi economica?
A che punto è la crisi economica?
La domanda ha senso perché una crisi è sempre un percorso. E’ costituita di momenti diversi, pur dentro un'unica, più o meno lunga fase di difficoltà o di vera e propria recessione economica. D’altra parte, ogni crisi è anche un nuovo inizio, come suggerisce l'etimologia stessa (krìsis in greco vuol dire “scelta”, “decisione”, oltre che “separazione”). Si tratta, perciò, di una dinamica di disequilibrio e, contemporaneamente, di ricerca di nuovi equilibri. Ed è bene non sottovalutare questo carattere costituente della crisi, il fatto, cioè, che essa prelude e prepara un nuovo assetto delle relazioni capitalistiche, tanto all'interno dei singoli sistemi-paese quanto a livello delle più complessive relazioni tra i diversi Stati nazionali.
Ovviamente coloro che pensano di essere alla vigilia del vero e proprio crollo del sistema capitalistico non hanno affatto bisogno di interrogarsi sul decorso della crisi, tantomeno sul suo andamento costituente. Se si stabilisce in maniera apodittica che siamo di fronte a un'agonia, l'unica trasformazione possibile diventa il passaggio dall'agonia alla morte. E però, un tale convincimento a me pare non solo immotivato nei suoi termini teorici, ma anche linearmente contraddetto da quanto avviene in vaste aree del mondo, dalla Cina al Brasile all'India, che presentano ancora consistenti trend di crescita, capitalistica appunto, e sono soltanto marginalmente sfiorati dalla crisi economica, la quale si incentra tutta, invece, tra le due sponde dell’Atlantico. Lo stesso Giappone, pur drammaticamente colpito dal disastro nucleare dei mesi scorsi, e penalizzato nelle esportazione da uno yen troppo forte, mantiene un trend economico più che accettabile, tanto che la borsa di Tokyo ha già sostanzialmente recuperato rispetto alla caduta del 2008.
- Details
- Hits: 2232
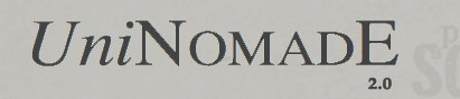
Riprendiamoci l’Europa!
Collettivo Uninomade
 1. Non c’era bisogno delle parole di Mario Draghi per capire che la crisi ha ormai raggiunto in Europa una soglia di irreversibilità. Crisi di «dimensioni sistemiche», aveva detto Jean-Claude Trichet un paio di mesi fa. Ora Draghi, suo successore alla guida della Banca Centrale Europea, ci informa che «la situazione è peggiorata» (16 gennaio). Difficile capire che cosa significhi il peggioramento di una crisi di «dimensioni sistemiche». Certo è che gli scenari che si prospettano per i prossimi mesi sono assai cupi, non solo per chi ormai da anni sta pagando la crisi e il farmaco che la alimenta – l’austerità, o più “sobriamente” il rigore. Anche settori consistenti del capitale e delle classi dirigenti europee cominciano a essere assaliti dal dubbio che, nel gigantesco processo di riassestamento globale degli equilibri di potere in atto, corrono il rischio di figurare tra i perdenti. Lo spettro del “declino”, se pur non ha smesso di aggirarsi per le metropoli statunitensi, ha preso a frequentare con maggiore assiduità le strade e le piazze d’Europa – o almeno di intere regioni europee. E non mancano i commentatori che intravedono dietro l’azione delle agenzie di rating una razionalità militare, le prime manovre di una «guerra mondiale del debito» in cui l’obiettivo della sopravvivenza del dollaro come moneta sovrana a livello mondiale (con il conseguente mantenimento degli attuali centri di comando sui mercati finanziari) può giustificare lo sgretolamento dell’euro. Sullo sfondo, le notizie che arrivano dallo Stretto di Hormuz ci ricordano che di fronte a una crisi di questa profondità e durata la guerra può essere una “soluzione” da tentare non soltanto sul terreno della finanza e dei debiti “sovrani”.
1. Non c’era bisogno delle parole di Mario Draghi per capire che la crisi ha ormai raggiunto in Europa una soglia di irreversibilità. Crisi di «dimensioni sistemiche», aveva detto Jean-Claude Trichet un paio di mesi fa. Ora Draghi, suo successore alla guida della Banca Centrale Europea, ci informa che «la situazione è peggiorata» (16 gennaio). Difficile capire che cosa significhi il peggioramento di una crisi di «dimensioni sistemiche». Certo è che gli scenari che si prospettano per i prossimi mesi sono assai cupi, non solo per chi ormai da anni sta pagando la crisi e il farmaco che la alimenta – l’austerità, o più “sobriamente” il rigore. Anche settori consistenti del capitale e delle classi dirigenti europee cominciano a essere assaliti dal dubbio che, nel gigantesco processo di riassestamento globale degli equilibri di potere in atto, corrono il rischio di figurare tra i perdenti. Lo spettro del “declino”, se pur non ha smesso di aggirarsi per le metropoli statunitensi, ha preso a frequentare con maggiore assiduità le strade e le piazze d’Europa – o almeno di intere regioni europee. E non mancano i commentatori che intravedono dietro l’azione delle agenzie di rating una razionalità militare, le prime manovre di una «guerra mondiale del debito» in cui l’obiettivo della sopravvivenza del dollaro come moneta sovrana a livello mondiale (con il conseguente mantenimento degli attuali centri di comando sui mercati finanziari) può giustificare lo sgretolamento dell’euro. Sullo sfondo, le notizie che arrivano dallo Stretto di Hormuz ci ricordano che di fronte a una crisi di questa profondità e durata la guerra può essere una “soluzione” da tentare non soltanto sul terreno della finanza e dei debiti “sovrani”.
Diciamolo chiaramente: l’Unione europea, per come l’abbiamo conosciuta in questi anni, è finita.
- Details
- Hits: 7504

La crisi e il saggio del profitto
Paolo Giussani
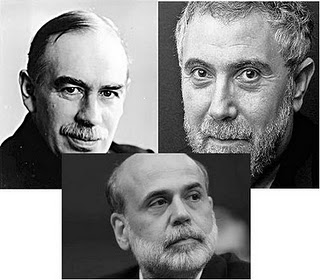 Dopo anni di virtuale silenzio stampa è finalmente arrivato il dì della riscossa - l'erompere della crisi - che ha liberato la produzione di moltissimi scritti, mossi dall’intento di spiegare quello che è successo - e tuttora prosegue - attraverso la teoria marxiana o marxista. Entro questa letteratura si trova un piccolo gruppo di economisti che cercano di collegare la crisi alla tendenza declinante del saggio del profitto, ma, siccome prima di poter far ciò bisogna stabilire se o meno questa tendenza esista, ciascuno di questi autori si sente di avanzare la propria misurazione empirica del movimento del saggio del profitto nel periodo del dopoguerra, col risultato di avere in pratica una pleiade di stime statistiche. Quasi una moderna conferma di un vecchio adagio popolare. Invece di “tante teste, tante idee”, qui si ha “tante teste, tanti saggi del profitto”: dopo alcuni secoli di capitalismo e parecchi decenni di contabilità nazionali moderne si tratta certamente di un risultato formidabile.
Dopo anni di virtuale silenzio stampa è finalmente arrivato il dì della riscossa - l'erompere della crisi - che ha liberato la produzione di moltissimi scritti, mossi dall’intento di spiegare quello che è successo - e tuttora prosegue - attraverso la teoria marxiana o marxista. Entro questa letteratura si trova un piccolo gruppo di economisti che cercano di collegare la crisi alla tendenza declinante del saggio del profitto, ma, siccome prima di poter far ciò bisogna stabilire se o meno questa tendenza esista, ciascuno di questi autori si sente di avanzare la propria misurazione empirica del movimento del saggio del profitto nel periodo del dopoguerra, col risultato di avere in pratica una pleiade di stime statistiche. Quasi una moderna conferma di un vecchio adagio popolare. Invece di “tante teste, tante idee”, qui si ha “tante teste, tanti saggi del profitto”: dopo alcuni secoli di capitalismo e parecchi decenni di contabilità nazionali moderne si tratta certamente di un risultato formidabile.
Ora è evidente che, visto che di saggi del profitto ve ne sono millanta che tutta notte canta, se uno ha in mente l’accumulazione il saggio del profitto che interessa deve essere direttamente connesso con l’accumulazione ossia quello del settore corporate dell'economia al netto delle tasse. Al netto delle tasse perché le tasse non si possono accumulare; e del settore corporate perché il settore noncorporate non conta praticamente nulla nella formazione di capitale fisso.
- Details
- Hits: 2464
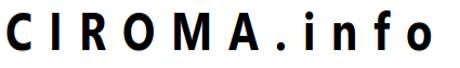
OWS: Occupy Everything
Paolo Carpignano*
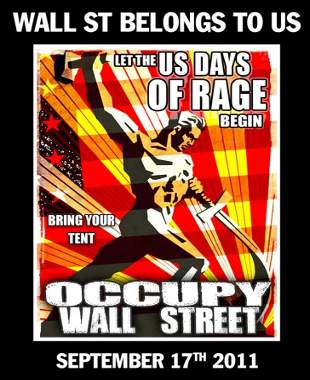 Forse era nell’aria: l’aria di primavera dei paesi arabi, o l’aria della Puerta del Sol di Madrid, o del Rothchild Boulevard di Tel Aviv, tutti avvenimenti che presagivano un anno caldo a livello globale. Ma quando a New York è scoppiata Occupy Wall Street (la metafora della esplosione sembra moto più appropiata), si è avuta subito la sensazione che non si trattasse di una ventata di attivismo, di un altro episodio dell’ «anno della protesta» come lo ha definito Time magazine, ma di un avvenimento trasformatore, un «game changing», un cambiamento delle regole del gioco.
Forse era nell’aria: l’aria di primavera dei paesi arabi, o l’aria della Puerta del Sol di Madrid, o del Rothchild Boulevard di Tel Aviv, tutti avvenimenti che presagivano un anno caldo a livello globale. Ma quando a New York è scoppiata Occupy Wall Street (la metafora della esplosione sembra moto più appropiata), si è avuta subito la sensazione che non si trattasse di una ventata di attivismo, di un altro episodio dell’ «anno della protesta» come lo ha definito Time magazine, ma di un avvenimento trasformatore, un «game changing», un cambiamento delle regole del gioco.
Non che nel contesto americano non ci fossero stati in quest’anno dei precedenti. Primo fra tutti, le grandi manifestazioni e l’assedio del Congresso dello stato del Winsconsin, nello scorso inverno. In quell’occasione si erano viste le prime crepe alla «risoluzione» neoliberale della grande crisi. Il governatore Scott Walker, forte di una vittoria elettorale finanziata da interessi a livello nazionale che volevano fare del suo stato un test della politica repubblicana conservatrice, e sulla scia dei successi del movimento del Tea Party e delle vittorie repubblicane al Congresso, aveva proposto un progetto di riforme strutturali tutte incentrate sulla politica dei sacrifici e sulla responsabilità fiscale; in realtà un attacco diretto a quello che rimaneva delle organizzazioni sindacali fra i lavoratori del pubblico impiego i cui contratti venivano di fatto abrogati. La reazione fu tanto inaspettata quanto massiccia tanto da essere chiamata la Piazza Tharir americana. Ma per quanto importanti e significative, le lotte riguardavano dei temi sostanzialmente difensivi, sindacali. Alla fine tutte le energie si sono concentrate sulle elezioni locali nel tentativo in parte riuscito di revocare le elezioni di alcuni deputati e dello stesso governatore, tutte attività ancora all’interno del sistema elettorale.
- Details
- Hits: 7831

Crisi finanziaria e governo dell'economia
Alberto Bagnai
«L'obscurité n'est pas un défaut quand on parle à des bons jeunes gens avides de savoir, et surtout de paraître savoir.»
Stendhal, Promenades dans Rome, 17 mars 1828.
 1. Introduzione
1. Introduzione
Accolgo con vivo piacere l’invito a contribuire a questo numero dedicato al governo del sistema monetario europeo e internazionale. Se posso permettermi un po’ di leggerezza, mi solleva il fatto che qualcuno sia ancora interessato a raccogliere le opinioni di un economista, in un periodo nel quale la scienza economica è particolarmente discreditata per non aver saputo prevedere lo scoppio della crisi, e per non averne saputo scongiurare le conseguenze. Non credo che questi rilievi siano del tutto corretti: esempi illustri di analisi “profetiche” non mancano. Ammetto però che da qualche tempo gli scambi più proficui su questo tema mi capita di averli con studiosi esterni alla mia professione: storici, geografi, giuristi. Questo dipende in parte dal mio percorso, che mi rende insofferente verso l’omodossia economica (non chiamerei “ortodossia” il cosiddetto pensiero mainstream, che è certamente unanime - omos - ma, visti i risultati, probabilmente non del tutto corretto - orthos). I benefici di questi scambi interdisciplinari dipendono però soprattutto dal fatto che essi costringono a riorganizzare le proprie categorie, a cercare nuove strade di trasmissione del proprio sapere “tecnico”, a reagire a stimoli imprevisti. Un esercizio utilissimo, da compiere con umiltà e con quel senso di responsabilità che deriva dal costituirsi rappresentante della categoria verso un mondo “esterno”. Il che obbliga a porsi due domande ben precise: in che modo posso aiutare la riflessione dei colleghi che hanno seguito altri percorsi (e farmi aiutare nella mia)? E in che modo posso fornire loro una rappresentazione critica ma non distorta dei risultati e delle aporie della mia disciplina?
Rinuncio fin da ora al secondo obiettivo: vivrò senza sensi di colpa la mia faziosità, sapendo di rivolgermi a un pubblico che ha gli strumenti critici per difendersi qualora le mie tesi non lo convincano, e soprattutto qualora lo convincano. Per lo stesso motivo rinuncerò al parlare oscuro (utile, come ci ricorda Stendhal, quando si parla a giovanotti ansiosi di sfoggiare il proprio sapere): parlando a un pubblico maturo sceglierò la strada della semplicità, sperando di non compromettere il rigore dei miei argomenti. Rivolgendomi a dei giuristi la linea di attacco più naturale mi sembra quella di riflettere sulle relazioni fra la crisi e le regole, scritte o non scritte, che governano il sistema finanziario internazionale.
- Details
- Hits: 2428

“Anomalie italiane”, o come si prepara la guerra ai lavoratori

Ad aprire lo show delle citazioni da antologia legate alle nuove forme di relazioni industriali, ci ha pensato, circa un anno fa, Sergio Marchionne che, ai giornalisti che gli chiedevano del “modello Pomigliano” e dell’opposizione dei lavoratori alle nuove politiche aziendali della Fiat rispondeva “Io vivo nell’epoca dopo Cristo, tutto ciò che è avvenuto prima di cristo non lo so e non mi interessa”. Ed ecco che, pochi giorni fa, tocca a Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, rilanciare sul piano ideologico: “[…]Da parte nostra c'è la massima volontà di lasciare fuori dal tavolo ideologie, di essere molto responsabili e molto seri".
L’oggetto della discussione, nel secondo caso, è naturalmente legato alla “riforma” del mercato del lavoro di cui tanto si parla e che è uno dei punti fondamentali su cui lavorano, senza sosta e di concerto con i sindacati (CGIL-CISL-UIL), Monti, Fornero, Passera & co. e, nel caso specifico, la Marcegaglia, che parla dell’articolo 18 e della “flessibilità in uscita”.
- Details
- Hits: 2736

Costa Concordia: la "movida" galleggiante
di Sergio Bologna
 Strano che nessuno si sia chiesto quale bandiera batte la “Costa Concordia”. Strano che nessuno si sia chiesto chi stava sul ponte di comando della nave al momento dell’incidente. Strano che nessuno abbia ricordato che ai primi di ottobre del 2011 la nave portacontainer “Rena” della MSC è andata a sbattere contro l’Astrolabe Reef in Nuova Zelanda, uno dei più preziosi paradisi marini del globo, e che da allora (sono passati tre mesi e mezzo) sputa petrolio su quelle acque incontaminate, creando il più grave disastro ecologico in quell’emisfero. Strano che nessuno ricordi come l’Italia abbia a che fare in questi incidenti, per più motivi. Costa Crociere, nata italiana come dice il nome, è controllata dal gigante americano del settore. Ma chi la gestisce?
Strano che nessuno si sia chiesto quale bandiera batte la “Costa Concordia”. Strano che nessuno si sia chiesto chi stava sul ponte di comando della nave al momento dell’incidente. Strano che nessuno abbia ricordato che ai primi di ottobre del 2011 la nave portacontainer “Rena” della MSC è andata a sbattere contro l’Astrolabe Reef in Nuova Zelanda, uno dei più preziosi paradisi marini del globo, e che da allora (sono passati tre mesi e mezzo) sputa petrolio su quelle acque incontaminate, creando il più grave disastro ecologico in quell’emisfero. Strano che nessuno ricordi come l’Italia abbia a che fare in questi incidenti, per più motivi. Costa Crociere, nata italiana come dice il nome, è controllata dal gigante americano del settore. Ma chi la gestisce?
Le navi, è bene si sappia, sono di proprietà, di norma, di una holding la cui prima preoccupazione è di metterle al riparo dal fisco e dalle norme sulle tabelle d’armamento presso certi paradisi fiscali ( da cui le cosiddette “bandiere ombra” o flag of convenience). Ma sono gestite da Ship Management Societies specializzate che decidono le assunzioni di personale e lo fanno di solito in base al principio del minor costo. Sulla “Rena” c’erano 15 filippini su 20 uomini di equipaggio. I filippini hanno pessima fama, ma ingiustamente, da “paria” del settore sono diventati oggi tra quelli meglio preparati, perché negli anni hanno imparato che la loro vocazione era quella ed hanno investito in scuole professionali, che rilasciano i diplomi ed i certificati necessari per l’imbarco. Purtroppo oggi il mercato dei certificati falsi è fiorente, oggi i “paria” sono altri, ucraini, vietnamiti, turchi, bielorussi.
1. Sabato c’è stata una manifestazione sul Canale della Giudecca a Venezia contro il passaggio delle grandi navi da crociera. Stava uscendo in quel momento la “MSC Magnifica”. MSC sta per Mediterranean Shipping Company ed è la creatura di un geniale italiano di Sorrento, Gianluigi Aponte, che ha trasferito le sue attività in Svizzera, a Ginevra, dove sembra abbia preso moglie con tanto di banca in dote.
- Details
- Hits: 3686

Le strategie dell’integrazione europea e il loro impatto sull’Italia*
di Massimo Pivetti**
 1. Nel corso dell’ultimo trentennio il capitalismo avanzato nel suo complesso ha sperimentato una poderosa restaurazione liberista, nel cui ambito il progresso è stato identificato con la mondializzazione e la conservazione con la difesa di uno Stato sociale e di una rete di tutele del lavoro dipendente considerati come di fatto pregiudizievoli per quest’ultimo, in quanto fonti di accrescimento del suo costo e di perdita di competitività.
1. Nel corso dell’ultimo trentennio il capitalismo avanzato nel suo complesso ha sperimentato una poderosa restaurazione liberista, nel cui ambito il progresso è stato identificato con la mondializzazione e la conservazione con la difesa di uno Stato sociale e di una rete di tutele del lavoro dipendente considerati come di fatto pregiudizievoli per quest’ultimo, in quanto fonti di accrescimento del suo costo e di perdita di competitività.
Ma mentre in Inghilterra e negli Stati Uniti l’attacco alle conquiste del lavoro dipendente e alle sue condizioni materiali di vita è avvenuto apertamente e frontalmente tra la fine degli anni Settanta e la prima metà degli anni Ottanta[1], nell’Europa continentale esso si è sviluppato in modo più graduale e indiretto, passando per il progressivo svuotamento delle sovranità nazionali.
Svilupperò questa mia relazione su integrazione europea e unità nazionale a partire da una concezione del progetto di unificazione economica e monetaria europea, quale si è concretamente imposto nel corso degli anni Ottanta e con il Trattato di Maastricht[2], come progetto consapevole d’ indebolimento dei movimenti operai nazionali. Cercherò poi di argomentare come nel caso dell’Italia l’indebolimento del suo movimento operaio possa essere considerato come il determinante principale della situazione di crisi in cui versa l’unità nazionale.
2. Alla luce dell’esperienza storica, è difficile nutrire dubbi sul fatto che pieno impiego e tutela effettiva dei principali diritti sociali comportano un cospicuo intervento dello Stato nella produzione e distribuzione del reddito.
- Details
- Hits: 14191

Vite parallele
Elisabetta Teghil
 Plutarco scrisse “Vite parallele”, biografie a confronto di personalità greche e romane.
Plutarco scrisse “Vite parallele”, biografie a confronto di personalità greche e romane.
Marx, si cita sempre in queste occasioni, disse che le vicende si ripetono due volte, la prima in termini tragici, la seconda in dimensione di farsa.
Non è questo il caso. L’anima dell’opera di Plutarco era precettistica ed etica, il dramma è oggi.
L’accostamento, allora, era spesso artificioso, mentre in questa occasione è calzante.
Intendiamo parlare di Lucas Papademos e Mario Monti che governano ad Atene e a Roma, presentati, l’uno e l’altro, come dei tecnici.
Secondo dei buontemponi, che tanto in buona fede non sono, ci sarebbero zone franche così dette “apolitiche”.
La nomina, ai vertici dello Stato, di tecnocrati, presentati sempre come provvidenziali, smaschera l’inconsistenza delle false alternanze politiche.
Intanto, chiariamo subito che, l’uno e l’altro, sono uomini di destra, checché ne dicano quelli/e che si sono inventati l’annullamento della destra e della sinistra.
- Details
- Hits: 2254
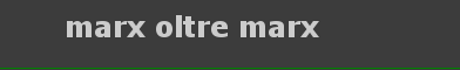
Le forme di appropriazione
di Valerio Bertello
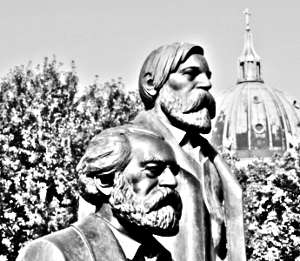 Fondamento del materialismo storico è l’idea che lo sviluppo delle forze produttive, quindi del lavoro sociale in quanto divisione del lavoro, porti necessariamente ad una socializzazione crescente delle strutture sociali, cioè alla piena realizzazione della società come comunità umana. Ma questo processo reale si riflette ideologicamente a livello sovrastrutturale nel pensiero economico di ogni epoca, in particolare in quello della società borghese in quanto fase culminante di tale sviluppo. Per cui, poiché essa prelude necessariamente al comunismo, e quindi in parte lo anticipa, così il suo pensiero economico contiene in nuce i principi del comunismo. La sua logica interna e le contraddizioni che ne seguono, sia a livello concettuale che pratico, la spingono verso questo approdo. Certamente non sono le idee e le loro contraddizioni il motore della storia, ma ne costituiscono solo il riflesso. Sono la rappresentazione distorta ma allusiva delle forze reali delle storia, vale a dire quelle dell’attività pratica umana, cioè del lavoro sociale. E’ possibile quindi seguire i due sviluppi, quello del movimento reale e quello ideologico, come processi che si illuminano a vicenda. Particolarmente chiarificatori sono i concetti fondamentali dell’ideologia borghese in campo economico, in particolare il concetto di proprietà, per il quale lo sviluppo delle sue contraddizioni conduce direttamente al comunismo.
Fondamento del materialismo storico è l’idea che lo sviluppo delle forze produttive, quindi del lavoro sociale in quanto divisione del lavoro, porti necessariamente ad una socializzazione crescente delle strutture sociali, cioè alla piena realizzazione della società come comunità umana. Ma questo processo reale si riflette ideologicamente a livello sovrastrutturale nel pensiero economico di ogni epoca, in particolare in quello della società borghese in quanto fase culminante di tale sviluppo. Per cui, poiché essa prelude necessariamente al comunismo, e quindi in parte lo anticipa, così il suo pensiero economico contiene in nuce i principi del comunismo. La sua logica interna e le contraddizioni che ne seguono, sia a livello concettuale che pratico, la spingono verso questo approdo. Certamente non sono le idee e le loro contraddizioni il motore della storia, ma ne costituiscono solo il riflesso. Sono la rappresentazione distorta ma allusiva delle forze reali delle storia, vale a dire quelle dell’attività pratica umana, cioè del lavoro sociale. E’ possibile quindi seguire i due sviluppi, quello del movimento reale e quello ideologico, come processi che si illuminano a vicenda. Particolarmente chiarificatori sono i concetti fondamentali dell’ideologia borghese in campo economico, in particolare il concetto di proprietà, per il quale lo sviluppo delle sue contraddizioni conduce direttamente al comunismo.
1. Legge del valore e legge del lavoro
Il rapporto di produzione capitalistico si presenta in forma duale: da una parte nella produzione come organizzazione del lavoro, dall’altra nella circolazione come scambio della forza lavoro contro salario. Le due forme differiscono radicalmente per diversi aspetti, ma in entrambe il rapporto appare nella forma giuridica di rapporto tra proprietari indipendenti. Sono però due forme diverse di proprietà: nel primo caso si tratta di proprietà originaria, nel secondo di proprietà derivata. Nel processo di lavoro il produttore è proprietario del bene in quanto ne è il creatore, cioè vale la legge del lavoro.
- Details
- Hits: 2650

La tecnica del capitale
Critica rivoluzionaria dell'esistente. Teoria e prassi per il non ancora esistente
Antiper[1]
“Siamo effettivamente nell’Età della Tecnica, ma questa non assomiglia assolutamente alle età che l’hanno preceduta, perché tutte le età che l’hanno preceduta dall’antichità, al medioevo, al rinascimento, l’illuminismo, il romanticismo, il positivismo erano tutte età pre-tecnologiche dove funzionava il paradigma che l’uomo è il soggetto della Storia e la Tecnica è lo strumento con cui realizza i suoi scopi. Oggi non è più così. La Tecnica è diventata il soggetto della Storia e gli uomini sono diventati funzionari negli apparati tecnici. Siamo stati deposti dal protagonismo storico. La Storia non è più il luogo della nostra azione, ma il luogo dell’azione della Tecnica” [2].
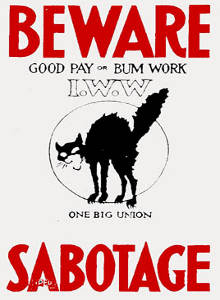 Da quando è nato il Governo “tecnico” di Mario Monti si è fatto un gran parlare di sottomissione della “politica” ai “tecnici”, di “espropriazione” e “sospensione” della democrazia, di “dittatura dei mercati finanziari”, ecc... Lo ha detto a gran voce la destra, lo dice la sinistra [3]. Ma è proprio così? C'è davvero un prima “democratico” e un dopo non democratico, post-democratico, anti-democratico di cui il Governo Monti rappresenta lo spartiacque?
Da quando è nato il Governo “tecnico” di Mario Monti si è fatto un gran parlare di sottomissione della “politica” ai “tecnici”, di “espropriazione” e “sospensione” della democrazia, di “dittatura dei mercati finanziari”, ecc... Lo ha detto a gran voce la destra, lo dice la sinistra [3]. Ma è proprio così? C'è davvero un prima “democratico” e un dopo non democratico, post-democratico, anti-democratico di cui il Governo Monti rappresenta lo spartiacque?
“La democrazia come acclamazione. Il fatto che la tecnica riduca il principio di autorità non significa che allarghi o favorisca il processo democratico, anzi: la riduzione del dominio politico ad amministrazione tecnocratica priva di oggetto ogni formazione democratica originata dalle volontà...” [4]
“A questo punto, il processo di formazione della volontà democratica si risolve in un procedimento regolamentato dall'acclamazione di elites chiamate alternativamente al potere” [5].
“A questo punto la democrazia cessa di essere la norma dei sistemi politici, e la tecnica, che la sostituisce come sistema normativo, finisce con il creare seri dubbi sulla possibilità, nelle società tecnicizzate, dell'esistenza della democrazia”[6]
Il ragionamento di Galimberti è suggestivo e coglie senz'altro un aspetto caratteristico della modalità attraverso cui oggi – specialmente in Italia - sembrano essere prese le decisioni, una modalità che appare “neutra”, “oggettiva” - “tecnica”, potremmo dire - in quanto interpretata in modo interscambiabile dalle diverse espressioni politiche che si alternano al potere.
- Details
- Hits: 3241

Traiettorie del Capitale
di Anselm Jappe
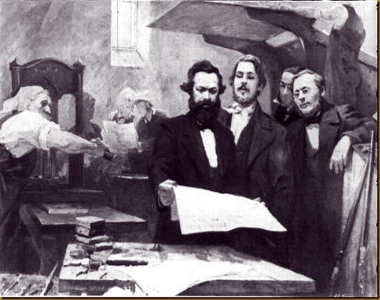 E' banale dire che stiamo vivendo un'epoca di enormi cambiamenti a livello tecnologico, che tutto diventa sempre più miniaturizzato e più veloce. Ciò che distingue un periodo storico da un altro, non è solamente la tecnologia, ma, soprattutto, i rapporti sociali. E, da questo punto di vista, ci troviamo più o meno nella stessa situazione che c'era nel XIX secolo, quando Karl Marx elaborò la sua critica del capitalismo. Soprattutto, se non consideriamo i rapporti sociali solo nella percezione della dominazione visibile da parte di una classe di persone - i proprietari dei mezzi di produzione - sugli altri gruppi sociali, costretti a vendere la loro forza lavoro. Ma se intendiamo per rapporto sociale, anche e soprattutto, le categorie fondamentali della società capitalistica: il lavoro e il valore, la merce e il denaro. Queste sono le forme, storicamente concrete, che prendono le attività produttive umane. Esse non sono naturali e non si trovano affatto in tutte le forme di società, tutt'altro. Dopo una lunga gestazione, a partire dalle loro forme embrionali, il lavoro e il valore, la merce e il denaro, il plus-valore e il capitale si sono imposti al centro della vita sociale a partire dalla rivoluzione industriale, e da oltre 250 anni queste categorie hanno continuato ad espandersi sopra aree sempre più ampie della vita umana, sia in senso geografico che all'interno delle società capitaliste, fino allo stadio attuale, dove non c'è praticamente alcun aspetto della vita che non sia determinato dal lavoro e dal valore, dalla merce e dal denaro, o dalle loro forme derivate.
E' banale dire che stiamo vivendo un'epoca di enormi cambiamenti a livello tecnologico, che tutto diventa sempre più miniaturizzato e più veloce. Ciò che distingue un periodo storico da un altro, non è solamente la tecnologia, ma, soprattutto, i rapporti sociali. E, da questo punto di vista, ci troviamo più o meno nella stessa situazione che c'era nel XIX secolo, quando Karl Marx elaborò la sua critica del capitalismo. Soprattutto, se non consideriamo i rapporti sociali solo nella percezione della dominazione visibile da parte di una classe di persone - i proprietari dei mezzi di produzione - sugli altri gruppi sociali, costretti a vendere la loro forza lavoro. Ma se intendiamo per rapporto sociale, anche e soprattutto, le categorie fondamentali della società capitalistica: il lavoro e il valore, la merce e il denaro. Queste sono le forme, storicamente concrete, che prendono le attività produttive umane. Esse non sono naturali e non si trovano affatto in tutte le forme di società, tutt'altro. Dopo una lunga gestazione, a partire dalle loro forme embrionali, il lavoro e il valore, la merce e il denaro, il plus-valore e il capitale si sono imposti al centro della vita sociale a partire dalla rivoluzione industriale, e da oltre 250 anni queste categorie hanno continuato ad espandersi sopra aree sempre più ampie della vita umana, sia in senso geografico che all'interno delle società capitaliste, fino allo stadio attuale, dove non c'è praticamente alcun aspetto della vita che non sia determinato dal lavoro e dal valore, dalla merce e dal denaro, o dalle loro forme derivate.
Nella società moderna basata sulla produzione di merci, il lavoro ha un aspetto duplice: è sia lavoro astratto che lavoro concreto. Tuttavia, questi non sono due diversi tipi di lavoro ed il lavoro astratto non ha nulla a che fare con il lavoro immateriale: una confusione terminologica costantemente mantenuta da alcuni autori. Ogni lavoro, indipendentemente dal suo contenuto, ha un lato astratto, vale a dire che costituisce semplicemente un dispendio di energia umana misurata dal tempo.
- Details
- Hits: 4947

La Cina può salvare il capitalismo?*
Sander
In tutto il mondo, gli stati capitalistici adottano delle misure d'austerità per rallentare la crescita del debito pubblico. Ma dal momento che frena il consumo, questa politica non è in grado di sostenere la crescita necessaria all'accumulazione del capitale.
Da dove può venire allora lo stimolo per mantenere la macchina in funzione? Per mancanza di alternative, lo sguardo si volge verso l’est. Sembra infatti che la storia - suprema ironia - abbia scelto la Cina "comunista" per il ruolo di salvatore del capitalismo mondiale.
.jpg) Quale crisi?
Quale crisi?
PI (Perspective Internationaliste) individua nella crisi attuale non solamente un evento ciclico nel processo d’accumulazione del capitale ma la manifestazione dell’obsolescenza delle fondamenta stesse del modo di produzione capitalistico, cioè a dire, della forma valore. La quale costringe il capitalista a misurare la ricchezza in termini di lavoro astratto quando, invece, la creazione di ricchezza reale dipende sempre meno dalla quantità di tempo di lavoro fornito, e sempre più dalle applicazioni produttive della conoscenza.
La previsione di Marx (nei 'Grundrisse'), che individuava in questa contraddizione fondamentale i limiti storici del capitalismo, trova oggi la sua piena realizzazione. Fondare sulla legge del valore le decisioni su cosa, come, quanto, dove e per chi produrre è diventato assurdo. Questa assurdità si manifesta nella coesistenza di una sovrapproduzione diffusa e di un’estrema povertà, nell’incapacità crescente del capitale di sfruttare l'aumento della forza lavoro disponibile –il cui effetto è la rapida espulsione di manodopera dalla produzione- mentre il denaro ricerca una sicurezza illusoria nelle bolle finanziarie.
Questa assurdità si manifesta negli sforzi fatti per imporre una carenza artificiale di beni che sarebbero altrimenti abbondanti e privi di valore (come i beni informatici). Nell'incapacità del Capitale di porre fine alla distruzione dell'ambiente, pur sapendo che le conseguenze disastrose sono sempre più minacciose.
- Details
- Hits: 2392

Perché adesso? Quale sarà il prossimo?
Conversazione tra Naomi Klein* e Yotam Marom**
 Naomi Klein - Una delle cose più misteriose riguardo a questo momento è: “perché adesso?” La gente ha lottato contro le misure di austerità e ha urlato per un paio di anni contro gli abusi delle banche, facendo essenzialmente la stessa analisi: “Non saremo noi a pagare per la vostra crisi”. Ma non sembrava proprio che acquistasse popolarità, almeno negli Stati Uniti. C’erano dimostrazioni e c’erano progetti politici e c’erano proteste come a Bloombergville. Ma, erano in gran parte ignorate. Non c’era davvero nulla su vastissima scala, nulla che realmente avesse un impatto significativo. E adesso, improvvisamente, questo gruppo di persone in un parco ha fatto esplodere qualche cosa di straordinario. Come lo spieghi, allora, dato che sei stato impegnato in OWS dall’inizio, ma anche nelle precedenti azioni contro l’austerità?
Naomi Klein - Una delle cose più misteriose riguardo a questo momento è: “perché adesso?” La gente ha lottato contro le misure di austerità e ha urlato per un paio di anni contro gli abusi delle banche, facendo essenzialmente la stessa analisi: “Non saremo noi a pagare per la vostra crisi”. Ma non sembrava proprio che acquistasse popolarità, almeno negli Stati Uniti. C’erano dimostrazioni e c’erano progetti politici e c’erano proteste come a Bloombergville. Ma, erano in gran parte ignorate. Non c’era davvero nulla su vastissima scala, nulla che realmente avesse un impatto significativo. E adesso, improvvisamente, questo gruppo di persone in un parco ha fatto esplodere qualche cosa di straordinario. Come lo spieghi, allora, dato che sei stato impegnato in OWS dall’inizio, ma anche nelle precedenti azioni contro l’austerità?
Yotam Marom – Ebbene, la prima risposta è: non ho idea , nessuno ne ha. Ma posso fare delle congetture. Penso che ci siano delle cose che si devono considerare con attenzione quando ci sono momenti come questi. Una sono le condizioni: disoccupazione, debito, sfratti, i molti altri problemi che deve affrontare la gente. Le condizioni sono vere e sono brutte, e non si possono simulare. Un altro tipo di base per questo tipo di cosa è quello che fa la gente che organizza per preparare momenti come questi. Ci piace fantasticare su queste insurrezioni e sugli importanti momenti politici – ci piace immaginare che vengano fuori dal nulla e che sia necessario solo questo – ma queste cose accadono se c’è dietro uno sforzo organizzativo enorme che viene fatto ogni giorno, in tutto il mondo, in comunità che sono realmente emarginate e che affrontano attacchi bruttissimi.
Page 543 of 612




































