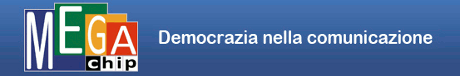Fai una donazione
Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________
- Details
- Hits: 3069
Il nuovo governo greco
Noi Restiamo intervista Joseph Halevi
 In questi giorni sono usciti molti articoli sul nuovo governo greco e in particolare su alcuni suoi componenti. La maggior parte di questi articoli si è concentrata su aspetti di costume e non sulla sostanza, ossia su quali politiche economiche potrà mettere in atto la nuova compagine governativa.
In questi giorni sono usciti molti articoli sul nuovo governo greco e in particolare su alcuni suoi componenti. La maggior parte di questi articoli si è concentrata su aspetti di costume e non sulla sostanza, ossia su quali politiche economiche potrà mettere in atto la nuova compagine governativa.
Abbiamo quindi intervistato Joseph Halevi, professore di economia presso l'Università di Sydney, che ben conosce Yanis Varoufakis, neo ministro delle finanze in Grecia, di cui è amico e con cui ha anche scritto un libro (insieme a Nicholas Theocarakis): “Modern Political Economy: making sense of the post-2008 world” (Routledge).
Noi Restiamo: ci dai un giudizio sul risultato delle recenti elezioni in Grecia?
Joseph Halevi: il mio giudizio è essenzialmente positivo. C'è ovviamente un problema dovuto al fatto che Syriza ha delle posizioni molto eterogenee. Però voglio dire che l'esigenza che nasceva dalla crisi del Pasok ovviamente ha trovato sbocco in Syriza.
- Details
- Hits: 1801
I segni cangianti di un’opera aperta
Benedetto Vecchi
Torna finalmente nelle librerie il saggio di Henri Lefebvre «Il diritto alla città». Un libro presto archiviato come incompleto, anche se negli anni successivi alla sua pubblicazione ha aperto sentieri di analisi sulle trasformazioni urbane come quelli di Mike Davis, Saskia Sassen e David Harvey
 Sono passati molti lustri da quando il filosofo francese Henri Lefebvre mandò alle stampe una riflessione sulla città — Le droit à la ville — critica nei confronti di una visione della metropoli allora dominante. A distanza di decenni, quell’analisi conosce un inedito e a tratti condivisibile revival, grazia a un lavoro di riscoperta che fa leva sui movimenti sociali che puntano alla riappropriazione della metropoli dopo una corrosiva privatizzazione dello spazio pubblico. Molte le differenza tra l’ordine del discorso allora dominante e quello attuale. Nei turbolenti anni Sessanta, infatti, gli urbanisti, affascinati dalle oscure declamazioni di Talcott Parson sulla realtà come un «sistema chiuso», sostenevano che la città era da considerare appunto un sistema autoreferenziale che stabiliva corrosivi rapporti di feedback con l’ambiente circostante al fine di riprodurre una forma del vivere sociale che non ammetteva alternativa al suo divenire.
Sono passati molti lustri da quando il filosofo francese Henri Lefebvre mandò alle stampe una riflessione sulla città — Le droit à la ville — critica nei confronti di una visione della metropoli allora dominante. A distanza di decenni, quell’analisi conosce un inedito e a tratti condivisibile revival, grazia a un lavoro di riscoperta che fa leva sui movimenti sociali che puntano alla riappropriazione della metropoli dopo una corrosiva privatizzazione dello spazio pubblico. Molte le differenza tra l’ordine del discorso allora dominante e quello attuale. Nei turbolenti anni Sessanta, infatti, gli urbanisti, affascinati dalle oscure declamazioni di Talcott Parson sulla realtà come un «sistema chiuso», sostenevano che la città era da considerare appunto un sistema autoreferenziale che stabiliva corrosivi rapporti di feedback con l’ambiente circostante al fine di riprodurre una forma del vivere sociale che non ammetteva alternativa al suo divenire.
La prima edizione del saggio di Lefebvre è del 1970, ma fu presto archiviato perché ritenuto un manoscritto incompleto. Da alcuni anni, però, il geografo David Harvey ha attinto a Il diritto alla città come una miniera di suggestioni per analizzare il ruolo della metropoli come un hub delle dinamiche economiche e sociali della contemporaneità. Ha dunque fatto bene la casa editrice ombre corte a ripubblicarlo, corredandolo di una utile prefazione di Anna Casaglia, che inquadra storicamente il saggio del filosofo francese (Il diritto alla città, pp. 138, euro 14).
- Details
- Hits: 2024
La Barbarie non è inevitabile
In memoria di Robert Kurz (1943 - 2012)
di Claus Peter Ortlieb
 Robert Kurz è morto il 18 luglio 2012, all'età di 68 anni. Tutto sta ad indicare come l'influenza dell'opera di una vita continuerà ben oltre la sua morte. Tanto l'influenza suoi scritti, quanto l'influenza diretta esercitata da Robert Kurz sulle persone che lo conoscevano, appare evidente dai molti necrologi. Un'influenza che derivava essenzialmente da una relazione con le sue conoscenze e con le sue convinzioni, insuscettibili di essere corrotte o strumentalizzate, come constata Daniel Späth:
Robert Kurz è morto il 18 luglio 2012, all'età di 68 anni. Tutto sta ad indicare come l'influenza dell'opera di una vita continuerà ben oltre la sua morte. Tanto l'influenza suoi scritti, quanto l'influenza diretta esercitata da Robert Kurz sulle persone che lo conoscevano, appare evidente dai molti necrologi. Un'influenza che derivava essenzialmente da una relazione con le sue conoscenze e con le sue convinzioni, insuscettibili di essere corrotte o strumentalizzate, come constata Daniel Späth:
"Da quando lo conosco non l'ho mai visto utilizzare la sua straordinaria posizione teorica al fine di interessi tattici di potere, o considerare la critica come luogo di realizzazione di sensibilità personali; l'arroganza e il culto del proprio ego gli erano profondamente estranei. Che questa accusa a volte sia stata mossa contro di lui da parte di alcuni compagni e compagne di viaggio, va attribuito, in una certa misura, al desiderio di dislocare sul piano personale quelle che erano delle differenze oggettive di contenuto e le sue forme di decisione necessariamente veementi. Giacché, per quanto polemici fossero i suoi testi ed i suoi libri, dal loro spirito raffinato e dalla loro convincente inesorabilità poteva derivare un contrasto sul contenuto e sulla sua trasformazione in critica radicale, ma non la necessità dell'autopromozione di una mera denuncia. Per quanti siano stati i confronti violenti,a volte spiacevoli, che Robert Kurz ha avuto nella e con la sinistra, egli non ha mai perso la speranza che questa sinistra si potesse liberare dai suoi residui borghesi, per realizzare finalmente il progetto di una 'anti-modernità emancipatrice'."
- Details
- Hits: 2117
Quel sapore anni ’50 nel QE di Supermario
di Maurizio Sgroi
 Chiunque si sia avventurato nell’esplorazione anche sommaria delle ultime decisioni della Bce temo sia naufragato nell’oceano di parole che le hanno accompagnate e nei commenti isterici che ne sono seguiti.
Chiunque si sia avventurato nell’esplorazione anche sommaria delle ultime decisioni della Bce temo sia naufragato nell’oceano di parole che le hanno accompagnate e nei commenti isterici che ne sono seguiti.
Travolto, soprattutto, dalla tecnicalità davvero barocca con la quale il Quantitative easing (QE) verrà declinato, il povero osservatore ha poche scelte: deve decidere se stare dalla parte di chi è soddisfatto o di chi non lo è, dovendosi peraltro confrontare con modalità di comunicazione che sembrano fatte apposta per celare piuttosto che per chiarire.
Mi spiego. Leggo e rileggo il comunicato con il quale la Bce ha spiegato senso e dimensioni dell’operazione. Proprio all’inizio c’è scritto che “La Bce estende gli acquisti alle obbligazioni emesse da amministrazioni centrali dei paesi dell’area dell’euro, agenzie situate nell’area dell’euro e istituzioni europee” e che “gli acquisti mensili di attività ammonteranno nell’insieme a 60 miliardi di euro almeno fino a settembre 2016″.
Uno perciò pensa che i 60 miliardi saranno spesi integralmente per comprare “obbligazioni emesse da amministrazioni centrali dei paesi dell’area dell’euro, agenzie situate nell’area dell’euro e istituzioni europee”.
- Details
- Hits: 2977
Quantitative Easing e elezioni greche: un cambio in Europa?
di Andrea Fumagalli
 La settimana appena trascorsa verrà probabilmente definita storica per l’Europa. La decisione della BCE di finanziare, in modo diretto, alla faccia del Trattato di Maastricht, il debito pubblico dei paesi dell’Unione e la vittoria di Syriza alle elezioni greche, con la messa in discussione delle politiche di austerity finora pervicacemente perseguite dall’oligarchia economico-finanziaria, possono segnare un momento di svolta?
La settimana appena trascorsa verrà probabilmente definita storica per l’Europa. La decisione della BCE di finanziare, in modo diretto, alla faccia del Trattato di Maastricht, il debito pubblico dei paesi dell’Unione e la vittoria di Syriza alle elezioni greche, con la messa in discussione delle politiche di austerity finora pervicacemente perseguite dall’oligarchia economico-finanziaria, possono segnare un momento di svolta?
Non è facile, a caldo, rispondere. Ci proviamo, con tutte le cautele del caso, partendo dalle decisioni della BCE, non a caso varate tre giorni prima delle elezioni greche.
Svolta della BCE?
Numerosi sono stati gli articoli che hanno presentato e commentato la svolta nella politica economica della BCE dopo la storica decisione dello scorso 22 gennaio di procedere all’acquisto di titoli finanziari (prevalentemente pubblici) per un ammontare di 60 miliardi di euro al mese, almeno sino a settembre 2016. In questa sede non entriamo nell’analisi dello scenario geo-economico globale in cui tale provvedimento si colloca. Lo ha già fatto egregiamente l’articolo di Raffaele Sciortino su queste stesse pagine. Ci limitiamo piuttosto a fare un’analisi critica dei commenti che lo hanno accompagnato, con particolare riferimento agli effetti e al caso italiano.
- Details
- Hits: 2600
#Tsipras, il gran botto nel Laboratorio Greco
di Pino Cabras
 Se consideriamo la Grecia come un laboratorio, così come in molti fanno da anni, in occasione della vittoria di Tsipras abbiamo assistito all'incendio di molti alambicchi. Chi conduce l'esperimento, specie se si tratta di un test pericoloso, corre anche il rischio di collaudare qualcosa che non risponde ai suoi modelli di partenza: mette nel conto di sacrificare risorse, forzare i limiti, spingere al massimo le resistenze, scoprire cosa brucia subito e cosa provoca ritorni di fiamma imprevisti.
Se consideriamo la Grecia come un laboratorio, così come in molti fanno da anni, in occasione della vittoria di Tsipras abbiamo assistito all'incendio di molti alambicchi. Chi conduce l'esperimento, specie se si tratta di un test pericoloso, corre anche il rischio di collaudare qualcosa che non risponde ai suoi modelli di partenza: mette nel conto di sacrificare risorse, forzare i limiti, spingere al massimo le resistenze, scoprire cosa brucia subito e cosa provoca ritorni di fiamma imprevisti.
Se gli va bene, scopre una nuova formula che potrà ogni volta padroneggiare. Se gli va male, può provare e riprovare ancora sulle cavie, e solo dopo potrà estendere le esperienze sicure su un sistema più vasto. Oppure può circondare di misure di sicurezza quel piccolo e scoppiettante laboratorio isolato.
La Grecia è stata già altre volte un'officina per gli sperimentatori delle élite occidentali. Se ci pensiamo, negli stessi anni in cui in Italia gli ambienti atlantisti influenzavano la vita politica con la strategia della tensione e vari tentativi di colpo di Stato, ad Atene i militari andavano davvero al potere con un golpe, instaurando la Dittatura dei Colonnelli (1967-1974). Nella culla della civiltà europea si poté così sperimentare per qualche anno la soppressione delle normali libertà civili, lo scioglimento dei partiti politici, l'istituzione di tribunali militari speciali, il ricorso alla tortura e al confino per migliaia di oppositori.
- Details
- Hits: 2675
E se fosse la Cina lo scudo dell'Italia?
di Pasquale Cicalese
 "Continuiamo a comprare partecipazioni in società italiane, ma ora siamo attenti a rimanere al di sotto della soglia del 2% in modo che non siamo obbligati a comunicarlo; deteniamo asset italiani, tra azioni e titoli di stato, pari a 100 miliardi di euro e continueremo". Zhou Xiaochuan, Governatore Banca Centrale Cinese, Davos 22 gennaio. Fonte: Milanofinanza on line, 22 gennaio.
"Continuiamo a comprare partecipazioni in società italiane, ma ora siamo attenti a rimanere al di sotto della soglia del 2% in modo che non siamo obbligati a comunicarlo; deteniamo asset italiani, tra azioni e titoli di stato, pari a 100 miliardi di euro e continueremo". Zhou Xiaochuan, Governatore Banca Centrale Cinese, Davos 22 gennaio. Fonte: Milanofinanza on line, 22 gennaio.
Lo stesso giorno della dichiarazione del Governatore della Banca Centrale Cinese partiva l’operazione QE di Draghi che sanciva la definitiva annessione alla Germania e il commissariamento dell’Italia da parte della Trojka, con il fine ultimo tedesco di abbattere del tutto l’economia produttiva italiana, concorrente a quella tedesca, e prendersi l’oro di Bankitalia una volta che gli spread schizzeranno in alto provocando la crisi e la disgregazione dell’euro, con la probabile uscita tedesca, una volta completata la strategia di distruzione dell’Europa iniziata con il Piano Werner del 1972.
Il lato debole di tale strategia è però la sua domanda interna e i troppi fronti imperialisti aperti per far piacere gli Usa, dai Balcani alla Russia. Le mire egemoniche e di grandezza dei tedeschi, per la terza volta, dopo la prima e la seconda guerra mondiale, si scontrano con i troppi fronti aperti.
- Details
- Hits: 2828
La dittatura del debito in Europa e le possibili vie di fuga
Luigi Pandolfi
 E’ ormai un dato storico, oltre che economico, il fatto che la crisi finanziaria scoppiata a cavallo tra il 2007 ed il 2008 abbia avuto un effetto deflagrante sulla finanza pubblica dei paesi europei. Il mix di salvataggi bancari, austerity e recessione, che ha segnato la storia europea degli ultimi anni, ha letteralmente fatto esplodere il debito nella gran parte dei paesi dell’Unione, mettendone a rischio, in alcuni casi, la stessa sostenibilità. Se guardiamo all’Eurozona nel suo complesso, è impressionante constatare come nel periodo 2007 – 2013 il debito aggregato sia passato dal 66,2% al 92,6% del Pil (In valore assoluto 8.842 miliardi di Euro)[1]. Certo, in questo dato ci sono situazioni molto diverse tra di loro, sia per l’entità dell’indebitamento che per la sua composizione, ma il fenomeno della crescita del debito ha riguardato tutti i paesi dell’area, ed anche quelli che al momento ne sono fuori.
E’ ormai un dato storico, oltre che economico, il fatto che la crisi finanziaria scoppiata a cavallo tra il 2007 ed il 2008 abbia avuto un effetto deflagrante sulla finanza pubblica dei paesi europei. Il mix di salvataggi bancari, austerity e recessione, che ha segnato la storia europea degli ultimi anni, ha letteralmente fatto esplodere il debito nella gran parte dei paesi dell’Unione, mettendone a rischio, in alcuni casi, la stessa sostenibilità. Se guardiamo all’Eurozona nel suo complesso, è impressionante constatare come nel periodo 2007 – 2013 il debito aggregato sia passato dal 66,2% al 92,6% del Pil (In valore assoluto 8.842 miliardi di Euro)[1]. Certo, in questo dato ci sono situazioni molto diverse tra di loro, sia per l’entità dell’indebitamento che per la sua composizione, ma il fenomeno della crescita del debito ha riguardato tutti i paesi dell’area, ed anche quelli che al momento ne sono fuori.
Prendiamo due paesi considerati agli antipodi dal punto di vista economico: la Germania e la Grecia. Nel periodo in esame, il primo fa registrare un balzo del proprio debito dal 65,2% al 78,4% (con una punta dell’81% nel 2012) della ricchezza nazionale, il secondo dal 107,4% al 175,1%.[2] Per quanto può valere sul piano economico, è impressionante però il divario tra i due paesi relativamente alla grandezza assoluta del proprio debito: 2.127 miliardi Euro la Germania (valore più alto dell’intera Unione), 317 miliardi la Grecia[3].
- Details
- Hits: 2837
Le ragioni della democrazia (e della sua crisi)
Giulio Azzolini intervista Alessandro Ferrara e Stefano Petrucciani
Proprio dopo essere diventata la forma di governo legittima per eccellenza, la democrazia è sempre più spesso percepita come un regime politico in grave crisi. A partire dai loro ultimi lavori – The Democratic Horizon (Cambridge University Press) e Democrazia (Einaudi) – Ferrara e Petrucciani affrontano in chiave filosofico-politica questo paradosso e molti altri problemi: dalla critica delle concezioni procedurali e competitive della democrazia alla proposta di un approccio normativo deliberativo, dal rischio di una deriva oligarchica e tecnocratica transnazionale fino alle conseguenze della crisi economica. Nella convinzione che oggi, per difendere la democrazia, riflettere sulle sue ragioni sia più utile che coniare nuovi slogan
 Esprimere un giudizio sugli ultimi mesi di “grande trasformazione” della nostra democrazia è forse prematuro. Di sicuro, però, il 2014 è stato un anno particolarmente fecondo per la riflessione italiana sulla democrazia. Vi hanno contribuito, tra gli altri, un sociologo e politologo del calibro di Ilvo Diamanti (con Democrazia ibrida, Laterza-la Repubblica), uno scienziato politico di fama internazionale come Leonardo Morlino (con Democrazia e mutamenti, Luiss University Press) e la teorica politica della Columbia University Nadia Urbinati (con Democrazia sfigurata, Egea). All’esercizio di studio della metamorfosi democratica non poteva dunque sottrarsi la filosofia politica italiana, che partecipa al dibattito grazie agli originali lavori diAlessandro Ferrara, The Democratic Horizon. Hyperpluralism and the Renewal of Political Liberalism (Cambridge University Press, pagg. 257, euro 72), e di Stefano Petrucciani, Democrazia (Einaudi, pagg. 260, euro 22). Educati rispettivamente alla tradizione liberal statunitense e alla teoria critica francofortese, i due hanno trovato nell’opera di Jürgen Habermas – del quale il primo è stato allievo e al cui pensiero il secondo ha dedicato un’importante Introduzione[i] – l’occasione di stabilire un linguaggio comune e di intendersi su molti temi, primo dei quali la democrazia.
Esprimere un giudizio sugli ultimi mesi di “grande trasformazione” della nostra democrazia è forse prematuro. Di sicuro, però, il 2014 è stato un anno particolarmente fecondo per la riflessione italiana sulla democrazia. Vi hanno contribuito, tra gli altri, un sociologo e politologo del calibro di Ilvo Diamanti (con Democrazia ibrida, Laterza-la Repubblica), uno scienziato politico di fama internazionale come Leonardo Morlino (con Democrazia e mutamenti, Luiss University Press) e la teorica politica della Columbia University Nadia Urbinati (con Democrazia sfigurata, Egea). All’esercizio di studio della metamorfosi democratica non poteva dunque sottrarsi la filosofia politica italiana, che partecipa al dibattito grazie agli originali lavori diAlessandro Ferrara, The Democratic Horizon. Hyperpluralism and the Renewal of Political Liberalism (Cambridge University Press, pagg. 257, euro 72), e di Stefano Petrucciani, Democrazia (Einaudi, pagg. 260, euro 22). Educati rispettivamente alla tradizione liberal statunitense e alla teoria critica francofortese, i due hanno trovato nell’opera di Jürgen Habermas – del quale il primo è stato allievo e al cui pensiero il secondo ha dedicato un’importante Introduzione[i] – l’occasione di stabilire un linguaggio comune e di intendersi su molti temi, primo dei quali la democrazia.
- Details
- Hits: 6591
Dipendenti pubblici troppo numerosi e poco produttivi
Una bugia!
di Guglielmo Forges Davanzati
La vicenda delle assenze dei vigili urbani di Roma ha accelerato il ddl Madia sulla “riforma del pubblico impiego”. Ma la strategia di ulteriore ‘dimagrimento’ del settore pubblico, controproducente per l’obiettivo della fuoriuscita dalla recessione, è giustificata con argomenti che non reggono alla prova dei fatti
 L’assenza, per malattia, di circa l’83% (per la stima del Comune) di vigili urbani a Roma la notte di Capodanno ha impresso una significativa accelerazione al ddl Madia sulla “riforma del pubblico impiego”. Per quanto è dato sapere, il punto principale del provvedimento riguarderà la maggiore discrezionalità assegnata alla Pubblica Amministrazione di licenziare propri dipendenti poco produttivi, e di affidare all’INPS i controlli medici per la certificazione dell’effettiva malattia dei dipendenti in caso di assenza.
L’assenza, per malattia, di circa l’83% (per la stima del Comune) di vigili urbani a Roma la notte di Capodanno ha impresso una significativa accelerazione al ddl Madia sulla “riforma del pubblico impiego”. Per quanto è dato sapere, il punto principale del provvedimento riguarderà la maggiore discrezionalità assegnata alla Pubblica Amministrazione di licenziare propri dipendenti poco produttivi, e di affidare all’INPS i controlli medici per la certificazione dell’effettiva malattia dei dipendenti in caso di assenza.
Al netto di singoli casi di comportamenti eticamente censurabili e comunque punibili, stando alla normativa vigente, occorre considerare i possibili effetti macroeconomici che tali misure verosimilmente produrranno. E occorre anche preliminarmente considerare che il c.d. decreto Brunetta già contiene tutte le misure necessarie per consentire il licenziamento di dipendenti pubblici, in un quadro normativo nel quale il regime di sanzionamento dell’assenteismo è diverso fra settore privato e settore pubblico.
Nel settore privato, la disciplina sulle assenze per malattia prevede che, per i primi tre giorni di assenza continuativa, l’indennità di malattia è a carico del datore di lavoro, con una percentuale di copertura definita dal contratto nazionale. A partire dal quarto giorno, l’Inps versa un’indennità non inferiore al 50 per cento della retribuzione, mentre la parte rimanente viene integrata dal datore di lavoro.
- Details
- Hits: 2930
Quantitative Easing. Dopo di me il diluvio?
Sergio Cesaratto
 Le promesse di ripresa dell’Eurozona per il 2014 non si sono materializzate, come i più avveduti si attendevano[1], mentre hanno preso concretezza quelle di deflazione. Durante il 2014 Draghi aveva ripetutamente annunciato misure più drastiche per sostenere l’Eurozona. Il 22 gennaio scorso ha annunciato il tanto atteso Quantitative Easing (QE) consistente in un piano di acquisti di titoli pubblici dell’Eurozona per 60 miliardi al mese sino (almeno) al settembre 2016.
Le promesse di ripresa dell’Eurozona per il 2014 non si sono materializzate, come i più avveduti si attendevano[1], mentre hanno preso concretezza quelle di deflazione. Durante il 2014 Draghi aveva ripetutamente annunciato misure più drastiche per sostenere l’Eurozona. Il 22 gennaio scorso ha annunciato il tanto atteso Quantitative Easing (QE) consistente in un piano di acquisti di titoli pubblici dell’Eurozona per 60 miliardi al mese sino (almeno) al settembre 2016.
La domanda di Draghi
Il Presidente della BCE è infatti da tempo perfettamente consapevole della natura vera dei problemi, come rivelato in un importante discorso tenuto a Jackson Hole nel settembre 2014 (Draghi 2014). In quel discorso egli sottolineò come il rischio di fare troppo per sostenere la domanda aggregata fosse assai minore di quello di fare troppo poco. Naturalmente tale perorazione fu accompagnata da quella alle riforme strutturali, ma questo era scontato. Più importante fu la denuncia della “crescita troppo lenta dei salari nei paesi non in crisi ciò che suggerisce una crescita fiacca della domanda” e degli spazi esistenti per la politica di bilancio laddove v’è un sostegno istituzionale della banca centrale, come negli Stati Uniti e in Giappone.
- Details
- Hits: 2530
Un libro di scritti di Minsky
Francesco Garibaldo
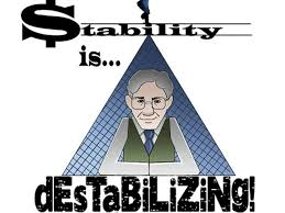 È uscita, per i tipi della casa editrice Ediesse, l’edizione italiana di una raccolta di scritti editi e inediti di Hyman Philip Minsky (1919-1996) pubblicata l’anno scorso negli Stati Uniti a cura del “Levy Economic Institute of Bard College”. Gli scritti, che spaziano dal 1965 al 1994, riguardano la lotta alla povertà, i problemi dello Stato Sociale e come raggiungere la piena occupazione.
È uscita, per i tipi della casa editrice Ediesse, l’edizione italiana di una raccolta di scritti editi e inediti di Hyman Philip Minsky (1919-1996) pubblicata l’anno scorso negli Stati Uniti a cura del “Levy Economic Institute of Bard College”. Gli scritti, che spaziano dal 1965 al 1994, riguardano la lotta alla povertà, i problemi dello Stato Sociale e come raggiungere la piena occupazione.
Il lettore, oltre agli scritti di Minsky, dispone di tre saggi introduttivi che arricchiscono in modo significativo il contenuto di conoscenza del volume. Il primo saggio è stato scritto per questa edizione italiana da Riccardo Bellofiore e Laura Pennacchi; il secondo, la vera e propria prefazione, e il terzo, l’introduzione, sono stati scritti per l’edizione originale, rispettivamente da Dimitri Papadimitriou, presidente dell’Istituto Levy, e da Randall Wray, senior scholar dell’Istituto, oltre che professore di economia. Il saggio di Bellofiore e Pennacchi vuole aiutare i lettori italiani a “un possibile utile uso di Minsky oggi in Italia”, per usare le loro stesse parole. Il saggio di Papadimitriou illustra il contenuto dei sette capitoli del libro mentre quello di Wray contestualizza il volume nel dibattito statunitense.
- Details
- Hits: 2265
La moratoria del debito italiano è un'illusione
Meglio emettere una nuova moneta statale
di Enrico Grazzini
 Le elezioni greche rappresentano una svolta storica. Syriza al governo contrasterà finalmente la Troika (UE, BCE, FMI) e cercherà di porre fine alla tragedia provocata dagli usurai pubblici e privati che prima hanno corrotto le classi dirigenti greche prestando irresponsabilmente denaro a fiumi, poi hanno succhiato il sangue del popolo greco riducendolo alla miseria. Viva Syriza! Tuttavia è ingenuo e semplicistico credere che la proposta avanzata da Alexis Tsipras in Grecia, cioè la moratoria del debito pubblico, possa essere una soluzione valida e ugualmente proponibile anche per l'Italia. Il debito pubblico italiano è troppo alto e non c'è alcuna possibilità di moratoria. L'euro ci strangola, è una moneta che serve solo alla finanza tedesca e del nord Europa. Ma uscire unilateralmente è come fare rientrare il dentifricio nel tubetto.
Le elezioni greche rappresentano una svolta storica. Syriza al governo contrasterà finalmente la Troika (UE, BCE, FMI) e cercherà di porre fine alla tragedia provocata dagli usurai pubblici e privati che prima hanno corrotto le classi dirigenti greche prestando irresponsabilmente denaro a fiumi, poi hanno succhiato il sangue del popolo greco riducendolo alla miseria. Viva Syriza! Tuttavia è ingenuo e semplicistico credere che la proposta avanzata da Alexis Tsipras in Grecia, cioè la moratoria del debito pubblico, possa essere una soluzione valida e ugualmente proponibile anche per l'Italia. Il debito pubblico italiano è troppo alto e non c'è alcuna possibilità di moratoria. L'euro ci strangola, è una moneta che serve solo alla finanza tedesca e del nord Europa. Ma uscire unilateralmente è come fare rientrare il dentifricio nel tubetto.
L'Italia potrebbe invece uscire dalla deflazione e dalla crisi grazie all'emissione di una nuova moneta statale complementare all'euro. Occorre infatti che gli stati riprendano almeno in parte la loro autonomia in campo monetario, senza attendere l'approvazione preventiva della Commissione Europea, della BCE e del governo tedesco. La proposta di creare una nuova moneta statale parallela all'euro (senza però uscire dall'euro) avanzata da Luciano Gallino e da altri economisti va proprio in questa direzione [1].
- Details
- Hits: 2232
I risultati delle elezioni greche
Grande incertezza, situazione eccellente
di Akis Gavriilidis
 Dopo il suo commento pre-elettorale, pubblichiamo un contributo di Akis Graviilidis sulla situazione greca dopo le elezioni e il giuramento del primo governo di SYRIZA. Quasi ironizzando sulle preoccupazioni di chi teme per i propri principi o per le proprie aspettative, Akis pone politicamente il problema delle possibilità aperte dal fatto della vittoria di Syriza. A noi questa annotazione politica pare decisamente importante. Prendere le mosse dal movimento che dal quel fatto può scaturire aiuta a evitare di ragionare sempre – in Grecia come altrove – come se nulla mai possa veramente cambiare, come se i soggetti politici siano sempre gli stessi.
Dopo il suo commento pre-elettorale, pubblichiamo un contributo di Akis Graviilidis sulla situazione greca dopo le elezioni e il giuramento del primo governo di SYRIZA. Quasi ironizzando sulle preoccupazioni di chi teme per i propri principi o per le proprie aspettative, Akis pone politicamente il problema delle possibilità aperte dal fatto della vittoria di Syriza. A noi questa annotazione politica pare decisamente importante. Prendere le mosse dal movimento che dal quel fatto può scaturire aiuta a evitare di ragionare sempre – in Grecia come altrove – come se nulla mai possa veramente cambiare, come se i soggetti politici siano sempre gli stessi.
***
1. La mia seconda nota sulle elezioni greche, questa volta dopo che hanno avuto luogo, sarà necessariamente più frammentaria e impressionistica, oltre che più sentimentale. Il che (almeno spero) non significa che sarà superficiale.
Il primo sentimento che viene alla mente è il sollievo. La gente che non vive in Grecia, o che non ha neppure avuto modo di visitarla occasionalmente negli anni scorsi, non ha neanche idea di quanto insostenibile fosse diventata l’amministrazione di Samaras, da un punto di vista politico, etico e persino estetico. È difficile spiegare il senso di soffocamento prodotto da questo dominio basato sulla paura, sull’odio, sull’autoavvilimento, su praticamente tutte le possibili passioni negative che sono state compensate, a livello immaginario, da un’overdose di vanità e autoglorificazione nazionalistica.
- Details
- Hits: 2166
Deflazione e disoccupazione in Europa
… e i problemi che il quantitative easing non risolve
di Michele Nobile
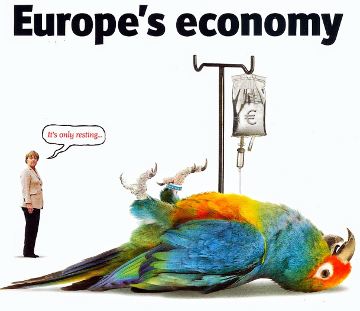
La signora Merkel e il pappagallo congelato
Un colossale pappagallo zampe all'aria, con tutta l'apparenza d'essere morto: così la copertina di The economist rendeva lo stato dell'economia europea nell'ultima settimana di ottobre dell'anno appena trascorso. Nella stessa immagine, una piccola Angela Merkel osserva il pappagallo affermando: sta solo riposando (it's only resting).
Di cosa potrebbe soffrire lo sventurato pappagallo? Di freddo, nonostante le temperature anomale dell'autunno. Freddo che in termini economici si chiama deflazione: The economist suggerisce dunque un paragone tra i prezzi e i parametri di temperatura entro cui si svolge la vita. Un certo livello d'inflazione nel processo economico è l'equivalente del sano riscaldamento del corpo nell'attività fisica: la crescita nominale dei prezzi e dei salari è indice di crescita dell'investimento e dell'occupazione, di vitalità economica. Viceversa, l'analogo della deflazione è il processo di congelamento, che causa sonnolenza, incoscienza e infine, se non si arresta, la morte. Ed è appunto questo il processo di cui può rimanere vittima il pappagallo, cioè l'economia europea.
Infatti, se si osserva il termometro dei prezzi al consumo, esso ci dice che la temperatura media annua nell'area dell'euro a ottobre era allo 0,4%, a novembre a 0,3%, a dicembre -0,2% (ultimo dato del flash Eurostat del 7 gennaio 2015).
- Details
- Hits: 2818
Verità e politica in Althusser: genesi di una problematica (1947-1956)
Fabio Raimondi
 Il rapporto tra verità e politica è una costante della filosofia di Althusser. In questo saggio mi concentrerò, senza pretese di esaustività, sul periodo, poco studiato ma non per questo poco importante, che va dalla tesi di laurea su Hegel (1947), discussa dopo due anni dal ritorno dalla prigionia nei campi di concentramento tedeschi (cfr. Journal de captivité) e un anno prima di iscriversi al Partito comunista francese (cfr. Moulier-Boutang), fino al 1956: l’anno del XX Congresso del Pcus. Un intervallo decisivo per capire Althusser che, nel laboratorio di quegli anni, traccia i confini del proprio campo problematico ed elabora alcune categorie della propria filosofia.
Il rapporto tra verità e politica è una costante della filosofia di Althusser. In questo saggio mi concentrerò, senza pretese di esaustività, sul periodo, poco studiato ma non per questo poco importante, che va dalla tesi di laurea su Hegel (1947), discussa dopo due anni dal ritorno dalla prigionia nei campi di concentramento tedeschi (cfr. Journal de captivité) e un anno prima di iscriversi al Partito comunista francese (cfr. Moulier-Boutang), fino al 1956: l’anno del XX Congresso del Pcus. Un intervallo decisivo per capire Althusser che, nel laboratorio di quegli anni, traccia i confini del proprio campo problematico ed elabora alcune categorie della propria filosofia.
1.
Asse portante della problematica entro cui Althusser misura il rapporto tra verità e politica è l’ipotesi che si possa costruire una scienza della storia e che, per farlo, sia necessario «pensare un trascendentale “dopo Hegel”» (cfr. Rametta, 111-113)1 .
Secondo Althusser, Kant e Hegel non sono riusciti, per motivi diversi, a liberarsi del «trascendentalismo», facendo sfociare le loro filosofie nel campo dell’ideologia2 .
- Details
- Hits: 3039

Quantitative easing: crescita o bolla?
Un'analisi critica della mossa della Bce
di Leonardo Mazzei
 «Crescita o bolla?» Prevedibilmente, la "seconda che hai detto". Tutto lascia pensare che le decisioni della Bce avranno ben poco effetto sull'economia reale. D'altronde, l'opinione di molti economisti è che le bolle speculative siano assolutamente necessarie. Nelle parole di Larry Summers, che fu anche ministro di Clinton, si tratta sì di una droga, ma di una droga assolutamente necessaria. Senza di essa il sistema si inceppa. E proprio parafrasando un noto slogan clintoniano, potremmo dire che "è il capitalismo-casinò, bellezza!».
«Crescita o bolla?» Prevedibilmente, la "seconda che hai detto". Tutto lascia pensare che le decisioni della Bce avranno ben poco effetto sull'economia reale. D'altronde, l'opinione di molti economisti è che le bolle speculative siano assolutamente necessarie. Nelle parole di Larry Summers, che fu anche ministro di Clinton, si tratta sì di una droga, ma di una droga assolutamente necessaria. Senza di essa il sistema si inceppa. E proprio parafrasando un noto slogan clintoniano, potremmo dire che "è il capitalismo-casinò, bellezza!».
Fa un po' sorridere, dunque, il trionfale commento di Padoan, che ha detto che «ora le famiglie possono cominciare a spendere». E perché mai? Il loro reddito è forse in risalita? Ma lasciamo perdere, che ad andar con gli zoppi si impara a zoppicare. Se poi lo zoppo è così ciarliero come il suo attuale principale, le conseguenze non possono essere che queste.
Ma vediamo, sinteticamente per punti, la sostanza delle decisioni prese dalla Banca Centrale Europea.
1. Il Quantitative easing europeo (QE) ha da ieri una forma. Gli acquisti di titoli partiranno dal primo marzo e dureranno almeno fino a settembre 2016. Al ritmo di 60 miliardi al mese, per diciannove mesi, si arriverà così ad un totale di 1.140 miliardi.
- Details
- Hits: 4222
Capitalismo e pulsione di morte
di Pierangelo Dacrema
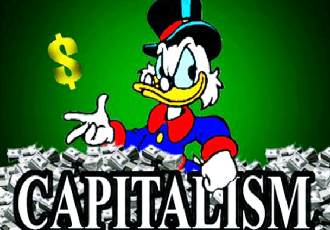 Può, l’economia, essere pane per la psicanalisi? Certo. Frutto dell’incantevole collegamento tra corpo e cervello, l’economia è pensiero tradotto in azione. E un cervello prigioniero di un corpo, che implica un corpo prigioniero di un cervello, è proprio materia da psicanalisti.
Può, l’economia, essere pane per la psicanalisi? Certo. Frutto dell’incantevole collegamento tra corpo e cervello, l’economia è pensiero tradotto in azione. E un cervello prigioniero di un corpo, che implica un corpo prigioniero di un cervello, è proprio materia da psicanalisti.
Un circolo virtuoso: Bloomsbury
Nel 1914 avviene il primo contatto tra Freud e Bloomsbury, il quartiere di Londra da cui prende il nome la singolare comunità di intellettuali che ha visto eccellere Virginia Woolf ed Edward M. Forster nel romanzo, Duncan Grant e Vanessa Bell nella pittura, Roger Fry e Clive Bell nella critica d’arte, Lytton Strachey nella biografia e nella storia, Desmond McCarthy nella critica letteraria, Leonard Woolf e J. M. Keynes nella politica e nell’economia. Keynes cita Freud nel terzo capitolo del suo folgorante Le conseguenze economiche della pace, quando traccia un ritratto dei protagonisti della Conferenza di Versailles e ci racconta di uno speciale complesso freudiano del presidente Wilson.
- Details
- Hits: 2680
L’enigma dello Stato islamico: potere, soldi, guerra
Riccardo Narducci
 Nell’epoca della globalizzazione determinate vicende assumono una conformazione totalizzante: non siamo più legati soltanto a ciò che accade nel nostro Paese, ma crisi, conflitti, mercato, politica sono dinamiche che oltrepassano i confini nazionali. Fra queste non può che esserci la questione legata al cosiddetto Stato Islamico الدولة الإسلامية (al-Dawla al-Islāmiyya) detto anche “Isis” o “Is” costituitosi tra la Siria, la Libia e l’Iraq il 3 gennaio 2014. Il governo, ufficialmente un Califfato guidato dal califfo Abu Bakr al-Baghdali, ha posto la sua capitale nella città di Al-Raqqa, una propria moneta, il Dinaro dello Stato Islamico, un proprio inno nazionale e un proprio motto Bāqiya wa Tatamaddad “Consolidamento ed espansione”. I terroristi che hanno costituito questo nuovo sistema politico, gli jihadisti, riescono a gestire problematiche economiche enormi, legate ai costi della guerra e del terrorismo internazionale.
Nell’epoca della globalizzazione determinate vicende assumono una conformazione totalizzante: non siamo più legati soltanto a ciò che accade nel nostro Paese, ma crisi, conflitti, mercato, politica sono dinamiche che oltrepassano i confini nazionali. Fra queste non può che esserci la questione legata al cosiddetto Stato Islamico الدولة الإسلامية (al-Dawla al-Islāmiyya) detto anche “Isis” o “Is” costituitosi tra la Siria, la Libia e l’Iraq il 3 gennaio 2014. Il governo, ufficialmente un Califfato guidato dal califfo Abu Bakr al-Baghdali, ha posto la sua capitale nella città di Al-Raqqa, una propria moneta, il Dinaro dello Stato Islamico, un proprio inno nazionale e un proprio motto Bāqiya wa Tatamaddad “Consolidamento ed espansione”. I terroristi che hanno costituito questo nuovo sistema politico, gli jihadisti, riescono a gestire problematiche economiche enormi, legate ai costi della guerra e del terrorismo internazionale.
Essi ormai operano attraverso canali non bancari, trattando petrolio e contanti non tracciati. I corridoi principalmente battuti sono quelli dell’Iraq nord-occidentale e quello della Siria nord-orientale, lontani da controlli stranieri. Per comprendere meglio dove finiscano i proventi di Is, e quanto l’occidente debba realmente preoccuparsi di questo “Stato”, farò una premessa legata alla religione su cui questi terroristi fanno riferimento: l’Islam.
- Details
- Hits: 2430
Monsters
Tracce per la decostruzione dell’immaginario distopico post-Charlie Hebdo
di Gaia Giuliani
 Nelle righe che seguiranno proverò, in linea e in dialogo con quanto scritto da Gabriele, a comprendere quanto dietro all’utopia della (ri)fondazione della comunità immaginata (dei buoni, dell’occidente) stia il delinearsi di una codificazione del mostruoso che, sin dall’11 Settembre, vede nel maschio musulmano non-bianco l’altro che per contrasto definisce il Noi. La letteratura critica è, per fortuna, molto vivace e tocca tantissimi temi – quello dell’islamofobia come eredità coloniale, della nuova fondazione dello stato ‘morale’ e conservatore mediante omonazionalismo e femonazionalismo (ossia la strumentalizzazione ideologica da parte del discorso nazionalista dei discorsi emancipazionisti delle formazioni gay e femministe) contro il barbaro immorale, il razzismo multiculturalista, le nuove forme di razzismo culturalizzate. Non sto ora a darne una descrizione approfondita, ma delle fantasie di bianchezza e delle gerarchie patriarcali ed eterosessiste abbiamo scritto in ciascuno dei brevi saggi apparsi in Distopie.
Nelle righe che seguiranno proverò, in linea e in dialogo con quanto scritto da Gabriele, a comprendere quanto dietro all’utopia della (ri)fondazione della comunità immaginata (dei buoni, dell’occidente) stia il delinearsi di una codificazione del mostruoso che, sin dall’11 Settembre, vede nel maschio musulmano non-bianco l’altro che per contrasto definisce il Noi. La letteratura critica è, per fortuna, molto vivace e tocca tantissimi temi – quello dell’islamofobia come eredità coloniale, della nuova fondazione dello stato ‘morale’ e conservatore mediante omonazionalismo e femonazionalismo (ossia la strumentalizzazione ideologica da parte del discorso nazionalista dei discorsi emancipazionisti delle formazioni gay e femministe) contro il barbaro immorale, il razzismo multiculturalista, le nuove forme di razzismo culturalizzate. Non sto ora a darne una descrizione approfondita, ma delle fantasie di bianchezza e delle gerarchie patriarcali ed eterosessiste abbiamo scritto in ciascuno dei brevi saggi apparsi in Distopie.
Mi voglio invece soffermare sulla costruzione del Noi – bianco, borghese, cristiano, ‘moralista’ e conservatore – e dei suoi nuovi abietti, i nuovi mostri ‘alieni’ ad una supposta civiltà occidentale che viene ora descritta quanto mai omogenea e solidale al suo interno.
Ciò che vedo di solidale è solo il consenso dei potenti alle strategie neoliberiste di ristrutturazione economica, sociale e culturale, e a parte ciò, non molto altro, ‘nonostante i proclami’ – o forse sarebbe meglio dire ‘suffragate e sostenute dai proclami’ – su diritti, integrazione e uguaglianza di genere alla base dei finanziamenti europei alla ricerca e alle politiche nazionali e comunitarie.
- Details
- Hits: 2244

Sulla rottura del dispositivo keynesiano
di Biagio Quattrocchi
 Recentemente Sandro Mezzadra e Toni Negri hanno aperto, per il collettivo Euronomade, una riflessione sulla concatenazione dell’imminente appuntamento elettorale in Grecia e su quello successivo, che si terrà in Spagna verso la fine dell’anno. La posta in gioco di questo doppio passaggio elettorale, senza nessuna retorica e senza alcuna particolare ingenua illusione, resta elevata. Non è in discussione né la rottura lineare del regime neoliberale europeo, né, nel tempo immediato, la definizione di un progetto compiutamente post-liberista su scala continentale. Ma si potrebbe trattare pur sempre di una rilevante rottura politica, qualora le più rosee previsioni elettorali per le due “nuove formazioni di sinistra” – Syriza e Podemos – dovessero essere confermate. Per cui, come scrivono gli autori: «questo non ci impedisce di cogliere la rilevanza che specifiche elezioni possono avere dal punto di vista della lotta di classe». Per noi, che pratichiamo la politica a partire dalla centralità delle lotte sociali, è in discussione innanzitutto la relazione tra queste lotte e la “verticalità” del soggetto politico. O, ancor più in là, il rapporto tra queste ultime due dimensioni dell’azione politica, quella istituzionale del governo e l’apertura di un terreno costituente per l’auto-organizzazione del Comune.
Recentemente Sandro Mezzadra e Toni Negri hanno aperto, per il collettivo Euronomade, una riflessione sulla concatenazione dell’imminente appuntamento elettorale in Grecia e su quello successivo, che si terrà in Spagna verso la fine dell’anno. La posta in gioco di questo doppio passaggio elettorale, senza nessuna retorica e senza alcuna particolare ingenua illusione, resta elevata. Non è in discussione né la rottura lineare del regime neoliberale europeo, né, nel tempo immediato, la definizione di un progetto compiutamente post-liberista su scala continentale. Ma si potrebbe trattare pur sempre di una rilevante rottura politica, qualora le più rosee previsioni elettorali per le due “nuove formazioni di sinistra” – Syriza e Podemos – dovessero essere confermate. Per cui, come scrivono gli autori: «questo non ci impedisce di cogliere la rilevanza che specifiche elezioni possono avere dal punto di vista della lotta di classe». Per noi, che pratichiamo la politica a partire dalla centralità delle lotte sociali, è in discussione innanzitutto la relazione tra queste lotte e la “verticalità” del soggetto politico. O, ancor più in là, il rapporto tra queste ultime due dimensioni dell’azione politica, quella istituzionale del governo e l’apertura di un terreno costituente per l’auto-organizzazione del Comune.
La rilevanza e l’urgenza di questo dibattito, è data dalle condizioni materiali che si sono concretamente determinate in questi due paesi. Il punto non è quello di discutere su un piano di trascendenza se le relazioni poc’anzi accennate possono essere in assoluto pensate o agite. Qui, si tratta di comprendere che in questi due paesi, nella violenza dell’attuale crisi, le lotte sociali in qualche caso hanno spinto, in altri hanno direttamente assunto su di sé, questo nuovo e inedito piano dell’agire politico. Eludere queste questioni sarebbe come giocare a mosca cieca. Al contempo, eludere il rischio di un “riassorbimento” delle stesse lotte sul piano istituzionale sarebbe da stupidi.
- Details
- Hits: 11310

Cosa sapete della Grecia? (fact checking)
di Alberto Bagnai
 Nei prossimi giorni si parlerà molto di Grecia. Ma voi, della Grecia, cosa sapete? Se siete qui per la prima volta, è probabile che sappiate solo quello che avete potuto apprendere dai mezzi di comunicazione italiani.
Nei prossimi giorni si parlerà molto di Grecia. Ma voi, della Grecia, cosa sapete? Se siete qui per la prima volta, è probabile che sappiate solo quello che avete potuto apprendere dai mezzi di comunicazione italiani.
L'associazione a/simmetrie segue da quando si è costituita (due anni or sono) la vicenda greca, e ha raccolto autorevoli testimonianze di prima mano, che trovate sul suo sito.
Ve ne parlerò dopo, ma qui voglio occuparmi di quello che a noi è arrivato attraverso i mezzi di comunicazione. Cosa vi hanno detto, questi mezzi di comunicazione, e voi cosa avete, quindi, potuto capire?
Vi hanno detto che la Grecia era il più gran successo dell'euro.
Forse ve ne siete dimenticati, ma prima che la Grecia venisse ridotta a un cumulo di macerie dalle politiche della troika, qualcuno disse che essa era stata il più gran successo dell'euro proprio perché l'euro l'aveva spinta ad adottare queste politiche. Quel qualcuno era Mario Monti:
Quando quella persona disse quelle parole, la Grecia si trovava nella posizione evidenziata dal puntino rosso:
- Details
- Hits: 2170
Gli effetti di un’uscita dall’euro su crescita, occupazione e salari
Riccardo Realfonzo e Angelantonio Viscione
L’analisi tecnica dimostra che hanno torto sia i catastrofisti sostenitori dell’euro senza se e senza ma sia gli ingenui teorici della moneta unica come origine di tutti i mali. L’euroexit potrebbe essere una strada per tornare a crescere, ma al tempo stesso cela gravi rischi, soprattutto per il mondo del lavoro. A ben vedere, tutto dipende da come si resta nell’euro e da come, eventualmente, se ne esce.
 1. Con l’austerity l’euro non regge
1. Con l’austerity l’euro non regge
È dalla fine del 2007 che l’eurozona ha smesso di crescere e i processi di divergenza tra i Paesi centrali e quelli periferici si fanno sempre più impetuosi[1]. Continuando con le politiche economiche di austerità imposte dai Trattati la crisi dell’eurozona è solo questione di tempo[2]. D’altra parte, la permanenza dei paesi periferici nell’euro, nel quadro delle politiche restrittive, produce effetti sociali ed economici drammatici. Il caso italiano è eloquente: stiamo assistendo a un lento, progressivo, declino; con una economia ampiamente decresciuta, la disoccupazione dilagante, una distribuzione del reddito sempre più diseguale, la ritirata dello stato sociale. Certo, cambiare il segno delle politiche europee sarebbe senz’altro l’opzione migliore. Ma si tratta di una soluzione politicamente sempre meno probabile, dal momento che la Germania e i suoi paesi-satellite continuano a respingere ogni apertura in tal senso. Bisogna quindi domandarsi quali potrebbero essere le conseguenze di una fuoriuscita dall’euro.
Naturalmente, non è semplice prevedere gli scenari successivi a una crisi dell’euro. Anche perché molto dipenderebbe dalla possibilità che l’euroexit coinvolga uno o più Paesi, e grande rilievo avrebbe il “peso” economico-politico di tali paesi. Ancora, le cose cambierebbero molto se le fuoriuscite fossero o meno coordinate e se sfociassero o meno in uno o più accordi di cambio. Ed è inutile dire che su tutto ciò per adesso si brancola nel buio.
- Details
- Hits: 3173
La sinistra assente
Francesco Algisi intervista Domenico Losurdo
 Domenico Losurdo è professore emerito di Storia della filosofia presso l'Università degli Studi di Urbino. Autore di numerose pubblicazioni – tra le quali ricordiamo "Controstoria del liberalismo" (Laterza, 2006), "Stalin. Storia e critica di una leggenda nera" (Carocci, 2008), "La lotta di classe" (Laterza, 2013), "Nietzsche, il ribelle aristocratico" (Bollati Boringhieri, 2014, II edizione) – ha recentemente dato alle stampe "La sinistra assente. Crisi, società dello spettacolo, guerra" (Carocci, 2014). Al pari dei precedenti, anche quest'ultimo saggio si legge con grande profitto. Su alcuni dei temi affrontati nel testo, abbiamo rivolto alcune domande all'Autore.
Domenico Losurdo è professore emerito di Storia della filosofia presso l'Università degli Studi di Urbino. Autore di numerose pubblicazioni – tra le quali ricordiamo "Controstoria del liberalismo" (Laterza, 2006), "Stalin. Storia e critica di una leggenda nera" (Carocci, 2008), "La lotta di classe" (Laterza, 2013), "Nietzsche, il ribelle aristocratico" (Bollati Boringhieri, 2014, II edizione) – ha recentemente dato alle stampe "La sinistra assente. Crisi, società dello spettacolo, guerra" (Carocci, 2014). Al pari dei precedenti, anche quest'ultimo saggio si legge con grande profitto. Su alcuni dei temi affrontati nel testo, abbiamo rivolto alcune domande all'Autore.
Prof. Losurdo, lei scrive che "ogni leader sgradito a Washington, che si tratti di Castro, Gheddafi o Saddam Hussein, sa che deve guardarsi quotidianamente e in ogni istante della giornata dalle trame e dai tentativi di assassinio orchestrati dalla CIA" (pag.127). Questo fatto incontestabile giustifica, a suo avviso, il mancato (o comunque "problematico") sviluppo "di rapporti realmente democratici all'interno dei paesi più deboli" (pag.136) e costretti "a vivere sotto l'incubo dell'aggressione" (pag.194) da parte degli USA?
Rispondo formulando a mia volta una domanda: il pericolo del ripetersi negli USA di attentati terroristici «giustifica» la decisione di rinchiudere a Guantanamo, senza processo e anzi senza neppure una notificazione del reato contestato, persone della più diversa età (compresi ragazzini e vegliardi) e di torturarle sistematicamente? E «giustifica» la decisione di procedere, grazie ai droni, a esecuzioni extragiudiziarie senza curarsi neppure dei cosiddetti «danni collaterali»?
- Details
- Hits: 2480
Contro Houellebecq
La sottomissione di Sisifo
di Lorenzo Mecozzi
 Prima di iniziare la lettura dell’ultimo romanzo di Michel Houellebecq, Soumission (Sottomissione, nella traduzione italiana Bompiani, uscita nelle librerie il 15 gennaio), e viste le polemiche suscitate dal romanzo a seguito degli eventi degli ultimi giorni, avevo iniziato a far mente locale sul rapporto tra romanzo e morale, tra i diritti del racconto e i doveri del romanziere, ma soprattutto sulle responsabilità del giudizio critico.
Prima di iniziare la lettura dell’ultimo romanzo di Michel Houellebecq, Soumission (Sottomissione, nella traduzione italiana Bompiani, uscita nelle librerie il 15 gennaio), e viste le polemiche suscitate dal romanzo a seguito degli eventi degli ultimi giorni, avevo iniziato a far mente locale sul rapporto tra romanzo e morale, tra i diritti del racconto e i doveri del romanziere, ma soprattutto sulle responsabilità del giudizio critico.
Per la vicinanza tematica e di visione del presente che lega Houellebecq a Walter Siti (due “apocalittici-integrati” della letteratura contemporanea secondo la bella definizione di Carlo Mazza Galanti), per prima cosa mi era tornata in mente la lunga ed appassionata discussione nata su Le parole e le cose, a seguito di un articolo nel quale Gianluigi Simonetti rispondeva al saggio che Andrea Cortellessa aveva voluto dedicare a Resistere non serve a niente di Siti. Così avevo iniziato a riflettere su quel “purtroppo”, pronunciato da Cortellessa, che aveva dato il via alla discussione (“E Resistere non serve a niente – purtroppo – è il libro più bello dell’anno”) e sui tre argomenti con i quali Simonetti ne aveva negato la legittimità (l’«argomento-Bataille», l’«argomento De Sanctis», l’«argomento Engels» – anche se le definizioni sono sempre di Cortellessa), preparandomi a dover affrontare problematiche simili nel recensire Houellebecq. Le prime pagine del romanzo, tuttavia, disinnescavano ogni preoccupazione, almeno nel senso che le roboanti critiche al libro lasciavano immaginare, consegnandomi alla lettura di un’opera allo stesso tempo tipicamente houellebechiana e in qualche modo diversa da tutti gli altri romanzi di Houellebecq.
Page 449 of 611