Fai una donazione
Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________
- Details
- Hits: 3810

Logica della conoscenza complessa
di Pierluigi Fagan
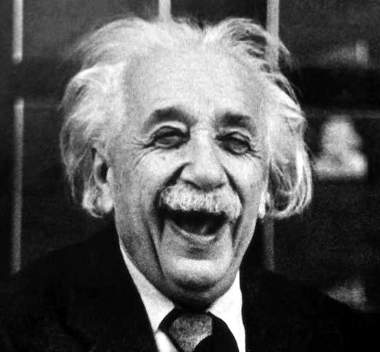 In quella rivoluzione epistemologica che fu la nascita e lo sviluppo della fisica quantistica avvenuta nel primo ‘900, s’incontrano due operatori logici applicati a due diversi principi. I due operatori logici sono “o – o” ed “e – e”. Per “operatore”, s’intende un dispositivo che dà forma allo sviluppo logico.
In quella rivoluzione epistemologica che fu la nascita e lo sviluppo della fisica quantistica avvenuta nel primo ‘900, s’incontrano due operatori logici applicati a due diversi principi. I due operatori logici sono “o – o” ed “e – e”. Per “operatore”, s’intende un dispositivo che dà forma allo sviluppo logico.
L’operatore “o – o” ha la sua più antica versione, tra quelle a noi conosciute, nel Principio di non contraddizione. Esso afferma che di un ente non è possibile predicare l’affermazione e la negazione al contempo, ovvero la sua realtà ed il suo contrario, ovvero apporvi predicati in contraddizione validi in uno stesso istante. Aristotele, almeno inizialmente, lo riteneva un principio ontologico relativo all’essere, libero da ogni predicato e/o attributo. Il principio si limita a vietare l’attribuzione di concetti contrapposti -in uno stesso istante- allo stesso soggetto ma non stabilisce cosa dobbiamo o possiamo ritenere “contrapposto”. La regola disgiuntiva, nella sua forma pura “o – o”, è un puro principio di esclusione di una attribuzione di verità che risulterebbe contradditoria. Senza l’ osservanza di questa regola, non vi sarebbe differenza e quindi non si produrrebbe informazione (ex falso sequitur quodlibet).
Nella fisica quantistica, il principio disgiuntivo ispirò la formulazione di un importante principio applicato alle regole di funzionamento della meccanica dei quanti. Del Principio di indeterminazione di W. Heisenberg (1927), venne proposta una prima versione in una lettera che W. Pauli[1] scrisse allo stesso Heisenberg un anno prima.
- Details
- Hits: 2676
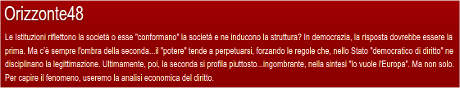
Il Treasury Usa tra Kalecky e il wishful thinking
di Quarantotto
 Partiamo da questa proposizione socio-giuridica per fissare un punto da cui decodificare lo scenario che si sta affacciando ai nostri occhi:
Partiamo da questa proposizione socio-giuridica per fissare un punto da cui decodificare lo scenario che si sta affacciando ai nostri occhi:
"Certamente, in un regime di permanente pieno impiego, il licenziamento cesserebbe di giocare il suo ruolo come strumento di disciplina [disciplinary measure]." Kalecky "Aspetti politici del pieno impiego" (par.II.4)
Questo assunto, intuitivo, ci consente di comprendere sempre, alla stregua delle coordinate di navigazione, il dibattito che si è svolto sulla questione "pubblico impiego". A cui faccio rinvio, per chi non l'avesse seguito. Questo stesso assunto ci consente una digressione "storico-economica" molto interessante.
La ritraiamo da un paper del prof. Aldo Barba, datato 25 maggio 2011, alla vigilia immediata di quella offensiva finale che, scatenata dalle vendite di Deutschebank sui titoli del nostro debito pubblico - a loro volta "figlie" del six packs approvato poche settimane prima-, innescò il gigantesco "regolamento di conti" che ha fatto emergere concretamente, per chi avesse occhi per vedere, la vera natura dell'euro. Sentite che dati ci offre:
Consideriamo brevemente alcuni dati essenziali. All'inizio degli anni settanta il peso sul prodotto della spesa pubblica al netto degli interessi è, in Italia, di sei punti percentuali più basso che in Francia e Germania. Nel 1980 la spesa pubblica al netto degli interessi in rapporto al prodotto è pari al 37% in Italia, al 45.4% in Francia e al 46.5% in Germania. Alla fine degli anni ottanta la nostra spesa primaria è allineata a quella dei tedeschi (43% circa), rimanendo in ogni caso inferiore di oltre cinque punti percentuali a quella dei francesi. Alla fine degli anni novanta la spesa primaria è pari in Italia al 41.5% del PIL, contro il 44.9% della Germania e il 49.6% della Francia (Fig. 1).
- Details
- Hits: 2824

L’uomo come zoon politikon
Società, comunità e associazione in Marx
Luca Basso
 L’articolo è incentrato sull’antropologia marxiana, a partire dall’idea secondo cui l’uomo è uno zoon politikon. In particolare, nella Einleitung del 1857, si afferma proprio che l’uomo è uno zoon politikon, e nel primo libro del Capitale si ribadisce tale concetto, sottolineando il fatto che l’espressione indicata può essere tradotta con “animale sociale”, più che con “animale politico”. Più avanti ritornerò su tali passi, mostrando il fatto che non possono venire interpretati a partire dalla convinzione di un presunto “aristotelismo” di Marx: l’elemento dello zoon politikon viene completamente “trasvalutato” rispetto ad Aristotele. Questo rilievo sull’uomo come zoon politikon fa emergere la dimensione antropologica del pensiero marxiano. Metterò in luce il carattere non astratto, non essenzialistico di tale antropologia, che si radica in una situazione determinata, all’interno di un determinato contesto storico e sociale. D’altronde, proprio dal momento che lo zoon politikon viene inteso come animale sociale, più che come animale politico, il riferimento alla società risulta decisivo: cruciale si rivela quindi la questione del rapporto fra individuo e società, e anche fra individuo e comunità, e individuo e associazione. Così il percorso svolto attraverserà i concetti di società, comunità e associazione, che devono venire tra di loro differenziati, ma nello stesso tempo presentano vari tratti comuni. Vista l’enorme vastità del tema di per sé, e nello specifico in Marx, pur fornendo un approccio complessivo al problema, mi soffermerò in particolare sul lemma società in senso stretto, Gesellschaft, cercando di farne emergere gli aspetti più rilevanti.
L’articolo è incentrato sull’antropologia marxiana, a partire dall’idea secondo cui l’uomo è uno zoon politikon. In particolare, nella Einleitung del 1857, si afferma proprio che l’uomo è uno zoon politikon, e nel primo libro del Capitale si ribadisce tale concetto, sottolineando il fatto che l’espressione indicata può essere tradotta con “animale sociale”, più che con “animale politico”. Più avanti ritornerò su tali passi, mostrando il fatto che non possono venire interpretati a partire dalla convinzione di un presunto “aristotelismo” di Marx: l’elemento dello zoon politikon viene completamente “trasvalutato” rispetto ad Aristotele. Questo rilievo sull’uomo come zoon politikon fa emergere la dimensione antropologica del pensiero marxiano. Metterò in luce il carattere non astratto, non essenzialistico di tale antropologia, che si radica in una situazione determinata, all’interno di un determinato contesto storico e sociale. D’altronde, proprio dal momento che lo zoon politikon viene inteso come animale sociale, più che come animale politico, il riferimento alla società risulta decisivo: cruciale si rivela quindi la questione del rapporto fra individuo e società, e anche fra individuo e comunità, e individuo e associazione. Così il percorso svolto attraverserà i concetti di società, comunità e associazione, che devono venire tra di loro differenziati, ma nello stesso tempo presentano vari tratti comuni. Vista l’enorme vastità del tema di per sé, e nello specifico in Marx, pur fornendo un approccio complessivo al problema, mi soffermerò in particolare sul lemma società in senso stretto, Gesellschaft, cercando di farne emergere gli aspetti più rilevanti.
- Details
- Hits: 3184
"Nuovo fascismo" o neoliberalismo?
Michel Foucault e l'affaire Croissant
Alessandro Simoncini
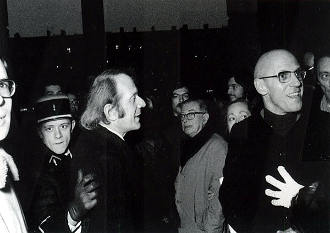 1. Nel cuore degli “anni di piombo”: il caso Croissant
1. Nel cuore degli “anni di piombo”: il caso Croissant
Come si sa, fin dai primi anni ’70 Michel Foucault avvierà l’elaborazione di un’analitica del potere capace di oltrepassare tanto la sterile dogmatica del contrattualismo liberale, quanto le insufficienze di un rigido economicismo marxista. (1) Ai suoi occhi, la lezione proveniente dagli eventi del ’68 aveva indicato la strada: i movimenti avevano rigettato materialmente l’ordine della società disciplinare affermando dal basso, e con radicalità globalmente diffusa, che «non si accettava più di essere governati in un certo modo». (2) Per dirla con Gilles Deleuze, quelle lotte avevano rappresentato «la messa a nudo di tutti i rapporti di potere, ovunque essi si esercitassero, cioè dappertutto». (3) In questo modo, esse avevano squadernato apertamente il “concreto” stesso del potere – sosteneva Foucault - fin nelle maglie più fini della sua rete. (4) Recepirne le indicazioni significava allora elaborare una “microfisica del potere” in grado di superare l’ossessione teorica della sovranità e di mostrare come la concretezza dei poteri e dei saperi avesse prodotto, storicamente e materialmente, l’assoggettamento delle menti e dei corpi: (5) il governo di tutti e di ciascuno.
- Details
- Hits: 6858

Tagli alle pensioni, o inutili o da esproprio
Maurizio Benetti
 La legge di stabilità di Monti nel 2011 ha segnato con tutta probabilità uno spartiacque negli interventi sul sistema pensionistico. Da un lato è intervenuta sull’età di accesso alla pensione portando a compimento un processo iniziato nel 1992 con la riforma Amato, dall’altro ha limitato pesantemente l’indicizzazione delle pensioni.
La legge di stabilità di Monti nel 2011 ha segnato con tutta probabilità uno spartiacque negli interventi sul sistema pensionistico. Da un lato è intervenuta sull’età di accesso alla pensione portando a compimento un processo iniziato nel 1992 con la riforma Amato, dall’altro ha limitato pesantemente l’indicizzazione delle pensioni.
Il primo tipo d’intervento è quello che, unitamente al cambiamento del metodo di calcolo delle pensioni introdotto con il metodo contributivo nel 1995, ha caratterizzato tutte le riforme del sistema pensionistico dal 1992 al 2011. Tutte queste misure hanno avuto come platea d’intervento i futuri pensionati, ossia i lavoratori, colpendoli progressivamente in misura via via maggiore sia nelle modalità di computo della pensione sia nell’età di pensionamento. Questo processo è ora giunto a compimento e le previsioni a medio-lungo termine della Ragioneria generale sulla spesa pensionistica indicano “come, nel panorama europeo, l’Italia risulti uno dei paesi con la più bassa crescita della spesa pensionistica in rapporto al PIL segnalando, sotto questo aspetto, un rischio contenuto in termini di impatto dell’invecchiamento demografico sulla sostenibilità delle finanze pubbliche”.
Questo significa che se nelle prossime leggi di stabilità si volesse ancora fare cassa sulle pensioni come si è fatto sino al 2011, la platea d’intervento non potrà più riguardare i lavoratori-pensionandi, ma non potrà che riguardare i pensionati. Monti-Fornero l’hanno già fatto attraverso il blocco dell’indicizzazione delle pensioni superiori a tre volte il minimo e l’ha ripetuto in forma più attenuata Letta modificando in peggio le norme sull’indicizzazione.
- Details
- Hits: 7148

La crisi perpetua come strumento di potere
intervista a Giorgio Agamben
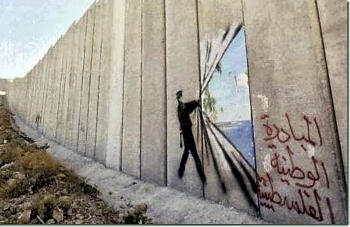 Lo scorso marzo lei ha proposto l’idea di un “impero latino” contro il dominio tedesco in Europa. Il suo intervento è stato tradotto in diverse lingue e discusso con molta passione. Aveva previsto tutta questa eco?
Lo scorso marzo lei ha proposto l’idea di un “impero latino” contro il dominio tedesco in Europa. Il suo intervento è stato tradotto in diverse lingue e discusso con molta passione. Aveva previsto tutta questa eco?
Vorrei innanzitutto precisare che il modo in cui “Die Zeit” ha presentato il mio articolo su “Libération”, non ne rispecchia né lo spirito né la lettera. A cominciare dal titolo (Das lateinische Reich soll einen Gegenangriff starten) che ovviamente, come un giornalista dovrebbe sapere, non è mio, ma della redazione. E come potrei voler contrapporre la cultura latina a quella tedesca, quando ogni europeo intelligente sa che la cultura italiana del Rinascimento o quella greca classica appartengono di pieno diritto anche alla cultura tedesca, che le ha pensate e riscoperte? Questo è l’Europa, questa assoluta specificità che scavalca tuttavia ogni volta i confini nazionali e culturali. L’obiettivo delle mie critiche non era la Germania, ma il modo in cui l’Unione Europea è stata concepita, su ragioni unicamente economiche che ignorano non solo quelle spirituali e culturali, ma anche quelle politiche e giuridiche. Se vi era una critica per la Germania, ciò era solo perché la Germania, che si trova in qualche modo in una posizione di leadership, malgrado la sua straordinaria tradizione filosofica sembra incapace di pensare una Europa che non sia quella della moneta e dell’economia.
- Details
- Hits: 3203

Vana ricerca del buon governo
di Antonio Negri
 Una bella lezione di umiltà ci dà Carlo Galli con questo libro: Sinistra, per il lavoro, per la democrazia (Mondadori, Milano, 2013). È un libro umile non perché semplificato in ossequio ai militanti democratici o evasivo rispetto alle ragioni elettorali che lo situano ma perché qui un intellettuale di grande spessore vuole sperimentare il suo sapere nella lotta politica e metterlo al servizio di una parte. Senza voler prendere in giro nessuno, direi, sulle orme di Hadot e Foucault, che qui ci si trova dinnanzi ad un vero e proprio “esercizio spirituale” che si colloca (mi si permetta di aggiungerlo) nella miglior tradizione del Partito Comunista Italiano. Al di là di questo, il libro non ha nulla di “comunista” se non una piccola (ma importantissima) – come chiamarla? – “derivazione” sulla quale torneremo alla fine di questa recensione.
Una bella lezione di umiltà ci dà Carlo Galli con questo libro: Sinistra, per il lavoro, per la democrazia (Mondadori, Milano, 2013). È un libro umile non perché semplificato in ossequio ai militanti democratici o evasivo rispetto alle ragioni elettorali che lo situano ma perché qui un intellettuale di grande spessore vuole sperimentare il suo sapere nella lotta politica e metterlo al servizio di una parte. Senza voler prendere in giro nessuno, direi, sulle orme di Hadot e Foucault, che qui ci si trova dinnanzi ad un vero e proprio “esercizio spirituale” che si colloca (mi si permetta di aggiungerlo) nella miglior tradizione del Partito Comunista Italiano. Al di là di questo, il libro non ha nulla di “comunista” se non una piccola (ma importantissima) – come chiamarla? – “derivazione” sulla quale torneremo alla fine di questa recensione.
Sono cinque capitoli di fattura diversa. Il primo e il secondo sono saggi di uno storico del pensiero politico. Alla fine del novecento, egli si interroga su quali siano state le figure specifiche e le diverse linee del pensiero politico della sinistra, in quel secolo: vi si scontrano il razionalismo democratico, il dialettismo progressista e socialista ed infine il pensiero negativo. Quest’ultimo scopre nella filosofia di Nietzsche il suo dispositivo – scettico e decostruttivo riguardo alla consistenza giuridica dello Stato, effettuamene aperto alla contingenza dei rapporti di forza che i movimenti politici definiscono, radicalmente capace di decisione e di normatività.
- Details
- Hits: 2957

Una fioca luce gettata sulla triste scienza
di Marco Bascetta
 È un atteggiamento usuale e sempre più frequente tra i seguaci di una dottrina economica spiegare i guasti evidenti scaturiti dalle proprie ricette con l'argomento che queste ultime non sono state applicate fino in fondo o con il dovuto zelo: non è stato privatizzato a sufficienza; il lavoro non è stato reso abbastanza flessibile; la spesa sociale non è stata ridotta quanto necessario per abbattere la pressione fiscale sulla libera impresa, e così via. Non c'è da sorprendersene. Quando si fa poggiare la dottrina su una assiomatica, sulla pretesa di agire secondo la razionalità indiscutibile di una tecnica matematica, che sbaraglia il vacuo accapigliarsi delle opinioni, l'errore non può risiedere nei postulati, ma solo nella loro negligente applicazione, nella debolezza degli agenti. Del resto è fin dalle sue origini che la «triste scienza» si propone come indagine e illustrazione di quelle «leggi di natura» che guidano in ogni suo aspetto la vita dell'homo oeconomicus e cioè dell'essere umano tout court. La promessa di benessere dell'economia liberista non teme smentite, non si lascia turbare dai capricci della contingenza, l'esperienza empirica, la contraddizione patente tra previsioni e risultati, le sono del tutto indifferenti.
È un atteggiamento usuale e sempre più frequente tra i seguaci di una dottrina economica spiegare i guasti evidenti scaturiti dalle proprie ricette con l'argomento che queste ultime non sono state applicate fino in fondo o con il dovuto zelo: non è stato privatizzato a sufficienza; il lavoro non è stato reso abbastanza flessibile; la spesa sociale non è stata ridotta quanto necessario per abbattere la pressione fiscale sulla libera impresa, e così via. Non c'è da sorprendersene. Quando si fa poggiare la dottrina su una assiomatica, sulla pretesa di agire secondo la razionalità indiscutibile di una tecnica matematica, che sbaraglia il vacuo accapigliarsi delle opinioni, l'errore non può risiedere nei postulati, ma solo nella loro negligente applicazione, nella debolezza degli agenti. Del resto è fin dalle sue origini che la «triste scienza» si propone come indagine e illustrazione di quelle «leggi di natura» che guidano in ogni suo aspetto la vita dell'homo oeconomicus e cioè dell'essere umano tout court. La promessa di benessere dell'economia liberista non teme smentite, non si lascia turbare dai capricci della contingenza, l'esperienza empirica, la contraddizione patente tra previsioni e risultati, le sono del tutto indifferenti.
Il buio dell'inconoscibile
Jean Paul Fitoussi, nel volume Il teorema del lampione (Einaudi, pp. 218, euro 18), riassume questa presunzione dottrinaria con la nota storiella dell'uomo che cerca un oggetto perduto sotto la luce di un lampione, non perché l'abbia perduto in quel luogo, ma perché è l'unico ad essere illuminato.
- Details
- Hits: 2971

Formare, obbedire, combattere
La valuta corrente della valutazione
di Gerolamo Cardini
 1. Diciamolo subito: la valutazione è esercizio brutale del comando mascherato da ideologia del merito. Proprio per questo, nell’articolare oggi una critica nei confronti del sistema della valutazione come elemento-chiave delle attuali trasformazioni della formazione scolastica e universitaria, non ha senso cedere a forme di nostalgia nei confronti di immaginari bei tempi andati. I tempi in cui ogni docente era giudice unico di se stesso e del proprio lavoro – fatte salve però le forme di corruzione, i rapporti di padronato e di servilismo di stampo feudale che imperversavano (e continuano a imperversare) in ambito universitario e, anche se in misura minore, in quello scolastico – sono passati, e non vale la pena versarvi lacrime, né ancor meno idealizzarli come il paradiso perduto della libertà di insegnamento e del rapporto ‘umano’ tra docenti e studenti. Chi non sia accecato dall’ipocrisia sa bene che le cose stavano diversamente, che il richiamo alla scuola di don Milani era poco più che uno slogan, che la condivisione dei percorsi formativi (la famosa ‘programmazione collegiale’) tra docenti, alunni e genitori era spesso aleatoria, nonostante una legislazione scolastica certamente avanzata; che il libero uso dell’intelletto in ambito universitario era perlopiù caldamente sconsigliato, e in ogni caso non premiato. Non verrà quindi da qui nessun rimpianto del tempo passato, al quale talvolta indulgono anche ben intenzionati compagni e compagne. Cercheremo piuttosto di svolgere una riflessione critica che provi a tenere insieme l’intero ambito della formazione scolastico-universitaria, mostrando la sostanziale omogeneità dei processi in corso, non a caso accompagnati da una retorica comune e scanditi da interventi legislativi e amministrativi che, nonostante l’alternarsi di governi di vario colore, mantengono un’impressionante coerenza.
1. Diciamolo subito: la valutazione è esercizio brutale del comando mascherato da ideologia del merito. Proprio per questo, nell’articolare oggi una critica nei confronti del sistema della valutazione come elemento-chiave delle attuali trasformazioni della formazione scolastica e universitaria, non ha senso cedere a forme di nostalgia nei confronti di immaginari bei tempi andati. I tempi in cui ogni docente era giudice unico di se stesso e del proprio lavoro – fatte salve però le forme di corruzione, i rapporti di padronato e di servilismo di stampo feudale che imperversavano (e continuano a imperversare) in ambito universitario e, anche se in misura minore, in quello scolastico – sono passati, e non vale la pena versarvi lacrime, né ancor meno idealizzarli come il paradiso perduto della libertà di insegnamento e del rapporto ‘umano’ tra docenti e studenti. Chi non sia accecato dall’ipocrisia sa bene che le cose stavano diversamente, che il richiamo alla scuola di don Milani era poco più che uno slogan, che la condivisione dei percorsi formativi (la famosa ‘programmazione collegiale’) tra docenti, alunni e genitori era spesso aleatoria, nonostante una legislazione scolastica certamente avanzata; che il libero uso dell’intelletto in ambito universitario era perlopiù caldamente sconsigliato, e in ogni caso non premiato. Non verrà quindi da qui nessun rimpianto del tempo passato, al quale talvolta indulgono anche ben intenzionati compagni e compagne. Cercheremo piuttosto di svolgere una riflessione critica che provi a tenere insieme l’intero ambito della formazione scolastico-universitaria, mostrando la sostanziale omogeneità dei processi in corso, non a caso accompagnati da una retorica comune e scanditi da interventi legislativi e amministrativi che, nonostante l’alternarsi di governi di vario colore, mantengono un’impressionante coerenza.
- Details
- Hits: 3517

Oltre l’accademia: le strade
di Girolamo De Michele1
 Confesso di aver seguito con un certo distacco, e anche un po’ di fastidio, il nascere del “Nuovo Realismo”, del cui testo fondante molte cose non mi convincevano, e continuano a non convincermi. Del resto, non essendo mai stato “post-modern”, non mi convinceva neanche l’eventuale difesa del bersaglio polemico. E, se devo dirla tutta, l’ambiente “Italian Theory” – tradotto come mangio: l’Italietta accademica che ha il suo quarto d’ora di notorietà modaiola, ora che il vestitino “French Theory” s’è sdrucito a furia di strofinature, nei McDonald culturali americani – mi faceva venire in mente il Poeta di Pavana: “di solito ho da far cose più serie, costruire su macerie, o mantenermi vivo”.
Confesso di aver seguito con un certo distacco, e anche un po’ di fastidio, il nascere del “Nuovo Realismo”, del cui testo fondante molte cose non mi convincevano, e continuano a non convincermi. Del resto, non essendo mai stato “post-modern”, non mi convinceva neanche l’eventuale difesa del bersaglio polemico. E, se devo dirla tutta, l’ambiente “Italian Theory” – tradotto come mangio: l’Italietta accademica che ha il suo quarto d’ora di notorietà modaiola, ora che il vestitino “French Theory” s’è sdrucito a furia di strofinature, nei McDonald culturali americani – mi faceva venire in mente il Poeta di Pavana: “di solito ho da far cose più serie, costruire su macerie, o mantenermi vivo”.
Nel giro di una settimana, due testi mi hanno fatto cambiare idea non sull’agone accademico, ma sull’utilità di intervenirvi. Il primo è la piccola Arca nella quale, su minima&moralia, sono stati imbarcati testi che potrebbero venire buoni après le déluge, e che testimoniano come una parte importante della narrazione contemporanea non sia riconducibile all’antitesi Realismo-Postmoderno; il secondo è l’intervento di Umberto Eco Ci sono delle cose che non si possono dire, sull’ultimo alfabeta2 [qui].
Quasi quattro anni fa, partecipando alla discussione sul romanzo italiano contemporanea aperta da Wu Ming 1 col suo saggio sul New Italian Epic, avevo sostenuto le ragioni della categoria del “neorealismo” usata da Gilles Deleuze a proposito del cinema:
- Details
- Hits: 2640
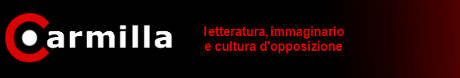
Errata corrige: Democrazia
di Sandro Moiso
“Il sogno della democrazia consiste nell’elevare il proletariato a livello dell’idiozia borghese” (Gustave Flaubert)
 Non è stata la manifestazione più grande, non ci ha lasciato immagini epiche da tramandare ai posteri e, nemmeno, slogan che passeranno alla storia…eppure, eppure…il corteo del 19 ottobre a Roma ha segnato il passaggio ad una fase nuova. Una massa che non si fa rappresentare, ma che si rappresenta. Una massa che non ascolta dichiarazioni e promesse, ma che si dichiara.Una massa combattiva e pacifica, determinata e multietnica. Una massa consapevolmente in guerra contro l’esistente e più pericolosa per le istituzioni di qualsiasi pubblica ed imbelle dichiarazione di guerra.
Non è stata la manifestazione più grande, non ci ha lasciato immagini epiche da tramandare ai posteri e, nemmeno, slogan che passeranno alla storia…eppure, eppure…il corteo del 19 ottobre a Roma ha segnato il passaggio ad una fase nuova. Una massa che non si fa rappresentare, ma che si rappresenta. Una massa che non ascolta dichiarazioni e promesse, ma che si dichiara.Una massa combattiva e pacifica, determinata e multietnica. Una massa consapevolmente in guerra contro l’esistente e più pericolosa per le istituzioni di qualsiasi pubblica ed imbelle dichiarazione di guerra.
Perché la democrazia non sta nelle costituzioni, se queste non prevedono il conflitto e il diritto alla rivolta. E non sta nelle leggi elettorali se non esistono partiti in grado di difendere e diffondere il conflitto sociale. E non sta nei partiti e partitini se questi si arrogano, comunque e soltanto, la rappresentazione del conflitto. La democrazia è conflitto e vive soltanto nel conflitto.
Là dove il conflitto è negato, la democrazia non c’è. Che sia un governo liberista a negarlo, oppure un governo ancor più marcatamente autoritario oppure, ancora, un governo socialista come quello sovietico dagli anni venti del ‘900 in avanti, ci si trova davanti ad una dittatura.
- Details
- Hits: 3233

Rendita, accumulazione e nuovi processi di valorizzazione nel web 2.0
di Andrea Cagioni
 L’articolo intende fornire un contributo critico su alcuni elementi di economia politica della new economy e offrire strumenti analitici utili alla comprensione delle aporie, dei rapporti di forza e dei conflitti che attraversano il campo del Web 2.0#1.
L’articolo intende fornire un contributo critico su alcuni elementi di economia politica della new economy e offrire strumenti analitici utili alla comprensione delle aporie, dei rapporti di forza e dei conflitti che attraversano il campo del Web 2.0#1.
Prima di concentrare l’attenzione su tali processi, vediamo di illustrare le caratteristiche salienti della finanziarizzazione dell’economia, al fine di comprendere i cambiamenti più rilevanti nei processi di valorizzazione capitalistici. L’egemonia della finanza, nella lettura sviluppata dal neo-operaismo, è indicativa delle nuove modalità di accumulazione del capitale poste in essere per fronteggiare tanto la diminuzione del saggio di profitto industriale del modello fordista, tanto la situazione di crisi strutturale determinata, a partire dalla prima metà degli anni ’70, dalla fase espansiva e dal carattere antagonista delle lotte operaie e dalla nuova composizione tecnica e politica della forza-lavoro. Marazzi dimostra come le fonti, gli agenti e i dispositivi della finanziarizzazione si siano moltiplicati ed estesi lungo tutto il ciclo produttivo, e di conseguenza la finanza sia divenuta consustanziale al ciclo economico. La finanziarizzazione attuale è quindi la forma di accumulazione che meglio esprime la forma contemporanea di valorizzazione del capitalismo.
- Details
- Hits: 6818

Karl Marx e il suo deficit originario*
Roberto Finelli
 Il deficit originario di Karl Marx
Il deficit originario di Karl Marx
1. Ciò che di Marx oggi non è più possibile accettare non è certamente la critica dell’economia – che invece trova sempre più conferme – quanto l’antropologia e la filosofia della storia che ne consegue. In buona parte dell’opera di Marx c’è infatti un deficit profondissimo di analisi e comprensione della soggettività, che ha avuto conseguenze assai negative nelle storie dei movimenti operai e delle emancipazioni sociali che si sono richiamate al marxismo.
Un deficit, la cui presenza è sempre stata espressa, e insieme dissimulata, proprio dal suo opposto, qual è la teoria dell’onnipotenza del soggetto che Marx ha posto a base della sua filosofia della storia e della rivoluzione.
La tesi fondamentale del materialismo storico è, com’è noto, quella della contraddizione tra forze produttive e rapporti sociali di produzione. La storia, secondo questa prospettiva, passa da una formazione economico-sociale all’altra ogni qual volta lo sviluppo delle capacità costruttive dell’homo faber (la cui accumulazione costituisce il filo rosso e il polo positivo di continuità tra le varie epoche) trova impedimenti non ulteriormente compatibili con la sua crescita.
- Details
- Hits: 4901

Più o meno Europa?
di Diego Fusaro
 In una lettera recentemente apparsa on line, l’amico e collega Luciano Canova ha mosso delle obiezioni alle mie posizioni sull’euro e sulla necessità di congedarsene il prima possibile. Lo ringrazio fin da ora per le stimolanti riflessioni su temi così nodali. E proverò qui di seguito a elaborare una risposta, sia pure sintetica.
In una lettera recentemente apparsa on line, l’amico e collega Luciano Canova ha mosso delle obiezioni alle mie posizioni sull’euro e sulla necessità di congedarsene il prima possibile. Lo ringrazio fin da ora per le stimolanti riflessioni su temi così nodali. E proverò qui di seguito a elaborare una risposta, sia pure sintetica.
In primis, caro Luciano, mi permetto di rettificare due punti: il “cretinismo economico” (Gramsci) non è un’accusa rivolta a te e all’economia in quanto tale, ma, più in generale, all’odierno spirito del tempo, di cui l’economia è espressione quintessenziale. La riduzione dell’essente a quantità calcolabile, sfruttabile e valorizzabile non è forse – come ben sapeva Heidegger – la triste essenza del nostro tempo? Non è forse questo il cretinismo economico di un tempo in cui non si ragiona se non in termini di debiti e crediti, di crescita e di profitto, di austerity e fiscal compact, di spread e di deregulation? Questo è l’orizzonte in cui siamo, e di questo dobbiamo occuparci (né di Marshall, né di Smith): l’economia di cui parla Aristotele è tutt’altro che cretinismo economico, ovviamente; ma quella odierna, elevata dal pensiero unico a teologia della disuguaglianza sociale? L’economia è oggi la teologia del capitale finanziario. I pochi economisti che, come te, si sottraggono a questa follia generale sono i benvenuti e dovrebbero essere i primi a indirizzare i loro strali contro i colleghi organici al sistema finanziario.
Seconda precisazione: a rigore, il paragone tra Hitler e la Merkel che tu mi attribuisci non è mio, ma del conduttore televisivo della trasmissione a cui ho partecipato qualche settimana fa.
- Details
- Hits: 2483
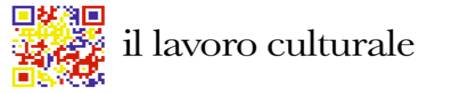
Cancella il debito?
Il debito in comune: dialogo sul filo del paradosso tra teoria politica, estetica e scienze umane
di Giacomo Tagliani
 Una singolare tendenza si aggira oggi nelle scienze umane. Sotto la dicitura onnicomprensiva di teologia politica, numerose analisi e interpretazioni del tempo presente si stanno infatti orientando sulla consustanziale attiguità tra le dinamiche sociali, culturali e politiche e una comune matrice teologica che le informa e dona loro senso ed efficacia. Se la precessione di un dominio sull’altro è argomento tuttora dibattuto, resta il fatto che l’effettiva presenza di tale paradigma continua ad acquisire sempre maggior credito, supportato da analisi e digressioni teoriche che sembrano riuscire a contestare con successo le obiezioni a tale cornice epistemologica avanzate dai teorici della democrazia negli ultimi decenni del secolo scorso.
Una singolare tendenza si aggira oggi nelle scienze umane. Sotto la dicitura onnicomprensiva di teologia politica, numerose analisi e interpretazioni del tempo presente si stanno infatti orientando sulla consustanziale attiguità tra le dinamiche sociali, culturali e politiche e una comune matrice teologica che le informa e dona loro senso ed efficacia. Se la precessione di un dominio sull’altro è argomento tuttora dibattuto, resta il fatto che l’effettiva presenza di tale paradigma continua ad acquisire sempre maggior credito, supportato da analisi e digressioni teoriche che sembrano riuscire a contestare con successo le obiezioni a tale cornice epistemologica avanzate dai teorici della democrazia negli ultimi decenni del secolo scorso.
Certamente la teologia politica è un tema che attraversa interamente il Novecento, a partire dai lavori di Carl Schmitt che innescarono un lunghissimo dibattito che coinvolse in egual misura giuristi e teologi, soprattutto di area tedesca, ma la sua ripresa più recente sembra essere dovuta alle analisi sul potere di Michel Foucault: sono proprio le analisi dedicate ai paradigmi della sovranità e del governo e alla centralità nelle società occidentali di alcune tecniche del sé di derivazione cristiana, la confessione su tutte, ad aver costituito lo spunto che ha permesso di congiungere il quadro teorico estremamente ampio ed astratto con la località analitica circoscritta. Sulla scia dei lavori di Ernst Kantorowicz, questo paradigma ha potuto infine essere traslato dalla regalità medievale alla “governamentalità” contemporanea, soffermandosi tanto sui singoli casi che su questioni di portata più generale.
- Details
- Hits: 3323

Quale sovranità monetaria? Pensare la crisi europea
di Stefano Lucarelli
 « Uno dei rischi peggiori di questa crisi è la chiusura su se stessi degli Stati-nazione, la corsa a svalutazioni competitive per riconquistare fette di mercato sottraendole agli altri con misure protezionistiche. È così che, di solito, scoppiano le guerre»[1]
.
« Uno dei rischi peggiori di questa crisi è la chiusura su se stessi degli Stati-nazione, la corsa a svalutazioni competitive per riconquistare fette di mercato sottraendole agli altri con misure protezionistiche. È così che, di solito, scoppiano le guerre»[1]
.
Le parole su cui Christian Marazzi pone l’attenzione del lettore in conclusione del suo libro Finanza Bruciata – apparso nel 2009, poi tradotto in inglese e recentemente tradotto in francese – delineano un orizzonte nefasto. D’altro canto pensare a fondo la crisi europea conduce inevitabilmente a rendersi conto del pericolo che incombe. Per scongiurare questo orizzonte Marazzi invita ad adottare un principio, che egli intravede a fondamento del Homeowner Affordability & Stability Plan voluto dall’amministrazione Obama (la cassa di rifinanziamento ipotecario su trent’anni per salvare dal pignoramento della propria casa quattro milioni dei famiglie americane in grado di ritrasmettere fiducia al settore del credito ben più degli interventi di salvataggio diretto): partire dal basso per riformare il sistema monetario.
Le tesi di Marazzi costituiscono, nel bene e nel male, il tentativo più coraggioso e rigoroso prodotto dall’area antagonista (talora definita neo-operaista) di riorganizzare le categorie necessarie alle soggettività che vogliono ribellarsi allo stato di crisi. Categorie scivolose per cogliere l’insolito forgiato dal comando finanziario, comprenderlo, corromperlo, affinché una qualche relazione fra “lotta (di classe?)” e “sviluppo (capitalistico?)” possa essere innanzitutto immaginata e poi riproposta in modo vivo e vitale.
- Details
- Hits: 3501

Limiti e necessità dello sperimentalismo democratico
Note a margine del memorandum di Barca
Salvatore Biasco
 Introduzione
Introduzione
Il contributo che Barca da alla definizione di un modo d’essere del partito della sinistra non é solo metodologico. E’ politico nei giudizi sul deficit culturale e di rapporto con la società che ha avuto il Pd; é politico nell’indicazione della funzione che spetta al partito; nella corposità e radicamento sul territorio che esso deve necessariamente avere, nella sottolineatura del lavoro e dei beni pubblici come questioni prioritarie che deve porsi. Vi é, tuttavia, molta insistenza sulla forma partito; sulla ricerca, cioè di una organizzazione (ma direi un modo d’essere e di concepirsi) che lo renda un partito idoneo a sperimentare e cercare le sue linee programmatiche insieme ai militanti e alla collettività in un flusso di informazione e elaborazione che non può che essere bidirezionale. Barca chiama questo “sperimentalismo democratico”.
Il suo partito ideale può essere il mio e può non esserlo. Provo a capire. Io raccomanderei, per iniziare, a Barca – che sicuramente ha un opzione socialdemocratica all’orizzonte – di non porre la socialdemocrazia a un estremo della scala rispetto a quello che é il suo punto d’interesse (lo sperimentalismo), ponendo all’altro estremo l’opzione liberista (che egli chiama minimalista, cioè incline alla Stato minimo).
- Details
- Hits: 2568

Un’opposizione per la nostra Europa
Guido Viale
 Non siamo più, e da tempo, cittadini italiani; siamo sudditi di un “sovrano” che si chiama governance europea: un’entità mai eletta, che risponde solo al “voto” dei “mercati”. E’ un governo di fatto che definisce le politiche dei paesi dell’Ue che gli hanno ceduto la loro sovranità, fino a concedere, con l’accordo two-packs, un controllo preventivo sui propri bilanci. Se le cose stanno così – come ci ricorda il ritornello “ce lo chiede l’Europa” – per riappropriarsi della possibilità di far sentire la nostra voce, per restituire alle comunità capacità di autogoverno, occorre creare un’opposizione in ambito e di respiro europei.
Non siamo più, e da tempo, cittadini italiani; siamo sudditi di un “sovrano” che si chiama governance europea: un’entità mai eletta, che risponde solo al “voto” dei “mercati”. E’ un governo di fatto che definisce le politiche dei paesi dell’Ue che gli hanno ceduto la loro sovranità, fino a concedere, con l’accordo two-packs, un controllo preventivo sui propri bilanci. Se le cose stanno così – come ci ricorda il ritornello “ce lo chiede l’Europa” – per riappropriarsi della possibilità di far sentire la nostra voce, per restituire alle comunità capacità di autogoverno, occorre creare un’opposizione in ambito e di respiro europei.
Ma come colmare l’abisso tra le politiche imposte dalla governance europea e, per suo tramite, dalla finanza internazionale, e le istanze dei movimenti e delle mille organizzazioni che si battono, ciascuno a suo modo e spesso per proprio conto, per diritti fondamentali che i governi dei paesi dell’Ue stanno erodendo: dignità, lavoro, reddito, casa, salute, istruzione cultura, vecchiaia serena, accoglienza, rispetto della vita di tutti? C’è nella rivendicazione di quei diritti l’embrione di un programma comune in cui si riconoscerebbero facilmente i partecipanti alle manifestazioni sia del 12 che del 19 ottobre, che i rispettivi promotori hanno invece concorso a tener separate per cautele politiche e aggressività verbali in entrambi i casi inaccettabili (se si vuole tutte radunare le forze disponibili).
A questo programma di massima le elezioni europee della primavera prossima, come hanno sostenuto Alfonso Gianni e Tonino Perna, potrebbero fornire una prima occasione per riproporlo in tutti i paesi dell’Unione.
- Details
- Hits: 3389

La crisi è crisi di sistema*
di Ferdinando Dubla
 La crisi è una categoria non nuova per le classi sociali che ne subiscono le conseguenze: le fasi del capitalismo hanno abituato i suoi portavoce ad isolarne alcuni aspetti per nasconderne la portata strutturale, tutta interna alla natura stessa del sistema sociale proprio per celarne le evidenti contraddizioni. Per cui assistiamo alla centralità ora della speculazione finanziaria che ha in mano il debito pubblico inesigibile per i paesi più deboli della catena, ora il disordine politico che ne alimenterebbe l’incapacità di soluzioni altrimenti a portata di mano, ora la disperazione sociale di coloro che non sanno difendersi dai colpi dell’ineguaglianza. Infine, la crisi morale: lasciata nell’indeterminatezza, sullo sfondo di discorsi retorici, ha conquistato l’udienza dell’attuale Papa, collocandosi nuovamente al centro di una riflessione meno episodica e contingente (in un caso specifico, nel dialogo a distanza tra lo stesso Pontefice e il decano dei giornalisti laici, Eugenio Scalfari).
La crisi è una categoria non nuova per le classi sociali che ne subiscono le conseguenze: le fasi del capitalismo hanno abituato i suoi portavoce ad isolarne alcuni aspetti per nasconderne la portata strutturale, tutta interna alla natura stessa del sistema sociale proprio per celarne le evidenti contraddizioni. Per cui assistiamo alla centralità ora della speculazione finanziaria che ha in mano il debito pubblico inesigibile per i paesi più deboli della catena, ora il disordine politico che ne alimenterebbe l’incapacità di soluzioni altrimenti a portata di mano, ora la disperazione sociale di coloro che non sanno difendersi dai colpi dell’ineguaglianza. Infine, la crisi morale: lasciata nell’indeterminatezza, sullo sfondo di discorsi retorici, ha conquistato l’udienza dell’attuale Papa, collocandosi nuovamente al centro di una riflessione meno episodica e contingente (in un caso specifico, nel dialogo a distanza tra lo stesso Pontefice e il decano dei giornalisti laici, Eugenio Scalfari).
Una lettura marxista della crisi morale e dell’etica individuale e sociale che ne consegue, naturalmente non tende a settorializzare il problema: lo lega al sostrato economico dei rapporti di produzione e del ruolo degli Stati nella regolazione degli squilibri devastanti che il sistema capitalistico produce; al ruolo delle oligarchie politiche che ne garantiscono la sopravvivenza e l’alimentazione nel senso comune della impossibilità di alternative.
- Details
- Hits: 6297

Il Capitale come Feticcio Automatico e come Soggetto, e la sua costituzione
Sulla (dis)continuità Marx-Hegel
Riccardo Bellofiore
 Abstract: This article will deal in two steps with the Marx–Hegel (dis)connection in Capital. First, I’ll present a survey of what I take to be the most relevant positions about the role of dialectics in Marx. Second, after reviewing Marx’s criticisms of Hegel, I’ll consider the debate within the International Symposium on Marxian Theory. Third, I will argue that it is exactly Hegel’s idealism which made the Stuttgart philosopher crucial for the understanding of the capital relation. Here, I will refer to the ‘Hegelian’ Colletti of the late 1960s-early 1970s, to Backhaus’ dialectic of the form of value, and to Rubin’s interpretation of abstract labour as a process. At this point, I will provide my reading of Marx’s movement from commodity to money, and then to capital, in the first 5 chapters of Capital. Marx is moving on following a dual path. The first path reconstructs the ‘circularity’ of Capital as Subject, as an Automatic Fetish: it is here that Hegel’s idealistic method of ‘positing the presupposition’ served Marx well. The second path leads him to dig into the ‘constitution’ of the capital-relation, and therefore into the ‘linear’ exploitation of workers and class-struggle in production. Here we meet Marx’s radical break from Hegel, and understand the materialist foundation of the critique of political economy.
Abstract: This article will deal in two steps with the Marx–Hegel (dis)connection in Capital. First, I’ll present a survey of what I take to be the most relevant positions about the role of dialectics in Marx. Second, after reviewing Marx’s criticisms of Hegel, I’ll consider the debate within the International Symposium on Marxian Theory. Third, I will argue that it is exactly Hegel’s idealism which made the Stuttgart philosopher crucial for the understanding of the capital relation. Here, I will refer to the ‘Hegelian’ Colletti of the late 1960s-early 1970s, to Backhaus’ dialectic of the form of value, and to Rubin’s interpretation of abstract labour as a process. At this point, I will provide my reading of Marx’s movement from commodity to money, and then to capital, in the first 5 chapters of Capital. Marx is moving on following a dual path. The first path reconstructs the ‘circularity’ of Capital as Subject, as an Automatic Fetish: it is here that Hegel’s idealistic method of ‘positing the presupposition’ served Marx well. The second path leads him to dig into the ‘constitution’ of the capital-relation, and therefore into the ‘linear’ exploitation of workers and class-struggle in production. Here we meet Marx’s radical break from Hegel, and understand the materialist foundation of the critique of political economy.
Introduzione
In questo articolo mi interrogherò sul rapporto di continuità/discontinuità tra Marx e Hegel. Inizierò con una rassegna personale idiosincratica delle posizioni più importanti che hanno influenzato la mia posizione.
- Details
- Hits: 3948

Lavoro e proprietà a fronte del comune
di Toni Negri1
 Lasciatemi cominciare ricordando un breve passaggio marxiano (Marx, Über Lists Buch): “Il lavoro è il fondamento vivente della proprietà privata, la proprietà privata come fonte creativa di se stessa. La proprietà privata non è altro che lavoro oggettivato. Se allora si vuol dare alla proprietà privata un colpo mortale, non bisogna attaccarla solo in quanto condizione oggettiva, bensì in quanto attività, in quanto lavoro. E’ uno dei più grandi equivoci parlare di lavoro libero, umano, sociale, di lavoro senza proprietà privata. La soppressione della proprietà privata giunge dunque a realtà solo quando venga concepita come soppressione del lavoro, una soppressione che naturalmente diviene possibile solo attraverso il lavoro, e cioè attraverso l’attività materiale della società”.
Lasciatemi cominciare ricordando un breve passaggio marxiano (Marx, Über Lists Buch): “Il lavoro è il fondamento vivente della proprietà privata, la proprietà privata come fonte creativa di se stessa. La proprietà privata non è altro che lavoro oggettivato. Se allora si vuol dare alla proprietà privata un colpo mortale, non bisogna attaccarla solo in quanto condizione oggettiva, bensì in quanto attività, in quanto lavoro. E’ uno dei più grandi equivoci parlare di lavoro libero, umano, sociale, di lavoro senza proprietà privata. La soppressione della proprietà privata giunge dunque a realtà solo quando venga concepita come soppressione del lavoro, una soppressione che naturalmente diviene possibile solo attraverso il lavoro, e cioè attraverso l’attività materiale della società”.
Marx assume qui – dalla tradizione lockeana – la definizione “classica”, laica e liberale della proprietà privata. È la definizione propria dell’individualismo possessivo. Macpherson (come noto) ha ampiamente studiato l’individualismo possessivo: in questa prospettiva l’individuo era considerato libero nella misura in cui fosse proprietario della propria persona e delle proprie capacità, l’essenza dell’uomo consisteva nel non dipendere dalla volontà altrui e la libertà era funzione di ciò che individualmente si possiede. (Non molto diversa, sia detto per inciso, era la concezione della libertà Harrington e in Winstanley, autori per altro ai quali volentieri ci richiamiamo poiché il telos collettivo del loro ragionamento incentivava un progetto comunista).
La società consiste dunque di relazioni di scambio tra proprietari.
- Details
- Hits: 5619
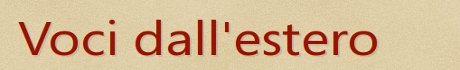
Operazione verità: a che punto è la notte italiana
 Questo è un lancio corale: vari siti e blog economici indipendenti, tutti insieme oggi rilanciamo questa operazione di verità sulla vera deriva che in questo contesto dissennato inevitabilmente prenderanno i conti pubblici italiani - e sulla colpevole falsità di chi annuncia una ripresa impossibile che slitta di anno in anno...
Questo è un lancio corale: vari siti e blog economici indipendenti, tutti insieme oggi rilanciamo questa operazione di verità sulla vera deriva che in questo contesto dissennato inevitabilmente prenderanno i conti pubblici italiani - e sulla colpevole falsità di chi annuncia una ripresa impossibile che slitta di anno in anno...
Il post è stato elaborato con la collaborazione di vari autori.
Premessa
In questi anni di crisi, oltre alle tasse e al disagio economico e sociale, c'è stata un'altra grande costante che ha tenuto compagnia alle nostre giornate, ai nostri momenti: la menzogna proferita in modo sistematico dai vari governi e dai politici di turno che, in maniera spudorata e vergognosa, hanno reiteratamente mentito e mistificato (e continuano a farlo) circa l'esatta situazione dell'economia e dei conti pubblici, in costante ed inesorabile deterioramento.
- Details
- Hits: 2678

Guida per gli occupabili del nuovo millennio
∫connessioni precarie
 Dubitiamo che i molti aspiranti lavoratori di questo paese inaugurino la settimana acquistando il Sole24ore. Siamo piuttosto certi, però, che quelli che lunedì mattina (per ragioni sulle quali tutt’ora si interrogano) hanno comprato il giornale di Confindustria a questo punto dovrebbero sentirsi rodere dai sensi di colpa o da un sentimento di profonda inadeguatezza: se sono disoccupati è solo colpa loro. A pagina 25 scopriamo infatti che le condizioni per muovere un decisivo «Scacco matto alla disoccupazione» sono lì, a portata di tutti, e che addirittura ci sarebbero 220mila posti di lavoro che si fatica a occupare. Le aziende italiane sarebbero impegnate nella vana ricerca di analisti, progettisti di software, ingegneri energetici, controller di gestione, e ancora parrucchieri, infermieri, disegnatori industriali. Ma non basta: in Europa, ben duemilioni di posti di lavoro sono a disposizione del miglior offerente, senza contare le straordinarie possibilità offerte dal resto del mondo e dai paesi emergenti. I disoccupati – o meglio, gli «occupabili», come li ha chiamati il ministro del lavoro Giovannini, che sta al passo coi tempi – devono dunque darsi da fare, e il Sole24ore offre con la sua «Guida alla ricerca del lavoro» indicazioni preziose per vendersi al meglio.
Dubitiamo che i molti aspiranti lavoratori di questo paese inaugurino la settimana acquistando il Sole24ore. Siamo piuttosto certi, però, che quelli che lunedì mattina (per ragioni sulle quali tutt’ora si interrogano) hanno comprato il giornale di Confindustria a questo punto dovrebbero sentirsi rodere dai sensi di colpa o da un sentimento di profonda inadeguatezza: se sono disoccupati è solo colpa loro. A pagina 25 scopriamo infatti che le condizioni per muovere un decisivo «Scacco matto alla disoccupazione» sono lì, a portata di tutti, e che addirittura ci sarebbero 220mila posti di lavoro che si fatica a occupare. Le aziende italiane sarebbero impegnate nella vana ricerca di analisti, progettisti di software, ingegneri energetici, controller di gestione, e ancora parrucchieri, infermieri, disegnatori industriali. Ma non basta: in Europa, ben duemilioni di posti di lavoro sono a disposizione del miglior offerente, senza contare le straordinarie possibilità offerte dal resto del mondo e dai paesi emergenti. I disoccupati – o meglio, gli «occupabili», come li ha chiamati il ministro del lavoro Giovannini, che sta al passo coi tempi – devono dunque darsi da fare, e il Sole24ore offre con la sua «Guida alla ricerca del lavoro» indicazioni preziose per vendersi al meglio.
Cominciamo col dire che le istruzioni per l’uso non sono uguali per tutti. Esiste un mondo di occupabili gggiovani, mediamente o altamente qualificati, che maneggiano il web e i socialnetwork con grande spirito di intrapresa, e un mondo di «over» le cui ultime speranze sembrano risiedere nelle paternalistiche «politiche attive» organizzate dal complesso Stato-regioni insieme al nuovo «braccio operativo» delle politiche pubbliche, le agenzie di reclutamento.
- Details
- Hits: 3100

L’Europa reale
Quindici tesi sul rapporto tra il capitalismo finanziario globale e la democrazia
a cura di Fausto Bertinotti
 1) La scelta di indagare il rapporto che si sta costituendo tra il capitalismo finanziario globale e la democrazia nell’Europa reale è già la scelta di un campo nella ricerca. Del resto non verrà taciuta l’ipotesi di partenza con la quale si vuole intraprendere l’indagine, non solo per correttezza metodologica, ma per poter dar luogo ad un confronto aperto e trasparente e alla stessa possibilità che essa venga falsificata.
1) La scelta di indagare il rapporto che si sta costituendo tra il capitalismo finanziario globale e la democrazia nell’Europa reale è già la scelta di un campo nella ricerca. Del resto non verrà taciuta l’ipotesi di partenza con la quale si vuole intraprendere l’indagine, non solo per correttezza metodologica, ma per poter dar luogo ad un confronto aperto e trasparente e alla stessa possibilità che essa venga falsificata.
Il campo in cui la ricerca si iscrive si può definire sia in negativo che in positivo. In negativo: esso si colloca fuori e contro la lettura del rapporto tra democrazia, economia e società alimentata dall’ideologia dominante, avendo essa sconfitto tutte le altre. Quest’ultima, dopo aver separato la questione democratica dalla natura della società, ha potuto proporre una scissione tra i diritti individuali, considerati formalmente come inalienabili, e i diritti sociali che, invece, dovrebbero farsi dipendenti dall’andamento dell’economia della concorrenza e della competitività. Da qui, la predisposizione ad un assetto post-democratico e al ritorno al primato delle élites in nome della governabilità. Si potrebbe parlare di una costituzionalizzazione del neo-liberismo. In positivo: la ricerca intende disvelare il rapporto distruttivo tra la natura specifica di questo capitalismo finanziario e la democrazia, non negando l’esistenza di una relazione tra la democrazia, i diritti e l’economia, bensì contestando in radice il carattere storicamente necessitato del dominio di questo tipo di economia su quelli e mettendo di questo dominio in luce, al contrario, il carattere soggettivo, fondato cioè su un determinato connotato assunto in questa fase storica dai rapporti sociali e, dunque, rivelando la possibile reversibilità del processo.
- Details
- Hits: 3136

Lavoro e reddito, un percorso di convergenza
di Claudio Gnesutta
 Che il tema del “lavoro” sia una questione strategica risulta ormai evidente dal fatto che gli aspetti negativi che lo investono – disoccupazione, compressione salariale, precariato, diffusa inoccupazione da scoraggiamento – non sono frutto di una crisi che è difficile considerarla congiunturale. Essa ha piuttosto i connotati di una prospettiva strutturale se si ha presente come la crescita occupazionale sia frenata sia dalla crescita della produttività del lavoro generate da innovazioni tecnologiche pressate dalla competizione internazionale, sia dalla pressione al ridimensionamento dell’intervento pubblico. Un futuro caratterizzato da un sistematico eccesso di offerta sul mercato del lavoro non può che tradursi in un deprezzamento – in quantità e qualità - del valore del lavoro, acutizzando l’attuale polarizzazione della distribuzione dei redditi che vede favorita la quota da capitale (profitti e rendite).
Che il tema del “lavoro” sia una questione strategica risulta ormai evidente dal fatto che gli aspetti negativi che lo investono – disoccupazione, compressione salariale, precariato, diffusa inoccupazione da scoraggiamento – non sono frutto di una crisi che è difficile considerarla congiunturale. Essa ha piuttosto i connotati di una prospettiva strutturale se si ha presente come la crescita occupazionale sia frenata sia dalla crescita della produttività del lavoro generate da innovazioni tecnologiche pressate dalla competizione internazionale, sia dalla pressione al ridimensionamento dell’intervento pubblico. Un futuro caratterizzato da un sistematico eccesso di offerta sul mercato del lavoro non può che tradursi in un deprezzamento – in quantità e qualità - del valore del lavoro, acutizzando l’attuale polarizzazione della distribuzione dei redditi che vede favorita la quota da capitale (profitti e rendite).
Il lavoro, non solo come risorsa produttiva, è divenuto, e rischia di essere sempre più, la variabile dipendente (dalla concorrenza internazionale fra proletariati privi di forza) dei processi di una crescita del prodotto (senza crescita dell’occupazione), tanto da poter sostenere che, allo stato attuale, la disoccupazione e la precarizzazione del lavoro sono dei non-obiettivi di politica economica (ed espressione di una non-politica del lavoro, se la si intende come garanzia della qualità della vita dei propri cittadini).
Page 493 of 612




































