Il vertice SCO a Tianjin apre una finestra sul nuovo mondo multipolare
di Roberto Iannuzzi
Gli eventi del vertice hanno messo in evidenza potenzialità e rischi di un nuovo ordine che si rafforza di pari passo con il tumultuoso declino di un Occidente sempre più smarrito e paranoico
 Mentre l’Occidente è assorbito dalle turbolenze nei rapporti transatlantici e da un crescente declino economico e politico, la Cina ha riunito un folto gruppo di leader non occidentali nella città settentrionale di Tianjin, ponendosi alla guida di un “Sud Globale” sempre più determinato a far sentire la propria voce nelle questioni internazionali.
Mentre l’Occidente è assorbito dalle turbolenze nei rapporti transatlantici e da un crescente declino economico e politico, la Cina ha riunito un folto gruppo di leader non occidentali nella città settentrionale di Tianjin, ponendosi alla guida di un “Sud Globale” sempre più determinato a far sentire la propria voce nelle questioni internazionali.
I ventisette leader si sono incontrati a partire dal 31 agosto per celebrare il 25° Vertice della Shanghai Cooperation Organization (SCO), durante il quale il presidente cinese Xi Jinping ha invocato una nuova era di governance globale che salvaguardi i paesi in via di sviluppo e si opponga alle politiche coercitive occidentali e allo scontro fra blocchi contrapposti.
La SCO nacque nel 2001, è governata dal Consiglio dei Capi di Stato che si riunisce annualmente, e include una Struttura Regionale Anti-Terrorismo (RATS, secondo l’acronimo inglese). Essa trae origine dal gruppo dei Cinque di Shanghai (Cina, Kazakistan, Kirghizistan, Russia e Tagikistan) costituitosi nel 1996 per risolvere dispute di confine e contrastare le ingerenze esterne nella regione centroasiatica.
Ai Cinque di Shanghai si sono poi associati nel corso degli anni l’Uzbekistan (in coincidenza con la nascita della SCO), India e Pakistan (nel 2017), l’Iran (2023) e la Bielorussia (2024).
Ai dieci membri dell’Organizzazione si aggiungono due stati “osservatori” (Mongolia e Afghanistan) e quattordici “partner di dialogo” (Arabia Saudita, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Cambogia, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Maldive, Myanmar, Nepal, Qatar, Sri Lanka e Turchia).
A Tianjin anche il Laos è entrato a far parte di quest’ultimo gruppo, portando a 27 il numero totale di paesi partecipanti.
Critica dell’attuale ordine internazionale
Al vertice, Xi Jinping e il suo ospite d’onore, il presidente russo Vladimir Putin, hanno promosso la visione di un nuovo mondo multipolare chiedendo all’intera comunità globale di mettersi alle spalle l’era coloniale e la “mentalità da Guerra Fredda”.
I paesi del Sud Globale, ampiamente rappresentati a Tianjin, nutrono un crescente risentimento nei confronti dell’ordine mondiale a guida americana nel quale l’Occidente detta le regole al resto del mondo e punisce coloro che non si conformano con sanzioni economiche e interventi militari.
Nel suo discorso, il presidente cinese ha ricordato che quest’anno segna l’80° anniversario della vittoria nella “guerra mondiale contro il fascismo” e della fondazione delle Nazioni Unite.
“Ottant’anni dopo”, ha osservato Xi Jinping, “le ombre della mentalità da Guerra Fredda, dell’egemonismo, e del protezionismo persistono, e nuove sfide e minacce continuano a emergere. Il mondo è entrato in una nuova fase di turbolenza e cambiamento, e la governance globale è di nuovo a un bivio”.
A tale riguardo, il cinese Global Times ha ulteriormente chiarito che:
“Le istituzioni internazionali esistenti hanno mostrato tre carenze. In primo luogo, una grave sotto-rappresentazione del Sud del mondo. L'ascesa collettiva dei mercati emergenti e dei paesi in via di sviluppo richiede un rafforzamento della rappresentanza del Sud del mondo e la correzione di ingiustizie storiche. In secondo luogo, l'erosione dell'autorevolezza. Gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite non sono stati effettivamente rispettati. Le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza sono state disattese. Le sanzioni unilaterali, tra le altre pratiche, hanno violato il diritto internazionale e sconvolto l'ordine mondiale. In terzo luogo, l'urgente necessità di una maggiore efficacia. L'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile è gravemente in ritardo. Questioni come il cambiamento climatico e il divario digitale stanno diventando sempre più rilevanti. Esistono lacune di governance in nuove frontiere come l'intelligenza artificiale (IA), il cyberspazio e lo spazio extra-atmosferico”.
Una nuova governance mondiale
Per porre rimedio a tali problemi, il presidente cinese ha lanciato la Global Governance Initiative (la quarta iniziativa globale proposta dalla Cina dopo la Global Development Initiative, la Global Security Initiative e la Global Culture Initiative).
Nel suo discorso, Xi Jinping ha riassunto tale iniziativa in 5 punti:
In primo luogo, dovremmo aderire al principio dell'uguaglianza sovrana. Dovremmo sostenere che tutti i Paesi, indipendentemente da dimensioni, forza e ricchezza, siano partecipanti, decisori e beneficiari paritari della governance globale. Dovremmo promuovere una maggiore democrazia nelle relazioni internazionali e aumentare la rappresentanza e la voce dei Paesi in via di sviluppo.
In secondo luogo, dovremmo rispettare il diritto internazionale. Gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e di altre norme fondamentali universalmente riconosciute in materia di relazioni internazionali devono essere rispettati in modo completo, nella loro interezza. Il diritto e le norme internazionali devono essere applicati in modo equo e uniforme. Non dovrebbero esserci doppi standard e le regole interne di alcuni Paesi non devono essere imposte ad altri.
In terzo luogo, dovremmo praticare il multilateralismo. Dovremmo sostenere la visione di una governance globale caratterizzata da ampie consultazioni e contributi congiunti per un beneficio condiviso, rafforzare la solidarietà e il coordinamento e opporci all'unilateralismo. Dovremmo salvaguardare fermamente lo status e l'autorità delle Nazioni Unite e garantirne il ruolo chiave e insostituibile nella governance globale.
In quarto luogo, dovremmo promuovere un approccio incentrato sulle persone. Dovremmo riformare e migliorare il sistema di governance globale per garantire che i cittadini di ogni nazione siano attori e beneficiari di tale sistema, in modo da affrontare al meglio le sfide comuni dell'umanità, colmare al meglio il divario Nord-Sud e salvaguardare al meglio gli interessi comuni di tutti i Paesi.
In quinto luogo, dovremmo concentrarci sull'adozione di azioni concrete. Dovremmo adottare un approccio sistematico e olistico, coordinare le azioni globali, mobilitare pienamente le diverse risorse e impegnarci per ottenere risultati più visibili. Dovremmo rafforzare la cooperazione pratica per evitare che il sistema di governance rimanga indietro o sia frammentato.
Come si evince da questi punti, pur promuovendo una nuova visione delle relazioni internazionali, la Cina non intende rinunciare ad alcuni pilastri dell’attuale ordine mondiale, inclusa la centralità dell’ONU (seppur parzialmente riformata), malgrado i problemi e i difetti che affliggono questa organizzazione ed alcuni suoi specifici programmi come l’Agenda 2030, a cui Pechino ha aderito.
Resta poi da vedere se sarà possibile tradurre in realtà i principi di parità, uguaglianza e cooperazione mutuamente benefica che caratterizzano la visione sino-russa del nuovo mondo multipolare, o se esso non finirà per essere contraddistinto da nuove rivalità.
La Dichiarazione di Tianjin
Tali principi sono stati in ogni caso inseriti nella Dichiarazione di Tianjin, a conclusione del vertice.
In essa si legge che “promuovere la costruzione di un nuovo tipo di relazioni internazionali basate sul rispetto reciproco, sull’equità e sulla giustizia, e sulla cooperazione reciprocamente vantaggiosa…ha un importante significato pratico”, assieme alla promozione di una “comunità con un futuro condiviso per l'umanità” (un concetto estremamente caro a Xi Jinping) e all’avanzamento di un dialogo basato sul concetto di "Una Terra, una famiglia, un futuro".
L’inserimento di quest’ultimo concetto costituisce una chiara apertura all’India, che lo introdusse al G20 da essa presieduto nel 2023. Tale visione presenta tuttavia ambiguità (in riferimento all’attuale modello capitalistico) non del tutto dissimili da quelle dell’Agenda 2030.
La dichiarazione si contraddistingue poi per una ferma condanna della “aggressione militare lanciata da Israele e dagli Stati Uniti contro l’Iran nel giugno 2025”, sottolineando che “tali azioni aggressive contro installazioni civili, tra cui infrastrutture nucleari di base, hanno causato vittime tra i civili, infrangono gravemente le norme del diritto internazionale e gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, violano la sovranità e l'integrità territoriale dell'Iran, compromettono la sicurezza regionale e internazionale e causano gravi conseguenze per la pace e la stabilità globali”.
Queste parole costituiscono una chiara espressione di solidarietà nei confronti dell’Iran (membro della SCO dal 2023) e una netta condanna di Israele e degli USA, che vengono citati in maniera esplicita.
La peculiarità di questa presa di posizione spicca ancor di più se confrontata con le parole ben più sfumate utilizzate dalla dichiarazione in riferimento alla tragedia di Gaza. In questo caso essa manifesta apprensione senza tuttavia formulare una condanna altrettanto chiara di Israele (e tantomeno degli Stati Uniti):
“Gli Stati membri ribadiscono la loro profonda preoccupazione per la continua escalation del conflitto israelo-palestinese e condannano fermamente le azioni che hanno causato numerose vittime civili e disastri umanitari a Gaza.
Gli Stati membri sottolineano la necessità di raggiungere un cessate il fuoco globale e duraturo il prima possibile, garantire l'accesso degli aiuti umanitari a Gaza e intensificare gli sforzi per assicurare pace, stabilità e sicurezza ai residenti della regione”.
La dichiarazione inoltre afferma che “l'unico modo per garantire la pace e la stabilità in Medio Oriente è una soluzione globale e giusta alla questione palestinese”, senza tuttavia fare più riferimento alla soluzione dei due stati.
Le lezioni della storia
I richiami del presidente cinese e della Dichiarazione di Tianjin all’80° anniversario della vittoria nella “guerra mondiale contro il fascismo” hanno trovato un’eco molto concreta, e una continuità discorsiva, il 3 settembre, nell’imponente parata militare per la celebrazione della “Giornata della Vittoria” contro l’occupazione giapponese al termine della seconda guerra mondiale.
Alle celebrazioni hanno preso parte più di 20 capi di stato e di governo stranieri fra cui il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, l’iraniano Masoud Pezeshkian, i leader delle repubbliche centroasiatiche, il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, il primo ministro slovacco Robert Fico e il presidente serbo Aleksandar Vucic (definiti da Foreign Policy “gli unici due leader occidentali presenti all’evento”), il leader nordcoreano Kim Jong Un, e il presidente Russo Vladimir Putin.
Questi ultimi due sono apparsi alla sinistra e alla destra di Xi nei momenti chiave della commemorazione.
Davanti ai leader schierati, hanno sfilato in Piazza Tienanmen migliaia di soldati e i più sofisticati armamenti dell’ormai modernissimo arsenale cinese (missili ipersonici, armi laser, droni subacquei).
Nel suo breve discorso per l’occasione, Xi Jinping ha rimarcato come la resistenza cinese contro l’invasione giapponese abbia rappresentato una componente fondamentale del secondo conflitto mondiale.
Gli storici cinesi e russi insistono nel sottolineare che Cina e Russia ebbero un ruolo chiave nella vittoria contro il nazifascismo durante la seconda guerra mondiale, e pagarono di gran lunga il prezzo più alto.
Mentre in Occidente si è soliti ricordare Pearl Harbor, lo sbarco in Normandia, o la battaglia di Stalingrado, i fronti orientali furono altrettanto decisivi e molto più sanguinosi.
Per la Cina la guerra iniziò addirittura nel 1931, quando il Giappone invase la Manciuria, e secondo gli storici cinesi fino a 35 milioni di loro connazionali perirono nel conflitto.
Nell’attuale confronto per la ridefinizione degli equilibri mondiali, la memoria storica è essa stessa un campo di battaglia, sul cui terreno Cina, Russia e il Sud globale sono determinati a correggere le deformazioni della storiografia occidentale.
Xi Jinping ha sottolineato che “l’umanità si trova nuovamente di fronte a una scelta tra pace e guerra, dialogo e scontro, esiti mutuamente vantaggiosi o giochi a somma zero”, aggiungendo che “il popolo cinese si schiera fermamente dalla parte giusta della storia e del progresso della civiltà umana, aderisce alla via dello sviluppo pacifico e lavora fianco a fianco con le persone di tutti i paesi per costruire una comunità con un futuro condiviso per l'umanità”.
Egli ha affermato che tutti i gruppi etnici della Cina devono implementare il “socialismo con caratteristiche cinesi” e unirsi nel “promuovere lo sviluppo della Cina come nazione forte e raggiungere il rinnovamento nazionale attraverso una modernizzazione in stile cinese”.
Ed ha concluso proclamando che “il grande rinnovamento della nazione cinese è inarrestabile” e che “la nobile causa della pace e dello sviluppo per l’umanità certamente trionferà”.
Gli occidentali vedono i muscoli, non la mano tesa
Ma in Occidente l’attenzione non si è focalizzata sulle parole del presidente cinese, bensì sulla potenza militare sfoggiata da Pechino, sia per rilevare come la tecnologia militare del gigante asiatico sia ormai in molti campi superiore a quella occidentale, sia per alimentare lo spauracchio della “minaccia cinese”.
Ad esempio, Jennifer Parker, specialista in studi navali presso la University of New South Wales di Canberra, ha sostenuto che “non si organizza una parata come questa per commemorare la fine della seconda guerra mondiale”, bensì “per dimostrare la propria forza, e si scelgono le capacità esposte nella parata per trasmettere un messaggio specifico”.
Il presidente americano Donald Trump ha riassunto in maniera tanto cruda quanto schietta il pensiero di molti commentatori occidentali scrivendo su Truth (il suo social preferito): “Che il presidente Xi e il meraviglioso popolo cinese possano godere di una grande e duratura giornata di festa. Vi prego di porgere i miei più sentiti saluti a Vladimir Putin e Kim Jong Un, mentre cospirate contro gli Stati Uniti d'America”.
Dal canto suo, l’alto rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaja Kallas, ha descritto l'incontro dei tre leader come una "sfida diretta al sistema internazionale basato su regole... Non è solo simbolica. La guerra della Russia in Ucraina è alimentata dal sostegno cinese".
Pochi in Occidente si sono soffermati a ricordare come siano state le scelte politiche americane a favorire il riarmo cinese e il riavvicinamento fra Russia, Cina e Corea del Nord.
Cambiano gli equilibri energetici euroasiatici
Un altro accordo potenzialmente epocale rinsalda la sempre più stretta amicizia fra Mosca e Pechino: la tanto attesa firma, lo scorso 2 settembre, del memorandum per la costruzione del gasdotto Power of Siberia 2, un imponente progetto destinato a ridefinire i flussi energetici del continente eurasiatico.
Sebbene costi e tempi di costruzione non siano stati ancora definiti, una volta realizzato, il gasdotto da 50 miliardi di metri cubi all’anno convoglierà in direzione della Cina, attraverso la Mongolia, il gas proveniente dai giacimenti che in passato hanno alimentato le industrie e riscaldato le abitazioni dei paesi europei.
Una volta entrato a regime il Power of Siberia 2, le esportazioni russe di gas attraverso le pipeline dirette verso la Cina ammonteranno a circa 106 miliardi di metri cubi all’anno, una cifra inferiore ai circa 160 miliardi che Mosca esportava in Europa prima del conflitto ucraino.
E la Russia guadagnerà meno per gli stessi volumi di gas perché la Cina lo acquisterà a prezzi inferiori a quelli pagati in passato dagli europei. Ciononostante, Mosca avrà un cliente stabile.
Tenuto conto anche delle quote di gas naturale liquefatto (LNG), Pechino acquisterà dalla Russia circa un quinto del proprio fabbisogno. Con ciò, il consolidamento della svolta russa verso l’Asia appare ancor più definitivo.
Per contro, l’Europa dovrà fare i conti con i prezzi estremamente più elevati dell’LNG assicurato da paesi come USA e Qatar, e con forniture intrinsecamente più instabili rispetto a quelle garantite dai gasdotti.
Di fronte alla crescente integrazione dell’Asia, l’Europa si profila sempre più come una propaggine isolata dai circuiti energetici e commerciali della massa eurasiatica per aver deciso di sottostare alle scelte politiche americane.
Triangolo Russia-India-Cina
Un ulteriore scossone agli equilibri mondiali è rappresentato dalla prima visita (in sette anni) del premier indiano Narendra Modi in Cina, in occasione del vertice di Tianjin. L’incontro amichevole fra Modi e Xi Jinping segna una distensione nei rapporti fra i due paesi favorita dalla guerra dei dazi di Trump.
Quest’ultimo ha imposto dazi del 50% a Nuova Delhi, colpevole di acquistare crescenti quantitativi di petrolio russo (ormai un terzo delle importazioni indiane). Il colpo basso è stato mal digerito da Modi, soprattutto alla luce del fatto che la Cina, il primo importatore di fonti energetiche russe, è stata invece risparmiata da una simile punizione.
La risposta indiana è stata di stringere ancor di più i rapporti con Mosca e di aprire un dialogo con Pechino. L’arrivo di Modi a Tianjin è stato preceduto dalla visita del ministro degli esteri cinese Wang Yi a Nuova Delhi.
In quell’occasione i due paesi hanno firmato un memorandum d’intesa impegnandosi a risolvere le dispute di confine attraverso consultazioni amichevoli.
L’apertura di Nuova Delhi nei confronti di Pechino rimane tuttavia parziale. L’India resta l’unico paese della SCO a non appoggiare la Belt and Road Initiative cinese. E Modi ci ha tenuto a fare tappa in Giappone prima di recarsi a Tianjin.
Il vero vincitore del raffreddamento nei rapporti fra Nuova Delhi e Washington è Vladimir Putin che, rinsaldando ulteriormente il legame con l’India, trova nel continente asiatico un contrappeso che gli consente di non dipendere esclusivamente da Pechino.
Ciliegina sulla torta del vertice di Tianjin è stato l’annuncio della creazione della SCO Development Bank, un istituto che contribuirà a isolare i membri dell’organizzazione dai sempre più rischiosi scambi denominati in dollari.
Nel loro complesso, gli eventi sviluppatisi attorno al vertice hanno perfettamente messo in evidenza le potenzialità e i rischi di un mondo multipolare che si rafforza di pari passo con il tumultuoso declino di un Occidente sempre più smarrito e paranoico.


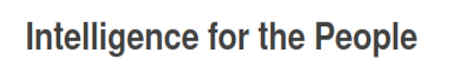




































Comments