L’instabilità mondiale si sposta verso l’emisfero occidentale
di Roberto Iannuzzi
 La Cina è inarrivabile. L’Occidente frana dall’interno. L’ex superpotenza USA dispiega la propria residua forza militare, e quella dei suoi alleati in crisi, in America Latina, Europa e Medio Oriente
La Cina è inarrivabile. L’Occidente frana dall’interno. L’ex superpotenza USA dispiega la propria residua forza militare, e quella dei suoi alleati in crisi, in America Latina, Europa e Medio Oriente
Mentre al vertice della Shanghai Cooperation Organization (SCO) di Tianjin il gigante cinese si è posto nettamente alla guida del mondo non occidentale, Stati Uniti e paesi europei sono alle prese con crescenti crisi politiche, economiche e sociali al proprio interno.
Militarmente, Washington si sta concentrando in primo luogo sul continente americano, scaricando sugli europei i costi di un conflitto ucraino sempre più fallimentare, e lasciandosi trainare dal disastroso avventurismo israeliano in un Medio Oriente sempre più in fiamme.
Arroccamento americano
Questa realtà potrebbe presto trovare conferma nella nuova Strategia di Difesa Nazionale del Pentagono. Una bozza del documento è attualmente allo studio del Segretario alla Difesa Pete Hegseth.
Secondo indiscrezioni, essa antepone per la prima volta la protezione del suolo nazionale e del continente americano all’esigenza di contrastare avversari come Russia e Cina.
Sebbene il documento possa ancora subire modifiche, si tratta per molti versi di una tendenza già in atto.
Il Dipartimento della Difesa ha inviato navi da guerra ed aerei F-35 nei Caraibi, ed ha mobilitato migliaia di uomini della Guardia Nazionale per mantenere l’ordine a Washington e Los Angeles, in un paese sempre più frammentato e diviso (come conferma il recente assassinio dell’attivista conservatore Charlie Kirk).
Se questa realtà trovasse riscontro nel nuovo documento del Pentagono, si tratterebbe di uno stravolgimento rispetto alla Strategia di Difesa Nazionale del 2018, sotto la prima amministrazione Trump, la quale poneva al primo posto il contenimento della Cina.
E’ significativo che Elbridge Colby, sottosegretario alla Difesa responsabile della stesura della nuova strategia di difesa, sia tradizionalmente considerato un falco nei confronti della Cina e abbia giocato un ruolo chiave nell’elaborazione del documento del 2018.
Malgrado questa connotazione, egli ha finito per allinearsi con il desiderio del vicepresidente JD Vance di disimpegnare gli USA dai propri eccessivi impegni oltremare.
Non ci troviamo tuttavia di fronte a una superpotenza disposta a rinunciare al proprio ruolo egemonico, bensì ad una crisi di leadership che spinge Washington a cercare disperatamente di ricompattare le proprie file, di guadagnare tempo, e di gettare le basi per una gestione del potere più coesa e circoscritta.
In sostanza, l’establishment USA sta ripiegando su una strategia di arroccamento, intesa a consolidare il controllo sugli alleati e sul proprio “cortile di casa”, e a soffocare ogni turbolenza interna.
Così, mentre la Guardia Nazionale viene dispiegata a pattugliare le città americane, le navi da guerra USA convergono nei Caraibi, e la Casa Bianca strappa accordi capestro ai partner europei.
Paradossalmente, proprio mentre gli strateghi di Washington si fanno meno scrupoli a parlare apertamente di impiego della nuda forza da parte degli Stati Uniti, rinunciando a triti slogan come quello dell’esportazione della democrazia, essi sono costretti a fare un uso più parsimonioso di tale forza a causa delle declinanti possibilità della macchina bellica americana.
Indisponibilità alla coesistenza
Come ha scritto l’ex diplomatico britannico Alastair Crooke, in Occidente “secoli di superiorità coloniale hanno plasmato una cultura al cui interno l’unico possibile modello è l’egemonia e l’imposizione di una dipendenza dall’Occidente”.
Di conseguenza, gli USA non essendo psicologicamente preparati a trattare da pari a pari con le potenze non occidentali, ricorrono a una sorta di “antagonismo difensivista”.
Riconoscere che Cina, Russia e India si sono “distaccate” dall’ordine internazionale a guida USA ed hanno costruito una sfera non occidentale separata, osserva Crooke, implicherebbe chiaramente “accettare la fine dell’egemonia globale dell’Occidente”.
Le classi dominanti statunitensi ed europee non sono assolutamente pronte a un simile riconoscimento. Per questa ragione, il vertice di Tianjin e la parata militare in Piazza Tienanmen a Pechino hanno causato costernazione a Washington, Bruxelles e Londra.
Come ha scritto l’analista russo Fyodor Lukyanov, l’idea promossa da quel vertice non è di un mondo alternativo “contro l’Occidente”, ma “senza l’Occidente”.
Se quest’ultimo non vuole aderire ad un ordine internazionale più equo e a una gestione più consensuale del potere (concetti sintetizzati dalla Global Governance Initiative del presidente cinese Xi Jinping), il mondo non occidentale procederà per conto proprio.
Quest’ordine basato sulla cooperazione e sul consenso, sostiene Lukyanov, è incarnato da organizzazioni come la SCO o l’ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Ad esse egli contrappone istituzioni come la NATO e l’UE “divenute non democratiche e autoritarie, e un pericolo per i loro stessi membri”.
Arroganza e autoisolamento
Similmente, l’accademico cinese Wang Xiangsui stigmatizza la reazione occidentale negativa di fronte alla parata militare per commemorare la vittoria cinese sul Giappone, affermando che l’Occidente non solo non è stato in grado di decodificare i segnali provenienti dalla Cina, ma non è capace di interpretare gli sviluppi contemporanei.
L’imponente dispiegamento di tecnologia militare all’avanguardia da parte di Pechino, sostiene Xiangsui, non costituisce un’intimidazione nei confronti dell’America, ma una risposta alla sua arroganza.
Su un altro piano, si potrebbe anche affermare che esso rappresenta una risposta al “secolo di umiliazione” impostole dall’Occidente.
Di fronte alle aggressive tattiche occidentali in molteplici domini, afferma Xiangsui, la risposta di Pechino è stata quella di ricorrere a un antico principio cinese (espresso da Sun Tzu nell’Arte della guerra) vantaggioso per tutti nell’era nucleare: “sottomettere il nemico senza combattere”.
Per questo l’esercito cinese “si è evoluto in una forza in grado di rivaleggiare con qualsiasi avversario, vantando una tecnologia avanzata, un addestramento rigoroso, un’organizzazione solida e una formidabile capacità di mobilitazione”.
Allo stesso tempo, proposte come la Global Governance Initiative servono a lanciare un messaggio di cooperazione e sviluppo condivisi. Un messaggio incarnato anche dalla crescente integrazione asiatica incentrata sull’asse russo-cinese.
La rivolta di Maidan in Ucraina nel 2014 segnò la fine del sogno di un’Europa da Lisbona a Vladivostok vagheggiato dal presidente russo Vladimir Putin, e da Michail Gorbaciov prima ancora di lui, accelerando invece l’integrazione russo-cinese.
Nel 2024, gli scambi commerciali fra il nordest della Cina e l’estremo oriente russo hanno raggiunto il valore di 105,8 miliardi di dollari, costituendo il 43% del commercio bilaterale fra i due paesi.
Un asse, quello russo-cinese, ulteriormente rafforzato dall’approvazione del gasdotto Power of Siberia 2, che porterà in Cina il gas che una volta andava in Europa.
L’assenza del presidente americano Donald Trump alla parata militare di Pechino, durante la quale Xi Jinping è stato affiancato da Putin e dal leader nordcoreano Kim Jong Un, e le accuse loro rivolte dall’inquilino della Casa Bianca di “cospirare contro gli Stati Uniti”, non hanno fatto altro che rafforzare l’impressione che il leader isolato fosse quello statunitense, piuttosto che Putin.
Una nuova dottrina Monroe
Di fronte all’immagine di unità lanciata da Tianjin, l’Occidente appare frammentato e diviso. Il rapporto transatlantico è incrinato. Dal Canada all’Europa, Trump impone dazi ai suoi stessi alleati.
Nel vecchio continente, il motore franco-tedesco dell’Unione Europea è inceppato da tempo, mentre la Francia è paralizzata da una crisi politica, oltre che economica, apparentemente senza uscita. Al di là della Manica, la Gran Bretagna è ugualmente in declino.
Oltreoceano, la Casa Bianca sembra intenta ad applicare una nuova Dottrina Monroe. Washington non si vanta più di esportare democrazia e sviluppo, ma guarda al continente americano come a un possedimento sul quale rifondare la propria declinante egemonia.
Con un certo velleitarismo, Trump ha minacciato di trasformare il Canada nel 51° stato americano e ha ventilato l’annessione della Groenlandia. Nei confronti dell’America Latina ha adottato atteggiamenti ancor più aggressivi.
Il continente sudamericano possiede vaste riserve di minerali essenziali per la transizione energetica, tra cui litio, rame e nichel, che stimolano gli appetiti di Washington.
Durante il suo primo mandato, Trump aveva tentato un cambio di regime in Venezuela ai danni del presidente Nicolás Maduro, aveva appoggiato il colpo di stato contro Evo Morales in Bolivia, e applicato dure sanzioni non solo contro Caracas, ma anche contro Cuba e Nicaragua.
Ciò non ha impedito, anzi per certi versi ha favorito, la crescente penetrazione cinese nell’America Latina. Mentre Washington usava le sanzioni come un’arma per isolare il Venezuela, Pechino ha sostenuto l’economia del paese con prestiti rimborsabili col greggio venezuelano, e con investimenti infrastrutturali e contratti energetici.
Nel novembre 2024, Xi Jinping ha personalmente inaugurato la costruzione del porto di Chancay in Perù, ora il più grande scalo in acque profonde sulla costa sudamericana del Pacifico.
E nel maggio 2025 la Colombia, un alleato chiave di Washington, ha aderito alla Belt and Road Initiative (BRI). Due terzi dei paesi sudamericani ormai aderiscono alla BRI.
Appena reinsediatosi alla Casa Bianca, Trump ha affermato che il Canale di Panama dovrebbe tornare sotto il controllo di Washington per contenere la crescente influenza della Cina.
E attualmente la sua amministrazione sta prendendo in esame diverse opzioni per lanciare attacchi militari contro presunti cartelli della droga in Venezuela. Il recente bombardamento di un’imbarcazione al largo delle coste venezuelane rappresenterebbe solo l’inizio. La campagna appare un pretesto per indebolire Maduro.
Come ha chiarito Pino Arlacchi, già direttore esecutivo dell’UNDCP (United Nations International Drug Control Programme), il tentativo di Trump di descrivere il Venezuela come un “narco-stato” è una truffa motivata da ragioni geopolitiche.
Il Venezuela è un paese assolutamente marginale nel panorama del narcotraffico sudamericano, e la vera ragione dell’interesse della Casa Bianca nei suoi confronti sta nelle sue risorse petrolifere.
Il vacillante fronte anti-russo
Nel frattempo gli Stati Uniti hanno scaricato sui paesi europei, molti dei quali devono fronteggiare crisi finanziarie e recessione, l’enorme costo del conflitto ucraino, che si aggira intorno ai 100 miliardi di dollari all’anno.
La “coalizione dei volenterosi” si è riunita a Parigi praticamente in coincidenza con il vertice di Tianjin.
Essa è composta da quei paesi che sono disposti a supportare l’Ucraina con l’invio di truppe di interposizione e altri aiuti militari nell’improbabile eventualità di un “accordo di pace” con la Russia che sancisca un nuovo conflitto congelato in Europa.
L’incontro di Parigi ha fatto da impietoso contraltare al vertice SCO – una riunione di leader europei un tempo dediti a perseguire prosperità e benessere, e ora proiettati con tutte le propri residue forze a prolungare a tempo indeterminato l’agonia dell’Ucraina.
Sebbene essi abbiano annunciato una “road map” per il dispiegamento di soldati europei sul territorio ucraino, le divisioni permangono, soprattutto tra Gran Bretagna e Francia (disposte a schierare le proprie truppe) da un lato, e Germania e Polonia (invece restie) dall’altro.
Alla luce di tali divisioni, dello stato disastroso in cui versano gli eserciti europei, e del fatto che l’amministrazione Trump non sembra intenzionata a fornire supporto logistico e di intelligence, lo schieramento di un adeguato contingente europeo in Ucraina appare oggi una fantasia.
Guerra israeliana su più fronti
L’unico fronte oltreoceano su cui Washington sembra ancora determinata a spingere, soprattutto perché trainata dall’alleato israeliano, è quello mediorientale.
L’obiettivo è di vecchia data: smantellare l’asse iraniano e ridisegnare gli equilibri di potere per consolidare l’egemonia regionale israeliana e il controllo americano sulle rotte energetiche e commerciali dell’Asia occidentale.
Ma anche in questo caso, rischi e incognite non mancano, e la propensione al conflitto perenne che caratterizza il governo israeliano potrebbe trasformarsi in un boomerang.
Mentre l’Iran appare determinato a difendere la propria residua influenza e la propria sovranità (e la “guerra dei 12 giorni” dello scorso giugno ha dimostrato che Teheran è in grado di infliggere colpi dolorosi a Israele), il governo Netanyahu continua a baloccarsi con l’idea del “grande Israele”: una Siria balcanizzata nella quale ritagliare una sfera d’influenza israeliana, una zona cuscinetto nel sud del Libano, l’annessione di una Striscia di Gaza spopolata e rasa al suolo, e dell’82% della Cisgiordania.
Da mesi Israele colpisce con frequenza talvolta quasi quotidiana obiettivi in Libano, sebbene sia in vigore un cessate il fuoco con quel paese, e in Siria, sebbene il nuovo governo insediatosi a Damasco non abbia mai osato alzare un dito contro Tel Aviv.
Le forze armate israeliane continuano a rispondere con bombardamenti sproporzionati ai lanci di droni e missili che il gruppo yemenita di Ansarallah (anche noto come gli “Houthi”) periodicamente indirizza contro Israele.
Tali bombardamenti sono recentemente culminati con un attacco che ha decapitato il governo di Sanaa, uccidendo il primo ministro e diversi membri dell’esecutivo.
Nel frattempo, con il benestare americano, il governo Netanyahu ha lanciato un’offensiva militare volta a spopolare Gaza City, dove attualmente risiede circa un milione di persone, e a radere completamente al suolo la città.
Cade un altro tabù
Tuttavia, mai fino a questo momento Israele aveva colpito il territorio di uno stretto alleato di Washington nella regione. Anche questo tabù è venuto a cadere, lo scorso 9 settembre, allorché aerei israeliani hanno preso di mira i leader di Hamas a Doha, la capitale del Qatar.
L’attacco a una monarchia del Golfo, nota per il suo ruolo di mediazione nei conflitti regionali (spesso in coordinamento con gli USA), e che ospita la più grande base militare americana in Medio Oriente, è senza precedenti.
Il fatto che Washington abbia permesso a Israele di bombardare impunemente un proprio importante alleato ha scosso l’intera regione. La conclusione che i leader del Golfo hanno tratto è che quanto è accaduto al Qatar potrà presto succedere anche a loro.
Ciò vale anche per altri paesi, come la Turchia e l’Egitto.
L’attacco israeliano fra l’altro sembra essersi risolto in un fallimento, perché i leader di Hamas ne sono usciti praticamente indenni. Ma ciò che conta, agli occhi degli alleati americani nel Golfo, è la debole reazione di Trump alla trasgressione di Israele.
Il presidente statunitense si è limitato a distanziarsi dall’azione israeliana affermando che “bombardare unilateralmente il Qatar, una nazione sovrana e uno stretto alleato degli Stati Uniti, che sta lavorando duramente e correndo coraggiosamente dei rischi insieme a noi per mediare la pace, non favorisce gli obiettivi di Israele o dell'America. Tuttavia, eliminare Hamas, che ha tratto profitto dalla miseria di chi vive a Gaza, è un obiettivo meritevole”.
Egli ha aggiunto che un incidente del genere non si ripeterà. Ma già a giugno il Qatar aveva dovuto subire la rappresaglia iraniana contro la locale base USA di Al-Udeid a seguito della decisione di Trump di bombardare i siti nucleari di Teheran.
E il fatto che l’attacco israeliano sia fallito fa temere alla monarchia qatarina un possibile secondo tentativo da parte di Tel Aviv.
Come ha sentenziato l’analista saudita Salman Al-Ansari, “il danno ormai è fatto. Un alleato americano è stato attaccato da un altro alleato americano…sotto lo sguardo e l’apparente luce verde di Washington, creando un precedente che non svanirà tanto presto”.
Progetti americani in crisi
L’immagine di garante della sicurezza del Golfo, che gli Stati Uniti hanno coltivato per decenni nella regione, giace ormai in frantumi. E le monarchie arabe potrebbero trarne le conseguenze cercando di diversificare gradualmente le loro relazioni di sicurezza.
Il primo effetto negativo dell’attacco israeliano su Doha inciderà sulle aspirazioni di Trump di estendere gli Accordi di Abramo ad altri paesi del Golfo, inclusa l’Arabia Saudita. Una prospettiva del genere, già messa in crisi dalla campagna genocidaria condotta da Israele a Gaza, appare ora ancor più remota.
Sempre più difficile da realizzare appare anche l’India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC), il corridoio economico proposto nella regione da Washington al G20 del 2023 in India, in competizione con la BRI, la Via della Seta cinese.
Da Tianjin la Cina ha promosso un’immagine di saldezza militare, sviluppo e integrazione economica che promette stabilità e allontana la prospettiva di una sfida armata da parte di Washington.
La declinante superpotenza americana e i suoi alleati offrono invece un quadro di fragilità interna, debolezza economica, e destabilizzante avventurismo militare.
Tale avventurismo rischia di seminare ulteriore caos, dall’America Latina all’Europa, al Medio Oriente, mentre stabilità e prosperità promettono di fiorire in Asia e nel Pacifico.


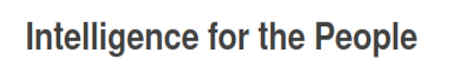

 Like
Like 


































Perdonate, neanche gli Usa meritano simile affronto ortografico