Questione comunista o questione della rivoluzione in Occidente?
di Sandro Valentini
A partire da questo intervento inviatoci dal compagno Alessandro Valentini, apriamo un dibattito sulla fase attuale del movimento comunista in Italia e il ruolo del Partito Comunista
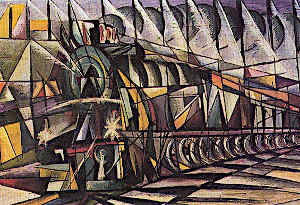 Comunista o rivoluzionario?
Comunista o rivoluzionario?
Quando sostengo la necessità di un nuovo soggetto politico per l’Italia e per l’Europa non ripropongo la questione comunista, anzi uso raramente la parola comunista e solo in occasione di riferimenti storici. Sono fermamente convinto che non è tramite il rilancio di un movimento comunista che si possa uscire dalla situazione di subalternità al pensiero liberale. Non è che non consideri le esperienze in cui i comunisti svolgono un ruolo importante, decisivo, strategico. Per esempio in Cina, in Russia, in Vietnam, a Cuba e in altri paesi, ma non è un caso che queste esperienze, tolte delle eccezioni, siano vive, influenti, contino in paesi non occidentali e siano espressione di complessi processi storici, che piaccia o no, si riflettono e pesano nello scenario internazionale.
D’altronde occorre avere in mente la storia. Lenin trasforma la fazione bolscevica del Partito socialdemocratico russo in Partito comunista e fonda sulla spinta dell’Ottobre l’Internazionale perché è certo del trionfo anche in Occidente, nel breve periodo, della rivoluzione. I partiti comunisti non nascono dunque per condurre una battaglia di lunga lena, non era questa la prospettiva indicata dai comunisti russi, ma per fare da subito la rivoluzione in quanto imminente. I partiti comunisti, solo alcuni anni dopo la loro nascita, che tra l’altro coinciderà con la loro sconfitta in Europa, cercheranno – e solo pochi ci riusciranno – di riorganizzarsi per darsi una politica di lungo respiro, che avrebbe dovuto tenere conto del ripiegamento del Pcus, con Stalin, sul socialismo in un solo paese.
In sintesi è stato questo il contesto storico che portò alla nascita dei partiti comunisti, ma questo contesto è superato e quindi sarebbe una pessima iniziativa cercare di riproporlo a distanza di un secolo, con il nuovo millennio. Non è sufficiente avere un nome e una storia gloriosa per continuare a essere necessari! Occorre rivisitare dunque una serie di categorie, elaborate da Marx, Engels, Lenin e Gramsci, ma anche dal Pci di Togliatti, magari in parte per riaffermarle, cercando però di aggiornarle, altre volte per correggerle rispetto alle trasformazioni del capitale, infine, in qualche caso, per consegnarle alla storia poiché superate. Non è mia intenzione gettare all’ortiche, come molti hanno fatto a sinistra, due secoli di storia del marxismo e di lotte del movimento operaio.
Chiarito ciò ritengo che non abbia senso – lo ribadisco – la riproposizione di un movimento comunista a livello globale. La mia convinzione è su questo punto molto forte. Del resto il Partito comunista cinese, che per autorevolezza e forza, ha tutte le carte in regola per essere il promotore di questa riproposizione si guarda bene – e affermo giustamente – dal farlo. Altre sono le strade da intraprendere per ricostruire una sinistra rivoluzionaria, di trasformazione. La crisi dei partiti comunisti in Occidente, ma anche quella delle socialdemocrazie, obbliga a interrogarci sul da farsi in termini del tutto inediti, spostando il campo di confronto non sulle storiche divisioni tra la II Internazionale (socialdemocratica) e la III Internazionale (comunista), ma sulle istanze poste dal presente, dalla realtà di oggi. Per questo riproporre, attualizzandolo astrattamente, il confronto storico tra due visioni diverse e contrapposte, anche se entrambe si richiamavano al marxismo, è fuorviante, non aiuta, cristallizza le riflessioni nell’ambito di un contesto storico che fa parte del passato e non si proietta verso «una analisi concreta di una situazione concreta» come sosteneva Lenin. D’altronde chi osa obiettivamente sostenere che il Partito socialista europeo sia una forza socialdemocratica, compreso il Pd? Oppure che il gruppo del Gue nel Parlamento europeo o la Sinistra europea siano dei raggruppamenti comunisti? Se non si parte dall’esaminare e dal valutare i dati reali non si combina molto. Non tutto può essere ridotto alla categoria del “tradimento” verso chi si definisce solo formalmente socialdemocratico, o a quella del “revisionismo”, in nome del marxismo-leninismo, come causa del declino dei partiti comunisti.
La crisi della sinistra in Europa deriva soprattutto dalla sua incapacità di leggere i processi di trasformazione e di mutazione del capitale e delle contraddizione inedite che ha prodotto. Molti non sono consapevoli, o non vogliono prenderne atto, che la creatura del marxismo-leninismo, partorita dalla mente di Stalin, ha bloccato per tutto un periodo la capacità di “revisionare” (atto del rivedere per correggere) il pensiero di Marx abilmente intrapresa da Lenin e da Gramsci e in parte, con risultati diversi, da Togliatti e da Mao. In questa ottica era Lenin il “revisionista” (termine che ha valenze ben diverse rispetto al “revisionismo storico” che si pone l’obiettivo di correggere e riscrivere la storia a uso della politica) e non l’ortodosso Kautsky, che tra l’altro era in rapporto di amicizia con l’anziano Engels, il quale gli inviò una lettera in cui suggeriva di non abusare della parola “comunismo” foriera di grande ambiguità e confusione per il partito socialdemocratico tedesco. Riguardo alle interpretazioni del pensiero di Marx è bene rammentare che la principale sua opera “Il Capitale” rimase incompiuta. Il I Libro fu pubblicato quando l’autore era ancora in vita (l’11 settembre 1867), gli altri due uscirono postumi, sulla base degli appunti di Marx. Il Libro II ed il III furono curati da Engels rispettivamente nel 1885 e nel 1894, mentre il Libro IV venne pubblicato (1905–1910) da Kautsky con il titolo “Teorie del plusvalore” (nel dopoguerra l’Istituto Marx-Engels-Lenin di Mosca acquistò il manoscritto e nel 1954, dopo averlo riordinato, fece uscire una nuova edizione che differiva da quella di Kautsky in quanto, si sostenne, non era del tutto aderente al progetto originario di Marx. Questa è oggi l’edizione più diffusa).
Marx ed Engels e le due vie al socialismo
Lenin ha giustamente osservato che “Il Capitale” è un’opera scritta a quattro mani, sia da Marx sia da Engels. Nel discorso funebre sulla tomba di Marx, Engels sottolineava con le seguenti e significative parole l’opera dell’amico: «Così come Darwin ha scoperto la legge dello sviluppo della natura organica, Marx ha scoperto la legge dello sviluppo della storia umana». C’è da dire che lo sviluppo della tradizione marxista, di cui Engels si fece il primo protagonista, partiva dalla preoccupazione di non lasciare l’egemonia politica e culturale al positivismo. Sono gli anni del suo stretto rapporto di collaborazione con Kautsky. Per quest’ultimo, con Marx «si apre una nuova età per la scienza storica. E tutti coloro che appartengono alla tendenza marxista devono essere degli storici come lo è stato Marx» se non si vuole restare estranei, «impermeabili alla concezione marxista nella sua totalità». La definizione del marxismo data da Kautsky negli anni ‘80, viene da lui concettualizzata nel 1908 in una formula divenuta famosa: «Il socialismo marxista non è altro, in ultima analisi, che la scienza della storia a partire dal punto di vista del proletariato».
La definizione sul materialismo che non lascia interpretazioni di sorta la fornisce Lenin nel famoso scritto “Tre fonti e tre parti integranti del marxismo”. Scrive Lenin: «La filosofia del marxismo è il materialismo». E aggiunge: «Il materialismo di Marx non coincide con il materialismo settecentesco». Per Lenin, Marx arricchisce la filosofia con la «filosofia classica tedesca, soprattutto fa riferimento al sistema di Hegel che a sua volta aveva condotto Feuerbach al materialismo. La principale di queste conquiste è la dialettica, cioè la dottrina dello sviluppo nella sua espressione più completa, più profonda e meno unilaterale». Lenin non intende costruire una filosofia sganciata dalla scienza, come ho rammentato nel capitolo “Progresso e sviluppo nel marxismo, ieri e oggi”, ma si prefigge di difendere Engels e il suo metodo dialettico applicato alla conoscenza scientifica, nonostante il groviglio di problemi e di semplificazioni a cui conduce. È bene rammentare che in Russia la tradizione engelsiana fu introdotta da Plechanov e solo poi successivamente fu ripresa da Lenin.
Nell’ambito della concezione materialistica della storia (concezione è un termine coniato da Engels) una delle questioni più dibattute è quella del passaggio da una società capitalistica a una società socialista. Si tratta cioè della questione della rottura rivoluzionaria (violenta o pacifica). Nelle opere di Marx e di Engels esistono non una, ma due vie al socialismo. La prima via, che ha caratterizzato il marxismo per tutta una lunga fase, è quella che prevede la rivoluzione nei paesi a capitalismo maturo, cioè i paesi progrediti dell’Occidente, in cui agiscono, su un triplice piano ma intrecciandosi, le forze produttive, la democrazia politica e la presa di coscienza delle masse. E in questi paesi la rivoluzione borghese precede logicamente la rivoluzione socialista. Ma è anche vero che Marx indica una seconda via. Questa ipotesi è formulata diverse volte, ad esempio nella sua ultima prefazione al “Manifesto” analizzando proprio la situazione russa. Sarà successivamente resa più esplicita da Engels negli scambi di lettere con i russi Vera Zasulič e Plechanov. Si tratta della possibilità di un passaggio al socialismo che consentirebbe di scavalcare se non lo stadio del capitalismo almeno lo stadio della sua espansione. Una rivoluzione socialista russa, su base contadina e che preceda rivoluzioni in Occidente, è considerata dunque da Marx ed Engels un’ipotesi concreta. Sarà successivamente Lenin ad attuarla sulla base di un’alleanza proletaria tra masse contadine e avanguardie operaie, in un paese che aveva nel frattempo sviluppato un proprio capitalismo industriale (1).Questa impostazione leniniana sarà poi ripresa da Mao, adattandola alla Cina.
La questione delle due vie rivoluzionarie aveva però anche altre implicazioni che condussero a letture diverse di interpretazione delle situazioni. Nei paesi in cui il capitalismo era meno progredito si affermò la strategia insurrezionale della conquista del potere, mentre soprattutto nei paesi a capitalismo avanzato si sviluppò il dibattito del rapporto tra riforme e rivoluzione. Se la rivoluzione è, in termini classici, la conquista degli apparati dello Stato, come condizione per determinare il rovesciamento dell’ordinamento sociale, quale allora deve essere il rapporto tra l’azione rivoluzionaria e una politica riformatrice? È stato questo un tema controverso, spesso drammatico, nella storia del movimento operaio, in quanto ha portato a profonde divisioni, a insanabili lacerazioni. Nei paesi dove la legge del valore è pienamente sviluppata le riforme possono essere giustamente intese come una serie di tappe del processo rivoluzionario, oppure al contrario, un modo per impedire o attenuare la spinta rivoluzionaria. È questo dibattito/confronto/scontro sulla natura della rivoluzione ha fortemente caratterizzato la storia del movimento socialista e comunista per tutta una fase, almeno fino alla prima metà del Novecento. È stato il tema centrale molto di più dell’analisi del passaggio da una società capitalistica, più o meno avanzata, al socialismo La rivoluzione deve essere necessariamente violenta o può essere pacifica, condotta cioè per vie legali? Si persegue l’atto insurrezionale (quella che Lenin definiva «situazione rivoluzionaria») o si adotta una linea graduale di riforme di avanzata al socialismo? Questo confronto/scontro ha spostato su un versante più politico (tattico per assumere poi un tratto strategico) l’analisi teorica di Marx ed Engels sulle due vie al socialismo.
Torno allora a Marx ed Engels perché mi pare importante ripartire da loro. Che vi siano due vie per il passaggio dal capitalismo al socialismo nel loro bagaglio teorico mi pare, come detto, fuori discussione. Nella prima via il processo rivoluzionario può avvenire anche in modo graduale arrivando a poco a poco al superamento (transizione) del sistema capitalistico; nell’altra via, invece, dove la legge del valore è poco sviluppata, vi è un “salto”, una “rottura” rivoluzionaria del sistema. Non è questa una mia libera interpretazione. Continui sono i richiami di Marx ed Engels alla società anglosassone nella quale si erano formate istituzioni democratiche e in questi casi si poteva ipotizzare un passaggio democratico e pacifico al socialismo. D’altronde Marx sosterrà, nel 1852, il suffragio universale in Inghilterra, con il quale si sarebbe determinato, se ottenuto, uno sviluppo straordinario del movimento socialista, maggiore di tutti i tentativi (talvolta avventuristici) insurrezionali organizzati in continente, in nome e per conto del socialismo. Ed Engels ricorda nell’ “Introduzione” per l’edizione di “Le lotte di classe in Francia”: «Già il “Manifesto comunista” aveva proclamato la conquista del suffragio universale, della democrazia, come uno dei primi importanti compiti del proletariato militante».
E scrive Marx, nel commentare la soppressione nel 1850 del suffragio universale in Francia: «La borghesia, respingendo il suffragio universale, del quale si era fino ad allora drappeggiata, dal quale aveva ricavato la propria onnipotenza, confessa apertamente: la nostra dittatura è fino a oggi esistita in forza della volontà popolare, ora essa deve venir consolidata contro la volontà popolare». Il movimento operaio scoprirà più avanti che questa analisi di Marx era parziale, anche se nello scritto “Il 18 brumaio” egli ebbe la straordinaria intuizione di denunciare l’uso strumentale (demagogico) del plebiscito da parte di Luigi Bonaparte (Napoleone III). Infatti l’introduzione del plebiscito fu adoperata come uno strumento per “pilotare” la volontà popolare. In seguito le leggi elettorali diverranno sempre più elaborate attraverso i collegi uninominali, gli sbarramenti e i premi di maggioranza in modo da rendere la selezione della classe politica un processo manovrabile a seconda delle diverse occasioni e dei diversi momenti storici. L’Europa borghese riuscirà ad addomesticare, dopo la drammatica esperienza del fascismo e della guerra, il suffragio universale utilizzando proprio queste correzioni per moderarne gli effetti “eversivi”. Per questo il concetto “una testa, un voto” (il sistema proporzionale a suffragio universale) è un principio per cui il movimento operaio ha duramente combattuto nel corso di due secoli di lotte.
La tesi dell’abbattimento violento dello Stato borghese sembrerebbe quella prevalente in Marx. Ma è altresì vero che egli ha sostenuto, e talvolta in contemporanea con la tesi dell’abbattimento violento dello Stato borghese, altre posizioni. Per esempio, al Congresso dell’Aja della I Internazionale, svoltosi nel 1872, affermò che nei paesi dove il capitalismo si era sviluppato, come Stati Uniti, Inghilterra e Olanda, si poteva determinare, proprio per l’affermarsi di processi democratici, l’indebolimento dell’apparato repressivo antisociale. Pertanto la transizione al socialismo poteva avvenire anche per via pacifica. Insomma, egli non escludeva la strada delle riforme. Marx perciò svolse all’Aja una importante riflessione di natura strategica, che sarà ripresa e ampliata dall’anziano Engels nella sua celebre “Introduzione a Le lotte di classe in Francia”. Con il suffragio universale «era entrato in azione – scrive Engels – un nuovo metodo di lotta del proletariato». Lo Stato borghese in cui si organizzava il dominio della borghesia offriva «altri appigli, a mezzo dei quali la classe operaia può combattere queste stesse istituzioni statali (…) Così accade che la borghesia e il governo arrivano a temere molto più l’azione legale che l’azione illegale del partito operaio, più le vittorie elettorali che quella della ribellione (…) L’ironia della storia capovolge ogni cosa. Noi, i rivoluzionari, i sovversivi, prosperiamo meglio coi mezzi legali che coi mezzi illegali o con la sommossa. I partiti d’ordine, come essi si chiamano, trovano la loro rovina nell’ordinamento legale che essi stessi hanno creato». Un brano formidabile, di grande intuizione politica. Engels era consapevole che la lotta di classe era divenuta cosa più complessa, che non si risolveva con dei moti rivoluzionari di piazza. Queste riflessioni mostrano la complessità e l’articolazione del pensiero di Marx e di Engels, ma non aiutano a risolvere la disputa tra riformisti e rivoluzionari e non chiariscono se le due vie rivoluzionarie possano condurre allo stesso risultato di edificazione di società socialiste. Sarà successivamente un tema centrale dell’indagine di Gramsci con la geniale nozione guerra di movimento e guerra di posizione.
La concezione di Lenin
Sul tema rivoluzione/dittatura del proletariato e democrazia/via legale e pacifica al socialismo vi è un interessante saggio di Jacques Texier “Stato e rivoluzione di Lenin e la faccia nascosta del pensiero politico marx-englesiano” pubblicato all’interno degli “Atti del Convegno Internazionale di Urbino” del 1994 sotto il titolo “Lenin e il Novecento”. Nel saggio Texier dimostra che vi è uno scarto non di poco conto nel pensiero politico di Marx ed Engels e si tratta della distinzione che di fatto i due introducono tra il “continente Europa”, in cui la rivoluzione, almeno nella maggior parte dei paesi, necessariamente sarà violenta in quanto qui esistevano e operavano apparati burocratici civili e militari oppressivi, e l’Inghilterra e più in generale il mondo anglosassone, dove in più di una occasione s’intravedeva la possibilità di un passaggio legale e pacifico al socialismo. Scrive Texier: «Nel corso del mio lavoro sono stato portato ad attribuire un’importanza sempre maggiore a questo scarto che Marx ed Engels stabiliscono tra il continente e il mondo anglosassone e ciò per una ragione molto semplice. Mi sono accorto che essa era costante lungo tutto il corso della vita di Marx, e, dopo la sua morte, nel corso dei dodici anni in cui Engels è solo ad aiutare coi suoi consigli i diversi partiti operai che nascono e si sviluppano. Sono stato impressionato dal fatto che Marx ed Engels mantengano fermamente questa idea, nel mentre l’insieme delle loro idee subisce forti scosse, come avviene con la rivoluzione del 1848 o con la Comune di Parigi. Sono stato infine anche impressionato dal fatto che i testi dove essi esprimono queste idee sono piuttosto numerosi, e senza dubbio ne ignoro ancora un certo numero. Io non ho ancora steso la lista dei testi ove si tratta del famoso concetto della dittatura del proletariato, ma è probabile che non siano più numerosi di quelli in cui si tratta della possibilità di un passaggio pacifico in un certo numero di paesi».
Naturalmente si tratta di calare queste considerazioni di Texier nel contesto storico e nelle situazioni che mutano e impongono cambiamenti di idee. Non bisogna mai dimenticare che nel 1848 e nel 1871 si sono svolte rivoluzioni reali, e successivamente anche nel biennio 1917-19. È necessario pertanto tener conto delle situazioni concrete che hanno suggerito anche a Marx, a Engels, e poi a Lenin percorsi non necessariamente organici al pensiero marxiano originario (le scelte dipendevano non solo dai rapporti di forza, ma anche dalle intenzioni concrete delle masse popolari). Ma anche storicizzando il loro pensiero ponendolo dentro i processi storici e non astraendolo da essi, lo “scarto” evidenziato da Texier mantiene la sua importanza. È parte integrante del patrimonio del marxismo. Texier si chiede come mai l’idea della rivoluzione violenta e della dittatura del proletariato abbia fatto così tanta strada nella storia e nella letteratura del movimento comunista, mentre la tesi di un passaggio pacifico al socialismo in determinati paesi sia poco conosciuta e riproposta, quasi come una novità assoluta, solo dopo il secondo conflitto mondiale, in particolar modo da alcuni partiti comunisti dell’Europa occidentale, come il Pci. La risposta, secondo lui, è in “Stato e rivoluzione” di Lenin. Il rivoluzionario russo, con molta probabilità considerava l’idea di un passaggio pacifico una tesi con minore peso teorico, oppure pensava che la dittatura del proletariato (da intendersi come dittatura della maggioranza delle classi oppresse sulla borghesia e dunque in fin dei conti configurata come “dittatura democratica”) fosse la proposta più corrispondente alla situazione rivoluzionaria russa nell’epoca dell’imperialismo. Scrive in “Stato e rivoluzione”: «La repubblica democratica è il miglior involucro politico del capitalismo» mentre «la democratica è la via più breve che conduce alla dittatura del proletariato». È su questa bivalenza della democrazia che Togliatti costruisce la strategia della via nazionale al socialismo, ma il Pci, almeno fino alla segreteria di Longo, considerava questa strategia aderente alle tradizioni e alle caratteristiche del movimento operaio italiano – come più volte Togliatti e Longo hanno riaffermato – e teneva conto delle possibilità via via offerte dalla situazione italiana. La via nazionale al socialismo non fu dunque adottata, come molti la interpretarono più tardi, per elaborare una teoria rivoluzionaria valida per tutti i paesi del mondo, caso mai poteva in qualche misura essere utile per alcuni paesi occidentali che erano in condizioni simili a quella italiana, quindi non si poneva come teoria alternativa al leninismo. Questo aspetto fondamentale è stato totalmente rimosso, anche da tutti quegli storici che si richiamano a una storiografia e al pensiero marxista, mentre è un importante spunto di riflessione teorica per l’oggi, in cui occorre fare i conti con il processo gran parte compiuto di affermazione di sistemi politici a-democratici in Occidente. Tale situazione del tutto inedita rispetto al Novecento ripropone con forza la questione di come organizzare la lotta per il socialismo. Nella possibilità almeno di influenzare e condizionare – individuando gli strumenti politici più adeguati – le scelte delle oligarchie finanziarie per condurre una politica di avanzata al socialismo. Il tutto non può ridursi solo al cambio di maggioranze parlamentari, tra l’altro con parlamenti svuotati dei loro poteri. Così è ridotta e si concepisce la democrazia oggi. E in ogni modo la democrazia dell’alternanza non era nell’orizzonte del Pci.
Tornando a Lenin, egli compie una scelta, rifiuta la via legale e pacifica, anzi, nel rimuoverla totalmente, la nega. Attua così una profonda revisione del pensiero marxista, misconoscendo una parte del suo patrimonio analitico. Ha la necessità politica di condurre un’azione rivoluzionaria, con lucidità e determinazione. E quindi, nonostante avesse una concezione democratica del partito e del rapporto tra partito e proletariato (basata sull’unità tra operai e contadini), sebbene avesse sostenuto con convinzione la Nep (2), e questa sua concezione democratica si avverte chiaramente in “Stato e rivoluzione”, nel tentativo di delineare la funzione dei Soviet, egli involontariamente consegna al marxismo-leninismo di Stalin un’arma formidabile per cancellare qualsiasi nesso tra lotta legale e pacifica e socialismo.
Il risultato, comunque, è che la via pacifica in “Stato e rivoluzione” è del tutto ignorata, o meglio, la tesi è riportata al solo scopo di condurre una dura polemica contro “l’opportunismo ortodosso” di Kautsky, mentre sono del tutto assenti dalle sue riflessioni i testi di Marx ed Engels che la illustrano. Certamente occorre anche qui collocare quest’opera nel contesto concreto: la prima guerra mondiale e i suoi disastri sociali da una parte, il tradimento del grosso dei gruppi dirigenti socialdemocratici dall’altra parte. Lenin inoltre aveva appena cominciato a ridefinire complessivamente il suo pensiero sulla base dell’esperienza rivoluzionaria. Ma detto tutto ciò – e non certo per ricercare un giustificazionismo politico che non avrebbe qui nessun senso – resta la questione che Lenin compie un’operazione teorica di messa in discussione di una parte non secondaria del pensiero di Marx ed Engels, imputando al solo Kautsky la responsabilità della tesi della via pacifica. Da qui si comprende forse il motivo per cui “Stato e rivoluzione” resta un’opera teorica incompiuta, che non riguarda solo la rivoluzione russa e in particolare l’atteggiamento da avere verso lo Stato (concetto che in Lenin, tra l’altro, ebbe una evoluzione in seguito alle difficoltà che la rivoluzione incontrò dopo la presa del potere), ma riguarda la stessa questione della concezione del potere del marxismo della III Internazionale. Lenin pare quasi rifiutarsi di tenere conto dell’innovazione dell’ultimo Engels che dichiarava che la repubblica democratica non è solo il terreno più avanzato della lotta di classe, «ma è la forma specifica della dittatura del proletariato» (“Critica del progetto del programma di Erfurt”, 1891).
Non vi è dubbio che la situazione in cui operava Lenin era profondamente diversa da quella di relativa pace intercapitalistica su cui ragionava Engels, nel cui contesto storico le lotte operarie avevano ottenuto risultati importanti per la democrazia e lo Stato sociale. Quanto allo Stato, un conto è analizzarlo in una tranquilla democrazia parlamentare, questione ben diversa è ragionarci sopra quando è in corso una guerra. “Stato e rivoluzione” rimane un’opera incompiuta anche perché Lenin non fu in grado di delineare la forma dello Stato rivoluzionario in Russia, se non nelle linee generalissime del potere ai Soviet. Il problema di come sarà complicata la gestione del potere nella transizione si porrà dopo: dall’Ottobre fino alla Nep i bolscevichi si muoveranno a tentoni, con improvvisazioni e con svolte brusche. Lenin è tatticamente troppo concentrato nello svolgere la sua dura polemica contro lo spostamento “centrista” della socialdemocrazia per introdurre riflessioni un po’ troppo attigue alle loro. Egli ha bisogno di distinguersi nettamente dalle posizioni della II Internazionale. Anche per questa ragione recupera il temine comunista, caduto da anni in disuso, affinché il suo movimento rivoluzionario non fosse assimilabile alle socialdemocrazie.
Per dirla in un altro modo, la via russa della transizione al socialismo diventò la norma, mentre doveva essere solo un’altra via, secondo le analisi e la visione di Marx: questa è stata la contraddizione, il paradosso della storia del socialismo. C’è addirittura chi sostiene che quella russa sia stata una rivoluzione prematura. Questo giudizio mi sembra eccessivo, poiché sottovaluta il ruolo straordinario di Lenin e del partito bolscevico. Non coglie in tutta la sua portata la funzione del soggetto (rivoluzionario) nei processi storici. Indubbiamente però la Rivoluzione d’Ottobre ha posto un grosso problema al marxismo in quanto ha contribuito alla sua deoccidentalizzazione, malgrado gli sforzi di Lenin per impedirlo. Con il ripiegamento tattico del Pcus di Stalin e l’ingabbiamento del pensiero di Marx e di Lenin in un corpus dottrinario e dogmatico, cioè il marxismo-leninismo che esalta solo una via per la realizzazione del processo rivoluzionario. Questa a me pare sia stata una delle pesanti eredità dello stalinismo.
I bolscevichi omettevano che vi potesse essere un’altra via rivoluzionaria rispetto a quella da loro attuata in Russia, ma anche i socialdemocratici negavano la possibilità di una seconda via, quella di Lenin, al socialismo. Anche tra i bolscevichi vi erano opinioni diverse. La soluzione praticata da Lenin susciterà il dissenso della Luxemburg (la quale lo accuserà di sostenere una teoria blanquista) e più avanti, pur con cautela, anche di Lukàcs, che riproporrà una lettura di Marx fortemente in chiave hegeliana. La Rivoluzione d’Ottobre (paradossalmente) porrà al movimento operaio problemi inediti, non del genere di quelli che si propongono in una qualsiasi rivoluzione, ma appunto problemi teorici che nascono da una rivoluzione proletaria che si deve porre necessariamente degli interrogativi sul modo in cui la classe operaia possa esercitare il suo ruolo di classe dirigente attraverso il potere statale. Il potere delle classi subalterne non è e non può essere solo l’espressione di una nuova formazione economica-sociale già maturata in precedenza in seno all’antica, ma partendo proprio dalla nuova formazione economica-sociale in sviluppo deve cominciare a creare determinate premesse non solo strutturali, ma anche politiche, sociali e giuridiche per la realizzazione di una società socialista.
Si è iniziato davvero a dibattere questi temi tardivamente, con il crollo dell’URSS. L’unica teoria che per tutta una lunga fase è stata accreditata nel movimento comunista, è l’interpretazione leniniana di Marx ed Engels attraverso il corpus dottrinario dello stalinismo. Solo dopo la morte di Stalin ci sarà una timida ripresa teorica grazie all’impegno di intellettuali e dirigenti, come Lukàcs e Togliatti (anche attraverso la diffusione del pensiero di Gramsci favorita da un’operazione editoriale e politica di massa della pubblicazione dei “Quaderni dal carcere”). Poi, inevitabilmente, con l’accentuarsi della crisi dell’Unione Sovietica, le analisi teoriche e il conseguente dibattito si imporranno. Il resto è storia recente e si conclude con il crollo del socialismo reale, anche se il pensiero comunista successivamente si arricchirà di altre esperienze: la rivoluzione cinese e cubana e la lotta di liberazione vietnamita. Ma queste rotture rivoluzionarie avvengono in situazioni particolari, e comunque in paesi dove il capitalismo era, come in Russia, relativamente poco sviluppato.
Dopo questo lungo excursus non vorrei essere frainteso. Nell’affermare che i bolscevichi hanno “rinnegato” Marx non sostengo che non fossero ispirati dal suo pensiero. Essi lo riaffermarono con la testimonianza dell’azione esplicita, con le conquiste realizzate. Ma erano consapevoli – almeno Lenin lo era – della complessità dialettica e non deterministica del materialismo. C’è una “provvidenzialità storica” negli avvenimenti dell’Ottobre: i bolscevichi “rinnegarono” alcune tesi de “Il Capitale”, ma non ne rinnegarono il pensiero immanente, vivificatore. Essi semplicemente non erano “marxisti”, ecco tutto; non considerarono le opere del “Maestro” come una dottrina esteriore fatta di affermazioni dogmatiche e indiscutibili. Interpretarono il pensiero di Marx come continuazione di un ragionamento teorico da reinterpretare e aggiornare, eliminando quelle incrostazioni positivistiche e naturalistiche: erano dei rivoluzionari! Da qui occorre ripartire. Questo è il senso del famoso articolo di Gramsci “La rivoluzione contro Il Capitale”, a sostegno della rivoluzione russa. E solo un rozzo e malizioso revisionismo storico può considerare questo Gramsci cosa altra dal materialismo storico. Ed è proprio sulla ricerca di una teoria rivoluzionaria per l’Occidente che egli si è arrovellato per tutta la vita. Anzi per lui questa ricerca era fondamentale (come per Lenin) per dare più forza e vigore allo stesso processo rivoluzionario russo. Che la questione principale fosse come fare la rivoluzione Marx l’aveva intuito sul piano teorico e Lenin genialmente l’aveva risolta, in polemica con la maggioranza dei partiti della II Internazionale, ma per la Russia e non per l’Occidente. L’errore fondamentale commesso dai partiti socialdemocratici fu di credere che fosse sufficiente la democratizzazione dello Stato borghese (democrazia parlamentare, repubblica), sulla base degli insegnamenti del vecchio Engels, dimenticando che nella sua “Introduzione” (già citata), apparsa per la prima volta sul “Vorwarts”, l’organo centrale della socialdemocrazia tedesca, tutti i richiami non in difesa di una tattica a ogni costo pacifica e contraria alla violenza erano stati omessi: censurati! Ed è questo un altro punto di ambiguità del pensiero marxista post engelsiano che non colse la complessità dei “padri fondatori”. Solo nel 1934 fu pubblicata in Unione Sovietica la versione integrale della prefazione di Engels in cui era chiara la problematica del suo pensiero. Tuttavia è storicamente evidente che Marx ed Engels furono tirati per la giacca in termini unilaterali sia dai socialdemocratici sia dai bolscevichi. Caso mai la questione di merito è che i primi aderirono alla guerra, mentre i secondi, piaccia o no, fecero una rivoluzione. Non è una differenza da poco!
Stalin e il marxismo-leninismo
È noto che la canonizzazione ufficiale del leninismo e l’invenzione del marxismo-leninismo furono opera di Stalin (tra l’altro è bene rammentare che Engels non userà mai la locuzione “marxismo” per esporre la concezione del materialismo storico). Nell’aprile del ’24, tre mesi dopo la scomparsa di Lenin, nelle lezioni tenute all’Università Sverdlov sui “Principi del leninismo”, Stalin diede la famosa definizione: «Il leninismo è il marxismo dell’epoca dell’imperialismo e della rivoluzione proletaria. Più esattamente il leninismo è la teoria e la tattica della rivoluzione proletaria in generale, la teoria e la tattica della dittatura del proletariato in particolare». A distanza di tanti anni ancora forse non si è compresa fino in fondo la portata “straordinaria” di opere come la “Storia del Partito Comunista Bolscevico dell’URSS” nel quale è contenuto il paragrafo “Materialismo dialettico e materialismo storico” o “Questioni sul leninismo”. Anche per questa ragione è iniziato assai tardi e ancora oggi va a rilento il processo di destalinizzazione filosofica, nonostante le tante prese di distanza dallo stalinismo.
«Prima, la questione nazionale si riduceva di solito a un gruppo ristretto di problemi che riguardavano, per lo più, le nazioni “civili”. Irlandesi, ungheresi, polacchi, finlandesi, serbi e alcune altre nazionalità dell’Europa: questo era il gruppo di popoli, privati dell’eguaglianza di diritti, delle cui sorti s’interessavano gli eroi della II Internazionale. Decine e centinaia di riunioni di uomini appartenenti ai popoli dell’Asia e dell’Africa, che subivano il giogo nazionale nelle sue forme più brutali e più feroci, di solito non venivano presi in considerazione. Non ci si decideva a mettere sullo stesso piano bianchi e neri, “civili” e “non civili”, collegando in questo modo il problema nazionale a quello delle colonie». La descrizione di questo significato epocale della Rivoluzione d’Ottobre è tratto dagli scritti (1924) di Stalin. Attenzione allora al grossolano errore di considerare lo stalinismo come un capitolo della storia comunista tutto da condannare. Storicamente non è così.
Proprio sulla questione razziale vi era una ideologia diffusa in tutto l’Occidente (ancora oggi presente) che fu praticata da Hitler in tutte le sue estreme e tragiche conseguenze fino al genocidio di cinque milioni di ebrei, di rom, di omosessuali e di dissidenti politici. Ma anche il “democratico” Churchill coltivava l’idea reazionaria, rilevata recentemente da autorevoli giornali inglesi come “The Guardian”, della sterilizzazione coatta dei vagabondi, degli oziosi e dei criminali, considerati tutti dei barbari incapaci di inserirsi nella società. È una idea che ricorda certe uscite di Salvini, che non è ritenuto a sinistra un democratico come Churchill. E pure Franklin Delano Roosevelt accarezzò per qualche tempo un progetto radicale brutale: «Dobbiamo essere duri con la Germania e intendo il popolo tedesco, non soltanto i nazisti. Dobbiamo castrare il popolo tedesco o trattarlo in modo tale che non possa proprio più continuare a riprodurre gente che voglia comportarsi come nel passato». Chissà perché idee di imbarbarimento della politica portate avanti da “sinceri democratici” siano state cucite addosso solo a Stalin: questa non è storia ma manipolazione della storia!
La verità storica è che il razzismo e le discriminazioni razziali sono stati fenomeni legati allo sviluppo degli Stati liberali coloniali e riproposti ferocemente nel nuovo mondo, in particolare negli USA, con il genocidio delle popolazioni indigene e con la tratta degli schiavi africani per attuare una economia schiavista. Questa politica non è stata condotta solo nel passato, ma anche in tempi a noi più vicini Theodore Roosevelt discutendo sui pellerossa osservava: «Non arrivo al punto di credere che gli indiani buoni siano soltanto quelli morti, ma credo che nei confronti di nove su dieci sia così; d’altronde non vorrei indagare troppo a fondo nemmeno sul decimo». È quindi sconcertante e filisteo l’atteggiamento di chi, nel considerarsi l’erede del “democratico Occidente”, demonizza Stalin. E a chi si accoda a sinistra alla sua demonizzazione suggerisco invece una riflessione diversa, non meno dura, sullo stalinismo. Suggerisco una critica dal punto di vista marxista.
Certamente sia l’opera di Marx sia quella di Lenin sono state drasticamente semplificate e distorte da Stalin. Con l’esemplificazione e la distorsione ha posto “la pietra angolare” del marxismo-leninismo. Per Engels (e soprattutto per Lenin) il materialismo dialettico era un terreno di ricerca, il materialismo dialettico staliniano, attraverso un processo di assolutizzazione, si affermò invece come ideologia ufficiale di Stato (successe la stessa cosa in Francia con la repubblica giacobina); ciò rese più difficile lo sviluppo creativo del pensiero marxista. Il corpus del marxismo-leninismo, come concezione fissa e dogmatica del marxismo, agì da freno, se non addirittura da blocco dell’indagine per la comprensione della società contemporanea. Sono tra quelli che pensano che ci fu una terribile frattura tra Lenin e Stalin, le cui conseguenze stiamo ancora pagando. Ma non è vero che Stalin fosse, come molti sostengono, un rozzo, al contrario fu capace di costruire un sistema teorico, il marxismo-leninismo, che solo in parte derivava dalle opere di Marx, di Engels e di Lenin. Era la sua “visione del marxismo”, per questo più che marxismo-leninismo bisognerebbe chiamarlo con il nome del suo fondatore: stalinismo. Stalin ha contribuito in termini decisivi a fissare la Rivoluzione d’Ottobre come un modello da imitare e non come uno straordinario evento. Vi era una spinta storica, come si è visto, oggettiva a trasformare l’Ottobre in un modello e non in un momento significativo e importante della formazione storica del socialismo, alternativa alla formazione storica della borghesia. Ma non vi è dubbio che Stalin abbia svolto un ruolo soggettivo di enorme importanza per affermare esclusivamente tale modello.
Ora qui non mi interessa svolgere una approfondita riflessione su Stalin, una figura contraddittoria che ha segnato un’epoca della storia del movimento comunista. Alcune sue intuizioni sono state lungimiranti, come quella del socialismo in un solo paese o la elaborazione di una teoria dello Stato pur discutibile, e ha dato prova di sagacia tattica con il trattato di non aggressione fra il Reich e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, comunemente noto come patto Molotov-Ribbentrop (3). Ma la teoria dello Stato era un tema del tutto assente dal marxismo, come ho già sottolineato, e non si dica che tale riflessione è contenuta in “Stato e rivoluzione” di Lenin, un saggio astratto e privo di concretezza, tra l’altro incompiuto, proprio perché lo stesso Lenin non sentì mai l’esigenza di concluderlo. Scrisse interrompendolo: «Ho da fare cose più importanti, fare la rivoluzione». Evidenzio solo un aspetto che ritengo rilevante. Il marxismo-leninismo non fu una canonizzazione dettata esclusivamente dall’esigenza di Stalin di fornire al giovane Stato sovietico una ideologia chiara, facilmente comprensibile, di riferimento per grandi masse popolari. Questo è un argomento sviluppato da moltissimi storici e quindi non ci torno sopra. A mio avviso vi era anche un’altra necessità come premessa alla prima esigenza, ma dagli storici non sufficientemente sottolineata. Il marxismo nel corso della sua storia non è mai stato, fin dalle origini, un corpo teorico univoco, coerente e compatto. Diverse sono le discrepanze, i salti logici non sempre dialettici.
Occorre quindi togliersi dagli occhi quei «pesanti occhiali ideologici», per dirla con Luporini, di un’idea rivoluzionaria d’interpretazione del presente dato dall’ideologia, cioè da un già scritto. Mi pare, a riguardo, che sia stato Antonio Labriola il primo a introdurre la distinzione tra ideologia e dottrina (nel senso di teoria). Che l’ideologia sia propedeutica alla formazione e allo sviluppo del senso comune che a sua volta è alla base della formazione storica del socialismo è incontestabile, ma è altra cosa dalla teoria, che è analisi e ricerca. Indubbiamente la teoria si nutre, tramite lo storicismo (4), sia della formazione storica del socialismo sia dell’ideologia, la quale però non deve mai divenire una religione con tutti i suoi dogmi. Pertanto la teoria, per essere efficace nel lavoro di ricerca non deve farsi condizionare dai vincoli ideologici. È chiamata a definire, non prescindendo dalla realtà data, una dottrina rivoluzionaria, una dottrina per la trasformazione.
Questa dovrebbe essere la relazione corretta tra ideologia e teoria, l’una ha bisogno dell’altra, ma operano su due campi distinti: la prima sul terreno immediato, quello prevalentemente politico, la seconda su quello dell’indagine e della ricerca, proprio per dare strumenti nuovi di interpretazione della realtà, cioè per dare vigore e linfa proprio all’azione politica. Tra formazione storica del socialismo e teoria vi deve essere pertanto un rapporto dialettico in costante sviluppo. Un rapporto che muta e con esso muta l’ideologia con gli adeguamenti e gli aggiornamenti teorici. Il tema del rapporto tra ideologia e teoria sarà, dopo Labriola, ripreso e sviluppato da Gramsci, per divenire un’acquisizione fondamentale del marxismo. Insomma, la complessa opera di Marx deve essere considerata un laboratorio epistemologico dal quale attingere per interpretare la realtà, il presente, e non per cucire un vestito su misura all’attualità, né un quadro di criteri fissi, né semplici e comode conferme.
Quando si trasforma il pensiero di Marx in un sapere stabilito ed eterno si fa banalmente retorica ideologia, come fece Stalin che impedì così lo sviluppo dell’indagine teorica. Oggi il dramma della sinistra in Europa è che non è ideologica (ha per la gran parte sposato la tesi del superamento delle ideologie) e quando alza una bandiera ideologica lo fa alzando una bandiera di altri tempi. E in entrambi i casi non ricerca una teoria per la trasformazione. È una sinistra che nel suo insieme non mostra interesse per una strategia rivoluzionaria. Semplicemente è niente, non esiste o è marginale. I modestissimi dati elettorali non sono un accidente della storia, ma il risultato prima di tutto della sua nullità sul piano teorico-politico, senza avere per altro una ideologia credibile di supporto, se non paradossalmente quella dell’ideologia della democrazia e dell’alternanza.
D’altronde occorre sempre rammentare che tutti i più grandi esponenti del marxismo, a iniziare da Marx, sono stati dirigenti e teorici rivoluzionari del partito operaio e dei lavoratori e molti loro scritti risentono dell’esigenza di imprimere al movimento una direzione politica, nella fase concreta in cui si svolgeva in quel momento la lotta di classe. Non elaboravano le loro teorie chiusi tra quattro mura o nelle Accademie, nelle Università o nei circoli culturali. Non erano degli intellettuali di professione, ma dei «rivoluzionari di professione», come precisa bene Lenin. Ecco, mi pare, che Stalin, una volta conquistato il potere, abbia voluto mettere “ordine nel marxismo” con un sistema lineare chiuso, negando e condannando qualsiasi aspetto teorico non funzionale al modello di socialismo dell’Unione Sovietica. Ha fissato il modello ideologico e ne ha delineato i confini ponendosi come custode del corpus dottrinario. Non si manifesta come artefice, il suo nome non è infatti inserito tra il fondatori del nuovo pensiero proletario, ma chiunque abbia tentato di andare oltre i confini stabiliti, senza la sua preventiva autorizzazione, è andato incontro alla scomunica, alla marginalizzazione politica se non addirittura alla liquidazione fisica. E questa ideologia costruita da Stalin è sostanzialmente rimasta in piedi e fatta propria dal movimento comunista fino alla metà del Novecento, anche perché dopo la morte di Stalin il gruppo dirigente del Pcus non è stato in grado di fuoriuscire da questo corpus dottrinario e quando lo ha fatto con Gorbaciov ha gettato via il bambino con l’acqua sporca.
Tentativi di riaprire una discussione
Di tutto ciò la storiografia marxista non ha discusso nel recente passato, ha preferito rimuovere l’insieme di queste questioni. Il corpus dottrinario del marxismo-leninismo ha di fatto – lo ripeto – impedito lo sviluppo di una discussione teorica. Considero questo aspetto dello stalinismo molto più grave dei crimini e degli inaccettabili metodi di lotta politica di cui si è macchiato. Solo nell’ultimo scorcio della fine del secolo vi è stata una significativa ripresa della ricerca marxista, in cui però il ruolo degli europei è stato scarso. Una ripresa avvenuta a seguito di esperienze interessanti, positive, di massa, realizzate in altre parti del mondo, che non a caso hanno coinciso con l’avvento della fase storica del multipolarismo. La discussione su questi temi si sarebbe dovuta affrontare invece negli anni ‘60 all’interno di tutta la sinistra per capire come riavviare una sua ricomposizione tre le due anime, quella socialdemocratica e quella comunista, in quanto le ragioni storiche della loro divisione erano superate. In Italia la questione fu posta da Giorgio Amendola con la proposta del partito unico della sinistra tra Pci e Psi, in quanto riteneva sorpassata la scissione del ‘21. La proposta di Amendola fu caldeggiata da Luigi Longo, ma incontrò forti resistenze sia nel Pci sia nel Psi, così il dibattito non decollò e si consumò in una brevissima stagione. Vi furono anche autorevoli dirigenti della socialdemocrazia, come Willy Brandt, che tentarono di riannodare un filo unitario, ma anche in questo caso non si fece molta strada. L’ultimo tentativo significativo fatto in Italia fu quello di Armando Cossutta e di Gianmario Cazzaniga con la loro mozione “Per una democrazia socialista” al XIX Congresso del Pci, quello della svolta di Occhetto. Da notare che il titolo della mozione rammenta il nome che si diedero gli ex comunisti della Rdt dopo la riunificazione delle due Germanie: Partito della democrazia socialista.
Della mozione Cossutta-Cazzaniga poco si è discusso (5). A differenza della mozione di Ingrao e di Tortorella tutta tesa alla difesa del Pci e degli orizzonti comunisti; la mozione scritta da Cazzaniga puntava a una analisi delle trasformazioni del capitale e di come il nuovo partito si dovesse attrezzare per affrontarle. Non poneva quindi la questione della difesa del Pci, ma metteva l’accento sulla natura del partito che si intendeva costruire. Un partito né socialdemocratico né liberaldemocratico, ma che fosse in grado di condurre una battaglia per la trasformazione nell’ambito di un processo unitario dell’insieme della sinistra. E non è un caso che la II mozione del No abbia concluso il suo percorso nel “gorgo” di Ingrao o nell’“Associazione dei comunisti democratici” di Tortorella. E se proprio devo dirla tutta, penso che la posizione di Ingrao avesse un senso, anche se non l’ho mai condivisa, mentre il “comunismo democratico” di Tortorella non l’ho mai capito né sul piano teorico né su quello politico. Occorre inoltre sottolineare che in Europa è riuscita, ma solo in parte e con risultati inadeguati, l’esperienza della Linke in Germania promossa dagli ex comunisti della Rdt, dalla corrente di sinistra della Spd di Oskar Lafontaine e da un gruppo di sindacalisti.
Le amenità della sinistra
D’altro canto non bisogna dimenticare che la storia del movimento rivoluzionario ha avuto diverse fasi: giacobini, socialisti, comunisti e movimenti nazionali di liberazione. Nessuno si sognerebbe oggi di costituire un partito giacobino anche se assolutamente non si disconosce il suo ruolo fondamentale nella Rivoluzione Francese. Non vedo perché tale scelta non possa e non debba essere fatta pure per quella che è stata la storia e l’esperienza del movimento comunista. Per questo trovo che siano delle amenità quelle posizioni portate avanti da gruppi composti da un esiguo numero di attivisti che propongono la rifondazione di un partito comunista (a cui in passato anch’io ho militato, ma almeno quel Prc che ho contribuito a fondare aveva la capacità di fare un po’ di massa critica), o la rinascita e il rilancio del Pci, senza per altro conoscerne la storia e il bagaglio teorico e politico, o promuovono l’unità dei comunisti, oppure si ostinano ancora ad attestarsi sul marxismo-leninismo o sulle diverse varianti del marxismo-trotskista.
Anche dalle culture post ‘68 mi pare che non venga niente o poco di buono. Ne scaturisce un orientamento che si richiama alla cultura delle differenze, viste come inedite forme di antagonismo, o al pensiero libertario come esaltazione dei diritti dell’individuo tramite il quale dischiudere un orizzonte socialista. Un orientamento che conduce analisi sociologiche, solo sovrastrutturali e quindi politicistiche, per poi trasformarle in proposta politica, o che rivolge la sua attenzione prevalentemente alla questione ambientale. Queste tendenze promuovono movimenti che s’intrecciano tra loro, ma in ultima analisi sorgono prevalentemente dalla crisi dello storicismo e dalla perdita di identità di consistenti settori della borghesia. Non è un caso che i verdi raggiungano i loro maggiori successi elettorali nei paesi dove la borghesia è molto forte e quasi sempre la loro collocazione parlamentare è di collaborazione, anche governativa, con forze liberali e centriste e spesso, come in Germania sono atlantisti.
Non nego l’importanza di tale orientamento culturale figlio del ’68, nonché la sua importanza nel sensibilizzare l’opinione pubblica su alcuni grandi temi, ma ha il limite di non porre mai la centrale questione del conflitto capitale-lavoro. Per questa ragione “il popolo bove” (uso tale espressione in termini provocatori ovviamente), che ha priorità più impellenti, non lo segue in queste battaglie e quando non si riconosce nella sinistra, perché questa non fa il suo mestiere, sceglie altre strade: quella del populismo, del sovranismo e della reazione di estrema destra.
La costruzione di un partito con caratteristiche di massa della sinistra non può che avvenire in un rapporto molto stretto con il movimento reale dei lavoratori, quindi con le sue attuali lotte sindacali di resistenza, anche accettandone, quando non si hanno alternative, le proposte minimali. La sinistra italiana mi pare una costellazione di gruppi guidati da dirigenti, che quando non sono settari sono ideologi con la testa chissà dove, ma non sulla realtà, non sui processi in atto, non sulle contraddizioni sociali che scaturiscono dal capitale. O peggio ancora sono frammenti di ceto politico protesi a realizzare accordi e intese con il Pd, un partito che ormai ha compiuto la sua mutazione genetica dopo la fusione a freddo dei Ds con gli ex democristiani. Questa sinistra ha come unico collante l’obiettivo di ritagliarsi un modestissimo e ininfluente spazio nelle istituzioni. So che con questi miei giudizi duri appaio anomalo, isolato, inattuale rispetto al dibattito molto litigioso che c’è a sinistra. Ma inattuale non sta per vetusto e superato, significa semplicemente che la questione non è all’ordine del giorno. Ciò che è inattuale oggi può divenire attuale domani.
Non voglio apparire vanitoso e presuntuoso nel paragonarmi ad Antonio Labriola che decise, nell’agosto del 1892, di non partecipare al Congresso di fondazione del Partito dei lavoratori che dopo un anno si trasformò in Partito socialista italiano. Labriola motivò la sua non adesione in una lettera inviata a Filippo Turati nella quale scriveva: «Siete andati a Genova con l’idea tradizionale di abbracciare un unico programma elastico e ambiguo, legalitari e antilegalitari, astensionisti e mazziniani». Egli denunciava il fatto che il neonato partito era privo di una teoria rivoluzionaria. Colse con altre parole il problema che Lenin si porrà e risolverà più tardi: la necessità di una «teoria rivoluzionaria per un partito rivoluzionario». Ecco, nel mio piccolo e senza volermi paragonare a un gigante del marxismo italiano, ho deciso, in questi ultimi anni, di non partecipare a nessuno dei momenti di aggregazione a sinistra, di gruppi tra loro simili, in vista di appuntamenti elettorali. Aggregazioni che sono ben misera cosa a confronto con la fondazione del Partito dei lavoratori, così tanto duramente criticato da Labriola.
Per essere il più chiaro possibile cito uno straordinario passaggio di Palmiro Togliatti tratto da “Il leninismo di Gramsci”, in cui egli insiste molto sulla necessità dei comunisti di avere una teoria della trasformazione, senza la quale il partito rivoluzionario non ha futuro. Scrive Togliatti: «Vi sono in Lenin tre capitoli principali, che determinano tutto lo sviluppo dell’azione e del pensiero; una dottrina dell’imperialismo, come fase suprema del capitalismo; una dottrina della rivoluzione e quindi dello Stato, del potere, e una dottrina del partito. Sono tre capitoli strettamente uniti, fusi quasi l’uno con l’altro e ciascuno di essi contiene una teoria e una pratica, è il momento di una realtà effettuale in sviluppo». Questa citazione di Togliatti mi pare ancora di grande attualità e incisività. Sintetizza i tratti fondamentali del leninismo, ma non in modo astratto e scolastico, ma come metodo per acquisire una visione autonoma della realtà, in mancanza della quale si è subalterni alle classi dominanti, anche quando si alza il tiro con parole d’ordine estremistiche non corrispondenti però a quello che la situazione politica imporrebbe di fare.
Due riferimenti: il Congresso del Pci di Lione e la I Internazionale
Idealmente ho due riferimenti alti: il Congresso del Pci di Lione e la I Internazionale.
Il Congresso di Lione del 1926 non fu importante solo perché il gruppo dirigente del Pci, guidato da Gramsci, pose definitivamente fine alla direzione settaria del partito di Amedeo Bordiga, che era già stato rimosso da Segretario. Questo è l’aspetto conclusivo del Congresso. L’aspetto essenziale è che con le “Tesi di Lione” per la prima volta un partito comunista occidentale ragionava sulle cause della sua sconfitta e sull’avvento del fascismo in Italia. Fu un impegno collettivo teso a condurre un’analisi strutturale del Paese per comprendere come mai il fascismo fosse potuto sorgere e fosse riuscito a conquistare il potere (6). Si definì quale doveva essere il rapporto con il sindacato e soprattutto si delineò, nell’ambito di questo rapporto, la funzione del partito. Non un partito di agitazione e di proclami ideologici, ma un partito il cui ruolo di guida della classe operaia non si sarebbe attuato se non fosse riuscito a dirigere le grandi masse nei loro movimenti reali, ponendosi alla testa e in difesa dei loro interessi economici immediati.
Queste battaglie si svolgono in prevalenza sul terreno sindacale e proprio da questa impostazione quasi banale sorge la natura riformista del sindacato. Ma doveva essere una priorità del Partito comunista la sua attività nel seno dei sindacati, necessaria per stabilire legami di massa. L’obiettivo era di conquistare la direzione del sindacato e tramite esso la direzione della gran parte degli operai e dei lavoratori. Quali formazioni oggi a sinistra sono impegnate in questo lavoro? O peggio, alcuni gruppi conducono il loro impegno sindacale rovesciando la questione con pratiche pan-sindacali, ma così facendo confondono drammaticamente l’attività sindacale con l’attività politica, compromettendole entrambe. Occorre una analisi seria su cosa è oggi il nuovo proletariato per un lavoro di radicamento sociale del partito a iniziare dall’impegno nel sindacato, nella Cgil. La sinistra non può prescindere da questo lavoro come condizione per costruire un partito dal carattere di massa. Ovviamente il lavoro di radicamento nel sindacato si deve accompagnare al lavoro di radicamento territoriale, dove si organizzano gruppi di nuovo proletariato o nascono comitati di scopo per battaglie importanti, come quelle per la casa, per la difesa dei beni comuni, per l’ambiente, ecc. ecc.
L’altro riferimento ideale è la I Internazionale (1864 e 1872-1876) fondata a Londra (Per una ricostruzione storica della I Internazionale vedere la voluminosa opera in due volumi di Gian Mario Bravo “La prima Internazionale”). È un riferimento non per la sua composizione politica simile per molti aspetti al Congresso del Partito dei lavoratori di Genova criticato da Labriola. Al momento della fondazione dell’Aio-Associazione internazionale degli operai, vi erano tendenze di ispirazione oweniana, gruppi di esuli politici mazziniani, proudhoniani. La I Internazionale fu pertanto l’insieme di tutto questo e di molto altro ancora, fu un fenomeno complesso e variegato non soltanto per la sua diffusione geografica, ma anche per la sua capacità di coinvolgere e far cooperare forze politiche e componenti filosofiche critiche della società di allora. Per questo vi aderirono figure come Mazzini, Bakunin, Lassalle, Blanqui e Garibaldi. Lo slogan dell’Internazionale “sole dell’avvenire” fu proprio coniato “dall’eroe dei due mondi”.
L’aspetto rilevante della I Internazionale è che fu una tappa fondamentale nel processo di costruzione teorica e organizzativa del proletariato. Nell’Aio confluirono senz’altro diverse componenti che si affrontarono e si confrontarono l’una con l’altra su tesi e modi di concepire la lotta sociale, ma tutte le componenti erano di matrice proletaria, i suoi associati erano prevalentemente operai, ecco perché, nonostante le visioni differenti, la I Internazionale fu portatrice di una proposta nuova e nel contempo – questo è l’aspetto che voglio sottolineare – promosse una forma altrettanto nuova di organizzazione del proletariato sulla base delle modalità e delle esperienze che si erano fatte nei singoli paesi. L’Aio era una associazione estremamente concreta, ma con lo sguardo fortemente rivolto verso il domani. Aveva come punto di vista il presente, cioè la condizione in cui si trovava la classe operaia, ma guardava con intensità al futuro. Fu il primo grande tentativo nella storia delle classi subalterne di concepire per l’avvenire una grandiosa edificazione di società e anche se questa edificazione di società non trovava nell’immediato uno sbocco politico, rappresentava comunque un momento non improvvisato ma organizzato di lotta sociale rivoluzionaria.
Ritorno a Marx?
I due fattori chiave che hanno caratterizzato la I Internazionale sono stati il principio dell’organizzazione su base di classe e l’internazionalismo che faceva fare alla lotta dei lavoratori un vero salto di qualità rispetto alle prime embrionali forme di resistenza e di difesa dei diritti del lavoro. Ovviamente avere la I Internazionale come punto di riferimento ideale non vuol dire, per quanto mi riguarda, un ritorno a Marx, il quale si fece beffa di tutti coloro che chiedevano, in polemica con Hegel, di tornare a Kant e persino ad Aristotele. Se si è sostenitore, non a chiacchiere, della concezione materialistica di Marx, non si deve mai rimuovere la tesi secondo cui la teoria si sviluppa a partire dalla storia, dalla materialità dei processi. Il ritorno a Marx è quindi un’idea astratta se non addirittura religiosa. Mi rammenta il desiderio di ritorno alle prime comunità cristiane di certi cattolici. Un ritorno a Cristo in quanto la Chiesa, quella fondata da Paolo e poi organizzata dai Padri della Chiesa fino a come storicamente si è formata, ha tradito il messaggio del figlio di Dio. Auspicare un ritorno a Marx è di fatto proclamare l’estraneità della sinistra – e di fatto è così in Europa – a tutte le vicende storiche del Novecento, dalla Rivoluzione d’Ottobre in poi. Si contrappone Marx all’insieme di questi avvenimenti considerati fallimentari, insomma come altra cosa, profondamente diversa, dal suo pensiero. Si fugge su mitici lidi indefiniti. E come i cattolici, si apprezzano solo quelle figure del movimento rivoluzionario considerate dei martiri, come la Luxemburg, Che Guevara e Gramsci, non l’azione politica dispiegata collettivamente da Marx in poi da tanti uomini e donne in carne e ossa. La storia è ostinatamente rimossa da questa sinistra. Si esalta acriticamente il pensiero di Gramsci, contrapponendolo a Togliatti, a Lenin (e ovviamente a Stalin), dimenticando che nel già citato articolo “La rivoluzione contro il Capitale” egli solidarizza con la Rivoluzione d’Ottobre contro i menscevichi e i socialdemocratici che lanciavano meccanicamente la parola d’ordine di un ritorno a Marx. Della ricostruzione storica non vi è traccia nella religiosa proposta di un ritorno a Marx. Per questa sinistra pare del tutto superfluo interrogarsi sui processi storici, talmente superfluo che è ormai senza memoria storica. Con il religioso ritorno a Marx (ma sempre di più questo ritorno sta a significare metterlo in soffitta) si gettano nella pattumiera non solo oltre cento anni di storia, ma soprattutto la sua concezione materialistica. Il riferimento alla I Internazionale non è dunque un tornare alle origini, bensì un richiamo ideale a ciò che si dovrebbe fare oggi per andare avanti, iniziando a riannodare i processi storici così come si sono determinati.
Per il Partito del Lavoro, un “nuovo inizio”
Ecco perché per la ricostruzione della sinistra non propongo di ripartire da partiti legati alle esperienze della II Internazionale o dell’Internazionale comunista. Il mio riferimento è la I Internazionale, facendo però tesoro di tutte le esperienze storiche, in particolare dalla lezione che ci viene dal III Congresso del Pci di Lione. Non si tratta naturalmente di ricostituire una nuova Internazionale, ma di stabilire un insieme di rapporti e di relazioni unitarie non solo su scala europea ma mondiale e in quest’ambito autonomamente procedere contestualmente con la formazione di partiti con le loro specificità. E non vi è dubbio che in Europa tale specificità è in primo luogo data da una presenza abbastanza solida del movimento sindacale, pur con i suoi limiti e contraddizioni. Quindi, almeno in Europa, la costruzione di un nuovo soggetto politico della sinistra deve affondare le radici nella realtà attuale, prima di tutto nel mondo del lavoro che i sindacati organizzano, con la consapevolezza di andare oltre, cioè di intercettare l’insieme di quel nuovo proletariato sorto dai processi di proletarizzazione determinati dal capitale. Dar vita insomma a un soggetto espressione dell’intero “mondo dei lavori”: un grande Partito del Lavoro che, dopo le rovinose sconfitte della seconda metà del Novecento e tenendo conto delle esperienze storiche, sia un “nuovo inizio” della lotta per il socialismo.
È un impegno di lunga lena? Senz’altro. Per questo è necessario un eccezionale lavoro per il radicamento sociale del partito e nel contempo compiere un grande sforzo collettivo di ricerca teorica senza la quale diviene difficile precisare e indicare obiettivi concreti, anche intermedi, su cui impostare un’azione politica, possibilmente la più unitaria possibile. C’è bisogno di luoghi di confronto e di dibattito, di centri di ricerca e di riviste autorevoli (non le solite riviste culturali che lasciano il tempo che trovano). Non è richiesto solo un mero impegno organizzativistico, ma una partecipazione collettiva centrata sul rapporto teoria-prassi. Pertanto, come fece Lenin con il “Che fare?”, è necessaria una politica dell’organizzazione che risponda alla necessità del momento. Inutili sono quei dibattiti inconcludenti e molto astratti sul tipo di partito di cui si avrebbe bisogno in un lontano domani, come se il processo della sua costruzione fosse compiuto (e d’altronde si può mai considerarlo compiuto?). Il resto, anche le scadenze elettorali, per le quali si deve comunque costruire una proposta, sono momenti che raramente e solo in determinate situazioni offrono prospettiva, sono il più delle volte gocce che scivolano sullo specchio. Sono gocce che lasciano una fastidiosa piccola scia che sporca lo specchio. Lo rendono opaco e così riflette un’immagine sfuocata della realtà in cui non si distinguono i contorni e i dettagli. Non si ha dunque una visione chiara, non si coglie il cuore del problema. Chi non si vuole battere contro l’ingiustizia sociale a sinistra? Perciò i contorni non sono contorni, i dettagli non sono dettagli, ma sono il modo con il quale costruire legami di massa. La proclamazione di intenti riesce solo a schizzare lo specchio sporcandolo. Ma non si va oltre, così non s’interpreta l’XI tesi di Marx su Feurbach: «I filosofi hanno soltanto diversamente interpretato il mondo, ma si tratta di trasformarlo».
Bisogna però anche contrastare tutte quelle tendenze che hanno appiattito il marxismo sull’anarchismo, che ha determinato conseguenze politiche il cui sbocco raramente è stato di sinistra. Il giovane Marc Bloch (grande storico francese trucidato durante la resistenza dai tedeschi) si attendeva dai Soviet la «trasformazione del potere in amore». Era questa una idea non solo del giovane storico francese. Nella Russia sovietica esponenti del Partito socialista rivoluzionario proclamavano che «il diritto è oppio per il popolo». Così si radicalizzava l’utopia e diveniva complicato il passaggio a una normalità costituzionale socialista, in quanto veniva bollata come borghese. «L’idea di Costituzione è un’idea borghese», sostenevano con vigore. Addirittura molti bolscevichi erano contrari al denaro, considerato la precondizione di un ritorno al capitalismo. Prendeva piede, tramite un binomio “marxismo-anarchismo”, un internazionalismo astratto, quasi religioso, che tendeva a liquidare come tendenze controrivoluzionarie le diverse identità nazionali in nome di un universalismo che però non era in grado di rispettare e valorizzare le libertà. Molti di questi fenomeni esploderanno poi in modo non sempre controllato nella guerra civile di Spagna. Anche nella storia recente dell’Italia, infantili visioni estremistiche che si richiamavano alla purezza rivoluzionaria, hanno confuso l’azione puramente terroristica con un’azione di guerra come l’attentato a Roma di via Rasella. E non mi riferisco solo ai brigatisti o ad altri gruppi terroristici, ma anche a chi non stava «né con le Br, né con lo Stato», per giustificare «i compagni che sbagliano».
Nel socialismo contemporaneo l’utopia dell’attesa messianica dell’estinguersi dello Stato, delle identità nazionali e della funzione della moneta, sono stati finalmente superati anche se sono aspetti che permangono forti in settori di sinistra molto minoritari di un certo mal digerito marxismo. E spesso sono tendenze critiche che partono da sinistra per avere però uno sbocco politico a destra, andando ad ingrossare il pensiero liberale. Come nel caso di chi considera la scelta di campo solo un conflitto geopolitico tra Stati. Questa posizione in Italia è espressa da orientamenti radicali di diversa matrice che in comune hanno la totale rimozione della nozione di imperialismo, rimozione che li accomuna, guarda caso, alle socialdemocrazie. Non si coglie l’insegnamento di Lenin che giustamente sosteneva che la lotta antimperialista è il terreno più avanzato dello scontro di classe, della lotta per il socialismo. Non si tratta di fare della pura accademia geopolitica, come è nell’impostazione di riviste e centri di ricerca liberal, ma di organizzare la lotta a un livello alto contro il capitale. Non a caso la sinistra di tutto il mondo è critica con la sinistra europea, la rimprovera di non essere affidabile nella dura lotta contro l’imperialismo. Una sinistra che quando è ancorata a qualche principio marxista parla a vanvera della lotta di classe, della contrapposizione capitale-lavoro e però ha amputato dai suoi ragionamenti la radice della questione: il ruolo dominante e imperialistico del capitale finanziario. Dunque è sulla funzione dello Stato e di conseguenza sullo scontro tra l’imperialismo del capitale finanziario e il complesso degli Stati a orientamento socialista o di nuovo industrializzazione o dove vige il capitalismo monopolistico di Stato che avviene, nell’attuale fase, il durissimo confronto, che piò comportare anche conflitti bellici, come in Ucraina .Altro che analisi geopolitica!
Lo sviluppo del pensiero socialista, cioè della formazionine in questa nuova fase storica del socialismo, ha messo definitivamente in discussione il mito della estinzione dello Stato e del suo assorbimento nella società civile. Gramsci sosteneva giustamente che la società civile è una forma dello Stato e che l’internazionalismo non vuol dire misconoscimento delle peculiarità e delle identità nazionali, le quali continueranno a sussistere anche col socialismo, come il mercato, che sarebbe stato meglio definire «mercato determinato» piuttosto che «mercato in astratto». Una riflessione, questa di Gramsci, che conferma quanto egli fosse lontano dalla teoria marxiana dell’estinzione dello Stato con il socialismo. Una riflessione su cui nel dopoguerra si baserà Togliatti per una teoria dello Stato, diversa dal modello staliniano, adatta alle caratteristiche dell’Italia (7).
È curioso dover annotare e sottolineare che proprio le due fragilità del pensiero di Marx e di Engels, quella della teoria della crisi finale del capitalismo, e quella della teoria dell’estinzione dello Stato, invece di segnare la crisi definitiva del marxismo lo hanno, in questo nuovo millennio, fortemente rilanciato, valorizzando l’insieme delle altre tesi enunciate da Marx, che hanno trovato piena conferma nelle contraddizioni del mondo contemporaneo.
Le esperienze rivoluzionarie degli ultimi trent’anni indicano una strategia nuova: la questione della critica al capitale non è risolta nell’ambito di una visione deterministica delle contraddizioni che sorgono al suo interno; ci sono e sono insanabili, ma non è questo che conduce a precipitazioni, come la storia insegna. È necessaria una forte soggettività per la trasformazione (rivoluzionaria) per perseguire il trapasso da una società dominata dal capitale a una società socialista. È questa la lezione più importante di Lenin e di Gramsci: il recupero della dialettica hegeliana finalmente emancipata da ogni incrostazione meccanicistica, deterministica ed economicistica da un lato, idealistica e politicistica dall’altro lato. La formazione storica del socialismo ha imparato dal passato, dal Novecento. Un processo di transizione verso il socialismo si realizza non con l’estinzione dello Stato, bensì con il suo rafforzamento, in ultima analisi con la costruzione di uno Stato nuovo, strumento fondamentale per governare i processi di mutazione. Allora senza nessuna esitazione occorre riproporre come questione centrale la funzione dello Stato messo in discussione, annichilito on Occidente dal capitale finanziario.
Nel condurre un lavoro di analisi e di ricerca teorica e nel contempo fornire indirizzi su obiettivi concreti di lotta possibili (avviando in tal modo il processo di costruzione lungo e complesso di un partito rivoluzionario) occorre avere un punto cardinale di riferimento: la lotta per un nuovo ordine mondiale multipolare, che la guerra in Ucraina mostra in tutta la sua grande portata. Una lotta che non è un pranzo di gala, ma è lastricata di lacrime e sangue. Attenzione però. La lotta per un mondo multipolare non è lotta antimperialista, ma contro la guerra di un Occidente che non rinuncia, anche con le armi, al controllo sull’intero pianeta. Nello schieramento per affermare questo nuovo ordine mondiale vi sono paesi e forze che non sono né comuniste, né rivoluzionarie e spesso neppure di sinistra. È uno schieramento composito, unito nella lotta contro l’Occidente e il capitale finanziario, unito insomma contro la volontà Usa di riproporre il suo dominio sul mondo. Solo così d’altronde si spiega l’alleanza che si è determinata tra paesi profondamente diversi tra loro. È un terribile errore strategico, che genera disastri, sovrapporre la lotta per un mondo multipolare alla lotta antimperialistica che è una peculiarità della sinistra rivoluzionaria. La lotta antimperialista va condotta come altro momento rispetto a quello oggi fondamentale per un nuovo ordine mondiale multipolare, con la consapevolezza che la realizzazione di questo ordine riapre una prospettiva socialista anche in Occidente. È un concetto semplice che una parte consistente della sinistra europea non coglie, imbevuta com’è del pensiero liberale.
Concludo con una bella riflessione di Galvano Della Volpe tratta da “Teoria marxista dell’emancipazione umana”: «Il Marx che si troverà in queste pagine (…) è, o vuol essere, un Marx moralista e filosofico (…) il teorico dell’emancipazione dell’uomo in genere, del borghese dunque oltre del proletario; è questa teoria morale, filosofica per il suo carattere unitario e generale che si dica, questa teoria dell’emancipazione umana (…) la risposta, che scaturisce travagliata ma potente, sicura, dai testi considerati, a qualcuno almeno dei quesiti fondamentali intorno all’uomo nuovo e ai suoi doveri e ideali; la risposta principalmente al quesito: su che si fondi l’esigenza del lavoro primo bisogno dell’esistenza, l’esigenza etica la più rivoluzionaria dopo il passaggio cristiano dell’amore. Tale risposta (…) è appunto l’inizio di una trasmutazione di tutti i valori che è riuscita a Marx mentre è fallita al Nietzsche in quanto pensatore ancora precristiano. Onde, con la sua filosofia sul lavoro, il marxismo supera sia l’illuministico moralismo di Rousseau e Kant che l’immoralismo nietzschiano: la vecchia cultura nel suo complesso, insomma, in tutte le sue parti, anche le più contrastanti fra loro (…) Marx con la sua filosofia, liquida il cristianesimo tradizionale dogmatizzato e isterilito, sia confessionale che laico (…) senza perdere il sostanziale insegnamento cristiano dell’uguale dignità di ogni umano individuo, anzi sviluppando questo insegnamento al massimo concepibile scientificamente: perché gli riesce insomma di conservare il cristianesimo rovesciandolo, di portare veramente in terra, nel mondo, la speranza cristiana dell’umana fraternità: donde il significato unico, incomparabile dell’ateismo marxista».
































Add comment