Il settantismo malattia senile del reducismo
di Gigi Roggero
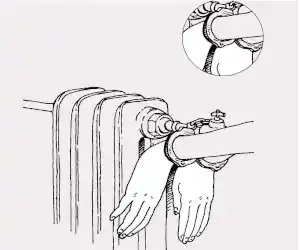 Una decina di anni fa affrontavamo la questione della «generazione scomparsa», composta da quei militanti «di movimento» nati negli anni Settanta. Da quel decennio, più ancora che indiscutibili ricchezze, tali militanti hanno ereditato innanzitutto un complesso: «quello dell’essere arrivati tardi». La fonte di ispirazione è diventata mitologia, i rapporti intergenerazionali si sono non di rado trasformati in accettata subalternità pedagogica, la venerazione di una memoria iconica è sfociata nel torcicollo politico, cioè nell’incapacità di guardare alle complessità del presente per fuggire in un passato spesso caricaturale. D’altro canto, molti di coloro che hanno vissuto politicamente quel decennio, con il passare del tempo, sono stati vittime della nostalgia canaglia, in primo luogo quella per la trascorsa gioventù: così, anziché mettere al servizio dell’oggi i limiti della loro esperienza, l’hanno trasfigurata in metro di misura della verità, in memorialistica picaresca, o in uno spaghetti western. Come se bastasse lo spirito d’avventura o l’eroismo combattentistico individuale a cambiare le sorti di un mondo senza tempo, indipendentemente dal contesto storico e dalle composizioni sociali. Questo articolo spiega come la necessità di lottare contro la dominante rimozione degli anni Settanta sia stata sublimata nell’ideologia del «settantismo». E in alcuni ambienti la toppa è stata forse peggiore del buco.
Una decina di anni fa affrontavamo la questione della «generazione scomparsa», composta da quei militanti «di movimento» nati negli anni Settanta. Da quel decennio, più ancora che indiscutibili ricchezze, tali militanti hanno ereditato innanzitutto un complesso: «quello dell’essere arrivati tardi». La fonte di ispirazione è diventata mitologia, i rapporti intergenerazionali si sono non di rado trasformati in accettata subalternità pedagogica, la venerazione di una memoria iconica è sfociata nel torcicollo politico, cioè nell’incapacità di guardare alle complessità del presente per fuggire in un passato spesso caricaturale. D’altro canto, molti di coloro che hanno vissuto politicamente quel decennio, con il passare del tempo, sono stati vittime della nostalgia canaglia, in primo luogo quella per la trascorsa gioventù: così, anziché mettere al servizio dell’oggi i limiti della loro esperienza, l’hanno trasfigurata in metro di misura della verità, in memorialistica picaresca, o in uno spaghetti western. Come se bastasse lo spirito d’avventura o l’eroismo combattentistico individuale a cambiare le sorti di un mondo senza tempo, indipendentemente dal contesto storico e dalle composizioni sociali. Questo articolo spiega come la necessità di lottare contro la dominante rimozione degli anni Settanta sia stata sublimata nell’ideologia del «settantismo». E in alcuni ambienti la toppa è stata forse peggiore del buco.
Oggi il problema del settantismo riguarda bolle sempre più residuali e anagraficamente connotate, orfane di quello che fu il Movimento (con la maiuscola, portato dell’anomalia italiana) e nello sfarinamento del «noi», che di epoca in epoca esiste solo come prodotto di un processo collettivo.
Tuttavia, tale problema interroga più complessivamente la produzione editoriale e politica di conoscenza sul passato, la necessità di liberarsi dalla memoria per agire nel presente, le possibilità di riallacciare i fili di una storia lunga senza farsi schiacciare dal peso di ciò che non tornerà mai più. O per dirla ancora con Mahler, lasciando l’adorazione delle ceneri a chi non ha più alcun fuoco da custodire. (G.R.)
* * * *
Una dozzina di anni fa uscì un formidabile libro di Sergio Luzzatto, Partigia. Lo storico, a partire da un fugace riferimento contenuto in un suo romanzo, indaga la breve esperienza partigiana di Primo Levi in Valle d’Aosta e il «segreto brutto» a cui fa cenno in quelle pagine. Si tratta dell’esecuzione di alcuni partigiani da parte della loro banda, perché colpevoli di aver rubato della farina a contadini del luogo. Il punto di vista di Luzzatto è chiaro, dall’inizio alla fine: è un punto di vista partigiano, che guida il suo rigore di storico, e proprio perciò non accetta una visione del mondo ispirata ai cartoni animati di Walt Disney. In Partigia l’autore ci vuole restituire la tragica grandiosità dell’esperienza partigiana, fino alla necessità di prendere decisioni spietate in fasi in cui il tempo per farlo è poco e gli sbagli possono costare la sconfitta, la cattura, la vita di tante persone. Ancor di più, vuole reincarnare la storia, cioè demitizzarla. Perché, ci dice, proprio la costruzione del mito della Resistenza è servita alla sua depoliticizzazione, ad archiviarla, a porvi fine, a recidere i possibili legami di continuità con quello che è venuto dopo: la pacificazione democratica.
A sinistra, apriti cielo. Il libro è stato condannato, da alcuni addirittura – affermavano tronfi – senza bisogno di leggerlo. Pesante come un macigno è così istantaneamente arrivata la più grande e inappellabile delle scomuniche: revisionismo storico. Come se la conoscenza storica non fosse, in sé, una continua revisione, ovvero un’interminabile ricerca volta a fare nuova luce non solo sul passato ma innanzitutto sul presente. Tuttavia, si sa, quando si rifiuta la discussione nel nome della scomunica, la politica cede il passo alla teologia. In questo campo, dunque, non possono che esistere categorie morali ed edificanti parabole in cui i buoni sono senza peccato, preda di cattivi assetati di sangue. Il punto di vista si riduce a pura ideologia, cioè a vescica gonfia di aria.
Perché abbiamo perso?
Una sorte analoga è toccata agli anni Settanta. Forse ancora peggiore. Perché quel decennio è stato sottratto al processo storico e stritolato in una tenaglia: dalla parte dei vincitori la condanna, dalla parte dei vinti la mitologia. In entrambi i casi, la rimozione di ciò che è materialmente stato. Icona del male o icona del bene, da maledire o da venerare, gli anni Settanta sono tumulati in una rappresentazione disincarnata e, perciò, politicamente inservibile. Soffermiamoci sulla nostra, di parte, perché quello che fa l’altra possiamo darlo per scontato.
Sia chiaro, a scanso di equivoci. C’è stata una fase in cui probabilmente era importante raccontare gli anni Settanta, sottrarli alla narrazione dominante. Quel racconto, però, è diventato prima discutibile apologia, poi stucchevole nostalgia. Salvo rare eccezioni, ci sono libri scritti da compagni che, dopo averli letti, ti sembra di capire meno di prima. Era tutto bello ed entusiasmante, le cose andavano a gonfie vele, ci si divertiva un sacco ed eravamo fortissimi. E allora, perché abbiamo perso? Di fronte alla complessa durezza della sconfitta, molti hanno preferito imboccare la scorciatoia dell’autogiustificazione: perché il nemico è cattivo, questa resta l’unica risposta. Risposta ancora una volta morale, non politica. Risposta ipocrita, perché l’obiezione è ovvia: perché il nemico avrebbe dovuto essere buono con chi lo voleva distruggere? È come voler vincere la Champions League e lamentarsi se gli avversari te lo impediscono.
Gli anni Settanta della sovversione, come altri periodi storici, dovrebbero essere ripercorsi con un metodo simile a quello di Luzzatto. Reincarnandoli in composizioni di forza storicamente determinate, cioè facendone emergere punti di forza e di contraddizione, ricchezze e limiti, avanzamenti e buchi neri, grandezza e tragedia. Domandandosi il perché delle insorgenze e il perché dei «segreti brutti». Partendo dal fatto che si tratta di una fase conclusa e perciò non ripetibile. È quello che abbiamo provato a fare, ormai un quarto di secolo fa, con Futuro anteriore, il cui sottotitolo non a caso recitava Dai «Quaderni rossi» al movimento globale: ricchezze e limiti dell’operaismo italiano. Non sta a noi giudicarne i risultati, certamente possiamo dire che è stata un’esperienza fondamentale, almeno per chi l’ha fatta: si è trattato di un incontro di generazioni militanti e non di subalterna ammirazione, di analisi critica del passato e non di mera trasmissione di memoria, di riflessione comune sulle discontinuità e non di un grottesco tentativo di riesumare un cadavere.
Restituire Peckinpah al cinema
Nel frattempo dai mitologici Settanta è passato ormai mezzo secolo, lo stesso lasso di tempo che intercorreva dal ’17 al ’68. Se allora la riproposizione del modello di organizzazione bolscevica fu un catastrofico errore, altrettanto possiamo dire oggi di ogni tentativo di riproporre modelli organizzativi che, tra l’altro, al palazzo d’inverno neanche si sono avvicinati. Nel frattempo, soprattutto a partire dagli anni Novanta e con un incremento esponenziale negli ultimi dieci-quindici anni, la letteratura sul leggendario decennio si è moltiplicata. Dal desiderio politico di ripensare e comprendere, si è via via passati alla memorialistica individuale, fino a raccontini grottescamente eroici e picareschi. Insomma, Il mucchio selvaggio è un film straordinario, ma averlo trasformato in un programma politico è stato prima tragico e poi farsesco. E quando la radicalità politica è diventata il folclore del gesto, e la critica delle armi ha cancellato le armi della critica, lì dobbiamo trovare una parte delle ragioni se non della sconfitta, certo del naufragio.
Ecco, tra i limiti di quelle esperienze ci interessano prioritariamente quelli della soggettività. Analizzando, ad esempio, le parabole biografiche dei militanti: da dove vengono e dove sono andati, prima e dopo che quelle parabole si incrociassero in una storia collettiva. Anche in questo caso, è piuttosto inutile cavarsela con giudizi morali, tesi a esaltare la coerenza di chi ha tenuto botta contro il tradimento di chi si è ritirato a vita privata, o ha fatto carriera, oppure – bestemmia delle bestemmie – di coloro che si sono pentiti. Già, perché come è possibile che chi fino a un certo punto veniva ritenuto un affidabile militante di organizzazione, subito dopo sia stato semplicemente liquidato come un debole o un infame, come se nulla avessimo noi a che fare con quella produzione di soggettività? Anche in questo caso vi è all’opera una rimozione, con lo scopo di giustificare le scelte dell’organizzazione, cioè le nostre.
Non vogliamo qui scadere in un becero determinismo, né ripescare sic et simpliciter quel vecchio arnese marxista per cui l’essere determina la coscienza. Però dovremmo partire da una banale constatazione: l’ambiente sociale ha fatto del movimento un polo di attrazione e immaginario. Per consistenti minoranze farne parte è stato come oggi cantare la trap: una cosa figa. Ambiente sociale significa storia, conflitto, processi produttivi e resistenza, dominio e sabotaggio. Allora da questa angolazione sì, sono stati gli anni Settanta a fare i militanti. O meglio, parafrasando qui il Marx del 18 brumaio, i militanti hanno fatto gli anni Settanta, ma non li hanno fatti in modo arbitrario, in condizioni scelte da loro stessi, bensì nelle circostanze che essi si sono trovati immediatamente davanti. In assenza di tale consapevolezza, quel periodo storico diventa una caricaturale epopea di individui coraggiosi e sprezzanti del pericolo. Ma per i rivoluzionari il coraggio è innanzitutto quello della decisione politica dentro le possibilità di una composizione sociale specifica, non è mai il coraggio dei muscoli, delle armi e delle avventure solitarie. Quando ci si dimentica queste cose, anche chi allora non ne ha fatto parte, o peggio ne ha subito le conseguenze, finisce retrospettivamente per esaltare le funeste gesta dei gruppetti combattenti.
Per farla breve: non è un merito aver vissuto gli anni Settanta, non è un demerito non averlo fatto. È pura casualità. E, detto per inciso, ci vuole molto più fegato a essere militanti oggi che allora. Perché è molto più semplice rischiare la galera in tanti che rischiare il ridicolo da soli.
Quant’è bella giovinezza che si fugge tuttavia
Chissà perché molte storie dei reduci su com’era verde la loro valle sono costantemente circondate da aloni di esaltazione adrenalinica, trench di riconoscimento, fumo e alcol, come se la rivoluzione fosse un’eterna gita adolescenziale. Euforia dell’ora, a cui inevitabilmente segue la depressione del poi. E questo poi depresso significa reducismo. Attenzione. Ci riferiamo al reduce come condizione soggettiva e non oggettiva. Non si è reduci, lo si diventa. E quando si diventa reduci, si cessa di essere militanti; più in generale, si smette di pensare e di vivere nel presente. Del resto, quella sindrome si tramanda di generazione in generazione. Il cringe dei discorsi che cominciano con «ai miei tempi» è sempre in agguato: è il rimpianto per la giovinezza perduta, è il livore per chi rivendica la libertà di vivere la propria. Tanto che, negli ultimi anni, la sindrome del centrosocialismo è la piccola continuazione del settantismo con gli stessi mezzi. Non c’è più la nostalgia di una volta, sentenziava Simone Signoret.
La patologia reducista è stata amplificata dai social network. Se un tempo era il bar del paese la sede deputata alle spacconerie dei pescatori sulle dimensioni delle prede, adesso ai settantisti non pare vero di poter combattere la solitudine trasformando facebook in una permanente associazione autogestita combattenti e reduci. Sembra di assistere, quotidianamente, alla piccola riproposizione di un altro gran bel film: Goodbye Lenin. Se lì il protagonista ricostruiva il socialismo in una stanza, qui gli attempati reduci ricostruiscono gli anni Settanta in una bacheca: e avanti di slogan, volantini, foto, ricordi, litigi, polemiche, rotture. Come se nulla fosse cambiato. Come se il tempo si fosse congelato. Anche quando apparentemente parlano o più spesso litigano su ciò che li circonda, altro non è che una proiezione dei fantasmi che abitano le loro menti. E se la realtà se ne infischia, tanto peggio per la realtà. Nel capitalismo delle piattaforme c’è spazio per i terrapiattisti, vuoi che non trovi cittadinanza la bolla dei settantisti?
Per farla finita, con l’articolo e soprattutto con questa sindrome. Nel secolo scorso in Italia c’è stata una grande anomalia, radicata nella forza delle lotte operaie e dei movimenti autonomi degli anni Sessanta e Settanta. È questa anomalia che ha portato, fino a tempi recenti, a parlare di Movimento con la lettera maiuscola. Non una mobilitazione temporalmente delimitata, single issue come si dice nel mondo anglosassone, bensì uno spazio permanente di organizzazione autonoma. Andavate fuori dai confini nazionali e non vi potevano capire. Quell’anomalia è finita, e con essa la lettera maiuscola. I movimenti a venire non avranno alcuna continuità con il Movimento. Ed è bene che sia così.
Il punto siamo noi, qualunque confine vogliate indicare con questa parola che è tornata a essere un generico pronome – perché categoria politica lo diviene solo dentro un processo collettivo. Quel noi è stato frantumato non dalle sconfitte, ma dall’incapacità di analizzarle. Il reducismo è proprio l’essenza del pensiero della sconfitta, perché traveste la solitudine nell’accettazione del presente da patetica agiografia dei bei tempi andati. Finché non ci libereremo della sindrome del settantismo, la nostra capacità di capire, e dunque di agire, sarà tumulata in una cappa di piombo. Sotto quella cappa di memoria stantia e ridicolmente nostalgica, giacciono anche le ricchezze di quei «maledetti» anni Settanta. Per liberare loro e noi stessi, dobbiamo allora liberarci dalla memoria settantista. Proprio quei Settanta, nella loro parte migliore, e l’operaismo ancor prima, hanno produttivamente praticato il nietzscheano elogio dell’assenza di quella memoria idolatrica di cui ci parla Luzzatto. Non c’è rottura possibile, dunque, se non si ha il coraggio di rompere con le sacre icone della nostra storia. Liberarci dalla memoria, infatti, significa aprirci allo stupore del presente. Perché ogni tempo ha i propri immaginari, linguaggi, desideri, pratiche, possibilità. E come dice il poeta, chi non sa dimenticare il suo primo amore non potrà mai conoscere l’ultimo.
Gigi Roggero è il direttore editoriale di DeriveApprodi. Pubblicista militante e curatore, per Machina, della sezione freccia tenda cammello. Ha pubblicato con DeriveApprodi: Elogio della militanza (2016), Il treno contro la Storia (2017), L’operaismo politico italiano. Genealogia, storia e metodo (2019), Per una critica della libertà. Frammenti di pensiero forte (2023); è inoltre co-autore di: Futuro anteriore e Gli operaisti.




 Like
Like 






































Non ho dubbi che la destra sia un nemico, la domanda e', una volta accertato che e' un nemico, l'unica arma sono le pallottole?
lei li vede i risultati delle pallottole?
No?
Eppure sono li, chiari, si chiamano Santi.
E in questi giorni kirk sta diventando beato, poi sara' santo. Indipendentemente da chi lo ha ucciso, forse uno piu' a destra di lui.
La destra ha aperto i canali di comunicazione e beatificazione, gliene frega se kirk lo ha ucciso uno della loro parte, un arcinemico per la sinistra.
I cannoni sull'etere e sui media stanno facendo il loro sporco lavoro. Quale fucile di precisione potrebbe contrastare questi mezzi? Non si possono annullare queste dinamiche a fucilate, queste dinamiche richiedono studio e contromosse studiate. Confesso che io non fare male a una mosca, ma se dovessi essere dell'avviso che bisogna sparare non mi limiterei a pensare alla precisione e tecnica dello sparo, ma anche all'opportunita' e ad altri dettagli della gestione post. Limitarsi a automatismi sei un nemico, ti sparo, significa regalare Santi perche' morto uno ne verra' un altro, spesso peggiore del primo.
I cinesi nella loro saggezza considerano saggio il grnerale che vince la guerra senza combattere o combattendo al minimo.
Si possono vincere conflitti di classe in quel modo? Non lo so, quel che so e' che l'automatismo del duello wester non ha mai regalato rivoluzioni. Le rivoluzioni sono state fucili e testa, soprattutto la testa per usare i fucili o ... non usarli.
Ha soluzioni pratiche? Soldi?
Si, soldi, perche' la destra ne e' piena e usa tutti i mezzi (soprattutto media di tutti i tipi) per diffondere e foraggiare il verbo.
Non credera' che maidan sia nata per generazione spontanea o kirk foraggiasse la sua bella e costosa vita con la paghetta delle offerte.
Questi sono organizzati, nutriti, foraggiati a piene mani e per scopi ben precisi. Se muoiono (di morte innaturale) li santificano e subito sono pronti sostituti e mezzi. Ha visto la tempestivita' dei tromboni Usa che il cadavere di kirk era ancora caldo? ha sentito la madre cristiana?
che a uccidere kirk sia stato uno piu estremista e folle di lui, un groyper.. a chi frega.
Lei come pensa di smontare questa propaganda? con la violenza? A me sembra che armi migliori sarebbero la scaltrezza e la capacita' di impostare e diffondere contro narrazioni con intelligenza, ma anche in modo spregiudicato. Bisogna avere e allevare le teste per farlo e educare le nostre teste a reagire a questo.
Se poi lei pensa che arginare e controbattere alla propaganda e studiare/trovare i mezzi e le forme non sia lotta e della piu feroce ... ok, mi fermo