Il paradigma immunitario
di Rocco Ronchi
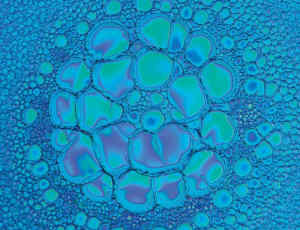 La pandemia ha causato capogiri ai filosofi, a quelli italiani in particolare. Talvolta l’effetto è stato un capitombolo, talaltra un surplus di lucidità e di autocritica intelligenza. Purtroppo le cadute rovinose sono state enfatizzate dai media, con grave disdoro della filosofia che si è così trovata accomunata alle peggiori farneticazioni complottiste, mentre i miglior contributi che il pensiero ha offerto alla comprensione del presente sono stati, come sempre, bellamente ignorati. Va subito detto che il mal di testa non si doveva al fatto che, a causa della pandemia, la filosofia si misurava con qualcosa di nuovo, di inatteso e di stupefacente. La vertigine nasceva piuttosto dal contrario: da un eccesso di conferma dell’ipotesi di fondo intorno alla quale il cosiddetto italian thought si era costituito e grazie alla quale aveva acquisito negli ultimi trent’anni un prestigio internazionale.
La pandemia ha causato capogiri ai filosofi, a quelli italiani in particolare. Talvolta l’effetto è stato un capitombolo, talaltra un surplus di lucidità e di autocritica intelligenza. Purtroppo le cadute rovinose sono state enfatizzate dai media, con grave disdoro della filosofia che si è così trovata accomunata alle peggiori farneticazioni complottiste, mentre i miglior contributi che il pensiero ha offerto alla comprensione del presente sono stati, come sempre, bellamente ignorati. Va subito detto che il mal di testa non si doveva al fatto che, a causa della pandemia, la filosofia si misurava con qualcosa di nuovo, di inatteso e di stupefacente. La vertigine nasceva piuttosto dal contrario: da un eccesso di conferma dell’ipotesi di fondo intorno alla quale il cosiddetto italian thought si era costituito e grazie alla quale aveva acquisito negli ultimi trent’anni un prestigio internazionale.
L’ipotesi “biopolitica” di un potere che dal piano esclusivamente “politico” si estende alla vita biologica, assumendosela in carico, gestendola e amministrandola, era verificata puntualmente dai fatti di cui tutti siamo stati testimoni e che è inutile, per la loro evidenza, elencare. L’ipotesi di una “governamentalità” che eccede la dimensione giuridica dello Stato, ponendo l’esecutivo in un costante “stato di eccezione”, era confermata dalle decisioni prese, quasi all’unisono, dai governi “democratici” per fronteggiare l’epidemia. Insomma, tutto quanto era stato teorizzato come critica di una tendenza che percorreva la modernità trovava una scioccante conferma nell’attualità. E siccome il più clamoroso esempio storico che si adduceva a suffragio della ipotesi era la biopolitica nazista, ecco allora che il nazismo poteva diventare l’inevitabile termine di paragone del presente.
Di fronte a una così eclatante validazione dell’ipotesi, il capogiro era dunque perfettamente giustificato: quando c’è una realizzazione troppo piena delle proprie attese si rimane infatti storditi. E lo stordimento spiega anche la deriva rovinosa che può prendere la cosa, perché l’eccesso di conferma può indurre qualcuno a dismettere i logori panni del teorico per vestire quelli più scintillanti del biblico profeta di sventura in rotta di collisione con il mondo, pagando però il prezzo, salatissimo, di una involontaria comicità. Ma fortunatamente non è questa la sola strada che è stata percorsa. Roberto Esposito, che è senz’altro tra i maggiori rappresentanti dell’italian thought, ha infatti colto l’occasione della pandemia per ridiscutere quel “paradigma immunitario” di cui negli ultimi anni si è lungamente occupato (Immunità comune. Biopolitica all’epoca della pandemia, Einaudi)
La sua tesi sull’immunizzazione è pan-esplicativa. Non c’è ambito della vita che si sottragga al suo dominio. Anch’essa ha ricevuto dalla pandemia un suo eccesso di conferma. Tutte le intuizioni di Esposito (si veda Immunitas. Protezione e negazione della vita, Einaudi, 2011) appaiono non solo validate ma addirittura sopravanzate da una realtà in cui la medicalizzazione della politica è diventata la posta in gioco del dibattito politico mondiale. Mi si vorrà perdonare se la risolvo in una formula semplice semplice, che spero, tuttavia, non sia fuorviante. Secondo quel paradigma non c’è salute dell’organismo individuale né salvezza del corpo sociale (la communitas) senza che qualcosa dell’opposto della vita, dunque qualcosa dell’ordine della morte, venga inoculato nel vivente per proteggerlo dalla morte che incombe sempre su di lui, proprio perché ancora vivente. Come ben sanno i teologi, dai quali i filosofi della “biopolitica” hanno tratto ben più di una ispirazione, occorre insomma una qualche dose intenzionale di male per tenere a freno l’avanzata dell’Apocalisse (un Katechon). Meglio ancora lo sapevano Edward Jenner, Louis Pasteur e Robert Koch ai quali si deve la teoria e la pratica della vaccinazione che tante vite ha salvato e continua a salvare ancora oggi.
Ma se l’immunizzazione assume una capacità pan-esplicativa è perché alle sue spalle agisce una metafisica della vita che, in ultima analisi, non è altro che la metafisica stessa, nella sua accezione più precisa. E la metafisica è una ontologia della morte. Per la metafisica, infatti, la morte è la condizione di intelligibilità della vita. Lo sanno anche i bambini: per la metafisica ciò che è deve giustificarsi di fronte al tribunale del non essere, mentre il non essere, il nulla non ha bisogno di giustificazione alcuna essendo, come diceva Leibniz, ciò che c’è di “più facile” per l’intelletto giudicante. La ricerca del perché concerne la vita e solo la vita, non riguarda la morte, che è, per così dire, lo stato di default. Il nulla, la negazione, la morte, con i suoi corollari “esistenziali” di finitezza, mancanza e contingenza, sono l’innegabile per la linea maggiore del pensiero occidentale.
In modo coerente con questo assunto dogmatico, secondo il paradigma immunologico, salute e salvezza, termini tra loro interscambiabili, presuppongono una vita tematizzata nell’orizzonte della morte, intesa come l’insieme di quei processi che ne dilazionano l’esito fatale. La vita non sarebbe nient’altro che l’insieme delle forze che resistono alla morte (Xavier Bichat) e la salute, come diceva un medico spiritoso, “uno stato precario che non promette nulla di buono”. Il vivente invece di contraddire apertamente la morte, come farebbe l’essere con il nulla, la economizzerebbe astutamente come una risorsa utile per continuare a vivere (a sopravvivere), cioè per morire il più tardi possibile. Jacques Derrida, il cui pensiero è interamente ascrivibile a questo paradigma, conia addirittura il lemma “la-vita-la-morte” per indicare il nodo indissolubile che legherebbe l’essere ancora, l’essere per un po’ di tempo, almeno, all’imminenza del nulla che arriverà comunque e per sempre.
Le pratiche immunitarie ad ogni livello, biologico come sociale, sono generate proprio da questo uso produttivo del negativo che non va confuso con l’hegeliana “negazione della negazione”, ma è una farmacologia che cura il simile con il simile. Nelle concezioni dialettiche il negativo negato è un’affermazione di grado superiore, nelle concezioni “immunitarie” il negativo non è invece negato (il nulla è infatti innegabile), ma accolto, piegato e utilizzato per dif-ferire, per dilazionare la negazione ultima (la morte) che costituisce il liquido amniotico di ogni vivente.
Tutta la saggezza del “buon” vivere diventa allora, secondo Esposito, una questione di metis, di astuzia. Bisogna saper trovare i modi giusti per articolare alla vita la negazione innegabile. Per la communitas politica questi modi sono le “istituzioni”, sono i “corpi sociali intermedi”, intermedi letteralmente tra la vita della comunità e la morte che regna sovrana. Per Esposito la crisi della democrazia è segnata soprattutto dal venir meno di questi luoghi di mediazione che erano invece considerati nel XVIII secolo da Tocqueville e dalla Arendt nel XX il cuore pulsante del progetto democratico americano (nelle pagine di Esposito è dunque la classica questione della “società civile” e della sua autonomia dal politico a ritornare prepotentemente sulla scena). Mediare significa immunizzare bene, immunizzare con misura, trarre insomma dal conflitto tutte le sue risorse positive per l’essere temporaneo e contingente della comunità che, va sempre ricordato, è, al pari dell’organismo individuale, votata al nulla come alla sua ragione di (non) essere.
Come ricorda però Esposito, il rischio che ogni organismo individuale o sociale corre preservandosi in tal modo è la malattia autoimmune, che è una specie di emancipazione del negativo dal suo compito “istituzionale” di servire la vita differendo la morte. Sul piano della storia sociale il caso più eclatante è quello sovente ricordato da Georges Bataille a proposito delle civiltà americane arcaiche. Queste si immunizzavano attraverso la pratica rituale del potlach. Una certa dose di spreco ostentatorio delle ricchezze, anche sotto forma di sacrificio umano, era funzionale alla gloria della comunità. Il grado dello spreco di risorse in termini di beni bruciati sugli altari, schiavi compresi, ne misurava la potenza e consolidava il senso di appartenenza alla communitas. L’essere della communitas (la sua identità) era direttamente proporzionale alla sua capacita di consumare inutilmente, cioè di donare senza calcolo e senza contraccambio.
Ma la logica del dono, che è una logica profondamente immunitaria, ha una ben precisa controindicazione. Il donare, tanto apprezzato dai nostri moralisti che hanno in orrore lo scambio, è il rovescio dell’usura, tanto disprezzata da quegli stessi moralisti. Come questa anche quello porta al collasso il sistema che dovrebbe difendere. Se non c’è sintesi dialettica, se non c’è negazione della negazione, ciò che resta è una corsa inflattiva ad un sempre più di potenza ostentata e, quindi, di spreco, fino al punto, come è storicamente accaduto con l’impero Azteco, di sacrificare l’essere stesso della communitas alla pratica del sacrificio, vale a dire alla pratica immunitaria che avrebbe dovuto preservarla, differendo la fine. Georges Bataille si rese perfettamente conto di tale metamorfosi dell’immunizzazione in malattia autoimmune. Dopo aver vagheggiato negli anni ’30 una communitas alternativa a quella capitalistica che fosse fondata sulla generalizzazione del dono, si rassegnò a praticarla solo nella forma inoffensiva della letteratura e in quella “privata” della “comunità (impossibile) degli amanti”. Probabilmente a indurlo a questo passo indietro fu la considerazione, rimasta per altro inespressa, tanto dell’inevitabile esisto catastrofico di quel progetto comunitario quanto della sua affinità spirituale con la “tanatopolitica” fascista.
Non vi sarebbe dunque biopolitica, nemmeno quella affermativa di Esposito, se non si giurasse concordi sulla definizione che del vivente umano ha dato il più controverso – e al tempo stesso ineludibile – filosofo del Novecento L’uomo è “essere-per-la-morte”. La vita umana, per Martin Heidegger, non è nient’altro che la morte, non è nient’altro che la dif-ferenza, la dilazione del morire. Il lemma derridiano, sopra citato, è solo una riscrittura di questa equazione. Il nulla è innegabile e solo ad un buon uso del negativo sono affidate le sorti di una convivenza possibile. Questa persuasione (perché tale è: a nessuno è data infatti l’evidenza del nulla), costituisce lo sfondo di ogni biopolitica.
C’è allora da chiedersi che ne sarebbe della politica e della vita e del loro rapporto se si sospendesse la nostra fede negli innegabili della metafisica, sui quali ancora si fonda il paradigma immunitario. Che accadrebbe, per la nostra vita individuale e collettiva, se si rovesciasse questa fede dogmatica nel nulla, nella negazione e nei suoi esistenziali corollari? Se li si congedasse tutti come pseudo-problemi? Nietzsche ha risposto che allora e solo allora ci sarebbe una “grande salute”. Una salute è “grande” non perché tiene accortamente più lontano il negativo con il negativo, ma perché del nulla non ne sa nulla, perché è sempre in atto in ogni vita che vive, intangibile e indistruttibile, una vita eternamente ritornante su se stessa. Sarebbe interessante scoprire cosa può generare sul piano politico questa concezione radicalmente immanente del vivente, quale communitas può produrre.
In un libro poco studiato dai filosofi della biopolitica, Le due fonti della morale e della religione (1932), Henri Bergson prova a fare l’esperimento. Bergson chiama “mistica” quell’azione politica che si libera dal fantasma del nulla e dall’angoscia del negativo. Se il dualismo amico-nemico, inclusione-esclusione (con i correlativi miti della patria, della nazione, dell’identità e della purezza dell’appartenenza), costituisce l’orizzonte claustrofobico in cui si risolve ogni agire politico legato alla logica dell’immunizzazione, l’agire “mistico” apre ad un’altra communitas differente per natura e non per grado da tutte le forme di organizzazione politica che l’hanno preceduta. Bergson la chiama “democratica” e ad essa affida le sue speranze di vecchio filosofo che è stato testimone dei disastri prodotti dalla logica immunitaria (la Grande Guerra). Per dare un’immagine più intuitiva di questa differenza di natura si può dire che la democrazia resta preda del paradigma immunitario fintantoché è una faccenda di equilibrio tra uguaglianza e libertà. Conciliarle, come ricorda Esposito, è impresa destinata al fallimento e “democrazia” è solo il nome per una cosa che non è mai esistita. Il passaggio al limite auspicato da Bergson si ha quando libertà e eguaglianza vengono radicate nel terzo termine del trinomio rivoluzionario, quello solitamente trascurato dai filosofi della politica: nella fraternità. Allora “democrazia” diventa tutta un’altra cosa, diventa il modo in cui la comunità umana partecipa dello slancio creatore che non cessa di generare ogni cosa, che “in qualche modo” è ogni cosa: diventa una grande salute.
































Comments
Fatico ad esprimere più chiaramente quello che voglio dire, ma posso affermare chiaramente che l'ultima proposizione dell'articolo, anche proprio per la funzione retorica che svolge, riflette una sorta di credenza che ha una grande carica astratta e ideologica. Mi chiedo, e davvero senza alcuna polemica (sto esprimendo un mio disagio), quanto l'autore abbia provato e provi quotidianamente, ma noi tutti, in un certo senso, proviamo a realizzare quotidianamente quella communitas, facendo vivere in noi il trinomio della chiusa, e specialmente il termine terzo che incarna i più astratti ed ideologici altri termini, cioè uguaglianza e libertà. Cioè mi chiedo: che distanza c'è fra queste parole e i fatti della nostra vita? di cosa vivono le nostre credenze circa la bontà di queste parole e l'effettiva loro vitalità entro la vita di ciascuno, fatto di attenzione, ascolto,
ecc ecc ecc. Mi dico anche: Può una concezione radicalmente immanente del vivente servirsi di concetti che così impiegati possano anche essere comuni, e in quanto comuni anche vivi, fra esseri umani che si trovano ad essere effettivamente insieme e provano a condividere effettivamente e praticamente insieme la loro vita, parole e concetti compresi, oppure questi concetti che evidentemente richiamano ad una tradizione ecc., sono comprensibili solo a qualche centinaio di lettori su questo blog e qualche altro blog su cui l'articolo presente viene pubblicato? Mi chiedo anche, ricevendo da me stesso l'impressione che con questo mio intervento non abbia detto sostanzialmente nulla di propositivo, ciò che mi sono chiesto all'inizio dello stesso: che distanza c'è fra parole e fatti? fra le proprie convinzioni e la loro possibilità di essere comuni al di la dell'universo di significati in cui si danno, e cioè in questo caso della filosofia politica occidentale?
Grazie,
l