Il “lavoro mentale” non è immateriale ed è sfruttato
di Ascanio Bernardeschi
Intervista a Guglielmo Carchedi sulle caratteristiche del lavoro mentale, della produzione di conoscenza in Internet e sulla validità della teoria del valore anche per la produzione di conoscenza
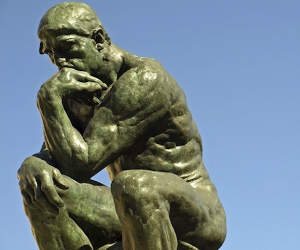 Guglielmo Carchedi, economista marxista di fama internazionale, è stato fra coloro che più radicalmente hanno combattuto le interpretazioni di tipo neoricardiano del Capitale di Marx, contestando la determinazione simultanea – à la Sraffa – del saggio del profitto, dei prezzi di produzione dei fattori produttivi e dei prodotti. Introducendo nella sua analisi il fattore tempo e interpretando la teoria del valore di Marx come un sistema di non equilibrio, ha mostrato che tale interpretazione consente di superare tutte le obiezioni fatte al procedimento marxiano di trasformazione dei valori in prezzi di produzione. Insieme a Alan Freeman ha curato e pubblicato un volume che è una pietra miliare di questa critica [1].
Guglielmo Carchedi, economista marxista di fama internazionale, è stato fra coloro che più radicalmente hanno combattuto le interpretazioni di tipo neoricardiano del Capitale di Marx, contestando la determinazione simultanea – à la Sraffa – del saggio del profitto, dei prezzi di produzione dei fattori produttivi e dei prodotti. Introducendo nella sua analisi il fattore tempo e interpretando la teoria del valore di Marx come un sistema di non equilibrio, ha mostrato che tale interpretazione consente di superare tutte le obiezioni fatte al procedimento marxiano di trasformazione dei valori in prezzi di produzione. Insieme a Alan Freeman ha curato e pubblicato un volume che è una pietra miliare di questa critica [1].
Ha letto anche, sempre con lenti marxiane, le caratteristiche di questa crisi economica, producendo tra l'altro un'analisi di classe delle contraddizioni insite nel processo di integrazione economica europea [2]. Recentemente ha dato un contributo teorico importante [3] per controbattere molte teorie di moda, sul lavoro cognitivo e su Internet in particolare, tendenti oggettivamente a disarmare la classe lavoratrice espungendone la componente dei lavoratori mentali e sostenendo l'inapplicabilità della teoria del valore al lavoro mentale. Insomma il suo contributo a confutare i “confutatori” ci consente di parlare ancora di pluslavoro e plusvalore e di individuare ancora nella classe lavoratrice il soggetto principale di un possibile superamento del modo di produzione capitalistico.




 James O’Connor è ben conosciuto, prima che per la sua proposta di un approccio “ecomarxista”, per la sua analisi della crisi fiscale dello stato. Di qui, l’estrema attualità di un autore che cerca di esaminare, dal punto di vista di un marxismo “critico”, problemi che al tempo in cui scrive sono “emergenti” e che oggi sono autentiche “emergenze”. In entrambi i casi, O’Connor osserva come il capitale esporti le proprie contraddizioni fuori dai ristretti confini della produzione, per ritrovarsi ad affrontarle quindi nel proprio ambiente: la produzione capitalistica funziona, da un certo punto di vista, come la macchina di Carnot, incapace di generare movimento senza esportare disordine al di fuori dei propri confini. Ma, diversamente dalla macchina di Carnot, che continua a compiere gli stessi movimenti, ci troviamo qui di fronte a processi storici, dove il capitalismo si espande colonizzando nuovi ambiti e nuovi territori, per ritrovarvi di volta in volta le proprie stesse contraddizioni. Un discorso di questo genere si colloca, in realtà, a pieno titolo sulla scia di un complesso di riflessioni sull’imperialismo, a partire da Hobson, Lenin e Rosa Luxemburg.
James O’Connor è ben conosciuto, prima che per la sua proposta di un approccio “ecomarxista”, per la sua analisi della crisi fiscale dello stato. Di qui, l’estrema attualità di un autore che cerca di esaminare, dal punto di vista di un marxismo “critico”, problemi che al tempo in cui scrive sono “emergenti” e che oggi sono autentiche “emergenze”. In entrambi i casi, O’Connor osserva come il capitale esporti le proprie contraddizioni fuori dai ristretti confini della produzione, per ritrovarsi ad affrontarle quindi nel proprio ambiente: la produzione capitalistica funziona, da un certo punto di vista, come la macchina di Carnot, incapace di generare movimento senza esportare disordine al di fuori dei propri confini. Ma, diversamente dalla macchina di Carnot, che continua a compiere gli stessi movimenti, ci troviamo qui di fronte a processi storici, dove il capitalismo si espande colonizzando nuovi ambiti e nuovi territori, per ritrovarvi di volta in volta le proprie stesse contraddizioni. Un discorso di questo genere si colloca, in realtà, a pieno titolo sulla scia di un complesso di riflessioni sull’imperialismo, a partire da Hobson, Lenin e Rosa Luxemburg.
 Voglio chiudere questo centenario di scarse e, ancor più, confuse celebrazioni parlando di uno dei pochi testi originali ed interessanti pubblicati dall’editoria italiana nel corso dell’anno tra quelli dedicati alla ricostruzione degli avvenimenti che condussero alla Rivoluzione di Ottobre. Non a caso il testo proviene dal mondo anglo-sassone la cui tradizione storiografica, nel corso degli anni, ha continuato a dedicare grande attenzione ad uno degli episodi destinati a fondare il ‘900 e il suo immaginario sociale, culturale e politico.
Voglio chiudere questo centenario di scarse e, ancor più, confuse celebrazioni parlando di uno dei pochi testi originali ed interessanti pubblicati dall’editoria italiana nel corso dell’anno tra quelli dedicati alla ricostruzione degli avvenimenti che condussero alla Rivoluzione di Ottobre. Non a caso il testo proviene dal mondo anglo-sassone la cui tradizione storiografica, nel corso degli anni, ha continuato a dedicare grande attenzione ad uno degli episodi destinati a fondare il ‘900 e il suo immaginario sociale, culturale e politico.
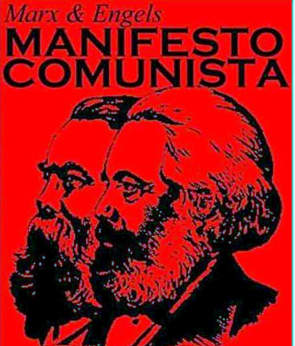 Anche Marx fa ricorso a Shakespeare per parlare dell'estraneità della lingua, della lingua come qualcosa che ossessiona, che non è mai del tutto integrata. Harald Weinrich lega insieme Shakespeare e Goethe nell'analogia del francese visto come lingua della menzogna. Derrida, da dentro tale lingua, in "Spettri di Marx" commenta "Il 18 brumaio" di Marx, soprattutto per quel che riguarda la parte in cui Viene detto che «indossa la maschera dell'apostolo Paolo», allo stesso modo in cui la Rivoluzione del 1789-1814 «ha indossato alternativamente come quelle della Repubblica romana e quella dell'Impero romano.»
Anche Marx fa ricorso a Shakespeare per parlare dell'estraneità della lingua, della lingua come qualcosa che ossessiona, che non è mai del tutto integrata. Harald Weinrich lega insieme Shakespeare e Goethe nell'analogia del francese visto come lingua della menzogna. Derrida, da dentro tale lingua, in "Spettri di Marx" commenta "Il 18 brumaio" di Marx, soprattutto per quel che riguarda la parte in cui Viene detto che «indossa la maschera dell'apostolo Paolo», allo stesso modo in cui la Rivoluzione del 1789-1814 «ha indossato alternativamente come quelle della Repubblica romana e quella dell'Impero romano.»
 L’annuncio dell’intervento italiano in Niger, fatto da Gentiloni su una portaerei, ha colto di sorpresa solo gli osservatori più distratti. La scorsa estate, nel periodo del giro di vite Minniti sugli sbarchi dalla Libia, il governo del Niger era già stato accolto a palazzo Chigi. Motivo ufficiale: una serie di discussioni, e di richieste di finanziamento da parte del paese africano, legate alla questione del contenimento dei flussi migratori. Minniti infatti, all’epoca (e non solo), sosteneva che le frontiere della Ue coincidessero con la Libia e che, proprio per quello, rafforzare la vigilanza in Niger avrebbe significato un alleggerimento dei problemi alla frontiera libica.
L’annuncio dell’intervento italiano in Niger, fatto da Gentiloni su una portaerei, ha colto di sorpresa solo gli osservatori più distratti. La scorsa estate, nel periodo del giro di vite Minniti sugli sbarchi dalla Libia, il governo del Niger era già stato accolto a palazzo Chigi. Motivo ufficiale: una serie di discussioni, e di richieste di finanziamento da parte del paese africano, legate alla questione del contenimento dei flussi migratori. Minniti infatti, all’epoca (e non solo), sosteneva che le frontiere della Ue coincidessero con la Libia e che, proprio per quello, rafforzare la vigilanza in Niger avrebbe significato un alleggerimento dei problemi alla frontiera libica.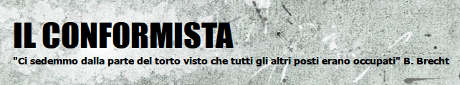
 Non molto tempo fa, la discussione sulla globalizzazione era data per morta e sepolta – dai partiti di sinistra come per quelli di destra.
Non molto tempo fa, la discussione sulla globalizzazione era data per morta e sepolta – dai partiti di sinistra come per quelli di destra.
 Fino a pochi anni fa la qualifica di ONG, introdotta en passant dall'art. 71 dello Statuto delle Nazioni Unite (1945), era certificata dal nostro Ministero degli esteri a valle di un giudizio di idoneità. Successivamente la legge 125/2014 ne ha resa la definizione più incerta e sostanzialmente desueta, sicché nel nostro ordinamento la sigla sopravvive per designare le associazioni già riconosciute come ONG in Italia o all'estero secondo i rispettivi ordinamenti, più in generale inquadrabili lato sensu nei criteri fondamentali della precedente norma, che cioè «abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo» e «non perseguano finalità di lucro» (legge 49/1987, art. 28).
Fino a pochi anni fa la qualifica di ONG, introdotta en passant dall'art. 71 dello Statuto delle Nazioni Unite (1945), era certificata dal nostro Ministero degli esteri a valle di un giudizio di idoneità. Successivamente la legge 125/2014 ne ha resa la definizione più incerta e sostanzialmente desueta, sicché nel nostro ordinamento la sigla sopravvive per designare le associazioni già riconosciute come ONG in Italia o all'estero secondo i rispettivi ordinamenti, più in generale inquadrabili lato sensu nei criteri fondamentali della precedente norma, che cioè «abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo» e «non perseguano finalità di lucro» (legge 49/1987, art. 28).
 1. Introduzione
1. Introduzione
 Con lieve ritardo (il libro è uscito circa un anno fa), leggiamo questo saggio che in realtà introduce e commenta uno scambio intellettuale avvenuto tra Umberto Eco e Rossana Rossanda sulle colonne di Rinascita nell’autunno del 1963. Il riferimento temporale è decisivo per comprendere il contesto: siamo dentro l’esplosione delle neoavanguardie (Novissimi, Gruppo 63 e dintorni), sull’onda del loro eclettico rapporto con l’operaismo, e nel vortice della crescita elettorale del Pci. C’è fermento insomma, e il rapporto tra politica e cultura è posto all’ordine del giorno delle questioni dirimenti (bei tempi). Lo scambio tra Eco e la Rossanda è solo una tessera di un quadro più vasto, che proprio su Rinascita troverà uno dei luoghi di confronto. Grazie a Mario Spinella, Eco interviene in una discussione che procede già da qualche anno: il comunismo italiano da tempo si domanda del rapporto progressivamente meno organico con il mondo intellettuale. Dagli anni Sessanta queste domande non provengono più solo dall’interno del partito, né solo rinfacciate dalla cultura borghese: ad intervenire, sulla scorta delle trasformazioni sociali del paese, sono una congerie di scrittori, artisti, critici e militanti politici che compongono quella che viene denominata «cultura d’opposizione». Una cultura che utilizza il marxismo come «metodo di critica» ma non più come «concezione del mondo» autosufficiente. Umberto Eco s’incarica di gettare il classico sasso nello stagno, generando un fervido confronto che svela una certa dinamicità del dibattito marxista italiano sul piano culturale, anche dentro il Pci.
Con lieve ritardo (il libro è uscito circa un anno fa), leggiamo questo saggio che in realtà introduce e commenta uno scambio intellettuale avvenuto tra Umberto Eco e Rossana Rossanda sulle colonne di Rinascita nell’autunno del 1963. Il riferimento temporale è decisivo per comprendere il contesto: siamo dentro l’esplosione delle neoavanguardie (Novissimi, Gruppo 63 e dintorni), sull’onda del loro eclettico rapporto con l’operaismo, e nel vortice della crescita elettorale del Pci. C’è fermento insomma, e il rapporto tra politica e cultura è posto all’ordine del giorno delle questioni dirimenti (bei tempi). Lo scambio tra Eco e la Rossanda è solo una tessera di un quadro più vasto, che proprio su Rinascita troverà uno dei luoghi di confronto. Grazie a Mario Spinella, Eco interviene in una discussione che procede già da qualche anno: il comunismo italiano da tempo si domanda del rapporto progressivamente meno organico con il mondo intellettuale. Dagli anni Sessanta queste domande non provengono più solo dall’interno del partito, né solo rinfacciate dalla cultura borghese: ad intervenire, sulla scorta delle trasformazioni sociali del paese, sono una congerie di scrittori, artisti, critici e militanti politici che compongono quella che viene denominata «cultura d’opposizione». Una cultura che utilizza il marxismo come «metodo di critica» ma non più come «concezione del mondo» autosufficiente. Umberto Eco s’incarica di gettare il classico sasso nello stagno, generando un fervido confronto che svela una certa dinamicità del dibattito marxista italiano sul piano culturale, anche dentro il Pci.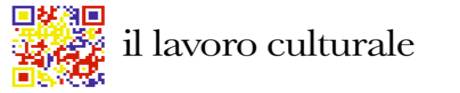
 Quelli raccolti in Economia della rivoluzione sono dei testi che Lenin dedicò alla politica economica sovietica a partire dall’ottobre 1917, anno della presa del potere da parte dei Soviet, fino al marzo 1923, momento in cui la malattia che lo aveva colpito gli impedì di proseguire il suo lavoro per condurlo, quasi un anno più tardi, alla morte. Articoli, saggi, abbozzi di risoluzioni politiche, resoconti stenografici di interventi pubblici, appunti, promemoria. Economia della rivoluzione è un insieme eterogeneo di scritti – già editi in Opere Complete, pubblicate prima da Editori Riuniti e poi, ampliate, da Edizioni Lotta Continua – organizzati da Giacché secondo una scansione temporale: I) la presa del potere e i primi mesi di governo; II) lo scoppio della guerra civile e il comunismo di guerra; III) la Nuova politica economica.
Quelli raccolti in Economia della rivoluzione sono dei testi che Lenin dedicò alla politica economica sovietica a partire dall’ottobre 1917, anno della presa del potere da parte dei Soviet, fino al marzo 1923, momento in cui la malattia che lo aveva colpito gli impedì di proseguire il suo lavoro per condurlo, quasi un anno più tardi, alla morte. Articoli, saggi, abbozzi di risoluzioni politiche, resoconti stenografici di interventi pubblici, appunti, promemoria. Economia della rivoluzione è un insieme eterogeneo di scritti – già editi in Opere Complete, pubblicate prima da Editori Riuniti e poi, ampliate, da Edizioni Lotta Continua – organizzati da Giacché secondo una scansione temporale: I) la presa del potere e i primi mesi di governo; II) lo scoppio della guerra civile e il comunismo di guerra; III) la Nuova politica economica.
 Giordano Sivini* è stato docente di Sociologia alla facoltà di Economia dell’Università della Calabria. Recentemente, insieme a Giuliana Commisso, ha pubblicato il libro “Reddito di cittadinanza. Emancipazione dal lavoro o lavoro coatto?” per le edizioni Asterios. Del libro abbiamo già parlato
Giordano Sivini* è stato docente di Sociologia alla facoltà di Economia dell’Università della Calabria. Recentemente, insieme a Giuliana Commisso, ha pubblicato il libro “Reddito di cittadinanza. Emancipazione dal lavoro o lavoro coatto?” per le edizioni Asterios. Del libro abbiamo già parlato 


 Chiunque parli di “crisi”, oggi, rischia di essere liquidato come un parolaio, data la banalizzazione che il termine ha subito attraverso il suo uso continuo e superficiale. Ma c’è un senso preciso in cui noi oggi stiamo effettivamente affrontando una crisi. Se la caratterizziamo con precisione e identifichiamo le sue dinamiche distintive, possiamo determinare meglio cos’è necessario per risolverla. Su queste basi, inoltre, potremmo intravedere un sentiero che ci guidi oltre l’attuale impasse, attraverso il riallineamento politico e verso la trasformazione della società.
Chiunque parli di “crisi”, oggi, rischia di essere liquidato come un parolaio, data la banalizzazione che il termine ha subito attraverso il suo uso continuo e superficiale. Ma c’è un senso preciso in cui noi oggi stiamo effettivamente affrontando una crisi. Se la caratterizziamo con precisione e identifichiamo le sue dinamiche distintive, possiamo determinare meglio cos’è necessario per risolverla. Su queste basi, inoltre, potremmo intravedere un sentiero che ci guidi oltre l’attuale impasse, attraverso il riallineamento politico e verso la trasformazione della società.
 1. Secondo lo schema geopolitico proposto dal geografo Alford John Mackinder in una celebre conferenza londinese davanti alla Royal Geographical Society la sera del 25 gennaio del 1904, l’insieme delle terre euroasiatiche (che costituiscono l’“isola del mondo” perché fisicamente compatte dall’Atlantico al Pacifico e dal Mar Glaciale Artico al deserto del Sahara) non è gerarchicamente uniforme, essendocene una porzione che rappresenta a suo dire il perno geografico della storia (come recita il sottotitolo della conferenza) ed il cui controllo politico potrebbe assicurare addirittura il governo del mondo. Su questa porzione di spazio euroasiatico, che Mackinder chiama Heartland ossia il “cuore della terra”, si incardinerebbero infatti le variabili di spazio geografico e di tempo storico che definiscono la nuova “scienza” della geopolitica. E siccome il “cuore della terra” è rappresentato dalla grande estensione delle steppe euroasiatiche che vanno dal fiume Don alla penisola di Kamciakta, esso finisce per coincidere di fatto con la Russia, così che (primo teorema geopolitico) chi la governa potrebbe essere in grado (il condizionale è d’obbligo) d’imporre la propria volontà al resto del pianeta.
1. Secondo lo schema geopolitico proposto dal geografo Alford John Mackinder in una celebre conferenza londinese davanti alla Royal Geographical Society la sera del 25 gennaio del 1904, l’insieme delle terre euroasiatiche (che costituiscono l’“isola del mondo” perché fisicamente compatte dall’Atlantico al Pacifico e dal Mar Glaciale Artico al deserto del Sahara) non è gerarchicamente uniforme, essendocene una porzione che rappresenta a suo dire il perno geografico della storia (come recita il sottotitolo della conferenza) ed il cui controllo politico potrebbe assicurare addirittura il governo del mondo. Su questa porzione di spazio euroasiatico, che Mackinder chiama Heartland ossia il “cuore della terra”, si incardinerebbero infatti le variabili di spazio geografico e di tempo storico che definiscono la nuova “scienza” della geopolitica. E siccome il “cuore della terra” è rappresentato dalla grande estensione delle steppe euroasiatiche che vanno dal fiume Don alla penisola di Kamciakta, esso finisce per coincidere di fatto con la Russia, così che (primo teorema geopolitico) chi la governa potrebbe essere in grado (il condizionale è d’obbligo) d’imporre la propria volontà al resto del pianeta.
 Alain Touraine, il decano dei sociologi francesi a cui si deve l’espressione “società postindustriale”, ha dedicato i suoi ultimi libri alla disgregazione della società industriale e ai conflitti che caratterizzano quanto viene definita “epoca postsociale”: l’epoca non più governata dalla dimensione socio economica dei problemi, bensì da quella etico individuale. Ne “La fine delle società” ha analizzato il capitalismo finanziario e il suo ruolo nella crisi delle principali istituzioni politiche e sociali: dallo Stato alla famiglia, passando per i sindacati e i diversi sistemi di protezione e controllo sociale (La fin des sociétés, 2013). Con “Noi soggetti umani” ha sottolineato la necessità di riscoprire i diritti umani per contrastare il capitalismo finanziario attraverso un rigurgito etico individuale (Nous, sujets humains, 2015). Infine, ne “Il nuovo secolo politico” ha riflettuto sul modo di affrontare i grandi temi che monopolizzano il dibattito pubblico: dalla questione nazionale a quella religiosa, passando per la lotta al terrorismo e la sfida ambientale (Le nouveau siècle politique, 2016).
Alain Touraine, il decano dei sociologi francesi a cui si deve l’espressione “società postindustriale”, ha dedicato i suoi ultimi libri alla disgregazione della società industriale e ai conflitti che caratterizzano quanto viene definita “epoca postsociale”: l’epoca non più governata dalla dimensione socio economica dei problemi, bensì da quella etico individuale. Ne “La fine delle società” ha analizzato il capitalismo finanziario e il suo ruolo nella crisi delle principali istituzioni politiche e sociali: dallo Stato alla famiglia, passando per i sindacati e i diversi sistemi di protezione e controllo sociale (La fin des sociétés, 2013). Con “Noi soggetti umani” ha sottolineato la necessità di riscoprire i diritti umani per contrastare il capitalismo finanziario attraverso un rigurgito etico individuale (Nous, sujets humains, 2015). Infine, ne “Il nuovo secolo politico” ha riflettuto sul modo di affrontare i grandi temi che monopolizzano il dibattito pubblico: dalla questione nazionale a quella religiosa, passando per la lotta al terrorismo e la sfida ambientale (Le nouveau siècle politique, 2016).
 L’economia neoclassica insegnata nei primi anni universitari presenta il tempo libero come uno dei due beni che determinano l’utilità individuale, sulla cui base calcolare l’offerta di lavoro operaia. Gli individui raggiungono maggiori livelli di utilità quanto più è alta la loro disponibilità di consumo e di tempo libero.
L’economia neoclassica insegnata nei primi anni universitari presenta il tempo libero come uno dei due beni che determinano l’utilità individuale, sulla cui base calcolare l’offerta di lavoro operaia. Gli individui raggiungono maggiori livelli di utilità quanto più è alta la loro disponibilità di consumo e di tempo libero.
 In Libia l’esercito italiano è presente con forze speciali, addestra i militari legati ad una delle parti in conflitto, invia 300 parà della Folgore a protezione dell’ospedale militare allestito per assistere i feriti della milizia di Misurata, mantiene la copertura aerea attraverso la portaerei Garibaldi e i caccia dell'Aeronautica schierati nelle basi di Trapani, Gioia del Colle e Sigonella oltre ai droni dell'Aeronautica militare, monitora i confini sud dove intende impiantare una propria base militare, è presente con le sue navi dal 2015 per presidiare le installazioni ENI al largo di Mellitah.
In Libia l’esercito italiano è presente con forze speciali, addestra i militari legati ad una delle parti in conflitto, invia 300 parà della Folgore a protezione dell’ospedale militare allestito per assistere i feriti della milizia di Misurata, mantiene la copertura aerea attraverso la portaerei Garibaldi e i caccia dell'Aeronautica schierati nelle basi di Trapani, Gioia del Colle e Sigonella oltre ai droni dell'Aeronautica militare, monitora i confini sud dove intende impiantare una propria base militare, è presente con le sue navi dal 2015 per presidiare le installazioni ENI al largo di Mellitah.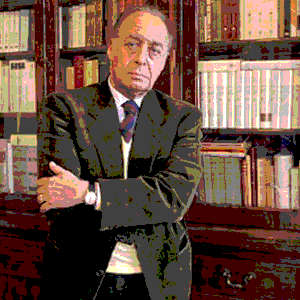 Si riprenda l’intervista rilasciata a Giampiero Mughini per Mondoperaio del novembre 1977, in cui Lucio Colletti riconosce, con accenti seccamente autocritici, di aver visto per lungo tempo “il modello di libertà in Stato e rivoluzione di Lenin, nella Comune di Parigi, nell’autogoverno dei produttori, nella democrazia diretta roussoiana” (Tra marxismo e no, pp. 143-52). Purtroppo, conclude, gli esperimenti degli Stati del socialismo reale, avendo dato vita a dittature, hanno dimostrato che quel modello, cioè l’autogoverno dei produttori e la democrazia diretta, è impraticabile. Quest’autocritica sul credo politico è scandita insieme alla riaffermazione dei principi del materialismo, che per Colletti coincidono con quelli delle scienze naturali, mentre rispetto alla conoscenza del mondo sociale ha oscillato tra una visione positivista – essa deve adottare metodi scientifici (peraltro mai da lui definiti) ‒, e un velato scetticismo sostenendo che rimane una questione irrisolta.
Si riprenda l’intervista rilasciata a Giampiero Mughini per Mondoperaio del novembre 1977, in cui Lucio Colletti riconosce, con accenti seccamente autocritici, di aver visto per lungo tempo “il modello di libertà in Stato e rivoluzione di Lenin, nella Comune di Parigi, nell’autogoverno dei produttori, nella democrazia diretta roussoiana” (Tra marxismo e no, pp. 143-52). Purtroppo, conclude, gli esperimenti degli Stati del socialismo reale, avendo dato vita a dittature, hanno dimostrato che quel modello, cioè l’autogoverno dei produttori e la democrazia diretta, è impraticabile. Quest’autocritica sul credo politico è scandita insieme alla riaffermazione dei principi del materialismo, che per Colletti coincidono con quelli delle scienze naturali, mentre rispetto alla conoscenza del mondo sociale ha oscillato tra una visione positivista – essa deve adottare metodi scientifici (peraltro mai da lui definiti) ‒, e un velato scetticismo sostenendo che rimane una questione irrisolta.
 La Cina “globale” ha prestato sempre più attenzione alla sua immagine, alla diffusione e alla promozione della propria cultura, ben consapevole del fatto che sul “soft power” i passi da compiere sono ancora molti. Ma anche sotto l’aspetto del cosiddetto “potere morbido” occorre ormai sganciarsi da una definizione consolidata – quella che notoriamente fa capo allo studioso statunitense Joseph Nye - perché rischia di “universalizzare” un caso di studio particolare – gli Stati Uniti appunto – per elevarlo a metro di giudizio globale in base al quale la Cina è sistematicamente condannata come Paese privo di particolare fascino e per questo impossibilitata a mettere realmente in discussione l’egemonia dell’american way of life. Mai infatti come in questi tempi di crescente impatto cinese sugli affari internazionali, si è ricorsi a questo tipo di ragionamento, quasi si volesse riaffermare quotidianamente – possiamo chiamarla “ridotta del soft power” - ad una centralità che nei fatti è sempre più in discussione.
La Cina “globale” ha prestato sempre più attenzione alla sua immagine, alla diffusione e alla promozione della propria cultura, ben consapevole del fatto che sul “soft power” i passi da compiere sono ancora molti. Ma anche sotto l’aspetto del cosiddetto “potere morbido” occorre ormai sganciarsi da una definizione consolidata – quella che notoriamente fa capo allo studioso statunitense Joseph Nye - perché rischia di “universalizzare” un caso di studio particolare – gli Stati Uniti appunto – per elevarlo a metro di giudizio globale in base al quale la Cina è sistematicamente condannata come Paese privo di particolare fascino e per questo impossibilitata a mettere realmente in discussione l’egemonia dell’american way of life. Mai infatti come in questi tempi di crescente impatto cinese sugli affari internazionali, si è ricorsi a questo tipo di ragionamento, quasi si volesse riaffermare quotidianamente – possiamo chiamarla “ridotta del soft power” - ad una centralità che nei fatti è sempre più in discussione. 1. Diritto senza territorio?
1. Diritto senza territorio?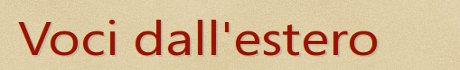
 Dal Collettivo Aristoteles, un gruppo di giovani torinesi che si occupano di tematiche economiche e politiche, abbiamo ricevuto questa intervista, da loro realizzata, agli autori del testo
Dal Collettivo Aristoteles, un gruppo di giovani torinesi che si occupano di tematiche economiche e politiche, abbiamo ricevuto questa intervista, da loro realizzata, agli autori del testo 
 Nel lessico politico della sinistra populismo è parola bollata negativamente, su ciò concordano le due principali correnti intellettuali e di pensiero politico dell’Otto e del Novecento, quella liberale e quella marxista. Anche in un contesto profondamente diverso dal nostro, quale quello americano, le cose non cambiano: i liberali e i progressisti individuano nel populismo il loro peggiore nemico; rimando in proposito al libro fondamentale, anche se discutibile, di Christopher Lasch, Il paradiso in terra. Populista è stato considerato il fascismo, così come il nazismo, nonché il comunismo sovietico, ovviamente il peronismo, le dittature sudamericane, ma anche Bossi e Berlusconi sono etichettati come populisti (io stesso ho curato una raccolta di saggi intitolata Dal leghismo al neopopulismo).
Nel lessico politico della sinistra populismo è parola bollata negativamente, su ciò concordano le due principali correnti intellettuali e di pensiero politico dell’Otto e del Novecento, quella liberale e quella marxista. Anche in un contesto profondamente diverso dal nostro, quale quello americano, le cose non cambiano: i liberali e i progressisti individuano nel populismo il loro peggiore nemico; rimando in proposito al libro fondamentale, anche se discutibile, di Christopher Lasch, Il paradiso in terra. Populista è stato considerato il fascismo, così come il nazismo, nonché il comunismo sovietico, ovviamente il peronismo, le dittature sudamericane, ma anche Bossi e Berlusconi sono etichettati come populisti (io stesso ho curato una raccolta di saggi intitolata Dal leghismo al neopopulismo).
 La Libia è oramai una mera espressione geografica, per usare un’espressione del principe Von Metternich. Dall’intervento occidentale contro Muhammar Gheddafi, il Paese – le regioni del Sahel con cui confina – è infatti sprofondata nel caos, con un nugolo di fazioni autofinanziate mediante quella che si configura in tutta evidenza come una moderna tratta degli schiavi e armate di fucili, lanciarazzi, pistole, ecc. sottratti dagli arsenali della Jamahiriya ormai distrutta che si contendono il territorio. Una situazione da cui le grandi imprese sperano di trarre ottimi profitti, attraverso l’applicazione di disegni egemonici studiati a tavolino quali quello
La Libia è oramai una mera espressione geografica, per usare un’espressione del principe Von Metternich. Dall’intervento occidentale contro Muhammar Gheddafi, il Paese – le regioni del Sahel con cui confina – è infatti sprofondata nel caos, con un nugolo di fazioni autofinanziate mediante quella che si configura in tutta evidenza come una moderna tratta degli schiavi e armate di fucili, lanciarazzi, pistole, ecc. sottratti dagli arsenali della Jamahiriya ormai distrutta che si contendono il territorio. Una situazione da cui le grandi imprese sperano di trarre ottimi profitti, attraverso l’applicazione di disegni egemonici studiati a tavolino quali quello 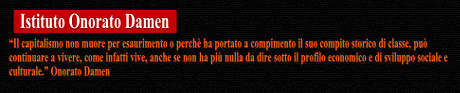


 1. Introduzione
1. Introduzione

































