Lettera aperta al giornale il manifesto: niente di personale!
di Michele Castaldo
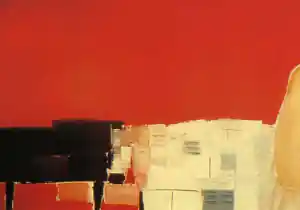 Da vecchio militante comunista, a fine agosto 2025, mi ero rivolto al quotidiano il manifesto - che conserva ancora, anche se in caratteri infinitesimali, sul titolo, la scritta quotidiano comunista – per poter postare a pagamento la copertina del mio libro La crisi di una teoria rivoluzionaria. Mi fu chiesto di visionare il libro, cosa che feci portandolo nella sede romana di via Bargoni 8, dove lo lasciai in attesa di conoscere l’esito. Ero interessato a pubblicare lo spot per il 28 settembre 2025, perché compivo 80 anni, che si compiono una volta sola, se si compiono.
Da vecchio militante comunista, a fine agosto 2025, mi ero rivolto al quotidiano il manifesto - che conserva ancora, anche se in caratteri infinitesimali, sul titolo, la scritta quotidiano comunista – per poter postare a pagamento la copertina del mio libro La crisi di una teoria rivoluzionaria. Mi fu chiesto di visionare il libro, cosa che feci portandolo nella sede romana di via Bargoni 8, dove lo lasciai in attesa di conoscere l’esito. Ero interessato a pubblicare lo spot per il 28 settembre 2025, perché compivo 80 anni, che si compiono una volta sola, se si compiono.
Dopo giorni di silenzio mi premunii di telefonare, parlando con la signora Caterina, con la quale ero entrato in contatto fin dalla prima telefonata, e mi fu risposto che avrei dovuto pazientare ancora qualche giorno. Ma di giorni ne passarono ancora e non ebbi mai risposta. Spazientito, nonché offeso, ma mai arreso, mi diedi da fare.
Ricordandomi del proverbio che ripeteva spesso mia mamma, comunista: «se pensi di suicidarti, vai al mare, perché nelle pozzanghere ti sporchi e non muori », lunedì 22 settembre telefonai al Corriere della sera per chiedere di pubblicare lo spot del libro di cui sopra. Mi fu chiesto il prezzo, gli inviai tramite l’editore l’impostazione grafica, feci il bonifico il 25 settembre e il giorno 28 settembre, come convenuto, comparì un piede nella pagina della Cultura, del più importante quotidiano italiano, lo spot de La crisi di una teoria rivoluzionaria.
Su suggerimento del mio sodale Alessio Galluppi, avevo fatto la stessa richiesta a Il Fatto quotidiano in contemporanea al il manifesto e anche a loro avevo consegnato il libro perché si rendessero conto del contenuto. Ma anche da Il Fatto ci fu silenzio. Poi, però, dopo che era stato pubblicato sul Corriere della sera mi telefonò il responsabile di Roma per chiedermi se volessi ancora pubblicare lo spot del libro. Mi chiesero il prezzo per una intera pagina, gli spedii tramite l’editore l’impostazione grafica, feci il bonifico e domenica 19 ottobre è comparso a tutta pagina anche su Il Fatto quotidiano lo spot de La crisi di una teoria rivoluzionaria.
A questo punto mi vien da fare una considerazione di questo tipo: per il manifesto – con la scritta nel titolo quotidiano comunista – un libro intitolato La crisi di una teoria rivoluzionaria ha rappresentato un pugno nell’occhio, il solo titolo, si badi bene, e messo da parte come qualcosa che scotta. Per il Corriere della sera, un giornale dell’establishment, cosa poteva preoccupare un titolo del genere? Suvvia. Mentre per i redattori de Il Fatto quotidiano il titolo, ne devo desumere, avrà incuriosito e lo hanno pubblicato.
Ora mi chiedo: se un giornale che si rifà a una tradizione democratica, fin dal suo sorgere addirittura contro il centralismo democratico del Pci da cui originò, teme il solo titolo di un umile militante comunista che seriamente si interroga su una teoria ideale che ci originò, qual è il senso della sua esistenza?
Si ha paura di affrontare le cause della nostra crisi? Ma è sotto gli occhi di tutti e viene utilizzata per buttare discredito su tutta la nostra storia. È da oltre cento e passa anni, dal 1917 tanto per indicare una data, che cercano di screditarci sputando fango sui nostri ideali. Da quando, cioè, a differenza della democrazia capitalistica che tolse la terra alla nobiltà e al clero per assegnarla con una serie di brogli alla borghesia, mentre i comunisti nella stessa notte dell’insurrezione come primo governo rivoluzionario provvisorio confiscarono la terra e gli immobili dei pomescichi, per poi assegnarla per bocche ai contadini poveri, ovvero ai mugichi.
La domanda vera è: perché abbiamo paura di affrontare le ragioni della nostra crisi? Dopo che si siamo imbevuti il principio del libero arbitrio fino al punto di pensare di dirigere le leggi del modo di produzione capitalistico? Per tanto e troppo tempo? Dopo abbiamo ipotizzato di abbattere il “capitalismo” proprio quando si avviava verso una straordinaria crescita? I conti, cari amici del il manifesto non tornano, bisogna rifarli, se non li rifacciamo noi per noi, li fanno gli altri per noi e sono ben peggiori, perché ci obbligano, come stanno tentando di obbligarci a fare, a rincorrerli sul loro terreno liberaldemocratico, dell’esasperato individualismo, del razzismo, del populismo e del nazionalismo.
Ciò succede, si badi bene, non in una fase di straordinaria accumulazione capitalistica dove potevano, lor signori, aver ragione del fatto che eravamo stati sconfitti per l’implosione dell’Urss, come con l’89, no, ma in una fase di crisi acuta dell’insieme del modo di produzione capitalistico, che sta implodendo addirittura nel suo epicentro, come negli Usa e ben presto per onde magnetiche si riverserà anche in Europa e non sappiamo con quali riflessi nel resto del mondo visto che si tratta di un sistema monista, in cui tutto si tiene o niente si tiene.
Perché uno spot per un libro così complicato? Non certamente per ragioni economiche, un idealista non rincorre quelle, ma come tentativo di aprire una discussione per far fronte alle difficoltà che abbiamo, per tentare di rilanciare la natura di un ideale piuttosto che annichilirci su noi stessi e vederci passare la storia sotto il naso. Tutto qua il motivo e le ragioni contenute ne La crisi di una teoria rivoluzionaria.
In che consiste il fulcro di detto libro? Presto detto: la messa in discussione della tesi di fondo contenuta nel Manifesto di Marx-Engels de 1848.
Sarei un dissacratore? No, cerco di analizzare quella tesi, incentrata sullo sviluppo storico avente come soggetto le classi, alla luce dei fattori per come si sono svolti negli ultimi 200 anni e arrivare a una conclusione per cui le classi sociali piuttosto che essere stati dei soggetti sono state l’effetto di cause impersonali dei rapporti degli uomini coi mezzi di produzione attraverso lo scambio.
Buttiamo a mare Marx ed Engels? No, li esaminiamo per quello che furono, ovvero dei laboratori particolari in una fase molto particolare della storia dove ipotizzarono, da giovani, un certo percorso che la storia poi diede loro torto e che loro stessi furono costretti a maturare riflessioni e conclusioni diverse. Sicché i peggiori “estimatori” di Marx ed Engels sono quelli che si attardano sugli inizi piuttosto che prendere in esame tutto il loro percorso fino a invalidare totalmente lo stesso Manifesto del 1848, come nei Grundrisse o Il Capitale.
Entriamo più nel merito senza fare troppi giri di valzer a vuoto, dicendo che la parola d’ordine che simbolizzava il Manifesto era Proletari di tutto il mondo unitevi! Ovvero un proclama, una esortazione rivolta alla classe operaia a ribellarsi come classe sfruttata e oppressa. Ed era rivolta a tutto il mondo, ma un mondo in cui per gran parte non esisteva ancora il proletariato. Non solo, ma che per potersi unire sarebbe stata necessario avere la coscienza di essere sfruttati e averla a tal punto di farne di questa una necessità politica per battersi contro un’altra classe, disarcionarla dal potere, impossessarsi dei mezzi di produzione e imporre la propria dittatura.
Bando alle chiacchiere, si trattava di una tesi volontaristica e metafisica, perché gli uomini si muovono non per coscienza ma per necessità, in modo particolare per quanto riguarda le classi oppresse e sfruttate
Ma c’era dell’altro e di più, perché la classe operaia, o proletariato che dir si voglia, si presentava come classe complementare in una parte minoritaria del mondo ed era tale – cioè complementare – contro un’altra parte che era maggioritaria del mondo, un mondo oppresso e sfruttato dal colonialismo. Questo è un punto fondamentale di cui ci tocca prendere atto piuttosto che continuare a fare i giri di valzer.
E allora per essere ancora più chiari dico che l’operaio ha i piedi per terra e non costruisce castelli in aria con la fantasia: egli sa che permanendo – ancora oggi, si badi bene – il modo di produzione capitalistico, il suo capitalista, per quanto sfruttatore e oppressore, deve competere con un altro capitalista che produce la stessa merce. Questo operaio per ragioni materiali immediate è più attratto dalle ragioni del proprio capitalista che da quelle di un altro operaio suo concorrente. Il nemico, perciò, è quella legge impersonale che si chiama concorrenza. Come potrebbe l’operaio sottrarsi a questo vincolo e sviluppare la propria autonomia di classe? Per Marx ed Engels la forza di quella legge oggettiva rappresentata dalla concorrenza è chiara e ben presente, difatti l’esortazione politica del Manifesto rivolta ai lavoratori, ripetiamo, è Proletari di tutto il mondo unitevi! Di tutto il mondo dunque perché c’è la consapevolezza che il modo di produzione capitalistico è mondiale e dunque deve essere affrontato a quel livello. Su che base i proletari si sarebbero dovuti unire non risulta chiaro se non nell’espressione della dittatura del proletariato. Perché dalla riva del modo di produzione capitalistico alla riva opposta, cioè l’ipotetica dittatura del proletariato proposta da Marx ed Engels, c’è di mezzo un fiume da guadare dove la forza della corrente dell’acqua è ben presente negli occhi e nella mente degli operai. Sicché il ponte da gettare per far valere le proprie esigenze risulta una nobile idea e nulla più. Perché gli operai possano pensare di guadare il fiume è necessario che si riduca la forza della corrente si prosciughi il greto, si incamminino per arrivare alla riva opposta.
Detto a chiare lettere: il moto storico del modo di produzione capitalistico ha dalla sua parte la forza delle leggi che lo “regolano”. Solo se vengono meno il proletariato si troverà costretto dalla forza delle proprie necessità a guadare il fiume, intanto prosciugato, perché saranno venuti meno i motivi che lo fecero sorgere e sviluppare.
Qual è il punto cui è arrivato il modo di produzione capitalistico? È sotto gli occhi di tutti, non ci vogliono particolari scienziati per spiegarlo:
- si è internazionalizzato e mondializzato lo scambio, non che prima non fosse internazionale, ma si è internazionalizzato a un grado di sviluppo mai raggiunto finora;
- In virtù della sua internazionalizzazione e mondializzazione ha accresciuto in modo esponenziale la concorrenza, al punto che alcuni paesi, o addirittura continenti, un tempo prede del colonialismo e imperialismo sono diventati acerrimi concorrenti dell’impero costituito dall’Occidente;
- Che i cardini su cui ruotavano le leggi moto-modo di produzione, ovvero sviluppo, accumulazione, più ricchezza, più investimenti, più sviluppo, più progresso e così, cioè l’insieme di uno straordinario movimento storico, si sta inceppando per sovrapproduzione di mezzi di produzione e merci in ogni angolo del mondo, e che a fronte di tale inceppamento si sta inceppando il meccanismo di crescita demografica, tranne che in Africa;
- Pertanto, a fronte di una maggiore produzione di mezzi di produzione e merci, si va riducendo la domanda per la decrescita demografica.
Si tratta di fenomeni che sono sotto gli occhi di tutti, anche di chi cerca di arrampicarsi sugli specchi di intelligenze artificiali e sciocchezze simili, ovvero di una nuova fase di sviluppo come fu la rivoluzione industriale nel suo passaggio dall’agricoltura.
Abbiamo una crisi in tutto l’Occidente, con epicentro gli Usa avviati verso una disgregazione e una guerra civile, con ripercussioni in Europa e nel resto del mondo proprio per le leggi dello scambio. Una crisi che le mobilitazioni dell’ultimo periodo contro il genocidio del popolo palestinese a opera dello Stato sionista di Israele proprio in Occidente hanno dato una luce chiara della sua crisi e di una presa di coscienza del disastro cui si va incontro in modo particolare per le nuove generazioni.
Il giornale il manifesto, non vede tutto questo, si vuole coprire gli occhi nella speranza che si tratti di una fase passeggera, che tutto possa riprendere come prima e meglio di prima, con una nuova fase di sviluppo e così via? Possono anche avere questo atteggiamento, ma in questo modo la storia passerà anche sotto il loro naso e procederà il suo corso.
Chi vivrà vedrà
Un caro saluto.
.









































Comments
la mia Lettera aperta al Manifesto, si completa, già nel titolo con la dizione "niente di personale".
Proprio perché di personale non ha niente.
Ho solo voluto - svenandomi, visto che sono un pensionato da 900 euro mensili, e grazie al mio sodale politico Alessio Galluppi - lanciare un sasso nello STAGNO
in cui siamo immersi, pagando una cifra non indifferente sia per il Corriere della sera che per IlFatto quotidiano.
Che al Manifesto ci lavori Tizio o Caio conta poco, anche il giornale Liberazione, e la stessa Rifondazione usufruivano di certo finanziamenti senza essere fascisti.
Dunque evitiamo questo livello di discussione, non mi è mai appartenuto.
Ripeto il mio intento: riaprire una seria riflessione teorica e politica sulla nostra storia per RILANCIARE L'INIZIATIVA PER IL NOSTRO IDEALE.
Con chi ci sta.
Michele Castaldo
Il fascista è il figlioccio di Tommaso Di Francesco, patrono di quel foglio anticomunista.
Si salvano solo due/tre giornalisti e verrebbe da chiedere cosa ci stanno a fare?
Chiaro che comprendo il bisogno di lavorare, ma forse avrebbero più possibilità il altri quotidiani