Ancora su specialismo e competenze. Una replica opportuna
di Francesco Coniglione
Questo articolo replica a quello pubblicato ieri di Di Remigio e Di Biase, Il primato della teoresi
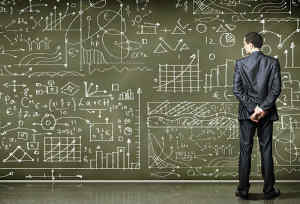 Ringrazio innanzi tutto Paolo Di Remigio e Fauste Di Biase per il loro intervento, che pone in modo intelligente alcune questioni che nel mio articolo erano rimaste sottintese e che non avevo avuto modo di approfondire visto la sua destinazione primaria (ricordo che era nato come un post su Facebook, poi ripubblicato come tale su Roars). E devo anche dire che se per un aspetto l’articolo citato richiede delle precisazioni da parte mia, per il resto non posso che essere d’accordo con i due autori nella critica che loro fanno alla “barbarie pedagogica” e alla necessità di rivendicare il ruolo della “teoresi”. E in merito potrei citare diversi miei articoli (pubblicati anche su Roars – basta scorrerne l’indice), in cui ho rivendicato le stesse cose.
Ringrazio innanzi tutto Paolo Di Remigio e Fauste Di Biase per il loro intervento, che pone in modo intelligente alcune questioni che nel mio articolo erano rimaste sottintese e che non avevo avuto modo di approfondire visto la sua destinazione primaria (ricordo che era nato come un post su Facebook, poi ripubblicato come tale su Roars). E devo anche dire che se per un aspetto l’articolo citato richiede delle precisazioni da parte mia, per il resto non posso che essere d’accordo con i due autori nella critica che loro fanno alla “barbarie pedagogica” e alla necessità di rivendicare il ruolo della “teoresi”. E in merito potrei citare diversi miei articoli (pubblicati anche su Roars – basta scorrerne l’indice), in cui ho rivendicato le stesse cose.
Ma veniamo al merito del principale rimprovero fattomi: io avrei confuso competenza e specializzazione scientifica, sicché ho trattato “il rapporto tra conoscenza e competenza come se coincidesse con il rapporto tra conoscenza universale e conoscenza particolare”. L’impressione che io abbia confuso questi due aspetti potrebbe derivare dal fatto che non li ho esplicitamente distinti, ritenendo tale opportuna differenziazione implicitamente data. Pertanto non ritengo tale omissione particolarmente grave: in fondo la conoscenza specialistica è la condizione necessaria per avere delle competenze, anche se da sola non è sufficiente.
Ed è ovvio (o almeno così pensavo fosse) che all’interno di una conoscenza generale si articolano più conoscenze particolari, che ne sono una speciazione lungo quel cammino progressivo verso la sempre maggiore specializzazione conosciuta dalla scienza nel corso del suo sviluppo storico. Quindi quando io parlo di specializzazione ho in mente questo prerequisito indispensabile, al quale si aggiunge ovviamente la vera e propria competenza, che è qualcosa di più sia rispetto alla conoscenza universale (quella ad es. del fisico teorico o generale) sia rispetto a quella particolare (quella ad es. del fisico dello stato solido).
In effetti il concetto di competenza, se sottratto alla vulgata politico-giornalistica, ha una apprezzabile e del tutto fondata genealogia epistemologica, sulla quale ho posto l’attenzione in miei passati articoli, sicché non si può dire che la introduca qui al solo scopo di replicare ai due autori. Esso affonda le sue radici nel concetto di “expertise” che è stato elaborato all’interno della riflessione sull’aspetto tacito, o appunto pragmatico, della conoscenza, e quindi sviluppato e reso applicativamente fecondo, tra l’altro, nell’ambito del management. I suoi fondamenti epistemologici sono stati posti da Kuhn col concetto di paradigma, Polanyi e Fleck con quello di “conoscenza inespressa o tacita”, per essere poi pienamente articolati da autori come Collins, Collins & Evans, Lundvall & Johnson e molti altri (ma per tutto ciò rimando al mio “Quale conoscenza per la ‘società della conoscenza’”, in Bollettino della Società filosofica italiana, 216, 2015, pp. 3-24, dove si troverà un’ampia bibliografia in merito). La questione potrebbe essere riassunta nei termini posti da Lundvall & Johnson, che distinguono diverse tipologie di conoscenza, e cioè:
- Il know-what, ovvero la conoscenza dei fatti rilevanti comunicabili come dati e trasformabili in unità discrete (in bit).
- Il know-why, ovvero la conoscenza dei principi scientifici e delle leggi che ci permettono di capire e spiegare i fenomeni di qualsiasi tipo (dalla natura, alla mente e alla società); questo tipo di conoscenza è alla base dello sviluppo tecnologico e la sua produzione è tipicamente demandata a istituzioni specializzate, come le università e i centri di ricerca, sicché le aziende che hanno bisogno di essa devono interagire con esse.
- Il know-how, ovvero le capacità (gli skills), che ci permettono di fare differenti tipi di cose a livello pratico, traducendo il know-why in concreta operatività, come ad es. il semplice saper condurre un esperimento di laboratorio.
- Il know-who (che comprende anche il know-when e il know-where) ovvero l’informazione che ci permette di reperire la persona che è in grado di risolvere il problema che abbiamo, cioè che sia in possesso del know-how o del know-why; tale tipo di informazione è peculiare ad una economia della conoscenza, nella quale l’innovazione è basata anche su peculiari processi di interazione orizzontale.
Ebbene, i primi due tipi di conoscenza sono quelli “codificabili” e in genere codificati, accessibili mediante pubblicazioni scientifiche e banche-dati, ed espressi di solito in un linguaggio standardizzato ed universale. E’ a queste che ci si riferisce quando si parla di conoscenze, che possono essere più ο meno specialistiche. Gli altri due tipi di “sapere” (per evitare di chiamarle “conoscenze”) si basano invece sull’attività pratica, sull’esperienza diretta, sull’apprendistato, sicché vengono spesso definite come “conoscenze tacite”: sono queste a costituire le competenze di cui si favoleggia tanto. Esse vengono apprese non sui “manuali” né con lezioni ex cathedra, ma nel concreto operare fianco a fianco con una persona che già le possiede, in un laboratorio e nel concreto ambito applicativo; la mia citazione di Galileo alludeva proprio a questa circostanza, ma potrei citare altri e più aggiornati autori, scienziati ed epistemologi, i quali hanno capito che la scienza non si apprende con sviolinate metodologiche, ma solo vedendo cosa fanno gli scienziati e lavorando al loro fianco, come ha sottolineato Paul Feyerabend (tanto per fare un nome noto). O, per citare un epistemologo meno noto, la scienza consiste nell’entrare in uno “stile di pensiero”, che richiede una sorta di “iniziazione” impartita da chi è già al suo interno, da chi già possiede conoscenze e competenze, in quanto «La pratica delle scienze naturali non la si può imparare da alcun libro, poiché il loro tipico modo di procedere è celato. Essa contiene tutte quelle piccole “anomalie”, dalle quali si prescinde, le “eccezioni” che dovrebbero solo confermare la regola, l’“accidentale” e l’“inessenziale”, “gli inevitabili errori”. Questi sono i modi di dire utilizzati, che stanno sempre a disposizione quando si vuole o si deve salvare la regola». Ecco perché è necessario, oltre all’insegnamento teorico, anche un vero e proprio apprendistato che ha una sorta di carattere iniziatico, concreto, in laboratorio, nel corso del quale si apprende anche a “saper vedere”: tutto ciò lo sostiene Ludwik Fleck, microbiologo ed epistemologo polacco che con la sua opera ha influenzato molto più di quanto non si creda e sappia il pensiero di Thomas Kuhn. Ed è per queste ragioni che – per tornare all’ambito a noi caro – il bravo insegnante non lo si forma impartendogli “corsi di didattica” con astratte lezioni di presunti esperti (che a loro volta la conoscono dai libri e manuali di didattica, mai in modo operativo, mai hanno messo piede in un’aula scolastica), ma affiancandolo per un periodo abbastanza lungo a un docente esperto, in una classe concreta (il “laboratorio”) e vedendo cosa questi fa e come interagisce e propone le proprie conoscenze. Si potrebbe continuare a lungo su questo tema, ma ritengo che queste cose Di Remigio e De Biase le sanno bene e le ho ricordate solo perché non si pensi che sia io a sconoscerle.
Detto ciò, bisogna però sottolineare il fatto che le “competenze” non potrebbero aver luogo, e sarebbero del tutto “cieche”, se non edificate sulla base di una preesistente, solida e approfondita conoscenza, cioè e soprattutto del know-why; e lo sapeva già il giustamente richiamato Aristotele quando distingueva la techne dalla episteme. Ciò che invece si fa oggi e che si vorrebbe introdurre nelle scuole da parte di pedagogisti arraffazzonati e poco consapevoli dello spessore epistemologico e filosofico che sta alla base dei concetti che con disinvoltura utilizzano (ma per fortuna non sono tutti di tale pasta e ne conosco di bravi che, guarda caso, mai sono scelti come consulenti dai ministri e dai politici) è una competenza che salta a piè pari il momento della preparazione teorica, così come ad es. avviene nella preparazione dei docenti, ormai più incentrata sulla didattica “impartita”, laddove la conoscenza delle discipline passa sullo sfondo. È proprio ciò a dover essere oggetto di critiche, non le conoscenze specialistiche, né le competenze in quanto tali, se intese nel quadro sopra delineato.
Ma il mio articolo non voleva criticare tali concetti, quanto l’uso giornalistico, irriflesso, dogmatico e mitico del concetto di competenza, utilizzato in maniera distorto e inappropriato. E ciò ho fatto col sottolineare quanto sia difficile essere effettivamente competenti in un settore (sempre sulla base di una conoscenza specialistica solida). È per fare un esempio, Roberto Cingolani “specialista e competente” (assomma cioè ambedue i fattori sopra distinti) per l’incarico ministeriale assegnatogli? È certamente un fisico specialista in nanotecnologia e ha acquisito, su questa base, una competenza in robotica. Ma ha conoscenze e quindi competenze anche in politica ambientale e su questioni legate alle fonti energetiche alternative? È come se io ritenessi di essere competente di filologia solo perché filosofia e filologia sono entrambe discipline umanistiche e si differenziano solo per due lettere. Ecco perché ho sottolineato la necessità di una cultura vasta e informata e non tanto delle “competenze”, sempre assai difficili da trovare quando si ha a che fare con fenomeni complessi che hanno a che fare non solo con la fisica ma anche con l’economia, la sociologia, la psicologia e la storia, come è appunto quello che della transizione energetica.
E questo non è un mio ghiribizzo da umanista minacciato nel proprio orticello, ma un’esigenza che non solo è stata posta da eminenti scienziati, ma anche dai teorici del “Knowledge Management”, che appunto hanno fatto uso del concetto di “expertise”. Il guru del management giapponese Ikujiro Nonaka ha ad esempio indicato la necessità di formare nel management quel che lui ha definito il “wise leader”: piuttosto che raccomandare una preparazione specialistica in economia, business, statistica ed econometria, così come fanno anche in Italia celebrate università i cui economisti, da essa formati, non azzeccano un’analisi economica (ho fatto l’esempio della domanda della regina), Nonaka insiste sul valore della formazione nelle scienze umane e tra queste mette al primo posto la filosofia: «Infine, il giudizio può essere coltivato diventando ben versati nelle arti liberali, come la filosofia, la storia, la letteratura e le belle arti. Il management è un’arte liberale […]; liberale perché si occupa dei fondamenti della conoscenza, della cognizione del sé, della saggezza e della leadership; arte perché riguarda anche la pratica e l’applicazione. Per seguire ciò che predichiamo, qualche anno fa abbiamo lanciato a Tokyo un programma per dirigenti di alto livello il cui programma principale è costituito da Aristotele, Machiavelli, Heidegger e altri classici» (si veda su ciò il mio articolo “Contro il sapere dimezzato. Le Olimpiadi e il senso della filosofia”, su Roars del 27-05-19).
Ebbene, io mi muovo esattamente su questa linea; ecco perché quel che maggiormente temo è la scomparsa di questa cultura generale, di questa capacità di inquadrare i problemi in un contesto unitario e in un’ottica sistemica, che non può essere fornita solo da una formazione meramente specialistica o addirittura basata esclusivamente sulle “competenze”. Perché, tra l’altro, basarsi solo sulle competenze fa venire meno quella conoscenza generale che sola permette l’aggiornamento costante e quindi di essere sempre al passo con innovazioni e cambiamenti nello scenario del sapere. E ciò è tanto più pericoloso quando si tratti di avere delle responsabilità politiche: sarebbe un guaio se un politico fosse solo uno specialista o un competente; esso verrebbe a mancare di quella cultura più generale che lo mette in grado non solo di risolvere i problemi (il “problem solving” tanto caro al moderno didattichese), ma di inquadrarli in un contesto più ampio e soprattutto di interagire con le altre persone, che hanno conoscenze e formazione diversa e con i quali deve essere in grado di parlare, che deve intendere e dei quali deve tener conto.
Infine concludo con un osservazione metodologica: in un breve articolo v’è spesso molto di più di quanto è esplicitamente scritto, che è solo la punta di un iceberg che affonda nel non-detto, nell’implicito (la “conoscenza tacita”, giustappunto), sul cui sfondo esso trova piena intelligibilità e legittimità e che l’autore omette per una questione di economia del discorso. Di solito delle indicazioni su ciò sono poste in quelle barbosissime note che corredano gli articoli scientifici; ma su internet e in una sede come Roars è bene evitare ciò, anche per non atteggiarsi a “maestrino del pensiero”, cosa che in genere evito accuratamente di fare. Per cui è benvenuta la possibilità di chiarire ulteriormente il proprio pensiero. Tuttavia è bene aver sempre presente quel “principio di carità” ermeneutica raccomandato da un altro grande epistemologo W.v.O. Quine e poi fatto proprio da Donald Davidson e Richard Rorty.
































Gentile prof. Coniglione,
apprezziamo molto la Sua risposta e le precisazioni con cui arricchisce la discussione. Più della confusione tra il concetto di competenza e quello di specializzazione, ci preoccupava il pericolo che passasse inosservato l’uso oscurantistico che di ‘competenza’ si fa nelle scuole. Lei ha ragione a ricordarci che questo esorbitava dal tema del Suo articolo, ma noi siamo ossessionati dall’urgenza di ricordare che le scuole italiane continuano a essere umiliate da un fanatismo pseudopedagogico che impone di raggiungere imprecisate competenze SENZA conoscenze, in ossequio a un pragmatismo primitivo. E ricordarlo ci sembra tuttora urgente. Sfogliando il volumetto che ha appena pubblicato, scopriamo che per il min. Bianchi la scuola non serve «a raccattare (proprio così: raccattare) informazioni», che non deve essere «un serbatoio (proprio così: serbatoio) di conoscenze», che finalmente è «liberata (proprio così: liberata) dall’obbligo di fornire soprattutto nozioni». Peraltro il ministro sembra aver oltrepassato non solo l’esigenza della teoresi, ma anche quella delle competenze: leggiamo che rinnovandosi di nuovo, la nuova scuola deve ricercare e potenziare «quelle attività che alla competenza aggiungono un carattere di ritrovata socialità». Il ministro le sintetizza «con l’acronimo CAMPUS (Computer/Coding, Arte, Musica, Polis, Sport)». Quasi temendo che «Computer/Coding» possa emettere suono troppo duro per i lettori, il ministro precisa che computer va inteso come «principale mezzo di socializzazione dei millennials» e coding va inteso da una parte come soluzione di problemi complessi, dall’altra come «esplorazione anche giocosa della logica computazionale». Il min. Bianchi è dunque passato dall’orientamento anti teorico, ma pragmatista, all’orientamento anti teorico, anti pragmatista e LUDICO. Non poteva essere diversamente: competenza senza conoscenza è una burla; chi si abitua a praticarla alla fine non può più fermarsi.
P. Di Remigio e F. Di Biase