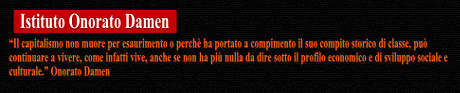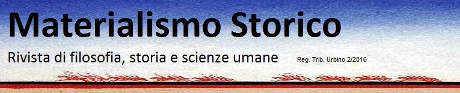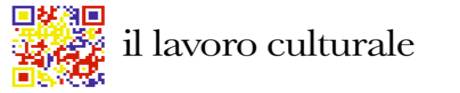Fai una donazione
Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________
- Details
- Hits: 1209
Uno si divide in due
di Alain Badiou
In Il secolo, Cap. 6, 7 - aprile 1999
 Il secolo, dunque, non è in alcun modo un secolo di “ideologie” nel senso dell’immaginario e delle utopie. La sua determinazione soggettiva principale è la passione del reale, di ciò che è immediatamente praticabile qui e ora. Abbiamo dimostrato che l’importanza della finzione non è che una conseguenza di tale passione.
Il secolo, dunque, non è in alcun modo un secolo di “ideologie” nel senso dell’immaginario e delle utopie. La sua determinazione soggettiva principale è la passione del reale, di ciò che è immediatamente praticabile qui e ora. Abbiamo dimostrato che l’importanza della finzione non è che una conseguenza di tale passione.
Che cosa dice il secolo, a proposito del secolo? Che, in ogni caso, non si tratta del secolo della promessa, ma del compimento. È il secolo dell’atto, dell’effettivo, del presente assoluto, non quello dell’annuncio e dell’avvenire. Dopo millenni di tentativi e di insuccessi, il secolo vive se stesso come il secolo delle vittorie. È al secolo precedente, all’infelice romanticismo del xix secolo che gli attori del xx riservano il culto del tentativo vano e sublime, e quindi l’asservimento ideologico. Il xx dice: basta con i fallimenti, è l’ora delle vittorie! Questa soggettività vittoriosa sopravvive a tutte le apparenti disfatte, in quanto non è empirica, ma costituente. La vittoria è il motivo trascendentale che organizza il fallimento stesso. Uno dei nomi di tale motivo è “rivoluzione”. La rivoluzione d’Ottobre, le rivoluzioni cinesi e cubana, e poi le vittorie degli algerini e dei vietnamiti nelle lotte di liberazione nazionale valgono tutte come prova empirica del motivo e sconfiggono i fallimenti, riparano i massacri del giugno 1848 o della Comune di Parigi.
Il mezzo della vittoria è la lucidità, teorica e pratica, nei riguardi di uno scontro decisivo, di una guerra finale e totale. Dal fatto che tale guerra sia totale deriva che la vittoria sia veramente vittoriosa.
- Details
- Hits: 1927

Specchi lontani e vicini: la malattia come evento e come rappresentazione
di Eros Barone
 Qui mira e qui ti specchia, / secol superbo e sciocco, / che il calle insino allora / dal risorto pensier segnato innanti / abbandonasti, e volti addietro i passi, / del ritornar ti vanti, / e procedere il chiami. / Al tuo pargoleggiar gl’ingegni tutti, / di cui lor sorte rea padre ti fece, / vanno adulando, ancora / ch’a ludibrio talora / t’abbian fra sé... libertà vai sognando, e servo a un tempo / vuoi di nuovo il pensiero...
Qui mira e qui ti specchia, / secol superbo e sciocco, / che il calle insino allora / dal risorto pensier segnato innanti / abbandonasti, e volti addietro i passi, / del ritornar ti vanti, / e procedere il chiami. / Al tuo pargoleggiar gl’ingegni tutti, / di cui lor sorte rea padre ti fece, / vanno adulando, ancora / ch’a ludibrio talora / t’abbian fra sé... libertà vai sognando, e servo a un tempo / vuoi di nuovo il pensiero...
Giacomo Leopardi, Da La ginestra.1
1. Una storia, più storie
La diffusione del coronavirus e il clima di allarme e di mobilitazione che il fenomeno in corso sta scatenando nel mondo e segnatamente nel nostro paese costringe a riconoscere nell’esperienza della malattia una dimensione largamente presente, e quindi cruciale, nella vita delle generazioni umane. In effetti, chi si avvicina alla storia del passato è inesorabilmente colpito dall’onnipotenza della malattia. Essa, del resto, ha sempre costituito uno dei passaggi obbligati della narrazione storica e della reinvenzione letteraria, da Tucidide ai cronisti medievali, da Boccaccio al Manzoni, senza dimenticare due classici del Novecento come La montagna incantata di Thomas Mann e La peste di Albert Camus.
Manifestazione del male e nel contempo inquietante metafora del male, la malattia rappresenta e simboleggia quel sentimento di insicurezza che, già ben presente e radicato nelle età antica, medievale e moderna, costituisce, ad onta delle rimozioni e a dispetto della scotomizzazione, il fulcro della sensibilità contemporanea nell’epoca del tardo capitalismo e della sua cronica “crisi generale”.
Endemica debolezza fisica, epidemie, pandemie, tubercolosi, malaria, malattie della pelle e malattie nervose, malformazioni di tutti i generi, mutilazioni, e, su tutto, la peste e la lebbra: la storia di queste fattispecie nosologiche è connessa in modo inestricabile con quella delle società, ed è un intreccio molteplice.
- Details
- Hits: 2326
Documento preparatorio della Tesi sul socialismo del XXI secolo
di Carlo Formenti e Alessandro Visalli
Contributi e revisioni: Andrea Zhok, Mimmo Porcaro, Onofrio Romano, Thomas Fazi
 1. Socialismo o barbarie
1. Socialismo o barbarie
Viviamo una fase storica in cui il socialismo appare, al tempo stesso, impossibile e necessario. Mentre la prospettiva socialista sembra oscurata da secoli di errori politici, teorici e culturali, l’alternativa socialismo o barbarie non è mai stata attuale come oggi. Questo perché quarant’anni di rivoluzione neoliberista hanno trascinato il mondo sull’orlo del collasso economico, politico, sociale e ambientale. Il capitalismo contemporaneo, in misura superiore a tutte le forme che lo hanno preceduto, distrugge a ritmo accelerato ogni struttura sociale e comunitaria, fino alle famiglie e agli stessi individui; genera disuguaglianze crescenti, che crescono su se stesse fino ad assumere proporzioni intollerabili; appiattisce il potere politico sul potere economico, distruggendo i fondamenti della democrazia; sconvolge l’ambiente in misura tale da minacciarne le condizioni di compatibilità con la specie umana.
Il combinato disposto della rivoluzione tecnologica – in particolare nei settori della comunicazione, dei trasporti, dell’intelligenza artificiale e della robotica industriale -, della deregulation finanziaria e della globalizzazione dei mercati di merci, forza lavoro e capitali genera effetti devastanti sulle condizioni di lavoro e di vita di miliardi di esseri umani. In tutto il mondo sono in atto “riforme” del lavoro che prevedono la riduzione delle tutele dal licenziamento, la proliferazione di mercati del lavoro che contemplano livelli diversi di tutele giuridiche, sanitarie, infortunistiche, assistenziali, ecc. dei lavoratori, l’autorizzazione di forme di lavoro precarie e a bassa retribuzione, l’accettazione di elevati tassi di disoccupazione, il depotenziamento dei diritti sindacali e la conseguente decontrattualizzazione dei rapporti di lavoro.
- Details
- Hits: 1164
I fantasmi di una recessione prossima ventura
Le sue implicazioni sul piano di classe e su quello internazionale
di Gianfranco Greco
 L’incendio della Grenfell Tower è la tragedia che ha riguardato un grattacielo, o meglio un termitaio, in cui erano accatestati/alloggiati poveri, immigrati, gente comune che ha avuto origine dall’incendio, nel 2017, di pannelli altamente infiammabili che costituivano il rivestimento esterno del medesimo grattacielo, pannelli il cui utilizzo – dato tristemente rilevante – consentiva un miserevole risparmio di 2,5 euro a metro quadro ma che – a causa della loro pericolosità – erano stati già banditi dal resto d’Europa. Al tirar delle somme quello spregevole risparmio, in linea con le regole auree dell’economia borghese, ha avuto quale tragico corrispettivo la morte di 78 persone.
L’incendio della Grenfell Tower è la tragedia che ha riguardato un grattacielo, o meglio un termitaio, in cui erano accatestati/alloggiati poveri, immigrati, gente comune che ha avuto origine dall’incendio, nel 2017, di pannelli altamente infiammabili che costituivano il rivestimento esterno del medesimo grattacielo, pannelli il cui utilizzo – dato tristemente rilevante – consentiva un miserevole risparmio di 2,5 euro a metro quadro ma che – a causa della loro pericolosità – erano stati già banditi dal resto d’Europa. Al tirar delle somme quello spregevole risparmio, in linea con le regole auree dell’economia borghese, ha avuto quale tragico corrispettivo la morte di 78 persone.
Il fattaccio della Grenfell Tower emblemizza, con cruda trasparenza, le crescenti criticità che involgono una realtà britannica tutta sospesa all’interno di una stucchevole pantomima, la Brexit, che, contrariamente ai desiderata di settori della borghesia britannica che hanno sempre considerato il permanere del Regno Unito nella UE come fastidioso orpello capace di mortificare i sogni degli hardbrexiters, tutti presi a favoleggiare di una “Singapore on Thames”, ossia un regno della finanza ultra-liberista completamente avulso da regole sul lavoro e sull’ambiente, è rimasta impantanata in tutta una serie di problemi, risolti i quali ne sorgerebbero – come per le teste dell’Idra di Lerna – altri ancora. Stando a tale scenario Londra metterebbe a profitto la fuoriuscita dall’Unione europea attestandosi quale spazio di intermediazione tra il sistema finanziario Usa e società della UE il cui preminente obiettivo sarebbe l’accesso ai mercati statunitensi.
- Details
- Hits: 2123
Quale Karl Polanyi?
di Michele Cangiani
Negli ultimi anni, è potentemente ripresa a livello scientifico la discussione sull'eredità di Karl Polanyi. Ma la maggior parte dei suoi interpreti contemporanei elude la questione, fondamentale per lui, delle caratteristiche più generali che distinguono la società contemporanea. È da qui, però, che bisognerebbe ripartire
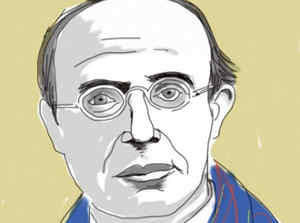 Tempo di crisi
Tempo di crisi
A un giornalista, che nel settembre 2007 gli chiedeva quale candidato preferisse per la presidenza degli Stati Uniti, Alan Greenspan, Presidente della Federal Reserve fino all’anno precedente, rispose che non importava molto: «Il mondo è governato dalle forze di mercato»[1]. Con quali risultati? Era in vista la crisi, che tuttora non si può dire superata. Teoria e pratica neoliberali restano in auge, benché dannose per l’ambiente umano e naturale e persino controproducenti rispetto al loro scopo “economico”. Continua, infatti, ad essere stentata e precaria la ripresa dell’accumulazione capitalistica, anche perché la svalutazione globale della forza lavoro e l’aumento della quota di reddito assorbita dalle rendite, finanziarie ma non solo, hanno un vantaggio immediato, ma poi un effetto deflattivo. Inoltre, la “crescita” sempre auspicata si scontra con quei «limiti dello sviluppo»[2], che non sono più una previsione, ma una realtà.
C’è chi parla di crisi ‘sistemica’ e chi ricorre a Karl Marx (Il Capitale, L. III) per spiegarla. Ben più assiduo riferimento viene fatto all’opera di Karl Polanyi, la fortuna del quale ha continuato a crescere nel tempo della nostra sfortuna, a partire dalla crisi degli anni 1970 e soprattutto con il successivo affermarsi della globalizzazione neoliberista.
La sensazione che i tentativi di superare le difficoltà in cui la nostra società si trova siano poco efficaci o addirittura controproducenti porta alla questione cruciale, rappresentabile con una metafora cibernetica: se correggendo la mira l’errore aumenta, è il sistema di puntamento che va modificato. Ma come? In The Great Transformation (1944)[3], Polanyi sostiene che la crisi del capitalismo liberale (ottocentesco, «vittoriano») era inevitabile e definitiva.
- Details
- Hits: 2556
La trasformazione dei valori in prezzi di produzione
Il capitolo IX del Terzo libro del Capitale
di Giorgio Bellucci
Materialismo Storico. Rivista semestrale di filosofia, storia e scienze umane è una pubblicazione dell'Università di Urbino con il patrocinio della Internationale Gesellschaft Hegel-Marx, n. 1 2019
 I.
I.
Sono passati più di 120 anni dall’uscita del III libro del Capitale di Marx a cura di F. Engels. Fin da subito, quel testo fu oggetto e bersaglio delle più forti critiche, da destra e da sinistra, da parte di tutte le più varie specie di economisti e filosofi, da parte di antimarxisti come da parte di marxisti eterodossi, ortodossi, rinnovatori o riformisti. Per onestà intellettuale bisogna riconoscere che una tale sequela, lunga più di un secolo, non ha eguali in letteratura né in economia.
Delle molte soluzioni che si sono tentate di dare al famoso problema della trasformazione dei valori in prezzi di produzione, si può discettare quale sia, o possa essere, la più vicina all’originale; nessuna però, in ogni caso, si presenta basata sui calcoli del Capitolo nono o sui ragionamenti impliciti ed espliciti dello stesso capitolo. La materia è dunque ancora incandescente e da parte degli studiosi, accademici o meno, il rischio di scottarsi è sempre alto.
Sono convinto da tempo che se anche si trovasse una soluzione logicamente coerente al problema della trasformazione, essa non sarebbe comunque considerata valida e validante ai fini dell’interpretazione della società capitalistica. Sono anzi convinto che essa scatenerebbe ulteriore livore verso l’opera di Marx. D’altronde, le continue accuse di falso che percorrono le pagine di Bortkievicz o di Steedman stanno lì a dimostrarlo. Come già avvenuto in passato, quando alcuni pezzi dell’intellettualità marxista e di quella keynesiana attribuirono addirittura a Marx e al suo esercito industriale di riserva le radici analitiche alla base delle teorie dell’inflazione legate alla curva di Philips, anche oggi la storia potrebbe ripetersi.
- Details
- Hits: 4671
Rosa Luxemburg, teorica marxiana dell’economia e della politica
di Riccardo Bellofiore
[Dal numero monografico dedicato a Rosa Luxemburg dalla rivista «Alternative per il socialismo», n. 56, dicembre 2019/marzo 2020]
 «Qualche sentimentale piangerà che dei marxisti bisticcino fra loro, che ‘autorità’ provate siano messe in discussione. Ma il marxismo non è una dozzina di persone che si distribuiscano a vicenda il diritto alla ‘competenza’, e di fronte alle quali la massa dei pii musulmani debba inchinarsi in cieca fede. Il marxismo è una dottrina rivoluzionaria che lotta per sempre nuove conquiste della conoscenza, che da nulla aborre più che dalle formule valide una volta per tutte, che mantiene viva la sua forza nel clangore delle armi incrociate dell’autocritica e nei fulmini della storia.» (Rosa Luxemburg, 1916)
«Qualche sentimentale piangerà che dei marxisti bisticcino fra loro, che ‘autorità’ provate siano messe in discussione. Ma il marxismo non è una dozzina di persone che si distribuiscano a vicenda il diritto alla ‘competenza’, e di fronte alle quali la massa dei pii musulmani debba inchinarsi in cieca fede. Il marxismo è una dottrina rivoluzionaria che lotta per sempre nuove conquiste della conoscenza, che da nulla aborre più che dalle formule valide una volta per tutte, che mantiene viva la sua forza nel clangore delle armi incrociate dell’autocritica e nei fulmini della storia.» (Rosa Luxemburg, 1916)
Sono trascorsi cento anni dall’assassinio di Rosa Luxemburg. Ecco che si sono svolte numerose iniziative per ricordarne la figura, è stato pubblicato qualche volume, o qualche articolo di rivista. Certo, nulla a che vedere con la doppia ricorrenza marxiana che abbiamo alle spalle (due anni fa, il cento- cinquantenario della pubblicazione della prima edizione del Capitale, l’anno scorso duecento anni dalla nascita di Karl Marx). Nel caso di Rosa Luxemburg, comprensibilmente (ma pur sempre discutibilmente) il fuoco eè stato sulla figura personale e politica, non sulla teorica, tanto meno sulla Luxemburg economista. Il che, dal mio punto di vista, è una mutilazione che cancella il centro della figura che si vuole ricordare, e in fondo rende concreto il rischio di disperderne l’eredità.
Mi proverò allora a ripercorrerne la riflessione guardando agli scritti economici e politici, oltre gli stereotipi. Si comincerà dalla Luxemburg marxista, per approdare alla Luxemburg marxiana, che ci interroga ancora oggi. Dovrò procedere un po’ con l’accetta, rimandando per un approfondimento a miei altri scritti, che saccheggerò qua e là.
Gli inizi: ristagno e crisi nel marxismo
Rosa Luxemburg nasce il 5 marzo 1871. Formalmente, la sua istruzione universitaria, un vero e proprio dottorato, fu a Zurigo (dov’era emigrata nel 1889), in legge ed economia, dopo iniziali studi in filosofia, scienze naturali e matematica.
- Details
- Hits: 973
La questione ambientale
di Ascanio Bernardeschi
Pubblichiamo la relazione introduttiva di Ascanio Bernardeschi al seminario promosso dell’Associazione la Rossa
 L’impegno, e l’auspicio di riuscirci, è che questo sia un primo seminario promosso dell’Associazione la Rossa per poter discutere, con maggiore possibilità di approfondimento di quanto possa avvenire nei pur interessanti, tradizionali dibattiti nelle feste rosse, di questioni della massima rilevanza.
L’impegno, e l’auspicio di riuscirci, è che questo sia un primo seminario promosso dell’Associazione la Rossa per poter discutere, con maggiore possibilità di approfondimento di quanto possa avvenire nei pur interessanti, tradizionali dibattiti nelle feste rosse, di questioni della massima rilevanza.
E la questione dell’ambiente e del clima ha la massima importanza, se si pensa che il doomsday clock, la lancetta virtuale che simboleggia la distanzia dalla catastrofe del pianeta, la quale nel 1947 indicava 7 minuti alla fine del mondo, oggi indica 100 secondi. Abbiamo cioè consumato abbondantemente ¾ del tempo a disposizione. Il motivo di tale pericoloso avvicinamento è dato sia dal rischio di un conflitto disastroso, sia dai rapidi cambiamenti climatici in atto. Le due cause hanno fra di loro una forte correlazione.
A noi non interessa interloquire con i negazionisti ma con chi, anche da posizioni diverse dalle nostre, prende atto del problema e si pone l’obiettivo di risolverlo.
Però, se va crescendo la consapevolezza della concretezza del problema, non è così per le cause e i rimedi, anche a causa di tesi massicciamente divulgate quanto fuorvianti, talvolta per insufficienza analitica, altre per deliberata scelta.
A fine gennaio, per esempio, mi sono imbattuto nel Manifesto di Assisi per un’economia a misura d’uomo contro la crisi climatica, un documento che ha raccolto ben 2 mila adesioni fra istituzioni, mondo economico, politico, religioso ecc. Fra i promotori, oltre al solito “ambientalista” embedded (nel senso di arruolato al sistema), Ermete Relacci, ed esponenti della Chiesa cattolica, vi figurano i presidenti di Coldiretti e Confindustria e gli amministratori delegati di Enel e Novamont. La compagnia è già di per sé eloquente.
- Details
- Hits: 1499
Il disastro della nuova scuola
E il compito di restaurare l’istruzione pubblica
di Paolo Di Remigio, Fausto Di Biase
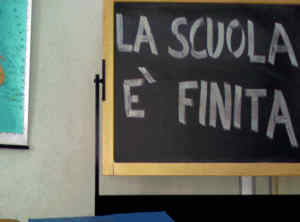 Le riforme attuate nella scuola italiana ed europea negli ultimi trent’anni contrastano in modo così risoluto con la natura della didattica da poter essere comprese soltanto come effetti del contemporaneo rivolgimento politico. Sconfitto l’«impero del male», l’oligarchia economica occidentale, quella che ispira i documenti degli organismi internazionali e parla attraverso i giornali, ha potuto finalmente rompere l’alleanza più onerosa, quella con le masse; ha dunque indebolito gli Stati e sottratto loro il controllo delle banche centrali per indebitarli e abbattere la spesa sociale, e ha introdotto la mobilità dei capitali, delle merci e delle persone per colpire il lavoro. Il diffondersi della disoccupazione ha falcidiato i salari, precarizzato i contratti dei lavoratori e annientato le loro organizzazioni. Sindacalisti e politici di sinistra hanno però conservato la loro professione – cambiando schieramento: li ha captati l’oligarchia perché la loro influenza sui lavoratori li rendeva utili a sopire le resistenze. Da allora progressisti e rivoluzionari dissimulano con la lotta contro l’eterno fascismo e per i diritti umani la loro complicità in un attacco al lavoro pari soltanto a quello avvenuto durante il vero fascismo[1].
Le riforme attuate nella scuola italiana ed europea negli ultimi trent’anni contrastano in modo così risoluto con la natura della didattica da poter essere comprese soltanto come effetti del contemporaneo rivolgimento politico. Sconfitto l’«impero del male», l’oligarchia economica occidentale, quella che ispira i documenti degli organismi internazionali e parla attraverso i giornali, ha potuto finalmente rompere l’alleanza più onerosa, quella con le masse; ha dunque indebolito gli Stati e sottratto loro il controllo delle banche centrali per indebitarli e abbattere la spesa sociale, e ha introdotto la mobilità dei capitali, delle merci e delle persone per colpire il lavoro. Il diffondersi della disoccupazione ha falcidiato i salari, precarizzato i contratti dei lavoratori e annientato le loro organizzazioni. Sindacalisti e politici di sinistra hanno però conservato la loro professione – cambiando schieramento: li ha captati l’oligarchia perché la loro influenza sui lavoratori li rendeva utili a sopire le resistenze. Da allora progressisti e rivoluzionari dissimulano con la lotta contro l’eterno fascismo e per i diritti umani la loro complicità in un attacco al lavoro pari soltanto a quello avvenuto durante il vero fascismo[1].
La sicurezza economica dei lavoratori per un lato dipende dall’azione dello Stato per realizzare la piena occupazione, per l’altro è condizione della famiglia. Le oligarchie non potevano realizzare il loro piano generale di precarizzazione[2] senza inserirvi la scuola, che si colloca tra famiglia e Stato. Così l’hanno separata da quest’ultimo per assoggettarla agli organismi internazionali, l’hanno denigrata con la propaganda e demoralizzata con lo stillicidio delle riforme perché gli abbienti si rivolgessero all’istruzione privata; inoltre le è stato prescritto di invadere le competenze della famiglia occidentale votata all’estinzione[3] e di educare ai valori della nuova società multietnica; infine è stata costretta a organizzare il tirocinio per il lavoro precario.
- Details
- Hits: 2109
Coronavirus, cronache del crollo
di Alessandro Visalli
 8 marzo 2020, ore 18.00, Napoli, Italia.
8 marzo 2020, ore 18.00, Napoli, Italia.
Una professoressa dei miei due figli potrebbe essere contagiata, o almeno lo teme. Un suo compagno ha un caso nel palazzo di casa e un altro, di un’altra classe, risulta positivo. Ma in Campania quasi un giorno fa risultavano meno di novanta casi.
Nel mondo cento paesi risultano[1] contagiati, in Cina si è arrivati al picco di circa ottantamila casi ma ora è in fortissimo calo, in Corea del Sud ci sono oltre settemila casi, in Italia più di seimila probabilmente, l’Iran ha quattromisettecento casi, seguono la Germania con seicentotrentanove casi, la Francia con seicentotredici, il Giappone con quattrocento, la Spagna con trecentosettanta, la Svizzera con duecento, gli Stati Uniti con duecentotredici casi, il Regno Unito con centosessanta, e via dicendo. In tutto circa centomila casi nel mondo e tremilacinquecento morti.
Obiettivamente, se fosse questo, sarebbe un’inezia.
Ma quel che conta sono due cose: ieri in Italia c’erano oltre mille casi in meno, e ovunque, salvo in Cina, l’andamento quando è monitorato è in crescita esponenziale; una parte dei casi rilevati, uno su cinque, sviluppa complicazioni polmonari serie o gravi e la metà deve essere ricoverato in terapia intensiva pena una rapida morte per asfissia.
Quanti sono uno su dieci? Troppi.
Prendiamo la celebrata sanità italiana: sessanta milioni di abitanti, al vertice insieme a Germania e Giappone della classifica delle popolazioni più anziane; centocinquantamila posti letto pubblici e quarantamila privati; ma solo cinquemila al massimo abilitati per la terapia intensiva per la quale bisogna avere, oltre alle attrezzature mediche, un medico specializzato e due infermieri specializzati per ogni quattro posti letto. Complessivamente si stima che sono impegnati fino a quindici addetti per ogni persona in grave rischio di vita.
- Details
- Hits: 1702
Didier Eribon, Ritorno a Reims
Consigli (o sconsigli) per gli acquisti
di Militant
 A volte capita di imbattersi senza nemmeno volerlo in libri che si rivelano molto più interessanti di quanto non si immaginasse quando li si è presi in mano. Ritorno a Reims, di Didier Eribon e pubblicato in Italia nel 2017 per i tipi della Bompiani è sicuramente uno di quei casi. Si tratta di un lavoro difficilmente catalogabile perché lo si potrebbe approcciare come un piccolo saggio di sociologia sulle trasformazioni delle classi popolari francesi, oppure, senza per questo sbagliare, potrebbe essere letto tranquillamente come l’autobiografia di un proletario cresciuto in un ambiente pieno di pregiudizi che si ferma a riflettere sulla propria omosessualità e sul percorso di soggettivazione e “reinvenzione di sé” che l’ha portato a scappare dall’ambiente sociale della sua infanzia e della sua adolescenza, fino a farne, come lui stesso si definisce, un “transfugo di classe”. A ben vedere, però, la definizione che più si addice a questo libro è quella data dallo stesso Eribon: un’analisi storica e teorica fortemente ancorata, però, ad un’esperienza personale. La morte del padre, che non vedeva ormai da anni, spinge infatti l’autore ad intraprendere un viaggio di ritorno verso quel “periurbano imposto”, quello spazio istituito della segregazione urbana e sociale in cui sono stati spinti a vivere i suoi genitori, due operai di tradizione comunista che nella loro vita avevano avuto la fabbrica come unico orizzonte sociale possibile.
A volte capita di imbattersi senza nemmeno volerlo in libri che si rivelano molto più interessanti di quanto non si immaginasse quando li si è presi in mano. Ritorno a Reims, di Didier Eribon e pubblicato in Italia nel 2017 per i tipi della Bompiani è sicuramente uno di quei casi. Si tratta di un lavoro difficilmente catalogabile perché lo si potrebbe approcciare come un piccolo saggio di sociologia sulle trasformazioni delle classi popolari francesi, oppure, senza per questo sbagliare, potrebbe essere letto tranquillamente come l’autobiografia di un proletario cresciuto in un ambiente pieno di pregiudizi che si ferma a riflettere sulla propria omosessualità e sul percorso di soggettivazione e “reinvenzione di sé” che l’ha portato a scappare dall’ambiente sociale della sua infanzia e della sua adolescenza, fino a farne, come lui stesso si definisce, un “transfugo di classe”. A ben vedere, però, la definizione che più si addice a questo libro è quella data dallo stesso Eribon: un’analisi storica e teorica fortemente ancorata, però, ad un’esperienza personale. La morte del padre, che non vedeva ormai da anni, spinge infatti l’autore ad intraprendere un viaggio di ritorno verso quel “periurbano imposto”, quello spazio istituito della segregazione urbana e sociale in cui sono stati spinti a vivere i suoi genitori, due operai di tradizione comunista che nella loro vita avevano avuto la fabbrica come unico orizzonte sociale possibile.
- Details
- Hits: 1610
Althusser e l’Ideologia
di Bollettino Culturale
 Viviamo in un mondo dominato da un modo particolare di vedere, in cui le opinioni neoliberali, socialmente autoritarie e pro-capitaliste sono date per scontate dalla maggior parte della popolazione, almeno in alcune parti del mondo. Questo fenomeno, indicato come «ideologia» nella teoria marxista, è il campo principale in cui Louis Althusser è rilevante.
Viviamo in un mondo dominato da un modo particolare di vedere, in cui le opinioni neoliberali, socialmente autoritarie e pro-capitaliste sono date per scontate dalla maggior parte della popolazione, almeno in alcune parti del mondo. Questo fenomeno, indicato come «ideologia» nella teoria marxista, è il campo principale in cui Louis Althusser è rilevante.
Sebbene non sia più ampiamente studiato nei corsi universitari, lo strutturalista marxista Althusser ha avuto una grande influenza sia sulla teoria critica, sia sullo sviluppo del marxismo dagli anni ’70. Badiou, Ranciere e Balibar sono tra i suoi seguaci più noti, Laclau e Castells sono tra i suoi ex allievi e Spivak, Žižek, Foucault e Negri mostrano tutti forti segni della sua influenza.
È diventato fuori moda per una serie di ragioni, alcune biografiche, altre teoriche. Tuttavia, essere fuori moda non implica necessariamente essere meno rilevanti. La teoria dell’ideologia di Althusser continua a fornire spunti sul funzionamento di un discorso dominante sempre più chiuso, anche se, come suggerito di seguito, presenta anche difficoltà fondamentali.
La funzione dell’ideologia
Per capire il lavoro di Althusser, è necessario dare un senso al modo in cui usa le idee della struttura sociale. Althusser è un teorico sincronico, non diacronico. Ciò significa che, anziché guardare alle origini storiche degli aspetti della struttura sociale, osserva come si adattano insieme in un sistema, le funzioni che svolgono e come possono essere ricostruiti teoricamente come escrescenze della logica sottostante del sistema.
- Details
- Hits: 970
Il ritorno della questione salariale
di Luca Casarotti
Una recensione a “Basta salari da fame!” di Marta e Simone Fana
 A due anni da Non è lavoro, è sfruttamento (già recensito qui su Lavoro Culturale), Laterza pubblica Basta salari da fame! (2019, pp. XX-172). L’accostamento dei titoli è sufficiente a segnalare che i due libri sono tra loro in rapporto di stretta parentela. Non solo perché Marta Fana è autrice del primo e coautrice – con il fratello Simone – del secondo, ma anche perché comune è il tema affrontato: i modi in cui si dà lo sfruttamento della classe lavoratrice, in Italia e non solo. Se il pamphlet del 2017 era soprattutto una fenomenologia del qui e ora, il saggio del 2019 mantiene il focus sull’attualità, ma imprime alla critica dello stato delle cose la profondità della prospettiva storica. L’obiettivo è rompere la gabbia del “non ci sono alternative”, ossia rispondere con gli strumenti del materialismo storico alla naturalizzazione del presente. O meglio, di un’idea del presente, quella condensata nell’ubiqua massima (d’autore incerto) secondo cui è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Una naturalizzazione che si è sentita evocare a più riprese in occasione dei trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino, e che non è affatto nuova. È anzi piuttosto datata: il libro che ne rappresenta il manifesto filosofico politico, The End of History and the Last Man di Francis Fukuyama, risale al 1991), ma riprende in buona sostanza Kojève, il quale a sua volta interpretava, forse unilateralmente, Hegel. Come che sia, è poca cosa accontentarsi di constatare quanto può essere vecchia e teoricamente insostenibile l’idea di un capitalismo naturalizzato, perché è su quest’idea (non a caso strenuamente difesa dal suo cantore, a costo d’introdurre caveat e fare concessioni ai critici) che si continuano a giustificare la realtà dei rapporti di produzione e le radicali ineguaglianze che ne sono il fondamento e il prodotto.
A due anni da Non è lavoro, è sfruttamento (già recensito qui su Lavoro Culturale), Laterza pubblica Basta salari da fame! (2019, pp. XX-172). L’accostamento dei titoli è sufficiente a segnalare che i due libri sono tra loro in rapporto di stretta parentela. Non solo perché Marta Fana è autrice del primo e coautrice – con il fratello Simone – del secondo, ma anche perché comune è il tema affrontato: i modi in cui si dà lo sfruttamento della classe lavoratrice, in Italia e non solo. Se il pamphlet del 2017 era soprattutto una fenomenologia del qui e ora, il saggio del 2019 mantiene il focus sull’attualità, ma imprime alla critica dello stato delle cose la profondità della prospettiva storica. L’obiettivo è rompere la gabbia del “non ci sono alternative”, ossia rispondere con gli strumenti del materialismo storico alla naturalizzazione del presente. O meglio, di un’idea del presente, quella condensata nell’ubiqua massima (d’autore incerto) secondo cui è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Una naturalizzazione che si è sentita evocare a più riprese in occasione dei trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino, e che non è affatto nuova. È anzi piuttosto datata: il libro che ne rappresenta il manifesto filosofico politico, The End of History and the Last Man di Francis Fukuyama, risale al 1991), ma riprende in buona sostanza Kojève, il quale a sua volta interpretava, forse unilateralmente, Hegel. Come che sia, è poca cosa accontentarsi di constatare quanto può essere vecchia e teoricamente insostenibile l’idea di un capitalismo naturalizzato, perché è su quest’idea (non a caso strenuamente difesa dal suo cantore, a costo d’introdurre caveat e fare concessioni ai critici) che si continuano a giustificare la realtà dei rapporti di produzione e le radicali ineguaglianze che ne sono il fondamento e il prodotto.
- Details
- Hits: 2351
Rapporto Oms. Come la Cina sta vincendo il virus
di Redazione Contropiano
 E voi “godetevi” la sanità privata e regionalizzata…
E voi “godetevi” la sanità privata e regionalizzata…
Una Commissione internazionale di esperti virologi, diversi dei quali statunitensi, è stata inviata in Cina dall’Organizzazione mondiale della sanità. Il loro rapporto finale, dopo un approfondito esame della situazione sanitaria in loco, è un poco meno che entusiastico.
Apprezzato tutto, dalle misure prese per il confinamento (decine di milioni di persone chiuse in casa) allo sforzo inaudito per rafforzare la sanità pubblica là dove era indispensabile. Con cifre impensabili qui da noi, non solo in assoluto (che è ovvio, vista la differenza di dimensione della popolazione…), ma soprattutto in percentuale.
Emerge la superiore efficienza di un modo di concepire e organizzare la vita sociale a partire da un interesse generale. Non c’entra nulla l’ideologia, quel che conta sono le priorità fissate politicamente, ossia gli obbiettivi che devono guidare un’azione generale.
Fin dall’inizio è stato chiarissimo che l’economia avrebbe subito un colpo molto duro, con una provincia di 60 milioni di abitanti, cuore dell’industria automobilistica cinese, completamente ferma per almeno un paio di mesi.
Ma nessuno è stato licenziato per questo, al contrario che qui da noi. Il Paese prende su di sé il carico di una sua parte che si deve fermare perché la priorità è fermare la diffusione del virus. Per l’economia si provvederà dopo, concentrando anche in quel caso lo sforzo generale.
Tutto l’opposto di quel avviene da noi, in tutta Europa e ancor più negli Stati Uniti, “patria” della privatizzazione e dove un tampone in un ospedale privato costa 3.200 dollari e quindi – come ha ben sintetizzato anche Vasco Rossi – nessuno o quasi lo fa. E dunque la diffusione del virus è “libera”. Le persone vengono ospedalizzate solo quando crollano.
- Details
- Hits: 1496
Prolegomeni a una filosofia della verità
di Vox Populi
In contrapposizione al nichilismo e al prospettivismo, il compito di una filosofia dell’emancipazione è quella di lottare per qualcosa: l’esistenza di una verità ne è precondizione, per orientare la guerra contro il capitale
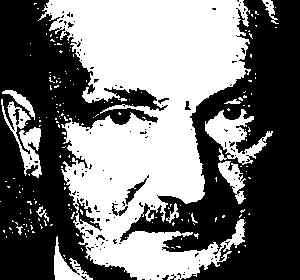 L’articolo affronta temi che orbitano intorno alla verità e al discorso in senso Foucaultiano, partendo dall’«occultamento-svelamento» di determinati aspetti della realtà, all’utilizzo dei discorsi e delle dislocazioni delle fonti di verità nella lotta di Socrate e Platone contro i sofisti e i cinici, allo scopo e ai tipi di critica (immanente e trascendente) infine alla proposta di un maggior ascolto della realtà al fine di potersi collegare in modo più profondo ed efficace con le masse, per dare nuova vita ed energie al movimento rivoluzionario.
L’articolo affronta temi che orbitano intorno alla verità e al discorso in senso Foucaultiano, partendo dall’«occultamento-svelamento» di determinati aspetti della realtà, all’utilizzo dei discorsi e delle dislocazioni delle fonti di verità nella lotta di Socrate e Platone contro i sofisti e i cinici, allo scopo e ai tipi di critica (immanente e trascendente) infine alla proposta di un maggior ascolto della realtà al fine di potersi collegare in modo più profondo ed efficace con le masse, per dare nuova vita ed energie al movimento rivoluzionario.
L’obiettivo è quello di dotare di nuovi strumenti teorico-discorsivi, come di comprensione, il movimento comunista di cui i tempi moderni hanno bisogno, per criticare il tempo presente e avere la meglio su movimenti di destra e nichilismo giovanile che si sono, in buona parte, saputi riaggiornare.
* * * *
La questione della verità
Al giorno d’oggi uno degli argomenti più bizzarri dello scenario culturale è la verità: coesistono opinioni per cui la verità condivisa non esiste (pertanto assume forma individuale, se non esiste proprio) ma la verità scientifica sì, per altri vale l’inverso, certi non si pongono il problema e altri ci pensano in maniera esclusivamente speculativa e non pratica.
Per noi il problema della verità si pone perché il movimento rivoluzionario deve innanzitutto esser capace di criticare lo stato di cose presente, di connettersi alle coscienze delle persone e di creare qualcosa di nuovo a partire da un panorama culturale storicamente dato: è importante affrontarlo per fissare i compiti più generali e le potenziali modalità con cui realizzarli.
- Details
- Hits: 1534
Gli abissi del potere: il “Deep State” tra mito e realtà
di Lucio Mamone
Torna sulle nostre colonne Lucio Mamone, che ci parla del tema del “Deep State” statunitense, recensendo il saggio “The Deep State: The Fall of the Constitution and the Rise of a Shadow Government” scritto dall’ex funzionario del governo di Washington Mike Lofgren e parlando delle dinamiche che regolano i rapporti di forza nella capitale dell’impero a stelle e strisce
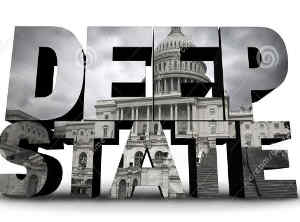 La vittoria nordamericana nello scontro epocale con l’Unione Sovietica ha lasciato presagire l’avvento di una lunga epoca d’espansione per la liberaldemocrazia e di egemonia mondiale per gli Stati Uniti stessi. Questa attesa diffusa ha trovato la sua espressione più consapevole e conseguente, nonché la più fortunata, nell’idea di «fine della storia» di Francis Fukuyama, autore divenuto così improvviso interprete dello spirito del tempo. Tempo però assai breve, poiché l’ironia della storia, che punisce puntualmente i sogni troppo affrettati di imperi millenari, ha prontamente intessuto per l’Occidente un intreccio di sfide inattese, dal terrorismo jihadista all’ascesa cinese, e di clamorosi fallimenti, dagli insuccessi militari in Nordafrica e Medio oriente alla crisi economica del 2008. È bastato così il primo decennio del millennio sia per smorzare l’entusiasmo dei profeti, che per produrre una profonda disaffezione e sfiducia all’interno della società occidentale verso quel modello politico-economico che avrebbe dovuto rappresentare il coronamento di millenni di evoluzione sociale. Non sarebbe tuttavia corretto dire che l’idea di «fine della storia» sia stata semplicemente sostituita da una nuova visione, più realistica o pessimistica a dir si voglia, quanto più che quel presentimento di compimento della parabola moderna abbia assunto la forma del timore, quasi claustrofobico, di essere intrappolati in un sistema obsolescente e incapace di riformarsi. D’altra parte la reazione alle ripetute crisi da parte delle classi dirigenti occidentali, quella statunitense in testa, si è tutta concentrata sul tentativo di mantenimento dello status quo e di convincimento circa l’impossibilità di un’alternativa, lasciando sempre più emergere il carattere impositivo dell’ideologia neoliberale di «fine della storia».
La vittoria nordamericana nello scontro epocale con l’Unione Sovietica ha lasciato presagire l’avvento di una lunga epoca d’espansione per la liberaldemocrazia e di egemonia mondiale per gli Stati Uniti stessi. Questa attesa diffusa ha trovato la sua espressione più consapevole e conseguente, nonché la più fortunata, nell’idea di «fine della storia» di Francis Fukuyama, autore divenuto così improvviso interprete dello spirito del tempo. Tempo però assai breve, poiché l’ironia della storia, che punisce puntualmente i sogni troppo affrettati di imperi millenari, ha prontamente intessuto per l’Occidente un intreccio di sfide inattese, dal terrorismo jihadista all’ascesa cinese, e di clamorosi fallimenti, dagli insuccessi militari in Nordafrica e Medio oriente alla crisi economica del 2008. È bastato così il primo decennio del millennio sia per smorzare l’entusiasmo dei profeti, che per produrre una profonda disaffezione e sfiducia all’interno della società occidentale verso quel modello politico-economico che avrebbe dovuto rappresentare il coronamento di millenni di evoluzione sociale. Non sarebbe tuttavia corretto dire che l’idea di «fine della storia» sia stata semplicemente sostituita da una nuova visione, più realistica o pessimistica a dir si voglia, quanto più che quel presentimento di compimento della parabola moderna abbia assunto la forma del timore, quasi claustrofobico, di essere intrappolati in un sistema obsolescente e incapace di riformarsi. D’altra parte la reazione alle ripetute crisi da parte delle classi dirigenti occidentali, quella statunitense in testa, si è tutta concentrata sul tentativo di mantenimento dello status quo e di convincimento circa l’impossibilità di un’alternativa, lasciando sempre più emergere il carattere impositivo dell’ideologia neoliberale di «fine della storia».
- Details
- Hits: 3254
Capitalismo digitale. Il futuro colonizzato
di Renato Curcio
Incontro-dibattito sul libro Il futuro colonizzato. Dalla virtualizzazione del futuro al presente addomesticato, di Renato Curcio (Sensibili alle foglie, 2019), presso il Csa Vittoria, Milano, 24 ottobre 2019
 Vorrei iniziare leggendo due frammenti di due interviste uscite recentemente sui giornali internazionali e italiani; sono poche righe, ma penso che potranno ben introdurci al tema che cercheremo in qualche modo di raccontare.
Vorrei iniziare leggendo due frammenti di due interviste uscite recentemente sui giornali internazionali e italiani; sono poche righe, ma penso che potranno ben introdurci al tema che cercheremo in qualche modo di raccontare.
La prima è di Leonard Kleinrock, un uomo importante nella storia di Internet, anzi si può dire il primo uomo: è stato quel ricercatore che nel 1969 è riuscito a mettere per la prima volta in contatto due computer. Per tanti anni ha poi lavorato ai progetti di nascita della rete ed è noto agli studenti di tutte le università perché è il fondatore dell’informatica come disciplina universitaria. A ottobre ha dichiarato: “Il nostro Internet era etico, di fiducia, gratis, condiviso. Oggi è passato da risorsa digitale affidabile a moltiplicatore di dubbi, da mezzo di condivisione a strumento con un lato oscuro. Internet consente di arrivare a milioni di utenti a costo zero in maniera anonima, e per questo è perfetto per fare cose malvagie: spam, addio alla privacy, virus, furto d’identità, pornografia, pedofilia, fake news. Il problema è nato quando si è voluto monetizzarlo: si è trasformato un bene pubblico in qualcosa con scopi privati che non ha la stessa identità del passato”. Kleinrock quindi afferma che ci sono due fasi: una prima in cui è nato Internet come progetto scientifico e di ri cerca, che aveva comunque un’intenzione pubblica, e una seconda in cui qualcuno ha cominciato a monetizzarlo ed è diventato una cosa ‘malvagia’.
Edward Snowden, che conosciamo tutti, in un’altra intervista ha sintetizzato così il suo punto di vista: “Alle origini Internet era il luogo in cui tutti erano uguali, un luogo dedicato alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità.
- Details
- Hits: 1658
Sull’epidemia delle emergenze e sulla catastrofe come campo del possibile
di Jack Orlando e Sandro Moiso
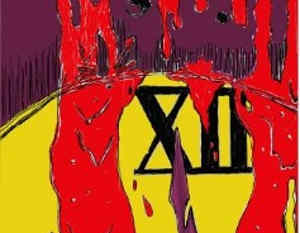 Il Coronavirus, uno spettro che si aggira per il globo. Non più quello del comunismo, ma nemmeno quello della pandemia; è piuttosto quello della Catastrofe, e della sua immediata articolazione: l’Emergenza. Non è infatti pienamente comprensibile il timore che suscita questa epidemia, se non lo si colloca nella sua cornice generale e nei suoi significati più profondi. Non è per una pandemia che si trema, è per la paura del collasso, per quel permanente senso di incapacità a mantenere in eterno l’attuale modo di produzione e di vita capitalistico.
Il Coronavirus, uno spettro che si aggira per il globo. Non più quello del comunismo, ma nemmeno quello della pandemia; è piuttosto quello della Catastrofe, e della sua immediata articolazione: l’Emergenza. Non è infatti pienamente comprensibile il timore che suscita questa epidemia, se non lo si colloca nella sua cornice generale e nei suoi significati più profondi. Non è per una pandemia che si trema, è per la paura del collasso, per quel permanente senso di incapacità a mantenere in eterno l’attuale modo di produzione e di vita capitalistico.
Il Coronavirus ha avuto un tempismo perfetto, cascando nel bel mezzo di una congiuntura che vedeva già intrecciarsi l’inizio di una nuova macroscopica crisi finanziaria ed economica, con una profonda crisi politica delle istituzioni locali, nazionali e globali e con una tensione crescente alla guerra, che solo in questi giorni prende una nuova accelerata, con masse di profughi che premono ai confini d’Europa e la Turchia che tenta di mangiarsi la Siria e conquistarsi un primato che non sarebbe più solo regionale.
Una grande situazione di possibilità, in fondo, che però trova pronta ad accoglierla una parte delle associazioni imprenditoriali1, ma non trova nessuno a raccoglierla tra le fila del “partito rivoluzionario”, sempre ammesso che ne esista ancora uno. Questo perché ci sembra che, dalle nostre parti, smarrite le bussole del conflitto, ci si adagi nella denuncia dell’emergenza accodandosi alla sua narrazione mediatica, senza coglierne le complessità né i margini di azione che ci offre.
- Details
- Hits: 2954
Chi esce dall’euro muore?
di coniarerivolta
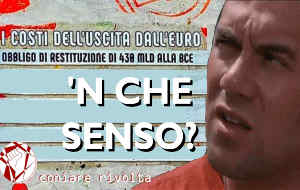 Spesso e volentieri nel dibattito sul ruolo e il destino dell’Unione europea il sistema mediatico dominante lancia anatemi sugli enormi rischi derivanti da un’eventuale uscita. Si tratta di una strategia preventiva volta a chiudere il dibattito sul nascere presentando ogni opzione di eventuale rottura, o anche solo ogni voce critica, come un’irresponsabile e puerile fuga in avanti irrealizzabile o terribilmente dannosa.
Spesso e volentieri nel dibattito sul ruolo e il destino dell’Unione europea il sistema mediatico dominante lancia anatemi sugli enormi rischi derivanti da un’eventuale uscita. Si tratta di una strategia preventiva volta a chiudere il dibattito sul nascere presentando ogni opzione di eventuale rottura, o anche solo ogni voce critica, come un’irresponsabile e puerile fuga in avanti irrealizzabile o terribilmente dannosa.
Di recente ci ha pensato Floris, noto presentatore “Di martedì”, a terrorizzarci con un elenco dei costi che l’Italia dovrebbe sostenere se qualche folle si mettesse in testa di uscire dall’Unione europea. E lo ha fatto ricorrendo ad un breve schema ad effetto.
-
obbligo di restituzione di 430 miliardi alla BCE;
-
fuga di investitori e capitali, rischio default banche;
-
maxi-inflazione, crollo potere acquisto salari e pensioni;
-
mutui in euro più cari da ripagare in lire;
-
aumento costo materie prime, aumento bollette.
Lo schemino di Floris ci fornisce lo spunto per fare chiarezza in particolare sul primo punto, quello relativo alla presunta restituzione di 430 miliardi alla BCE. Ci si riferisce al saldo di un conto, aperto presso la BCE, noto come Target 2.
- Details
- Hits: 2134
Capitale e natura
di Carla Filosa
 Unità di natura e modo di produzione
Unità di natura e modo di produzione
In questo scritto ci si propone di considerare i cambiamenti climatici determinati dalle attività umane separati da quelli naturali. Ci si concentrerà su questi ultimi non da un punto di vista tecnico, demandato agli esperti del settore, ma da un punto di vista sociale e storico. Si assumerà il problema del riscaldamento climatico (Global Warming), e non solo, secondo le analisi effettuate sin dagli anni ’50 dall’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), quale massimo consesso mondiale di esperti sul clima.
Non si ritengono attendibili, al contrario, le tesi relative all’“allarmismo climatico” perché volte a negare o minimizzare le rilevazioni scientifiche che potrebbero compromettere la regolare continuità delle incidenze umane. Queste sono infatti considerate altamente probabili – la cui possibilità è data al 95-100% - su un riscaldamento dell’atmosfera terrestre e degli oceani, che comporterebbe disastri quali scioglimento di nevi e ghiacci con conseguente innalzamento dei mari, pericolo per gli insediamenti umani sulle coste delle terre emerse, concentrazione di gas serra tra cui soprattutto CO2, ecc. Siccome si riscontra una scarsa comprensione delle relazioni specifiche che intercorrono tra sistemi economico-sociali e la variabilità naturale del clima nel corso della storia, si cercherà di portarle all’attenzione come un fattore complesso e non subalterno all’ideologia della semplificazione ad ogni costo. Si è certi che senza l’analisi congiunta di entrambi gli aspetti, quello naturale modificato e continuamente modificabile da quello storico determinato, non può darsi consapevolezza concreta dei problemi e, con questa, la capacità – auspicabilmente efficace – di intervenire per la loro possibile risoluzione in positivo.
- Details
- Hits: 1461
Bambini allo Stato
di Il Pedante
 Premessa: sono felice di avere frequentato una scuola materna e di averla fatta frequentare ai miei figli. Lo sono anche i miei coetanei, pur con poche, ma rispettabili e motivate, eccezioni. Dovrei dunque rallegrarmi del fatto che il nostro governo propone in questi giorni di renderne obbligatoria la frequenza? No, anzi. La notizia mi ha fatto male, come fa male assistere a una violenza sproporzionata e gratuita. Perché l'obbligo è una violenza: in certi casi necessaria, ma comunque tale. E nella marea di nuovi obblighi, adempimenti e sanzioni che sta salendo in questi anni sembra appunto svelarsi la trama di una società sempre più violenta nel metodo. Che non sapendo più offrire, costringe. E non sapendo convincere, impone. Perché, mi sono chiesto, un servizio ai cittadini deve trasformarsi in un dovere? Perché un diritto deve negare un altro diritto? Perché rendere odiosa e minacciosa un'occasione di crescita bene accolta da tutti? Perché farne un pretesto per accorciare il guinzaglio?
Premessa: sono felice di avere frequentato una scuola materna e di averla fatta frequentare ai miei figli. Lo sono anche i miei coetanei, pur con poche, ma rispettabili e motivate, eccezioni. Dovrei dunque rallegrarmi del fatto che il nostro governo propone in questi giorni di renderne obbligatoria la frequenza? No, anzi. La notizia mi ha fatto male, come fa male assistere a una violenza sproporzionata e gratuita. Perché l'obbligo è una violenza: in certi casi necessaria, ma comunque tale. E nella marea di nuovi obblighi, adempimenti e sanzioni che sta salendo in questi anni sembra appunto svelarsi la trama di una società sempre più violenta nel metodo. Che non sapendo più offrire, costringe. E non sapendo convincere, impone. Perché, mi sono chiesto, un servizio ai cittadini deve trasformarsi in un dovere? Perché un diritto deve negare un altro diritto? Perché rendere odiosa e minacciosa un'occasione di crescita bene accolta da tutti? Perché farne un pretesto per accorciare il guinzaglio?
Nel cercare le risposte a queste domande, il mio malessere cresceva. In un tweet del 16 febbraio, il viceministro all'istruzione Anna Ascani spiegava che «estendere l'obbligo alla scuola dell'infanzia significa dare a tutti i bambini e alle loro famiglie più opportunità». Pochi giorni dopo, il Corriere della Sera dava la notizia dell'«asilo obbligatorio dai tre anni» aggiungendo nel titolo: «oggi frequenta solo il 12% dei bimbi». In entrambi i casi, non bisogna essere maliziosi per capire che c'è un grosso problema: sia nel rappresentare un obbligo come il suo contrario (una «opportunità»), sia nel suggerirne l'urgenza affiancandogli a caratteri cubitali un dato inapplicabile e irrilevante. Il «12% dei bimbi» è infatti la quota di frequenza degli asili nido, cioè dei bambini fino ai tre anni di età, mentre le scuole dell'infanzia oggetto della proposta sono già frequentate dal 92,60% dei piccoli del nostro Paese, che si colloca così al nono posto in Europa (fonte Openpolis).
- Details
- Hits: 2456

Capitalismo della sorveglianza
di Salvatore Bravo
 Le metamorfosi del capitalismo
Le metamorfosi del capitalismo
Il capitalismo è un movimento rivoluzionario, la sua ascesa ed il suo impero è sempre stato nell’ottica di una rivoluzione del plusvalore che mentre libera dai vincoli, dalle leggi, dalle identità tradizionali impone nuovi ceppi. Il movimento rivoluzionario del capitalismo è dunque non solo complesso, ma integra piani diversi di sfruttamento in funzione del plusvalore. La verità del capitalismo resta inalterata nei secoli associa lo sfruttamento all’alienazione, ma le forme storiche sono in perpetua metamorfosi. Il divenire sempre più veloce delle forme strutturali rende difficile la risposta politica dei suoi oppositori. Il testo di Shoshana Zuboff Il capitalismo della sorveglianza ci è di ausilio per conoscere e sistematizzare la nuova forma che il capitalismo sta assumendo. Shoshana Zuboff definisce l’attuale fase del capitale “capitalismo della sorveglianza”, quest’ultimo si struttura per la capacità di strumentalizzare lavoratori e non attraverso la capacità di astrarre, conservare ed utilizzare informazioni sulla loro vita a fini commerciali e determinare i loro comportamenti. Si tratta di un’operazione che investe l’intera società trasformata in un laboratorio sperimentale dove attuare tecniche predittive sui comportamenti. Il capitalismo mentre invita ad abbandonare ogni limite nel consumo, nel contempo determina le scelte fino a sostituirsi in modo impalpabile ai “liberi consumatori…”
- Details
- Hits: 2169
Le determinanti della produttività del lavoro nell’Area Euro
di Stefano Lucarelli, Marco Veronese Passarella
 1. La funzione della produttività di Paolo Sylos Labini
1. La funzione della produttività di Paolo Sylos Labini
Il divario nei tassi di crescita della produttività del lavoro tra centro e periferie europee viene spesso indicato come uno dei principali fattori alla base degli squilibri esteri dei paesi membri dell’Area Euro che hanno segnato il primo decennio degli anni duemila (si veda, ad esempio, Draghi 2013). Proprio quel divario fornisce il maggiore argomento a favore delle cosiddette “riforme strutturali”, chiamate a risollevare la competitività delle produzioni periferiche attraverso un aumento della flessibilità nelle condizioni lavorative. Ricondurre la dinamica della produttività del lavoro alla struttura del mercato del lavoro dei paesi membri dell’Area Euro ha l’indubbio vantaggio di mettere in luce il fatto che la prima non è il semplice riflesso di condizioni tecniche esogene. Al contrario, la produttività del lavoro è una grandezza endogena che dipende da una varietà di fattori economici, sociali e istituzionali. Ma è davvero la struttura del mercato del lavoro il fattore più importante? Non la pensava così Paolo Sylos Labini (1920-2005), uno dei più influenti ed acuti economisti italiani del ventesimo secolo. Per Sylos Labini le determinanti chiave della produttività del lavoro andrebbero piuttosto ricercate nella crescita dei mercati dei prodotti, nel rapporto tra costo del lavoro e prezzo dei macchinari, nel costo assoluto del lavoro e nella dinamica degli investimenti (si rinvia a Sylos Labini 1984, 1992, 2004).
Che l’estensione del mercato sia uno dei principali vincoli alla divisione del lavoro e dunque all’introduzione di innovazioni tecniche ed organizzative è un’osservazione che si deve già al padre dell’economica politica, Adam Smith, il quale ne parla estesamente nella sua Ricchezza delle Nazioni del 1776.
- Details
- Hits: 758
Osservatorio internazionale: il mondo di Trump
di Alberto Benzoni
 Thailandia
Thailandia
Il Tribunale costituzionale, emanazione del regime conservatore/militare oramai in sella da anni ha sciolto il principale partito di opposizione democratica. Fortemente presente sia nei grandi centri urbani e nelle aree neglette del paese, con 81 seggi in Parlamento su 300.
Motivazione: l’uso, a quanto pare illecito, di fondi a disposizione del presidente del partito per finanziarne la campagna elettorale. Pena accessoria: l’inibizione a svolgere attività politiche per 12 anni comminata al presidente e ai massimi dirigenti.
Reazione dei medesimi: “prendiamo atto di quanto è avvenuto; ma continueremo a lottare per ristabilire la democrazia nel nostro paese; e con mezzi pacifici”.
Reazioni della collettività internazionale; non pervenute.
India
Visite di Modi negli Stati Uniti: nessuna sotto Obama ( c’era ancora la faccenda della sua complicità, come presidente di uno stato, in un pogrom in cui erano stati uccisi 2000 musulmani ). Una, con tappeti srotolati e effusioni reciproche con l’avvento di Trump.
Oggi, visita di Trump in India. Ipermediatica, con sfilate, cerimonie, folle oceaniche e ipereffusioni complimentose e reciproche ( nessun negoziato firmato o avviato; ma lo stesso Trump ha annunciato che si apriranno presto e porteranno a risultati “terrific”, leggi strabilianti). In compenso complimenti a gogo; “comuni destini, identità di vedute, esempi per tutto il mondo libero, India simbolo dell’armonica coesistenza di etnie e religioni diverse”; e via discorrendo.
- Details
- Hits: 1131
Quando l’Europa suicidò il Pianeta, e si continua
di Carlo Bertani
 Il 3 Agosto del 1914 l’Europa decise di suicidarsi: in un anelito di gloria e di fulgore bellico – che tutto annebbiò, compresi i rischi che ne derivarono – l’Europa decise di farla finita. Con un pessimo trattato di pace, nel 1919, gettò le basi per il secondo tempo, come oramai tutti gli storici sono concordi nel definire Prima e Seconda guerra mondiale un unico evento, frammentato in due episodi.
Il 3 Agosto del 1914 l’Europa decise di suicidarsi: in un anelito di gloria e di fulgore bellico – che tutto annebbiò, compresi i rischi che ne derivarono – l’Europa decise di farla finita. Con un pessimo trattato di pace, nel 1919, gettò le basi per il secondo tempo, come oramai tutti gli storici sono concordi nel definire Prima e Seconda guerra mondiale un unico evento, frammentato in due episodi.
Dal 3 Agosto del 1914 al 15 Agosto del 1945, in soli 31 anni, la follia degli ultimi re ed imperatori, spalleggiati dai presuntuosi francesi e poi da qualche dittatore, ridussero un intero continente alla fame. Nel Novembre del 1918, appena giunta la pace, i giornali di Vienna salutarono come degli angeli una colonna di mezzi militari italiani che giunse a Vienna, con rifornimenti per la popolazione che moriva letteralmente di fame, giacché la mancanza di uomini nei campi aveva impedito quasi del tutto le semine primaverili.
I rifornimenti, ovviamente, non potevano essere italiani (alla fame come gli austriaci!) ma erano giunti dagli Stati Uniti via nave a Venezia: si tornava a mangiare! Peccato, però, che nel 1917 in Kansas fosse comparso un piccolissimo virus denominato, poi, spagnola perché i primi giornali a fornire notizie furono quelli spagnoli, mentre nel resto d’Europa la stampa era sotto censura militare e certe notizie venivano cancellate con un tratto di penna dai solerti generali-censori.
La Spagnola non si conosce nemmeno quanti morti causò: si narra dai 50 ai 100 milioni di vittime, dovute ad una variante del solito virus H1N1, quello della comune influenza, soltanto che il virus s’abbatté su popolazioni stremate dalla fame, dal freddo e dalle privazioni: in Italia, le vittime furono 600.000, tante quante ne causò la guerra.
Page 244 of 612