Per un'analisi scientifica del potere nel capitalismo contemporaneo
di Andrea Pannone
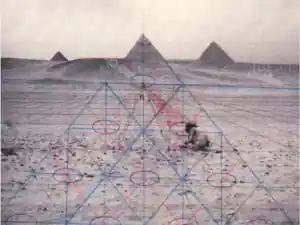 Alla luce delle trasformazioni strutturali del capitalismo contemporaneo Andrea Pannone scrive che oggi è necessario ridefinire il concetto di potere, superando la concezione che lo intende come semplice capacità di influenzare l’azione altrui tipica dell'economia mainstream e ampliando la prospettiva marxista. Pannone in quest'articolo definisce potere come la capacità differenziale di agire sulla sfera economica, politica e sociale attraverso la centralizzazione del controllo di risorse materiali, umane e finanziarie.
Alla luce delle trasformazioni strutturali del capitalismo contemporaneo Andrea Pannone scrive che oggi è necessario ridefinire il concetto di potere, superando la concezione che lo intende come semplice capacità di influenzare l’azione altrui tipica dell'economia mainstream e ampliando la prospettiva marxista. Pannone in quest'articolo definisce potere come la capacità differenziale di agire sulla sfera economica, politica e sociale attraverso la centralizzazione del controllo di risorse materiali, umane e finanziarie.
* * * *
L’analisi scientifica del potere: un vuoto da colmare
Nel panorama dell’analisi economica, il concetto di potere — inteso come capacità di plasmare relazioni sociali e controllare risorse — rimane sorprendentemente marginale, specialmente nell’economia mainstream. I paradigmi neoclassici, focalizzati su equilibrio di mercato, efficienza e razionalità individuale, tendono infatti a ridurre il potere a un effetto secondario di dinamiche competitive, trascurando il suo ruolo strutturale nelle asimmetrie tra capitale e lavoro, o tra grandi corporation e interessi collettivi. Sebbene però le scuole eterodosse, come l’economia marxista, riconoscano il potere come intrinseco alle relazioni di produzione, le loro analisi, pur ricche di profondità teorica, spesso mancano di un approccio sistematico che combini rigore analitico con una chiara validazione empirica. Questo paper rappresenta un primo passo verso la costruzione di un quadro metodologico scientifico che integri il potere come categoria centrale nello studio delle dinamiche dell’economia contemporanea, dalla finanziarizzazione, alla centralizzazione del capitale, fino alla formazione di temibili oligarchie transnazionali.
La visione mainstream del potere
Come messo in evidenza da Giulio Palermo (2007, 2014, 2016), uno dei pochi economisti che ha approfondito di recente l’argomento, nella visione economica mainstream il «potere» è declinato come la capacità di «qualcuno» di influenzare le azioni degli «altri». In questa prospettiva, il potere si riduce alla dimensione interpersonale: nel mercato, dove, ad esempio, alcuni venditori impongono attraverso i prezzi le condizioni di accesso alle merci ai compratori, e nell’impresa, dove capitalista e lavoratore, lungi dall’essere considerate come entità sociali, sono visti semplicemente come individui dotati di diverse qualità innate che si esprimono sul luogo di lavoro instaurando una relazione gerarchica. L’esistenza di una relazione di potere, così concepita, è totalmente preclusa in un mercato concorrenziale in equilibrio walrasiano ossia in un mercato in cui l’offerta eguaglia perfettamente la domanda. In base al primo teorema del benessere (Arrow e Debreu 1954), infatti, sappiamo che questa condizione di equilibrio permette un’allocazione delle risorse efficiente nel senso di Pareto (ottimo paretiano). Un ottimo paretiano implica che non è possibile migliorare il benessere (utilità) di un soggetto, senza peggiorare il benessere degli altri soggetti. Quindi in questa configurazione di mercato nessuno può avere «potere» su qualcun altro, coerentemente a come questo concetto è stato definito. L’esistenza di un’asimmetria di potere (ossia del fatto che «qualcuno abbia potere su qualcun altro»), necessariamente, dipende dall’introdurre una serie di imperfezioni sul modello di concorrenza perfetta, che appare come «uno stato di natura», privo cioè di qualunque spiegazione storica. L’analisi concentra interamente il proprio fuoco sulla dimensione dello scambio (la circolazione delle merci), senza alcun tentativo di spiegare come tali imperfezioni si siano formate nel tempo. Secondo alcuni autori, queste imperfezioni — e quindi la questione stessa del potere — potrebbero teoricamente essere definitivamente rimosse (o almeno molto ridotte) attraverso l’adozione di tecnologie digitali come l’intelligenza artificiale o la blockchain, in virtù della loro potenziale capacità di eliminare i vincoli informativi che ostacolano l’efficienza allocativa dei mercati[1].
L’ontologia del potere in una prospettiva marxista
Lo stesso Giulio Palermo, nel lodevole tentativo di costruire un’ontologia del potere coerente con l’analisi di Marx, fornisce una differente definizione di potere focalizzata prioritariamente sulla dimensione della produzione. Dal punto di vista marxiano la produzione capitalistica ha una natura di sfruttamento: il capitale impone la sua logica sul processo del lavoro e consente al suo proprietario di appropriarsi del plusvalore prodotto dal lavoratore (Marx 1864). Lo sfruttamento nell’economia impone forme particolari di potere e coercizione nella società. Dunque, così come il modo di produzione capitalistico è basato in modo essenziale sullo sfruttamento dei lavoratori, ugualmente si basa anche su potere e coercizione. L’economia non è soltanto una fra le tante fonti possibili del potere, bensì è la sfera nella quale le forme essenziali del potere capitalistico sono generate. Si può notare che il concetto di potere, in questa prospettiva, non rappresenta solo il «potere di influenzare l’azione di altri» (come invece risulterebbe limitandosi a guardare la sola dimensione della circolazione delle merci), quanto la capacità di chi possiede e controlla il capitale (la classe dei capitalisti) di influenzare le azioni di chi deve vendere il proprio tempo di lavoro per sopravvivere (la classe dei lavoratori). Lo sfruttamento è essenzialmente una relazione sociale, non una relazione interpersonale tra un singolo capitalista e un singolo lavoratore (Chattopadhyay 1994). Ed è per questo che anche il potere capitalistico è essenzialmente una relazione sociale e non un’imperfezione eventuale, causata dalla scarsa concorrenza tra capitalisti. Il meccanismo coercitivo opera attraverso le classi sociali e impone l'accumulazione di capitale produttivo come obiettivo della società.
Dall’accumulazione di capitale produttivo all’accumulazione pecuniaria
Ad ogni modo, l’accumulazione di capitale produttivo – capitale fisico e forza lavoro – ha cessato di essere oggi il motore centrale della dinamica del capitalismo. Questo tipo di accumulazione, infatti, ha lasciato sempre più spazio a un altro processo: l’accumulazione di asset finanziari e monetari, che definiremo accumulazione pecuniaria e che viene in questa sede associato al cosiddetto fenomeno della finanziarizzazione. Già dagli anni Ottanta del secolo scorso, infatti, appare chiaro come il saggio del profitto tenda a cadere, pur con periodi di inversione del trend, nella maggior parte dei settori produttivi delle economie occidentali, spingendo le imprese a rallentare gli investimenti in capitale fisico e a investire sempre di più sui mercati finanziari per differenziare il proprio portafoglio di attività (si veda qui)[2]. Come conseguenza, ad esempio, la quota media dei profitti delle imprese USA che deriva dalle attività finanziaria è arrivata attualmente a salire intorno al 30%, con punte che superano il 50% per grandi banche come ad esempio Goldman Sachs e JP Morgan. Inoltre, pur tenendo conto della volatilità ciclica e delle fluttuazioni economiche globali, negli ultimi 33 anni gli indici azionari hanno continuato a salire in modo costante, dando corpo a una disconnessione sempre più strutturale tra i valori degli asset finanziari e i valori degli asset reali (vedi Bichler e Nitzan 2023), alimentata da politiche monetarie accomodanti e strategie manageriali finalizzate alla crescita dei primi. Già dalla fine degli anni novanta, la valorizzazione degli asset finanziari è divenuta un’espressione tutt’altro che «fittizia» del capitale reale trasformandosi in una leva concreta per operazioni di fusione e acquisizione (M&A) [3]. Attraverso queste operazioni le grandi imprese possono crescere, riorganizzare interi settori e consolidare il proprio dominio sui mercati, spesso in alternativa agli investimenti produttivi, in particolare per ciò che riguarda l’acquisizione rapida di innovazioni e tecnologia (si veda ad esempio qui e qui).
Il processo descritto è andato a configurare e strutturare un fenomeno di centralizzazione della ricchezza nelle mani di poche imprese (vedi Brancaccio et al. 2018). É noto che, oggi, la capitalizzazione di mercato – ossia il valore totale delle azioni di un’azienda, calcolato moltiplicando il prezzo per azione per il numero di azioni in circolazione – delle prime 50 imprese dello S&P supera abbondantemente quella delle 250 imprese più piccole dell'indice. Il termine centralizzazione non è casuale e si richiama al concetto di centralizzazione a cui si riferisce Marx nel primo libro del Capitale (1867), sebbene ora il processo si riferisca a una sfera parallela alla produzione materiale sottostante a quella ricchezza[4].
Va osservato anche che, in questo nuovo contesto, l’intrinseca capacità di sfruttamento dell’essere umano a fini di profitto, che per Marx costituisce l’essenza del modo di produzione capitalistico, certamente non scompare ma assume una dimensione sempre più totalizzante e non riducibile al solo lavoro. La «lotta di classe» che era un tempo principalmente incentrata sul «pavimento della fabbrica», ora si è diffusa in ogni aspetto dell’esistenza e dell’inesistenza sociale (lerler e Nitzan 2006). L’obiettivo fondamentale non è più primariamente la produzione di beni e servizi, ma la modellazione di soggettività prevedibili e tracciabili. Nell’era delle tecnologie digitali, infatti, gli individui diventano fonti continue di dati, trasformabili in risorse esclusive – brevettabili, commerciabili – e convertibili in valore economico mediante algoritmi predittivi (vedi Zuboff 2019). Questo valore deriva da proiezioni di comportamenti futuri, che trovano espressione nella capitalizzazione di borsa: una quantificazione della capacità di un’azienda di ottenere guadagni grazie alla protezione legale della tecnologia e ad altre forme di esclusione, che rendono i suoi asset sempre più appetibili per gli operatori finanziari. Tale dinamica ha contribuito ad accentuare le disuguaglianze, poiché i benefici della rivalutazione patrimoniale si sono concentrati nelle fasce più abbienti della popolazione, determinando una enorme divaricazione nella distribuzione dei redditi e della ricchezza (Piketty 2013).
In altri termini, la finanza diventa la sfera in cui vengono attualmente generate le forme essenziali del valore capitalistico. In questo contesto, la produzione non scompare, ma viene subordinata alle logiche di valorizzazione finanziaria e capitalizzazione anticipata del valore futuro, diventando uno dei molteplici terminali di una dinamica di accumulazione che si riproduce e genera diseguaglianze primariamente attraverso il controllo dell'informazione, della liquidità e del rischio[5].
Verso una nuova definizione di potere
Alla luce delle trasformazioni strutturali del capitalismo contemporaneo riteniamo sia necessario ridefinire il concetto di potere. Superando la concezione del potere come semplice capacità di influenzare l’azione altrui – propria di approcci fondati esclusivamente sulla sfera della circolazione – e ampliando la prospettiva marxista adottata da Palermo– centrata primariamente sulla capacità di estrarre plusvalore dai lavoratori nel processo produttivo– definisco come potere la capacità differenziale di agire sulla sfera economica, politica e sociale attraverso la centralizzazione del controllo di risorse materiali, umane e finanziarie. Questa definizione non contraddice quella marxiana, ma semmai la ingloba, per renderla coerente con l’evoluzione del capitalismo verificatasi negli ultimi tre decenni. Come visto nel paragrafo precedente, il controllo oggi non si esercita soltanto nella dimensione produttiva, ma anche – e soprattutto – nella capacità di orientare e strutturare le convenzioni speculative che si formano a monte della produzione, ossia già prima che vengano generati beni e profitti[6]. Ciò si verifica grazie alla messa in moto di aspettative in grado di autorealizzarsi, se accompagnate da un adeguato volume di liquidità e investimenti finanziari che solo poche grandi imprese sono in grado di mobilitare[7]. Tale mobilitazione sottrae risorse agli investimenti produttivi, «sabotando» l’espansione della sfera della produzione, e al tempo stesso favorisce la l’aumento medio della capitalizzazione di mercato delle stesse imprese, trasformandola come visto sopra in potenziale strumento di scambio per acquisizioni strategiche e crescenti concentrazioni societarie.
Tuttavia, questa è solo una parte della storia. La capitalizzazione di un’impresa sul mercato borsistico nazionale, infatti, fornisce solo indicazioni limitate sulla sua effettiva struttura di controllo. Questo per almeno due motivi. Anzitutto, la rapida espansione dei mercati azionari negli ultimi anni ha contribuito a spostare il baricentro del controllo aziendale all’interno di una rete finanziaria transnazionale, rendendo estremamente complessa — anche dal punto di vista normativo e giuridico — l’identificazione del reale proprietario (ultimate owner) di un investimento estero e della sua nazione di origine, complessità ulteriormente aggravate dall’uso frequente di veicoli societari registrati in paradisi fiscali e normativi off-shore[8]. Inoltre, la capitalizzazione non riflette l’influenza esercitata dai possessori/azionisti sulla proprietà dell’azienda – come nel caso dei grandi fondi di investimento (prima di tutto BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity Management, ecc.)– la cui capacità di indirizzare le strategie aziendali con quote azionarie molto al di sotto del 50% (anche con il 20, il 10 o il 5 per cento) è ampiamente documentata nella letteratura contemporanea[9]. Non di rado, questi fondi detengono quote rilevanti in imprese concorrenti operanti negli stessi mercati, incentivando comportamenti collusivi sia espliciti (accordi diretti più o meno difficili da tracciare) sia impliciti[10]. La possibilità di spostare rapidamente, e senza ostacoli significativi, ingenti flussi di capitale destinati all’acquisizione di partecipazioni in imprese attive nei settori strategici di paesi terzi — come difesa, energia, telecomunicazioni e infrastrutture — ha poi consentito ai grandi fondi di investimento di estendere la propria sfera d’influenza ben oltre i confini aziendali e nazionali, favorendo l’espansione di conglomerati multinazionali nei comparti produttivi chiave dei paesi coinvolti, quasi sempre a scapito dei lavoratori e delle piccole e medie imprese[11].
Sul potere dello Stato e delle istituzioni pubbliche
Di fronte a tale penetrazione, gli Stati hanno imparato ad interpretare un ruolo sempre più acquiescente, al punto da competere tra loro nell’offrire regolazioni permissive e incentivi fiscali agli investitori esteri, pur di ottenere la sottoscrizione dei loro titoli di debito[12] o qualche insediamento produttivo in grado di assicurare, purché a costi non eccessivamente onerosi, un certo numero di posti di lavoro. In molti casi, le concessioni implicano trasferimenti di interi rami d’azienda a società di nuova costituzione (le cosiddette newco), create appositamente per accorpare ciò di cui ci si vuole evidentemente disfare, spesso in un clima di colpevole inconsapevolezza rispetto agli effetti sistemici di tali scelte (vedi Undiemi 2021). Ne è conseguita una progressiva svendita di ampie porzioni del tessuto produttivo degli Stati e un drastico ridimensionamento dello spazio di intervento della politica industriale, sempre più condizionata dagli interessi di potenti lobby sovranazionali. Queste, attraverso il noto meccanismo delle «porte girevoli», sono sempre più in grado di esercitare una pressione decisiva non solo sui governi, ma anche sui principali organismi multilaterali, contribuendo a ridefinire i confini stessi della sovranità economica[13]. Per ragioni analoghe, le Banche Centrali hanno finito per allinearsi agli interessi della finanza rinunciando deliberatamente a contenere le dinamiche speculative. Le loro politiche monetarie sono state infatti impiegate come leva per favorire la crescita dell’intermediazione finanziaria al di fuori del perimetro bancario tradizionale e regolamentato, aprendo così la strada al sistema bancario ombra. Tale comportamento è stato giustificato elevando a dogma il principio dell’autoregolazione dei mercati. Quando poi i rischi accumulati hanno minacciato la stabilità dell’intero sistema finanziario, le stesse autorità sono intervenute per evitare il collasso, mascherando così le proprie responsabilità. Dopo il tracollo del 2008, si sono moltiplicati gli impegni solenni a non ripetere gli errori del passato. Eppure, i fatti raccontano un’altra storia: sotto la vigilanza delle stesse istituzioni, il sistema bancario ombra non solo non è stato ridimensionato, ma ha continuato a crescere, raggiungendo nel 2024 un ammontare complessivo di attività pari a 238,8 trilioni di dollari — ben oltre i 62 trilioni del 2007[14].
In conclusione, diventa illusorio considerare lo Stato e le istituzioni nazionali e sovranazionali come un campo di battaglia da riconquistare attraverso riforme politiche più o meno progressiste, capaci in ogni caso di interrompere o limitare i processi di accumulazione selvaggia nell’economia e nella società. Ovviamente ciò non implica che «le forze politiche» non possano più assumere una posizione indipendente o anche fortemente critica nei confronti dell’azione delle istituzioni pubbliche e del governo. Possono. Ma la probabilità che lo facciano, così come la portata della loro indipendenza, tendono a diminuire drammaticamente di fronte ai margini di autonomia che le oligarchie economico-finanziarie sono disposte a tollerare. Inoltre, la struttura di queste formazioni di potere e la rete di connessioni su cui si reggono presentano un livello di complessità e opacità tale da sottrarsi a qualsiasi lettura lineare o immediata. Proprio tali caratteristiche rendono estremamente difficile, per le istanze di rappresentanza collettiva, anche solo articolare adeguatamente il problema del loro contrasto— ammesso che tale contrasto rappresenti un fine effettivamente perseguito. Questo emerge chiaramente, ad esempio, in relazione a misure come la minimum global tax (OCSE, 2021), introdotta dall’OCSE nel 2021 (Pillar Two). Tale misura è finalizzata a garantire che i profitti delle multinazionali siano tassati ad almeno il 15% a livello globale, indipendentemente dal Paese in cui vengono dichiarati, applicando un’imposta integrativa quando l’aliquota effettiva pagata in una giurisdizione è inferiore alla soglia minima. Tuttavia, la misura non intercetta il valore accumulato transnazionalmente: le imprese possono eluderne in parte l’efficacia reinvestendo gli utili in operazioni di fusione e acquisizione (M&A), spesso strutturate tramite scambi azionari, così che i profitti non vengano distribuiti come dividendi tassabili, ma trasformati in guadagni di capitale latenti, non soggetti a imposizione immediata. Questo è possibile perché il meccanismo della Pillar Two si concentra sulla tassazione degli utili contabili realizzati e registrati a livello di singola giurisdizione fiscale, senza includere in modo sistematico le plusvalenze non realizzate o i trasferimenti di valore intragruppo legati a operazioni straordinarie.
Un ulteriore aspetto riguarda la reale efficacia dello strumento dei dazi. Quando i governi impongono tariffe sui beni importati per proteggere le economie locali o riequilibrare la bilancia commerciale, le multinazionali possono aggirare tali ostacoli acquisendo aziende nei mercati di destinazione. Ad esempio, se gli Stati Uniti applicano dazi sui prodotti cinesi, una multinazionale cinese può investire in M&A acquistando un’azienda americana, spostando la produzione localmente e vendendo i propri beni come «prodotti locali», evitando così le tariffe. Questo tipo di strategia consente alle multinazionali di neutralizzare l’impatto dei dazi, mantenendo la loro competitività globale e aggirando le politiche commerciali restrittive imposte dagli Stati.
Multinazionali e reti di controllo: verso un’analisi scientifica del potere
Da quanto è emerso finora, dovrebbe apparire evidente che, nell’attuale fase del capitalismo, un’analisi del potere che aspiri ad avere un fondamento scientifico non può prescindere dall’indagare il ruolo dei conglomerati multinazionali operanti su scala globale, a partire proprio dagli investimenti diretti esteri (IDE) che essi realizzano all’interno dei singoli contesti nazionali. Senza di ciò, l’idea stessa di costruire un «contropotere»capace di contrapporsi efficacemente alla forza di quegli interessi organizzati appare del tutto velleitaria. Tale indagine è, comprensibilmente, tutt’altro che semplice. Ad esempio, le statistiche sugli IDE vengono elaborate considerando solo le due controparti immediate coinvolte nella relazione finanziaria, mentre gli investimenti delle multinazionali sono spesso canalizzati attraverso diversi paesi lungo una rete di affiliate interconnesse. Di conseguenza, le stesse statistiche possono non rappresentare accuratamente quali paesi e quali settori di attività economica siano gli effettivi beneficiari finali dei flussi e degli stock di investimenti (vedi Accoto e Oddo 2023). Damgaard et al. (2019) stimano che circa il 40% degli IDE globali sia costituito da “gusci societari” privi di attività economiche reali, che operano prevalentemente come entità di pass-through, veicolando i flussi finanziari verso altre destinazioni, spesso per finalità opache o elusive. Tale fenomeno riduce in modo significativo la capacità dei governi di valutare, al di là delle dichiarazioni degli investitori, i benefici effettivi derivanti dall’ingresso di nuovi capitali e, più in generale, di misurare l’impatto reale degli IDE sullo sviluppo economico nazionale.
Inoltre, va considerato il fatto che il luogo di quotazione di un’impresa multinazionale non fornisce, il più delle volte, informazioni trasparenti sulla nazionalità degli azionisti di riferimento, sulla localizzazione effettiva dell’origine delle operazioni e sulle reali finalità dell’investitore (produttiva, finanziaria, fiscale, illegale, regime sanzionatorio, ecc), tenuto conto del core business della sua attività. Il problema è estremamente rilevante dato che, a oggi, quasi un terzo di tutti gli asset globali è di proprietà di stranieri (e forse di più, data l'opacità dei legami internazionali con la criminalità e il riciclaggio di denaro). In altri termini, per dirla alla Bichler e Nitzan (2006), i capitalisti che vivono negli Stati Uniti, ma anche in Cina o in Russia, sono sempre meno «americani», «cinesi» o «russi» in termini di ciò che possiedono, e spesso molti di coloro che possiedono beni «americani», «cinesi» o «russi» vivono altrove.
In conclusione, l’identificazione del reale beneficiario di un IDE, la proprietà effettiva di un’impresa, e il reale potere economico a essa collegato, richiede innanzitutto un metodo capace di analizzare in profondità le reti di partecipazione societaria e le relazioni di controllo, dirette e indirette, delle imprese che hanno effettuato investimenti diretti esteri in un dato territorio[15]. A questo fine è utile ricorrere alle moderne tecniche di analisi di rete (o «network analysis»), strumenti potenti per analizzare la proprietà azionaria e comprendere la struttura del comando all'interno delle aziende (vedi Vitali 2011, Brancaccio et al. 2022, Brancaccio et al. 2018, per una disamina e alcune applicazioni). Più precisamente, queste tecniche consentono di visualizzare le connessioni tra gli azionisti e le società, identificando chi detiene posizioni di influenza e controllo, soprattutto attraverso partecipazioni incrociate e holding. L'analisi di rete può infatti evidenziare: a) nodi centrali (azionisti o gruppi di controllo) che possiedono un'influenza significativa su più società; b) percorsi di controllo indiretto, dove una società o individuo può influenzare un’altra azienda tramite partecipazioni intermediarie; c) grado di centralizzazione del controllo, misurando quanto il potere sia concentrato nelle mani di pochi attori.
Sulla costruzione di indici per la valutazione del potere delle multinazionali
Una volta strutturata l’analisi di cui al precedente paragrafo, è necessario individuare algoritmi efficaci per misurare l'influenza esercitata dalle società quotate, come ad esempio i principali fondi patrimoniali, sulla rete proprietaria globale sottostante all’impresa che ha effettuato un IDE. Questo allo scopo di comprendere quanto un soggetto riesca ad esercitare potere o controllo attraverso il possesso (anche minoritario) di quote azionarie. Nella maggior parte degli studi presenti in letteratura, invece, si misura il potere dei proprietari finali di controllare le aziende (si veda Vitali et al. 2011, Mizuno et al. 2020) ma i gestori patrimoniali, ad esempio, non sono i proprietari finali; sono azionisti intermedi che sono anch'essi di proprietà dei loro proprietari finali. Inoltre, come osservano Mizuno et al 2023, alcuni dei grandi gestori patrimoniali sono società a partecipazione diffusa, la cui proprietà è spesso suddivisa tra numerosi azionisti meno influenti. Eppure, essi esercitano un'influenza sostanziale. Come si raccoglie il potere di controllo societario? Un indicatore efficace deve considerare il controllo indiretto derivante dalla dispersione proprietaria nelle reti globali. Mizuno et al. (2023) hanno introdotto il Network Power Flow (NPF), un indice che quantifica l’influenza degli azionisti, sia finali che intermedi, mappando il flusso di controllo attraverso un algoritmo di campionamento casuale con 20.000 iterazioni su dati del database Orbis Van Dick del 2020. L’NPF identifica i canali attraverso cui il potere si propaga in strutture complesse, come le proprietà incrociate, integrando l’Indice Herfindahl-Hirschman (HHI) per valutare la concentrazione del controllo[16]. L’NPF consente di osservare la distribuzione del potere tra gli azionisti, evidenziando il ruolo cruciale degli intermediari. Pur con limitazioni legate a dati storici e ad alcune assunzioni restrittive, esso offre una visione innovativa della governance aziendale nelle reti globali[17] e potrebbe diventare un elemento importante di un programma di ricerca volto a ricostruire rigorosamente le mappe del potere nel capitalismo contemporaneo. Nei prossimi mesi lo sviluppo di questo programma sarà l’oggetto principale del mio lavoro.
Note
[1]Ad esempio, nel suo articolo «Intelligent Technology» pubblicato nel 2016 su Finance & Development, Hal Varian , tra l’altro capo economista di Google, spiega come la mediazione informatica sia ormai centrale in quasi tutte le transazioni economiche, poiché i computer consentono di registrare, raccogliere e analizzare dati su vaste scale, migliorando la qualità e l’efficacia delle transazioni future. In particolare, Varian sottolinea come i sistemi informatici riducano l’asimmetria informativa e mitighino problemi quali selezione avversa e azzardo morale, eliminando potenzialmente gli ostacoli al buon funzionamento del mercato.
[2] Osserviamo che per finanziarizzazione intendiamo in questa sede principalmente il processo di spostamento della liquidità dagli investimenti produttivi alle attività finanziarie. Molti autori hanno usato lo stesso termine per descrivere (almeno alcuni degli) aspetti trattati in questo articolo. Ad ogni modo, i contributi risultano piuttosto disomogenei e privi di una visione coerente di ciò che debba essere spiegato (Krippner 2005, p. 181). Come sottolineano Carnevali et al. (2022), a distanza di molti anni manca tuttora un’interpretazione univoca del concetto.
[3] Nel 29-esimo capitolo del terzo libro del Capitale (1894) Marx riconosce in effetti che la quotazione dei titoli – capitalizzazione di borsa - viene regolata indipendentemente dal valore del capitale effettivo che questi titoli, almeno in parte, rappresentano. Dunque, quando questi titoli non rappresentano capitale effettivo ma soltanto dei semplici diritti sui proventi futuri, il diritto su uno stesso provento si traduce in capitale monetario fittizio, soggetto a continue oscillazioni. Tuttavia, queste oscillazioni possono discostarsi significativamente dal valore del capitale effettivo, che per Marx dipende dal valore-lavoro, solo per un tempo limitato. Dopodiché, spesso per effetto di una crisi finanziaria, la capitalizzazione di borsa tenderà a riallinearsi.
[4] Ricordiamo che la centralizzazione, in Marx, riguarda la redistribuzione della proprietà dei capitali e trova una spiegazione teorica proprio nella concorrenza tra capitalisti in lotta per la valorizzazione del proprio capitale produttivo. In questo senso la centralizzazione completa l’opera dell’accumulazione mettendo in grado i capitalisti industriali di allargare la scala delle loro operazioni (vedi Fineschi, 2012, p. 695).
[5] Osserviamo che sebbene l’approccio cognitivista (vedi ad esempio Vercellone 2006 e Fumagalli 2007) abbia colto l’espansione della sfera produttiva al di là del lavoro materiale, individuando nella «sussunzione vitale» una nuova forma di cattura del valore, esso tende tuttavia a riproporre la centralità della produzione – questa volta immateriale e digitale – come nucleo della dinamica capitalistica, non cogliendo a pieno, a mio parere, il tratto cruciale del capitalismo del XXI secolo.
[6] Negli ultimi 10-15 anni, i riacquisti di azioni proprie (buyback) si sono imposti come strumento chiave per sostenere artificialmente titoli e indici. Riducendo le azioni in circolazione, aumentano l’utile per azione e i prezzi, anche senza solidi fondamentali, offrendo una «scommessa quasi sicura» a tutti gli investitori finanziari. La favorevole fiscalità e le pressioni competitive ne hanno reso l’uso uno standard, adottato massivamente anche dalle imprese più grandi e, un tempo, più innovative quali Apple, Google, Facebook e Microsoft (vedi Lazonik 2023).
[7] A partire dal 2022, l’inasprimento delle condizioni del credito e l’aumento dei tassi di interesse deciso dalle Banche Centrali hanno ridotto drasticamente la platea di operatori in grado di mobilitare ingenti risorse per investimenti finanziari. L’accesso alla leva finanziaria, che nel periodo di Quantitative Easing successivo alla crisi del 2008 aveva sostenuto un’ampia espansione delle posizioni speculative e degli investimenti a lungo termine, è divenuto molto più oneroso e rischioso. In questo nuovo contesto, la capacità di ottenere e impiegare liquidità su larga scala si è concentrata su un numero estremamente ridotto di grandi imprese, le quali, grazie a bilanci solidi, accesso privilegiato ai mercati dei capitali e utilizzo di strumenti finanziari complessi, hanno consolidato un vantaggio di liquidità differenziale. Questo vantaggio non solo consente loro di operare quando la maggior parte degli altri attori è costretta a ridurre l’esposizione, ma accresce anche il loro potere di influenza sui mercati e sulla determinazione dei prezzi degli asset.
[8] I «paradisi normativi» si riferiscono a luoghi o giurisdizioni in cui le normative fiscali, finanziarie o legali sono particolarmente favorevoli o vantaggiose per le imprese o gli individui. Le giurisdizioni considerate paradisi normativi possono offrire vantaggi che vanno al di là della semplice tassazione bassa (come avviene invece nei «paradisi fiscali»), quali ad esempio regimi legali e normativi che favoriscono la privacy, la protezione degli asset e la flessibilità operativa.
[9] Questo dipende essenzialmente dalla dispersione azionaria, dal voto per delega, dal peso istituzionale e dalle alleanze strategiche con altri investitori. È noto poi come i tre fondi siano strettamente intrecciati fra loro: Vanguard e State Street detengono insieme il 12% di Blackrock; Vanguard e Blackrock possiedono il 18% di State Street; mentre Blackrock e State Street hanno il 20% di Vanguard e sono al centro di un vasto intreccio azionario, in cui compaiono altri importanti Mutual Funds e soggetti finanziari (tra cui: Fidelity, T-Rowe, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley). Sulle ragioni della crescita imponente del ruolo delle Big Three, strettamente connesso alla disponibilità differenziale di risorse liquide, si veda ad esempio Fichtner et al. 2017.
[10] Nel secondo caso (collusione implicita), più subdolo e diffuso, le imprese allineano spontaneamente i propri comportamenti in funzione degli interessi comuni dell’azionista condiviso, spesso senza bisogno di comunicazioni dirette. Un esempio attuale è rappresentato dalla presenza simultanea delle Big Three (BlackRock, Vanguard e State Street) nel capitale sia di NVIDIA che di Alphabet, due attori centrali nel mercato strategico dei chip per l’intelligenza artificiale: pur in assenza di un coordinamento formale, la condivisione degli stessi investitori dominanti tende a scoraggiare comportamenti aggressivi e a promuovere una forma di «disciplina settoriale» che riduce la competizione effettiva.
[11] Va notato che, a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, la maggior parte degli investimenti diretti all’estero vengono realizzati attraverso fusioni e acquisizioni transfrontaliere (Mergers and Acquisitions: M&A) - che equivalgono a flussi finanziari per acquisire pacchetti azionari di aziende già esistenti nel paese target - piuttosto che tramite la creazione ab integro di nuove strutture produttive (investimenti greenfield). Ciò inizia a verificarsi, in particolare, nei paesi che intraprendono un’ampia privatizzazione delle imprese pubbliche. Rispetto agli investimenti greenfield, quindi, li M&A possono essere implementati più rapidamente grazie all'acquisizione di entità già operative sul territorio/mercato che si intende penetrare. Mentre non tutte le M&A sono assimilabili a investimenti finanziari, la crescente predominanza della logica finanziaria sugli obiettivi industriali che caratterizza il capitalismo attuale, può rendere questa tipologia di IDE sempre più simili a tali operazioni, specialmente nelle strategie di internalizzazione. Sebbene sia difficile fornire stime precise negli ultimi due anni è abbastanza evidente che nei paesi sviluppati (che includono la maggior parte dei paesi OCSE), le fusioni e acquisizioni abbiano storicamente costituito la quota dominante degli di IDE in entrata rispetto agli investimenti greenfield (vedi ad esempio qui).
[12] Nel 2024, il debito pubblico statunitense ha raggiunto circa 36,1 trilioni di dollari, di cui 28,7 trilioni detenuti da investitori pubblici. Le «Big Three» – BlackRock, Vanguard e State Street – e le banche commerciali USA (come JPMorgan Chase, Bank of America e Citibank) svolgono un ruolo cruciale come detentori di questo debito. (vedi ad esempio qui).
[13] Si tratta della tematica, di dominio pubblico ormai, ma ben esplorata anche dalla letteratura scientifica, delle revolving doors, espressione con cui si identifica il passaggio di funzionari pubblici e politici dal settore pubblico a quello privato, ma anche l’ingresso nelle pubbliche amministrazioni e negli organismi internazionali di esperti e manager provenienti da aziende private e viceversa e dell’impresa (vedi Gallino 2011, Coveri et al 2023, Pannone 2024).
[14] Si veda sul punto Katharina Pistor.
[15] Ovviamente, per poter applicare il metodo di indagine è necessario poter accedere 1) a un ampio database che contenga informazioni sugli IDE realizzati in un dato paese in un certo arco temporale, distinti per stato di avanzamento (ad es. annunciati, in via di completamento, già terminati) e per tipologia (ad es. greenfield o M&A); 2) a informazioni dettagliate su bilanci, struttura proprietaria, operazioni di M&A, aspetti ESG e governance, con elevata qualità e copertura internazionale.
[16] Per misurare il grado di autonomia che un azionista i possiede nell'esercizio del proprio potere di controllo societario, Mizuno et al (2023) introducono una nuova versione dell'indice di Herfindahl-Hirschman (HHI), che tradizionalmente viene usato per misurare il grado di monopolio in un dato settore. In questo caso HHI, calcolato come la somma dei quadrati delle quote di controllo di ciascun azionista, misura la concentrazione del potere in una rete. Valori bassi (es. 0,05) indicano controllo frammentato, mentre valori più alti (es. 0,2) suggeriscono maggiore concentrazione.
[17] Ad esempio, l’assunzione di voto transitivo di Mizuno et al. (2023) semplifica l’analisi del NPF assumendo che il controllo si propaghi senza attriti attraverso la rete di proprietà, con i soci controllati che votano in linea con i loro controllori. Questa ipotesi consente di mappare il flusso di controllo in reti complesse, ma è limitata da potenziali conflitti di interesse, azioni senza diritto di voto e regolamentazioni. Ampliarla includendo comportamenti non cooperativi, classi di azioni differenziate, vincoli regolamentari, dinamiche temporali o influenza di minoranza renderebbe l’NPF più realistico, ma aumenterebbe la complessità computazionale e il fabbisogno di dati. Tali miglioramenti potrebbero essere testati con casi studio per valutarne l’efficacia.
Bibliografia
-
N. Accoto, G. Oddo, (2023), Looking Beyond the Curtain: Pass-through Capital and Round-tripping in Italy's Foreign Direct Investment (April 21). Bank of Italy Occasional Paper No. 762, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4464149 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4464149
-
K. J. Arrow, G. Debreu, (1954), Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy. «Econometrica», 22(3), 265–290.
-
S. Bichler , J. Nitzan (2006), New imperialism or new capitalism?, MPRA paper n. 5578, 4 novembre, consultabile al link https:// mpra.ub.uni-muenchen.de/5578/.
-
S. Bichler e J. Nitzan (2023), The mismatch thesis. Fiction and reality in the accumulation of capital, in «Revista de Estudios Globales», pp. 13-40 (consultabile al link https://bnarchives.net/id/eprint/818/2/20231200_bn_the_mismatch_thesis.pdf )
-
E. Brancaccio, R. Giammetti, M. Lopreite, M. Puliga, (2018), Centralization of capital and financial crisis: A global network analysis of corporate control, «Structural Change and Economic Dynamics», Volume 45, pp. 94-104.
-
E. Brancaccio, R. Giammetti, S. Lucarelli, (2022), La guerra capitalista. Competizione, centralizzazione, nuovo conflitto imperialista, Mimesis, Milano.
-
E. Carnevali, F. Ruggeri, M. Veronese Passarella (2022), Inequality and Exchange Rate Movements in an Open-Economy Macroeconomic Model, «Review of Political Economy», 36(2), 722–760. https://doi.org/10.1080/09538259.2022.2062961.
-
P. Chattopadhyay, (1994), The Marxian concept of capital and the Soviet experience, Westport, Praeger.
-
A. Coveri, C. Cozza, D. Guarascio (2023), Blurring boundaries: an analysis of the digital platforms-military nexus, LEM Papers Series 2023/47, Laboratory of Economics and Management (LEM), Sant'Anna School of Advanced Studies, Pisa, Italy.
-
J. Damgaard, , T. Elkjaer, N. Johannesen (2019). What is real and what is not in the global FDI network? International Monetary Fund Working Paper n 19-274.
-
J. Fichtner, EM Heemskerk, J. Garcia-Bernardo (2017), Hidden power of the Big Three? Passive index funds, re-concentration of corporate ownership, and new financial risk, «Business and Politics», 19, (2), 298-326
-
R. Fineschi, 2011. Marx Engels. Opere Complete. XXXI Il Capitale. La Città del Sole.
-
A. Fumagalli (2007), Bioeconomia e capitalismo cognitivo. Verso un nuovo paradigma di accumulazione, Carocci
-
L. Gallino, (2011). Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi. Torino: Einaudi.
-
G.R. Krippner (2005), The Financialization of the American Economy, «Socioeconomic Review», vol. 3 (2): 173-208,
-
W. Lazonik, (2023), The Scourge of Corporate Financialization: Income Inequity, Employment Instability, Productive Fragility, «Institute of New Economic Thinking», 21 Agosto (consultabile al link).
-
K. Marx (1864), The process of production of capital, Draft chapter 6 of Capital — Results of the direct production process. Retrieved from: www.marxists.org/archive/marx/works/1864/economic/index.htm.
-
K. Marx (1867)(1990), Capital: A Critique of Political Economy, Vol. 1. Trans. Ben Fowkes. Penguin, New York.
-
K. Marx, (1894)(1998) Capital III: The Process of Capitalist Production as a Whole, che incorpora l'intero volume delle Collected Works di Karl Marx e Frederick Engels: Volume 37 (International Publishers: New York).
-
T. Mizuno, S. Doi, S. Kurizaki (2023) The flow of corporate control in the global ownership network. PLoS ONE 18(8): e0290229. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290229
-
OECD (2021). Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy.
-
G. Palermo, (2007), The ontology of economic power in capitalism: Mainstream economics and Marx, Cambridge Journal of Economics, 1 of 23doi:10.1093/cje/bel036.
-
G. Palermo (2014), The economic debate on power: A Marxist critique, «Journal of Economic Methodology», vol. 21, n. 2, pp. 175-92.
-
G. Palermo (2016), Economics and power: A Marxist critique, London, Routledge
-
A. Pannone (2024), Dall’imperialismo delle nazioni alle guerre delle oligarchie. Ripensare Lenin per il XX secolo, in «Alternative per il Socialismo» n. 73.
-
T. Piketty (2013), Le capital au XXI siécle, Paris, Seuil. English translation (2014) Capital in the twenty-first century, Harvard University Press, Cambridge (Mass.).
-
T. Tørsløv, L. Wier, G. Zucman,. (2022). The Missing Profits of Nations. Review of Economic Studies, 89(2), 867–899.
-
L. Undiemi (2021), La lotta di classe nel XXI secolo, Ponte delle Grazie, Firenze.
-
C. Vercellone (a cura di) – Capitalismo cognitivo. Conoscenza e finanza nell’epoca postfordista, 2006, Manifestolibri
-
S. Vitali, JB Glattfelder, S. Battiston (2011), The network of global corporate control. PloS ONE.;6(10):e25995. pmid:22046252
-
S. Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, PublicAffairs, 2019.







































Add comment