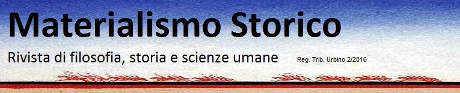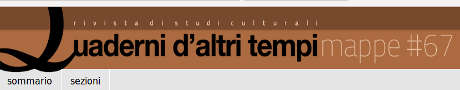Fai una donazione
Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________
- Details
- Hits: 1265
Perché la regionalizzazione della scuola è costituzionalmente borderline
di Carlo Scognamiglio
 1. Genesi e sostanza dell’autonomia differenziata
1. Genesi e sostanza dell’autonomia differenziata
L’accelerazione politica del processo di decentramento amministrativo sollecita un ritorno alla discussione sul tema del federalismo, e solleva l’allarme sulla sua compatibilità costituzionale, poiché tra le tante materie su cui si intendono distribuire le competenze, c’è anche l’organizzazione del sistema di istruzione, tradizionalmente legato alla questione unitaria. Questo è un tema difficile, che non può essere affrontato con facili proclami. A poco serve urlare all’incostituzionalità o alla rottura dell’identità nazionale. Occorre ragionare con calma. Altri Stati hanno sistemi di istruzione organizzati regionalmente, e l’Italia stessa ha già delegato agli enti regionali molte funzioni. Bisogna capire, in questo caso, cosa significa e come si sviluppa la questione politica dell’autonomia differenziata. Proviamo a fare un passo indietro, per inquadrare correttamente il tema.
L’Italia ha una tradizione comunale, non regionale. Il Risorgimento aveva condotto all’agognato e difficile obiettivo del superamento di una frammentazione territoriale tradizionalmente percepita come il principale fattore di debolezza dell’Italia. Lo Stato unitario aveva certamente aggregato all’antica istituzione comunale l’amministrazione periferica prefettizia, le Province, con funzioni prevalentemente tecniche. Nel 1865 Minghetti propose la costituzione di Regioni amministrative, ma la proposta venne bocciata. Si trattava di un progetto che – si diceva – metteva a rischio il senso di unità nazionale già fragile. Don Luigi Sturzo e il Partito Popolare, nel primo dopoguerra, ripresero la questione, in vista di un’auspicata autonomia regionale. Ma poi ebbe inizio il ventennio fascista, contrario alle autonomie locali, subordinando anche gli istituti comunali alla tutela dello Stato centrale. Per questa ragione, secondo lo storico Claudio Pavone, “la Resistenza è stata pressoché unanime, nelle sue prese di posizione esplicite, nel rivendicare decentramento e autonomie locali”.
- Details
- Hits: 2864
Gramsci e il populismo
Recensione di Nicolò Pennucci
Guido Liguori (a cura di): Gramsci e il populismo, Unicopli, Milano 2019, pp. 173, ISBN: 884002056X
 Gramsci e il populismo ha l’ambizione di affrontare un problema fondamentale nel dibattito politico contemporaneo, quello della relazione del pensiero politico della sinistra con il populismo e in particolare il rapporto tra la categoria della classe sociale, centrale nell’elaborazione marxista, e quella di popolo, che sembra negare in toto la portata sociologica e politica dell’unità d’analisi marxista. Partire da Gramsci è imprescindibile, in quanto la teoria politica contemporanea che avoca la possibilità di un populismo di sinistra si riferisce direttamente al suo pensiero nell’elaborazione concettuale della propria proposta. Ciò solleva non pochi problemi alla base dei contributi che si susseguono nel volume collettaneo.
Gramsci e il populismo ha l’ambizione di affrontare un problema fondamentale nel dibattito politico contemporaneo, quello della relazione del pensiero politico della sinistra con il populismo e in particolare il rapporto tra la categoria della classe sociale, centrale nell’elaborazione marxista, e quella di popolo, che sembra negare in toto la portata sociologica e politica dell’unità d’analisi marxista. Partire da Gramsci è imprescindibile, in quanto la teoria politica contemporanea che avoca la possibilità di un populismo di sinistra si riferisce direttamente al suo pensiero nell’elaborazione concettuale della propria proposta. Ciò solleva non pochi problemi alla base dei contributi che si susseguono nel volume collettaneo.
Cercare di analizzare un problema contemporaneo con le lenti di un pensatore di un’altra epoca pone infatti un problema metodologico. Quentin Skinner in un lavoro paradigmatico per la storia del pensiero politico insegna che il pensiero si conosce attraverso i testi che devono essere letti sotto la doppia luce di testo e contesto per evitare distorsioni e imprecisioni ermeneutiche (SKINNER, QUENTIN, 1969: Meaning and Understanding in the History of Ideas, “History and Theory”, Vol. 8, No. 1 pp. 3-53 ). Sradicare completamente un testo dal suo contesto storico-politico è un’operazione che si apre alla possibilità di distorsioni pericolose e all’abuso di categorie che diventano completamente snaturate. Ciononostante un pensatore, soprattutto un pensatore come Gramsci che ha fatto della praxis la nota definitoria del suo progetto filosofico, non può restare relegato all’uso dei filologi. Come conciliare la corretta lettura filologica con l’uso politico del pensiero gramsciano nella contemporaneità è la grande domanda che sottostà all’intero sviluppo del libro e valutare i limiti e le potenzialità di questo sforzo è uno dei compiti del presente lavoro. Che questo doppio filo leghi tutti i contributi è dimostrato dallo stesso curatore. Liguori, infatti, nell’introduzione dichiara «presentiamo i contributi che compongono il volume non nell’ordine nel quale si sono susseguiti nel corso del seminario di Roma, ma cercando di collocarli in una sequenza che, partendo da Gramsci e dalla lettura dei suoi testi, cerchi di interrogare il presente del dibattito sul neopopulismo contemporaneo» (p. 10).
- Details
- Hits: 1359
La Germania dubita
di Vincenzo Comito
La frenata dell’economia tedesca dipende solo in parte dalla situazione congiunturale della guerra dei dazi Usa-Cina. Serpeggia in Germania un diffuso disagio e anche un fermento politico che mette in dubbio i dogmi dell’austerity
 L’andamento dell’economia
L’andamento dell’economia
Come ha sottolineato di recente, tra gli altri, anche il Financial Times (The Editorial Board, 2019), negli ultimi 15 anni la Germania è stata il motore della più o meno elevata crescita europea; vi si sono registrati alti livelli di produttività, relativamente, anche se solo relativamente, bassi livelli di diseguaglianza, ridotti tassi di disoccupazione, pur se non sono mancati a questo proposito altri problemi, quali un’accresciuta precarietà del lavoro. Dalla crisi finanziaria ad oggi la crescita del reddito pro-capite tra i Paesi del G-7 è stata comunque la più elevata dopo quella degli Stati Uniti. Perché dubitare di tale modello, si chiede dal canto suo Le Monde (Editorial, 2019), quando il Paese registra un avanzo annuale di bilancio di 60 miliardi di euro, un debito pubblico inferiore al 60% del Pil, una bilancia commerciale fortemente in surplus?
Ma idati e le valutazioni più recenti disponibili per quanto riguarda quella economianon sembrano piùmolto incoraggianti, o almeno essi appaiono contraddittori e incerti. Il quarto trimestre del 2018 ha registrato così una crescita del Pil pari a zero, mentre per l’intero anno il risultato è stato quello di un aumento dell’1,4%, contro il 2,2% a suo tempo ottenuto nel 2017. Per l’anno in corso poi, le ultime stime di marzo del governo parlano di una possibile crescita dello 0,5%, percentuale che non sarebbe certo vista con molto entusiasmo neanche in un Paese come l’Italia.
Peraltro molti economisti appaiono relativamente più ottimisti del governo, puntando ad uno 0,8%,mentre gli ultimi dati a consuntivo pubblicati nel maggio 2019 mostrano qualche speranza per un miglioramento della situazione anche per il settore industriale, grazie alla resistenza delle esportazioni, mentre in ogni caso il settore dei servizisi comporta abbastanza bene.
Per altro verso, si registra anche, nell’ultimo periodo, un crescente senso di insoddisfazione e di ingiustizia nel Paese (Bramucci, 2019), sul piano economico come su quello sociale e politico. Qualcuno parla, a questo proposito, tra l’altro, di un declino sociale del Paese (Nachtwey, 2019).
- Details
- Hits: 1672
Immanenza e politica, crisi di un rapporto
di Mattia Di Pierro, Francesco Marchesi
L’Almanacco di Filosofia e Politica (Quodlibet, 2019), diretto da Roberto Esposito, sarà presentato giovedì 16 maggio alle 17.00 a Villa Mirafiori (via Carlo Fea 2, Aula IV) all’interno del Seminario permanente di Filosofia Teoretica dell’Università di Roma La Sapienza. Intervengono Donatella Di Cesare, Roberto Esposito, Marcello Mustè, Mario Tronti, Elettra Stimilli. Modera Roberto Ciccarelli. Qui anticipiamo un estratto dell’introduzione dei curatori del primo numero, dedicato alla Crisi dell’immanenza
 Perché i conflitti che ci interessano significano solo se stessi, perché il Ruanda, la Jugoslavia, le primavere arabe significano solo se stesse, sono eventi illeggibili, pure vittime, mentre la politica comincia quando non esistono più eventi illeggibili o pure vittime, quando diventa giusto morire e soprattutto uccidere in nome di qualcosa, anche se oggi non osiamo più pensarlo, anche se oggi non oseremmo scriverlo, o lo faremmo solo in una poesia. Per questo guardo il viale e passo ad argomenti prossimi, per questo voglio sentirmi credibile e presente – i miei problemi, la forma dei suoi occhiali, la chemioterapia di un amico, la gravidanza di un’amica, un altro neonato. Ci salutiamo così.
Perché i conflitti che ci interessano significano solo se stessi, perché il Ruanda, la Jugoslavia, le primavere arabe significano solo se stesse, sono eventi illeggibili, pure vittime, mentre la politica comincia quando non esistono più eventi illeggibili o pure vittime, quando diventa giusto morire e soprattutto uccidere in nome di qualcosa, anche se oggi non osiamo più pensarlo, anche se oggi non oseremmo scriverlo, o lo faremmo solo in una poesia. Per questo guardo il viale e passo ad argomenti prossimi, per questo voglio sentirmi credibile e presente – i miei problemi, la forma dei suoi occhiali, la chemioterapia di un amico, la gravidanza di un’amica, un altro neonato. Ci salutiamo così.
(Guido Mazzoni, Angola)
1. Dopo il ’68
Sul piano della teoria la spinta propulsiva del Sessantotto sembra essersi esaurita. L’immanenza, e la ricerca di una politica radicata in essa e solo in essa, hanno visto venire progressivamente meno la loro funzione. Si è consumato così un grande progetto di liberazione. Quello sessantottesco è stato, se colto da questo punto di vista, il tentativo di costruire un pensiero del tutto privo di gerarchie: condizione ritenuta essenziale per la creazione di un mondo radicalmente egualitario. Di qui l’immanenza come, ad un tempo, premessa e fine del lavoro filosofico, depurato di universali sovraordinati o di fondamenti celati sotto la superficie del visibile. Questo tratto complessivo assumeva tuttavia due accezioni in parte divergenti: da un lato riprendeva la sperimentazione delle scienze umane del dopoguerra, tesa nel suo insieme a pensare sistematiche del tutto orizzontali, ma pur sempre sistematiche. Un’eredità modernista ancora persuasa della possibilità di un ordine egualitario, che ordine restasse. Dall’altro si apriva a un processo poi risultato prevalente, almeno in ambito continentale: la distruzione di tutti gli assoluti filosofici che non fossero la singolarità isolata e quasi tribale visibile ancora oggi, in un movimento di pensiero libertario che ha teorizzato la disseminazione e la proliferazione delle differenze, approssimandosi alla decostruzione complessiva dei fondamenti della tradizione filosofica. Su una dotazione di senso egualitaria ha così prevalso la superficie dispersa. Sul piano politico questo è progressivamente divenuto l’ideale regolativo guida ma anche l’obiettivo pragmatico da conseguire.
- Details
- Hits: 2761

Vittoria del capitalismo?
di Hyman Minsky
"Il 25 ottobre 1990 il Centro culturale Progetto di Bergamo ha organizzato il convegno Vittoria del capitalismo?, relatore Hyman Minsky. Pochi mesi dopo la caduta del muro di Berlino, quando c’era chi preconizzava la fine della storia con la vittoria finale del capitalismo, Minsky contrapponeva una lucida lettura, anticipando le caratteristiche del nuovo fragile sviluppo capitalistico..."[Paolo Crivelli]
 Il collasso delle economie di tipo Sovietico è stato salutato come una vittoria del Capitalismo e il crollo simultaneo dei regimi politici comunisti è stato usato per convalidare l’identificazione del Capitalismo con la democrazia.
Il collasso delle economie di tipo Sovietico è stato salutato come una vittoria del Capitalismo e il crollo simultaneo dei regimi politici comunisti è stato usato per convalidare l’identificazione del Capitalismo con la democrazia.
Da alcune parti si avanza l’idea che questa vittoria segni la fine della Storia così come noi l’abbiamo conosciuta. Ma le vicende del Golfo, la fragilità della prosperità capitalistica e le pressioni nazionaliste risvegliate dal collasso dell’egemonia Sovietica nell’Europa orientale indicano che la Storia non finisce, ma fluisce come il Mississippi che nella canzone “...continua a scorrere”.
Non c’è dubbio che il Socialismo centralistico autoritario di tipo Sovietico è crollato. Ma questa forma di Socialismo non è la sola possibile. Il modello Sovietico ha sempre avuto la caratteristica di non consentire che le preferenze e i desideri della gente influenzassero la produzione. Segnali effettivi (decisioni) nel Socialismo di tipo Sovietico andavano dall’alto verso il basso, mai dal basso, dalla popolazione verso coloro che avevano il potere di decidere che cosa e come produrre. Esistono modelli teorici alternativi di Socialismo nei quali regna una sovranità del consumatore più ampia rispetto a quella delle economie di tipo capitalistico.
Questo modello autoritario di economia centralizzata non è cattivo quando i compiti assegnati all’economia sono semplici: quando si deve produrre solo pane o carri armati. Un’economia centralistica ha funzionato bene nella trasformazione da una società di tipo contadino ad una economia di produzione di massa limitata nella varietà di beni – quando acciaio, cemento e macchinari sono tutto ciò che deve essere prodotto: questo tipo di economia funziona altrettanto bene per la produzione di materiale bellico. Gli approvvigionamenti militari negli Stati Uniti e nel Regno Unito durante la Seconda Guerra Mondiale seguivano un modello di economia centralistica.
- Details
- Hits: 2276
“Capitale, egemonia, sistema. Studio su Giovanni Arrighi” di Giulio Azzolini
di Paolo Missiroli
Recensione a: Giulio Azzolini, Capitale, egemonia, sistema. Studio su Giovanni Arrighi, Quodlibet, Macerata 2018, pp. 176, euro 18, (scheda libro)
 Giovanni Arrighi non è un pensatore troppo valorizzato nel panorama italiano e sono pochi i luoghi che dedicano un qualche spazio a riflessioni su questo storico ed economista. Eppure Arrighi è importante nel dibattito internazionale a proposito del capitalismo e della sua storia; esempio ne sia il suo ruolo nella discussione seguita alla pubblicazione di Impero di Toni Negri e Michael Hardt. Dai post-operaisti Arrighi era considerato, pur nel forte disaccordo, un interlocutore di prim’ordine.
Giovanni Arrighi non è un pensatore troppo valorizzato nel panorama italiano e sono pochi i luoghi che dedicano un qualche spazio a riflessioni su questo storico ed economista. Eppure Arrighi è importante nel dibattito internazionale a proposito del capitalismo e della sua storia; esempio ne sia il suo ruolo nella discussione seguita alla pubblicazione di Impero di Toni Negri e Michael Hardt. Dai post-operaisti Arrighi era considerato, pur nel forte disaccordo, un interlocutore di prim’ordine.
Per questo la pubblicazione di una monografia su Arrighi è una buona notizia. Capitale, egemonia, sistema di Giulio Azzolini, oltre ad essere una novità per il solo fatto di trattare di Arrighi, ha il pregio di trattare la sua opera dall’inizio alla fine, cogliendone i punti salienti in un numero di pagine ammirevolmente ridotto; pone con chiarezza gli elementi di contatto con altri autori, scuole e correnti di pensiero; colloca Arrighi nel suo tempo storico ed anche nella sua dimensione di militante politico all’altezza degli anni Settanta. Fare una recensione di un testo simile significa quindi porsi, non senza un qualche grado di arbitrarietà, l’obbiettivo di riportare alcuni fra tutti questi elementi. L’arbitrio sta, appunto, nel fatto che non tutti potranno essere qui trattati. Il testo che discutiamo, peraltro, si presta con facilità, data anche la buona scorrevolezza che lo contraddistingue, ad essere sfogliato e letto da chiunque lo voglia. Non ci concentreremo eccessivamente sugli esiti più noti del pensiero dell’Arrighi maturo, che sono già stati trattati, su Pandora, in recensioni apposite. Qui è possibile trovare la recensione a Il lungo XX secolo e qui e quiquelle a Adam Smith a Pechino.
Può facilitarci il compito il fatto che in effetti si potrebbe dire che il senso della riflessione arrighiana è quello di dare ragione della crisi all’interno del sistema capitalistico. Questo presuppone, com’è evidente, una definizione di tale sistema, ma non è l’obbiettivo del suo pensiero. Già la formulazione della questione in questi termini “la crisi all’interno del sistema capitalistico” non è affatto scontata, come vedremo.
- Details
- Hits: 2806
Landini, Marx e la cultura economica della CGIL
di Luca Michelini
 Un bel convegno organizzato dall’Università di Pisa sul pensiero di Marx (dal titolo Marx 201. Ripensare l’alternativa) ha avuto tra gli ospiti Maurizio Landini, neo-segretario della CGIL. Ero molto curioso di ascoltare Landini, perché mi aspettavo che parlasse appunto di Marx e del marxismo, cioè del ruolo che il pensiero marxiano e marxista poteva avere, o non avere, oggi, all’interno della più grande organizzazione del cosiddetto movimento operaio italiano. Il titolo della relazione, del resto, prometteva bene: Il lavoro nel capitalismo globalizzato. Per una nuova internazionale.
Un bel convegno organizzato dall’Università di Pisa sul pensiero di Marx (dal titolo Marx 201. Ripensare l’alternativa) ha avuto tra gli ospiti Maurizio Landini, neo-segretario della CGIL. Ero molto curioso di ascoltare Landini, perché mi aspettavo che parlasse appunto di Marx e del marxismo, cioè del ruolo che il pensiero marxiano e marxista poteva avere, o non avere, oggi, all’interno della più grande organizzazione del cosiddetto movimento operaio italiano. Il titolo della relazione, del resto, prometteva bene: Il lavoro nel capitalismo globalizzato. Per una nuova internazionale.
I presupposti culturali perché il tema fosse rilevante sono numerosi. Il marxismo è stato per lungo tempo l’ideologia portante del sindacato italiano “rosso”, fin dalle sue origini. Ciò non significa affatto che Marx fosse una sorta di profeta da cui trarre dottrina e pratica del sindacalismo: fin dalle sue origini, la fortuna di Marx in Italia si è intrecciata con continue riletture e re-interpretazioni del suo pensiero, fino ad arrivare a vere e proprie critiche, talune anche radicali, tanto da decretarne l’accantonamento come punto di riferimento teorico e politico. Particolarmente rilevante fu in Italia il cosiddetto “revisionismo”, che ebbe notevole impatto sul pensiero economico socialista, grazie ad Achille Loria; ma ebbe rilievo anche in ambito filosofico e storiografico grazie agli scritti di Benedetto Croce di Giovanni Gentile.
Marx, tuttavia, rimaneva un pensatore con il quale il confronto era ineludibile, se non altro perché la storia del capitalismo italiano e la storia mondiale riproponevano continuamente la sua attualità: ora analitica, con lo svilupparsi degli imperialismi occidentali, lo scoppio del primo conflitto mondiale, la Grande Crisi, lo svilupparsi si sistemi economici socialisti; ora politica, con la Rivoluzione d’Ottobre, la nascita del fascismo e del nazismo, l’instaurarsi di regimi socialisti di ispirazioni marxiana, come la Cina ecc. La tradizione di pensiero che, opponendosi al revisionismo, principia con il filosofo Antonio Labriola ed arriva fino ad Antonio Gramsci, costituirà una delle colonne portanti della cultura del Partito Comunista Italiano, cioè di quel partito che con la CGIL aveva un rapporto privilegiato e di continua osmosi culturale e politica.
- Details
- Hits: 2253
La relazione europeismo-corporativismo nei sindacati
di Domenico Moro
 Da circa dieci anni l’austerity europea, combinata con la più grave crisi economica dal 1929, sta devastando la società europea. I danni più gravi sono stati sopportati dal lavoro salariato che ha registrato importanti balzi all’indietro a tutti i livelli. Eppure, le mobilitazioni più importanti contro l’austerity europea sono venute soprattutto da movimenti extrasindacali sorti fuori dai luoghi di lavoro, come gli indignados e i gilet gialli, invece che dalle organizzazioni tradizionali dei lavoratori. Non sono mancate le eccezioni, come in Francia, dove negli ultimi anni si sono avute alcune forti mobilitazioni sindacali, anche recentemente, come nel caso dei ferrovieri. Invece, le mobilitazioni contro l’austerity e le controriforme del mercato del lavoro, delle pensioni, ecc. sono state particolarmente deboli nel nostro Paese, dove persino i provvedimenti del governo Monti, di gran lunga il peggiore almeno dell’ultimo decennio, sono passati senza alcuna opposizione da parte dei sindacati principali. Le ragioni della particolare debolezza della riposta sindacale in Italia sono molteplici, e vanno dalle massicce delocalizzazioni alla estrema frammentazione contrattuale del lavoro salariato. Ma, almeno in parte, sono da ascriversi alle scelte politiche del sindacato stesso, in particolare al connubio di concertazione, neocorporativismo e filo-europeismo, che ha caratterizzato i tre principali sindacati italiani, compreso il maggiore, cioè la Cgil.
Da circa dieci anni l’austerity europea, combinata con la più grave crisi economica dal 1929, sta devastando la società europea. I danni più gravi sono stati sopportati dal lavoro salariato che ha registrato importanti balzi all’indietro a tutti i livelli. Eppure, le mobilitazioni più importanti contro l’austerity europea sono venute soprattutto da movimenti extrasindacali sorti fuori dai luoghi di lavoro, come gli indignados e i gilet gialli, invece che dalle organizzazioni tradizionali dei lavoratori. Non sono mancate le eccezioni, come in Francia, dove negli ultimi anni si sono avute alcune forti mobilitazioni sindacali, anche recentemente, come nel caso dei ferrovieri. Invece, le mobilitazioni contro l’austerity e le controriforme del mercato del lavoro, delle pensioni, ecc. sono state particolarmente deboli nel nostro Paese, dove persino i provvedimenti del governo Monti, di gran lunga il peggiore almeno dell’ultimo decennio, sono passati senza alcuna opposizione da parte dei sindacati principali. Le ragioni della particolare debolezza della riposta sindacale in Italia sono molteplici, e vanno dalle massicce delocalizzazioni alla estrema frammentazione contrattuale del lavoro salariato. Ma, almeno in parte, sono da ascriversi alle scelte politiche del sindacato stesso, in particolare al connubio di concertazione, neocorporativismo e filo-europeismo, che ha caratterizzato i tre principali sindacati italiani, compreso il maggiore, cioè la Cgil.
Un appello e una lettura dell’Europa sbagliati
Il recente Appello per l’Europa, firmato congiuntamente da Confindustria e sindacati (Cgil, Cisl e Uil), è la dimostrazione emblematica di questa situazione. L’organizzazione che rappresenta i maggiori beneficiari delle controriforme europee, le grandi imprese internazionalizzate, e le organizzazioni che dovrebbero rappresentare i più penalizzati, i lavoratori salariati dell’industria, firmano insieme un manifesto che riproduce quelle illusioni sull’Europa nelle quali forse si poteva cadere qualche anno fa, ma che ora non ha più senso ripetere.
- Details
- Hits: 1825
Moneta fiscale: perchè tocca ai governi attuare misure non convenzionali per rilanciare lo sviluppo
di Enrico Grazzini
Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo contributo sulla controversa proposta di moneta fiscale, con l’auspicio che possa contribuire al dibattito pubblico
 L’eurozona è ancora una volta in crisi e ha urgente bisogno di nuovo ossigeno monetario per fare ripartire la domanda aggregata, e quindi la produzione e l’occupazione. La BCE per bocca di Mario Draghi ha annunciato una nuova serie di operazioni di rifinanziamento a lungo termine (T-LTRO 3) per le banche a partire da settembre 2019 fino a marzo 2021 con scadenza biennale. L’obiettivo proclamato è di rifornire le banche a costo (quasi) zero della liquidità necessaria per alimentare i prestiti all’economia reale.
L’eurozona è ancora una volta in crisi e ha urgente bisogno di nuovo ossigeno monetario per fare ripartire la domanda aggregata, e quindi la produzione e l’occupazione. La BCE per bocca di Mario Draghi ha annunciato una nuova serie di operazioni di rifinanziamento a lungo termine (T-LTRO 3) per le banche a partire da settembre 2019 fino a marzo 2021 con scadenza biennale. L’obiettivo proclamato è di rifornire le banche a costo (quasi) zero della liquidità necessaria per alimentare i prestiti all’economia reale.
L’annuncio dello T-LTRO III segue solamente di pochi mesi la fine (evidentemente prematura) della più importante manovra monetaria anticonvenzionale portata a termine nella storia dell’eurozona e dell’Europa: il Quantitative Easing. Grazie al piano di espansione monetaria la BCE dal marzo 2015 al dicembre 2018 ha fornito 2600 miliardi di euro al sistema bancario in cambio di titoli di stato (comprati dalle banche) e altri titoli. 2600 miliardi sono una cifra enorme, pari a circa il 20% del PIL europeo. Eppure anche il QE non ha ottenuto l’effetto sperato: per molti aspetti è stato un fallimento. L’eurozona è ferma, la domanda aggregata nell’economia reale langue, investimenti e consumi non ripartono, l’inflazione non cresce e la disoccupazione resta elevata. In realtà l’eurozona non è mai uscita dalla crisi, nonostante l’enorme quantità di moneta creata dalla BCE a favore (soprattutto) delle banche in ragione di migliaia di miliardi di euro.
Se i soldi creati dalla BCE fossero stati assegnati non alle banche ma direttamente agli stati, alle famiglie e alle imprese la domanda aggregata (consumi, investimenti, spesa pubblica) e l’inflazione si sarebbero riprese subito e avrebbero trascinato immediatamente al rialzo la produzione e l’occupazione. Basta fare due semplici calcoli: 2,6 triliardi distribuiti ai 340 milioni di abitanti dell’eurozona (neonati e ultraottantenni compresi) avrebbero comportato che ogni abitante poteva percepire oltre 7650 euro, cioè circa 160 euro al mese per i 46 mesi del QE.
- Details
- Hits: 2145
Cambiare o Perire: la dura Scelta del Bolivarismo venezuelano
di Amos Pozzi
 Il tentato golpe raffazzonato di Juan Guaido degli ultimi giorni ha riportato sotto i riflettori mondiali il Venezuela. E con esso il solito insieme di cliché sulla sua situazione economica. I media non ci hanno risparmiato nulla: dal socialismo “che rende tutti poveri”, all’aneddoto dei cugini che “stavano benissimo” e ora “muoiono di fame”. Ma abbiamo anche sentito la campana di un certo riduzionismo culturale che attribuirebbe l’intera crisi al ruolo degli USA o degli speculatori interni. Ci è sembrato quindi il caso, per quanto assolutamente non facile, di provare a fare il punto della situazione economica dello stato sudamericano, dell’evoluzione della crisi e delle sfaccettature sociali della stessa.
Il tentato golpe raffazzonato di Juan Guaido degli ultimi giorni ha riportato sotto i riflettori mondiali il Venezuela. E con esso il solito insieme di cliché sulla sua situazione economica. I media non ci hanno risparmiato nulla: dal socialismo “che rende tutti poveri”, all’aneddoto dei cugini che “stavano benissimo” e ora “muoiono di fame”. Ma abbiamo anche sentito la campana di un certo riduzionismo culturale che attribuirebbe l’intera crisi al ruolo degli USA o degli speculatori interni. Ci è sembrato quindi il caso, per quanto assolutamente non facile, di provare a fare il punto della situazione economica dello stato sudamericano, dell’evoluzione della crisi e delle sfaccettature sociali della stessa.
Naturalmente trovare dati economici affidabili sul Venezuela dopo il 2014 è diventata un’impresa. Per quanto possibile ci siamo basati su dati della Banca Mondiale evitando dati governativi o think tank interni di area opposizione in modo da mantenere il più possibile “neutra” la raccolta dei dati di partenza.
Partiamo quindi dall’osservare l’evoluzione del PIL venezuelano dal 1990 fino al 2014, ultimo anno in cui abbiamo dati indiscutibili sullo stesso.
- Details
- Hits: 2403

“Ciò che sta dietro il denaro”
Ancora una postilla sulla Ciociara di Moravia
di Eros Barone
 La realtà vera, nei suoi complessi rapporti che la legano alla finzione, si dischiude solo a una coscienza sviluppata, che non è più in sé, ma è per sé e per gli altri.
La realtà vera, nei suoi complessi rapporti che la legano alla finzione, si dischiude solo a una coscienza sviluppata, che non è più in sé, ma è per sé e per gli altri.
György Lukács
-
1. Forza dialettica e oggettività del “realismo critico”
Le pagine centrali della Ciociara sono quelle più vicine alla diretta esperienza dell’autore. 1 E fra le pagine più belle perché più vere vi sono quelle dedicate alle riflessioni sulla natura e sugli scopi della guerra, uno ‘specimen’ delle quali si è scelto qui di riprodurre attraverso la figura e la vicenda di Tommasino, cioè di un personaggio legato alla monomania del negozio e, come accadeva in tempo di guerra, alla pratica della borsa nera: un personaggio quindi ferreamente condizionato dal feticismo del denaro e che pagherà con la perdita del senno e della vita la scoperta di “ciò che sta dietro il denaro”. Si tratterà allora, per un verso, della scoperta di ciò che costituisce la vera sostanza di quell’apparenza spettrale, ossia nel caso la macchina bellica, e, per un altro verso, del fatto che la merce non potrà mai sfamare il mondo, che è proprio quanto dovrà constatare amaramente a sue spese la moglie di Tommasino.
E qui Moravia, ritrovando, potenziata ‘in rebus ipsis’ dalla lezione del marxismo e del leninismo, la forza morale dello scrittore “agro e giansenista” che egli era stato nella sua giovinezza, 2 esprime una piena ed icastica consapevolezza di quale sia la realtà retrostante alla forma-denaro e alla forma-merce, ossia il nocciolo sanguinoso e distruttivo della lotta per il profitto capitalistico e per la supremazia territoriale, la cui logica – suggerisce l’autore – si esplica in tutta la sua dirompente violenza (il bombardamento a tappeto serve, innanzitutto, a terrorizzare la popolazione civile, incrinandone il consenso al governo esistente) nella guerra inter-imperialistica e nelle contrapposte occupazioni militari (quella tedesca che sarà responsabile del sequestro e dell’uccisione di Michele, quella anglo-franco-americana che sarà responsabile dello stupro di Rosetta).
- Details
- Hits: 4161
Franco CFA
Tutto quello che avreste sempre voluto sapere e non avete mai osato chiedere
di Thomas Fazi
 Franco CFA. Fino a poco tempo fa queste due parole non avrebbero significato un granché per la maggior parte degli italiani. Oggi, invece, il termine è entrato nel dibattito pubblico anche da noi, grazie alle dichiarazioni di alcuni noti politici italiani, che hanno scatenato un’aspra crisi diplomatica tra Roma e Parigi. Dunque, chi segue la cronaca politica sa probabilmente che il franco CFA è una valuta utilizzata da una serie di paesi africani e soggetta alla tutela più o meno esplicita e più o meno disinteressata – a seconda dello schieramento del dibattito a cui si è scelto di credere – della Francia. Tuttavia per i più la questione rimane a dir poco fumosa. Vediamo dunque di fare chiarezza una volta per tutte.
Franco CFA. Fino a poco tempo fa queste due parole non avrebbero significato un granché per la maggior parte degli italiani. Oggi, invece, il termine è entrato nel dibattito pubblico anche da noi, grazie alle dichiarazioni di alcuni noti politici italiani, che hanno scatenato un’aspra crisi diplomatica tra Roma e Parigi. Dunque, chi segue la cronaca politica sa probabilmente che il franco CFA è una valuta utilizzata da una serie di paesi africani e soggetta alla tutela più o meno esplicita e più o meno disinteressata – a seconda dello schieramento del dibattito a cui si è scelto di credere – della Francia. Tuttavia per i più la questione rimane a dir poco fumosa. Vediamo dunque di fare chiarezza una volta per tutte.
Tanto per cominciare, quando parliamo di franco CFA, parliamo in realtà di due unioni monetarie: la Comunità economica e monetaria dell’Africa centrale (CEMAC), di cui fanno parte il Camerun, il Gabon, il Ciad, la Guinea Equatoriale, la Repubblica Centrafricana e la Repubblica del Congo; e l’Unione economica e monetaria ovest-africana (UEMOA), che comprende il Benin, il Burkina Faso, la Costa d’Avorio, la Guinea-Bissau, il Mali, il Niger, il Senegal e il Togo.
Queste due unioni monetarie usano due franchi CFA distinti, che però condividono lo stesso acronimo: per il franco della zona CEMAC, CFA sta per “Cooperazione finanziaria in Africa centrale”, mentre per il franco dell’EUMOA sta per “Comunità finanziaria africana”. Ad ogni modo, questi due franchi CFA funzionano esattamente alla stessa maniera e sono ancorati all’euro con la stessa parità di cambio. Insieme a un quindicesimo Stato – l’Unione delle Comore, che usa un franco distinto ma soggetto alle stesse regole – formano la cosiddetta “zona del franco”. Complessivamente, più di centosessantadue milioni di persone usano i due franchi CFA (più il franco delle Comore), secondo i dati ONU del 2015.
- Details
- Hits: 2913
Il tabu del debito pubblico nasconde chi ci guadagna
di Claudio Conti
 Il debito pubblico, spiegava Marx, è l’unica cosa davvero comune a tutta la popolazione in una società divisa in classi. Come per ogni “bene comune”, però – per quanto “negativo” come il debito – c’è sempre una modo per avvantaggiare alcuni a scapito di altri.
Il debito pubblico, spiegava Marx, è l’unica cosa davvero comune a tutta la popolazione in una società divisa in classi. Come per ogni “bene comune”, però – per quanto “negativo” come il debito – c’è sempre una modo per avvantaggiare alcuni a scapito di altri.
Fuori da ogni disputa ideologica – che è “falsa coscienza”, ovvero “narrazione” fasulla per coprire il reale – occorre guardare a questo debito con occhi decisamente diversi da quelli totalmente strabici di un Cottarelli, Giannini, Alesina, Giavazzi, Monti e via cantando sulle note dell’austerità.
Un editoriale di Guido Salerno Aletta per Milano Finanza aiuta – come spesso ci accade – a chiarire alcuni dettagli che svuotano di senso quella narrazione, illuminando su altre soluzioni. Quelle proposte da Carlo Messina, amministratore delegato di Banca Intesa, e riprese da questo editoriale, non sono ovviamente le nostre. Ma mostrano quasi fisicamente che si possono seguire altre strade anche restando in ambito totalmente capitalistico.
Ma, se si possono seguire altre persino garantendo al mondo del business di continuare a far soldi, allora sono possibili anche starde che portano da tutt’altra parte. In entrambi i casi – ed è questo l’interessante – viene distrutta la narrazione per cui “non c’è alternativa”. Un’autentica tortura mediatica (pensiamo solo alla quantità di volte che Carlo Cottarelli viene invitato da Fabio Fazio o Paolo Floris…) che ha anestetizzato le capacità critiche soprattutto della cosiddtta “sinistra”, incapace oggi persino di articolare un pensiero senzato di fronte alla più devastante delle domande: “ma dove si trovano i soldi?”.
La strada dell’a.d. di Banca Intesa, per esempio, rivela che non solo “i soldi ci sono”, e in misura persino eccessiva rispetto allo scopo di abbattere il debito pubblico, ma soprattutto che quella domanda retorica da talk show nasconde gli interessi reali che hanno guadagnato ricchezze colossali:
- Details
- Hits: 3072
La globalizzazione e l’economia
intervista a Sergio Cesaratto
 Sergio Cesaratto, professore ordinario nel Dipartimento di Economia Politica e statistica dell’Università degli Studi di Siena, da sempre economista eterodosso e ormai punto di riferimento della divulgazione dell’economia classica in Italia. Ha recentemente pubblicato due importanti libri che hanno fatto molto successo: Chi non rispetta le regole? del 2018 e Sei lezioni di Economia del 2016, dimostrandosi ancora una volta come importante voce critica della sinistra e dei processi di involuzione che la stanno attraversando.
Sergio Cesaratto, professore ordinario nel Dipartimento di Economia Politica e statistica dell’Università degli Studi di Siena, da sempre economista eterodosso e ormai punto di riferimento della divulgazione dell’economia classica in Italia. Ha recentemente pubblicato due importanti libri che hanno fatto molto successo: Chi non rispetta le regole? del 2018 e Sei lezioni di Economia del 2016, dimostrandosi ancora una volta come importante voce critica della sinistra e dei processi di involuzione che la stanno attraversando.
* * * *
Osservatorio Globalizzazione: Ormai a quasi trent’anni dall’inizio del processo di globalizzazione in senso neoliberale, possiamo provare a tracciarne un bilancio, lei cosa ne pensa?
Sergio Cesaratto: Per molti versi il processo di globalizzazione era ineludibile con l’entrata nel capitalismo e nel mercato mondiale di molti Paesi che erano un tempo chiamati del Terzo Mondo. L’espansione dell’esercito industriale di riserva anche attraverso la delocalizzazione delle produzioni in quei Paesi, ha tuttavia comportato l’indebolimento del movimento operaio e delle conquiste nei Paesi di più antica industrializzazione. Quindi il bilancio per noi è negativo sul piano dei diritti sociali.Simmetricamente all’esplosione della globalizzazione vi è stato il crollo del modello socialista. Questo, forse più della globalizzazione, ha fatto crollare l’idea stessa di una alternativa al capitalismo – in un certo senso la traiettoria cinese del capitalismo guidato dallo Stato, esperienza peraltro non nuova, può essere vista anche in questa luce. La crisi verticale della sinistra è tutta qui. Senza un modello socio-economico alternativo, rimangono solo le utopie, le belle parole, i diritti civili, mentre le masse popolari guardano altrove, purtroppo a destra. E questo è naturalmente paradossale, perché a destra non c’è nessuna vera alternativa, anzi.
- Details
- Hits: 4060
Brexit and Exit
di Italo Nobile*
 Abituato a fare appelli a Capi di Stato, Sting ha esortato il suo paese a ripensarci sulla Brexit1. E’ la notizia più frivola su un processo che, dopo le incertezze ed un dibattito parlamentare fatto di bocciature e rinvii2, è stato da più parti derubricato a pasticcio3 e ad errore. Perciò è necessario analizzarlo un po’ meglio cercando di restituire ad esso lo spessore che merita.
Abituato a fare appelli a Capi di Stato, Sting ha esortato il suo paese a ripensarci sulla Brexit1. E’ la notizia più frivola su un processo che, dopo le incertezze ed un dibattito parlamentare fatto di bocciature e rinvii2, è stato da più parti derubricato a pasticcio3 e ad errore. Perciò è necessario analizzarlo un po’ meglio cercando di restituire ad esso lo spessore che merita.
L’Unione Europea e l’euro sono le forme assunte negli ultimi decenni nel nostro continente dalle politiche neoliberiste, per quanto queste ultime si fossero già parzialmente affermate a livello nazionale in molte parti del mondo negli anni Ottanta (Usa, Gb ma anche Francia e Italia) e Novanta (paesi dell’Est Europa e poi Russia).
La crisi del modello di accumulazione capitalistico degli anni Settanta5 ha portato alla globalizzazione (intesa come strategia liberoscambista di abbattimento delle barriere alla circolazione mondiale di merci e di capitali)6 e dunque ai processi di riorganizzazione capitalistica volti a risolvere (con implicazioni contraddittorie) le crisi mediante l’espansione industriale e/o finanziaria all’esterno e la riduzione del salario e del welfare all’interno7.
Ciò accelerava sia la competizione tra Stati e anche tra intere aree economiche8 sia la creazione di macroregioni che garantissero una sufficiente centralizzazione di capitale per competere al meglio. Non è un caso che la difficile costruzione dell’Unione Europea si è resa necessaria tra nazioni che erano o sconfitte nell’ultima guerra o vincitrici grazie all’intervento di una nazione più forte. Non è un caso che tale costruzione si sia accelerata quando l’unificazione tedesca rischiava di destabilizzarla9 e quando è stato chiaro che il tempo avrebbe giocato a sfavore delle nazioni europee isolatamente considerate.
Non dimentichiamo che la quota del commercio mondiale detenuta dalle singole nazioni europee è costantemente diminuita nel corso di questi anni (la grande Germania è passata dal 9,43% del 1994 al 7,48% del 2014, la Francia dal 7,06 al 3,97, il Regno Unito dal 6,43 al 4,01, l’Italia dal 4,63 al 2,65, i Paesi Bassi e la Spagna sono rimasti allo stesso livello e cioè 3,9 e 1,9)10.
- Details
- Hits: 1842
Benvenuti nel reale antropocene: fase due
di Roberto Paura
 Il fondatore del transumanesimo, Max More, pubblicò online, nel 1999, una celebre Lettera a Madre Natura. Con un tono più ironico e senza dubbio più diretto di quello usato da Giacomo Leopardi nel rivolgersi alla stessa interlocutrice un paio di secoli prima, More osserva che, pur avendoci la Natura fornito una serie di doni importanti (“il massimo controllo del pianeta”, “un’aspettativa di vita fra le più lunghe del regno animale”, “un cervello complesso”), al tempo stesso essa si è dimostrata avara su numerosi aspetti:
Il fondatore del transumanesimo, Max More, pubblicò online, nel 1999, una celebre Lettera a Madre Natura. Con un tono più ironico e senza dubbio più diretto di quello usato da Giacomo Leopardi nel rivolgersi alla stessa interlocutrice un paio di secoli prima, More osserva che, pur avendoci la Natura fornito una serie di doni importanti (“il massimo controllo del pianeta”, “un’aspettativa di vita fra le più lunghe del regno animale”, “un cervello complesso”), al tempo stesso essa si è dimostrata avara su numerosi aspetti:
“Ci hai creati vulnerabili alle malattie e alle ferite. Ci hai obbligati a invecchiare e a morire – proprio quando cominciamo a diventare saggi. Sei stata un po’ avara nel darci consapevolezza dei nostri processi somatici, cognitivi ed emotivi. Sei stata poco generosa con noi, donando sensi più raffinati ad altri animali. Possiamo funzionare solo in certe specifiche condizioni ambientali. Ci hai dato una memoria limitata e scarso controllo sui nostri istinti tribali e xenofobici” (More, 1999).
Le accuse di More sono senz’altro giuste, ma d’altronde, a pensarci bene, cosa potrebbero dire gli altri animali, se potessero esprimere qualche critica a Madre Natura? Di sicuro, tra tutti, siamo stati i più fortunati, gli unici a essersi evoluti fino a raggiungere un’autocoscienza complessa e una capacità di modificare noi stessi e il resto della natura. Pensatori come Thomas Ligotti, così come numerosi filosofi del passato, hanno messo in dubbio il fatto che la nostra intelligenza sia un beneficio, dato che comporta, come effetto collaterale, una dose di preoccupazioni non indifferenti. Non è nemmeno da escludersi che molti animali possano considerare i nostri presunti “benefici” come “maledizioni”, qualora potessero spingersi a un simile livello di consapevolezza. Ma, secondo la visione del transumanesimo, che è poi la filosofia alla base dell’accelerazione tecnologica dei nostri tempi, il nostro compito dovrebbe essere quello di potenziare l’essere umano per affrancarlo dal suo determinismo biologico, attraverso la tecnologia.
- Details
- Hits: 3821
Euro: una questione di classe
di Thomas Fazi
Ringraziando Stefano Tancredi, Robin Piazzo e Domenico Cerabona Ferrari per il bell'incontro di ieri a Settimo Torinese, riporto il testo del mio intervento, in cui rispondevo alla seguente domanda: «Un singolo Stato può “reggere” dal punto di vista economico l’uscita dalla realtà economica neoliberista dell’UE? Se “no” perché? È più opportuno un processo di riforme economiche nel contesto europeo? Come rapportarsi ai vincoli economici imposti dall’UE? Se si può “reggere” questa uscita come? Quali strategie adottare? Si deve ritornare alla propria moneta? È possibile un’alleanza economica con altri Stati dalla struttura economica più simile alla nostra?»
 La prima cosa da dire è che c’è poco da scegliere. O meglio, la scelta non è se uscire dall’UE o se riformare l’UE, per il semplice fatto che quest’ultima opzione non è praticabile.
La prima cosa da dire è che c’è poco da scegliere. O meglio, la scelta non è se uscire dall’UE o se riformare l’UE, per il semplice fatto che quest’ultima opzione non è praticabile.
L’UE è strutturata in maniera tale da non essere riformabile, perlomeno non nel senso che auspicano gli integrazionisti di sinistra, cioè nella direzione di una riforma dell’UE in senso democratico e progressivo/sociale, men che meno nella direzione di un vero e proprio Stato federale sul modello degli Stati Uniti o dell’Australia.
Come disse il compianto Luciano Gallino poco prima di morire: «Nessuna realistica modifica dell’euro sarà possibile», in quanto esso è stato progettato «quale camicia di forza volta a impedire ogni politica sociale progressista, e le camicie di forza, vista la funzione per cui sono state create, non accettano modifiche “democratiche”».
Basti pensare che per “riformare i trattati” è necessaria l’unanimità di tutti e 28 gli Stati membri dell’UE. In altre parole, sarebbe necessario che in tutti e 28 i paesi dell’UE salissero al potere dei governi progressisti che condividono le stesse prospettive di riforma “di sinistra” dell’euro. Ora, non bisogna essere particolarmente pessimisti per capire perché questo non accadrà mai.
E non accadrà mai innanzitutto perché le condizioni economiche, politiche, sociali, ecc. che si registrano nei diversi Stati sono estremamente eterogenee: ci sono paesi che registrano tassi di disoccupazione estremamente bassi (come la Germania) e paesi come il nostro che registrano tassi di disoccupazione altissimi; ci sono paesi che crescono e paesi che non crescono, ecc.
- Details
- Hits: 2871
Come ci siamo ridotti così? Risvegliamoci!
di Francesco Ciafaloni
 Mi è capitato di recente di leggere o rileggere alcuni testi sulla riduzione e la redistribuzione dell’orario di lavoro scritti più o meno un quarto di secolo fa, quando si discuteva di 35 ore, di autori che mi sono familiari, come Giovanni Mazzetti (Teoria generale della necessità di redistribuire l’orario di lavoro) o Giorgio Lunghini (Introduzione a L’ABC dell’economia, di Ezra Pound).
Mi è capitato di recente di leggere o rileggere alcuni testi sulla riduzione e la redistribuzione dell’orario di lavoro scritti più o meno un quarto di secolo fa, quando si discuteva di 35 ore, di autori che mi sono familiari, come Giovanni Mazzetti (Teoria generale della necessità di redistribuire l’orario di lavoro) o Giorgio Lunghini (Introduzione a L’ABC dell’economia, di Ezra Pound).
Mi sono reso conto che alcune delle tesi sostenute dagli autori, che avevo ben presenti venti anni fa, erano come sparite dal mio orizzonte mentale negli ultimi tempi. Avevo smesso di fatto di usarle per cercare di capire quello che succede tutti i giorni. Mi sono accorto di essermi come addormentato, intontito dall’eterna ripetizione delle tesi correnti: l’eccesso di spesa pubblica, la necessità di puntare sull’innovazione tecnica e sull’industria 4.0, la possibilità che si crei, all’interno del sistema produttivo, occupazione sostitutiva di quella distrutta dall’automazione, l’ossessione e la necessità della crescita del PIL.
Venti anni fa erano vivi De Cecco, Graziani, Gallino, non c’era la resa culturale che ci sommerge ora. C’erano economisti, sociologi, storici autorevoli, che non si rifugiavano nel silenzio e avevano modo di esprimersi sui giornali maggiori. Oggi prevale l’imbarazzante ripetizione di parole senza senso, come “mercato”, inteso come il dispensatore di giudizi inappellabili di adeguatezza, positività, efficienza di qualsiasi iniziativa; “crescita” intesa come la tendenza naturale di tutti i Paesi del mondo, a meno di colpe gravi dei loro cittadini, ad aumentare il PIL più o meno del 3% l’anno; “equilibrio”, inteso come la naturale, automatica, tendenza all’equilibrio tra domanda e offerta («l’equilibrio è un caso», avrebbe ribattuto Lunghini citando Marx).
Eravamo abituati a distinguere tra economisti ortodossi ed eterodossi. Gli ortodossi avevano un bel sistema ma negavano l’evidenza della disoccupazione involontaria, della concentrazione della ricchezza, dell’uso del denaro per arricchirsi senza produrre.
- Details
- Hits: 2135

La cultura nel capitalismo assoluto
di Salvatore Bravo
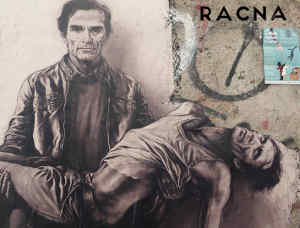 Con la cultura non si mangia
Con la cultura non si mangia
La parola cultura ha subito un processo di deflazione del suo significato, al punto che nel 2010 il ministro dell’economia Tremonti affermò che con la cultura non si mangia. La verità torna sempre a galla malgrado i raggiri ideologici, e Tremonti ha espresso la verità del liberismo postborghese nel quale non vi è posto per il pensiero, per la formazione, ma solo per il calcolo, per il consumo dell’essere e dell’esserci.
Il giudizio ideologico di Tremonti non esaurisce i significati della parola cultura, per nostra fortuna, ma esprime l’imbarbarimento della condizione attuale. La cultura fine a se stessa o al servizio della persona è uno scandalo (dal greco skàndalon inciampo) da respingere, non si può inciampare e fermare il consumo, essa è un’ insostenibile trasgressione alla struttura economica che sta consumando l’intero pianeta (su otto milioni di specie di viventi un milione è a rischio estinzione secondo i calcoli dell’ONU).
In verità La cultura è radicale ed antitetica rispetto al capitalismo assoluto: in primis essa è portatrice di valori universali ed in quanto tali, non vendibili, in secundis l’etimologia della parola ci suggerisce il suo essere altro rispetto al tempo del capitalismo cultura (dal lat. cultura, der. di colĕre «coltivare»), essa è attività e temporalità della formazione, il tempo della cultura tesse il presente nel suo ordito, nella sua distensione riannoda ella continuità teleologica ciò che era disperso. Il capitalismo assoluto si esaurisce nell’immediatezza, è sciolto da ogni legame temporale e comunitario, pertanto è estraneo alla domanda sul senso, sostituita dal calcolo, dal silenzio degli enti che devono corrispondere al solo utile immediato.
Una difficile definizione
La cultura è una parola polisemica, nel corso della storia le sono stata attribuite innumerevoli significati, ciò malgrado ogni definizione si attuava in tensione con altre configurazioni simboliche.
- Details
- Hits: 2387
La natura sociale dell’Unione Europea*
di Ernesto Screpanti
 Il secondo appuntamento del Maggio filosofico 2019 è per Giovedì 16 maggio alle ore 21:00, presso la Biblioteca comunale Don Milani di Rastignano e ha per oggetto l’Europa nella storia: gli Stati Uniti (capitalistici) di Europa. Infatti l’attuale Unione Europea è l’unità asimmetrica di nazioni con un “centro” e una “periferia” dove il centro esporta merci e acquista titoli pubblici “periferici” rendendosi creditore di una periferia che si indebita. Ma nell’interesse di chi? Non pare proprio in quello dei salariati sia del centro che della periferia…
Il secondo appuntamento del Maggio filosofico 2019 è per Giovedì 16 maggio alle ore 21:00, presso la Biblioteca comunale Don Milani di Rastignano e ha per oggetto l’Europa nella storia: gli Stati Uniti (capitalistici) di Europa. Infatti l’attuale Unione Europea è l’unità asimmetrica di nazioni con un “centro” e una “periferia” dove il centro esporta merci e acquista titoli pubblici “periferici” rendendosi creditore di una periferia che si indebita. Ma nell’interesse di chi? Non pare proprio in quello dei salariati sia del centro che della periferia…
L’Unione Europea non è un’unione politica con una costituzione approvata dai popoli. È un’entità statale (di fatto se non di diritto) costituita con trattati internazionali che si sovrappongo alle costituzioni nazionali tentando di demolirle (Russo, 2017). Gli organismi politici che determinano le sue politiche monetarie e fiscali sono la Banca Centrale Europa e il governo tedesco, e nessuno dei due è responsabile verso i popoli europei.
Il ruolo del governo tedesco merita di essere chiarito. Il predominio della Germania sull’economia europea si era affermato già dagli anni ’70, e divenne ingombrante dopo l’unificazione tedesca del 1990. Con la fondazione dell’Unione è accaduto che i governi di quel paese sono riusciti a conquistare per la sua industria vantaggi competitivi senza precedenti. Con le riforme Hartz (2003-2005) e le politiche fiscali restrittive, la crescita salariale è stata posta sotto controllo, completando un processo avviato già negli anni ’90. Inoltre le imprese tedesche hanno esteso le loro catene del valore verso i paesi dell’Est europeo (e in parte del Sud), dove i salari sono più bassi che in Germania. In questa maniera l’industria tedesca ha avuto un costo del lavoro che è cresciuto sistematicamente di meno rispetto a quello dei principali concorrenti, in particolare Francia, Italia e Spagna. Ciò ha permesso alla Germania di mantenere un elevato e crescente surplus commerciale, spingendo i paesi del Sud Europa verso il deficit del conto corrente (l’Italia e la Spagna fino al 2012, la Francia ancora oggi).
- Details
- Hits: 1971
Luoghi comuni. Smart city a chi?
di Giovanna Sissa e Giulio De Petra
Articolo pubblicato (pp. 59 – 66) sul primo numero di “Luoghi Comuni” (Castelvecchi Editore). Qui disponibile l’intero numero
 Smart
Smart
L’aggettivo smart è stato associato a qualunque sostantivo, dal frigorifero alle reti elettriche, per indicare un miglioramento, un superamento di qualche limite. Ma se il sostantivo che diventa smart non è più un oggetto fisico, il significato ammiccante dell’aggettivo qualificativo – paradigmatico dell’innovazione digitale – diviene rarefatto. Un telefono smart si può supporre che abbia più funzioni di uno normale, così come un termometro o un palo della luce, ma che cosa è il lavoro smart, e soprattutto, che cosa è una città smart? Nessuno si permetterebbe di dire che la Roma antica, la Firenze rinascimentale o la Parigi della Belle Époque fossero città stupide, dunque erano città intelligenti: così una smart city dovrebbe per definizione essere qualcosa di più. Ma cosa?
Se cercate una definizione di smart city ne troverete moltissime, nessuna precisa e dunque troppe. Si parla di smart city da molto tempo. Possiamo datare l’introduzione del termine alla fine degli anni Novanta ed attribuirla a IBM. Nei primissimi anni 2000 il termine smart city si afferma a partire dagli USA e si diffonde sia nel nord che nel sud del mondo, dove lo sviluppo di mega metropoli, in Cina come India, dà un forte impulso alla creazione, talvolta ex novo – di nuove città smart. In Europa si impone a cavallo dei primi due decenni del nuovo millennio. Nel report Mapping smart cities in the EU (2014) la smart city è definita «una città che cerca di affrontare le sue emergenze più significative attraverso l’utilizzo intenso e innovativo delle tecnologie digitali». La città smart, a seconda dell’ambito di utilizzo che si intende promuovere, diventa Knowledge city, sustainable city, talented City, wired city, digital city, eco-city. Le smart cities europee sono inizialmente identificate come città con almeno una iniziativa rivolta a una fra le seguenti sei caratteristiche: smart governance, smart people, smart living, smart mobility, smart economy e smart environment.
- Details
- Hits: 2335
I gilets jaunes e la stampa italiana. Lettera aperta a “il Manifesto”
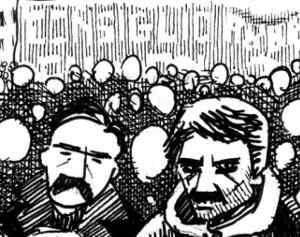 Gentile Redazione de “il Manifesto”,
Gentile Redazione de “il Manifesto”,
siamo un gruppo di italiane/i che risiedono a Parigi per ragioni di studio o di lavoro e che partecipano da ormai più di cinque mesi al movimento dei Gilet Gialli. Vi scriviamo per manifestarvi il nostro sdegno a fronte del trattamento riservato nelle pagine del vostro giornale, nella penna di Anna Maria Merlo, vostra corrispondente a Parigi, al sollevamento in atto – e in Atti – dei Gilet Gialli, nonché alla questione politica e sociale che, con inedita forza, esso continua a porre, in Francia e in Europa – dunque, potrebbe darsi, anche in Italia. Ci rivolgiamo a voi, e non ad altri quotidiani nazionali, perché convinti che “il Manifesto” sia luogo di confronto e diffusione di informazioni critiche, nonché voce delle lotte del presente. Tuttavia, malgrado alcune rare ma felici eccezioni[1], la maniera in cui il vostro quotidiano ha parlato finora del movimento francese, attraverso gli articoli dell’autrice, ha prodotto in noi sconcerto e rabbia.
Prima di entrare nel merito, e per capirci meglio, lasciateci un attimo “contestualizzare”.
Il movimento dei Gilet Gialli continua a manifestare la sua forza nell’insieme del territorio francese e in alcuni territori d’oltremare da ben venticinque sabati consecutivi: ciononostante, quando se ne parla in Italia, lo si fa soltanto basandosi sulle cifre del Ministero dell’Interno francese, dati certamente poco attendibili ad oggi.
Per comprendere come non si tratti di qualcosa di passeggero ma di una profonda trasformazione nella storia sociale e politica del paese, dovrebbe bastare, in controluce, la reazione del potere costituito: da novembre ad oggi il sovrano Macron ha dovuto reagire con due “solenni” discorsi alla nazione, una lettera indirizzata ai francesi, una lettera agli europei, e un “Gran Dibattito Nazionale”, che ha assunto il senso di un confuso rilancio, nella crisi profonda del suo governo, della sua politica “start-up”.
- Details
- Hits: 4063
La sinistra, la Cina, la globalizzazione
di Romeo Orlandi*
Riproponiamo dal numero dell’autunno 2018 di Critica marxista il saggio di Romeo Orlandi ‘La sinistra, la Cina, la globalizzazione’, con due note redazionali
 Lo scontro USA Cina dentro questa globalizzazione si fa sempre più complesso e rischioso. L’ottimismo ideologico del libero mercato si era spinto irragionevolmente, coinvolgendo anche tutte le sinistre compresa la nostra, a pensare che la globalizzazione sarebbe stata di segno occidentale e che la bandiera della democrazia sarebbe sventolata a Pechino e a Shanghai. E’ successo invece il contrario, la Cina è tutto fuorché democratica ma produce sempre di più e meglio mentre l’Italia punta ancora sul fascino antiquato del made in Italy piuttosto che sull’innovazione.
Lo scontro USA Cina dentro questa globalizzazione si fa sempre più complesso e rischioso. L’ottimismo ideologico del libero mercato si era spinto irragionevolmente, coinvolgendo anche tutte le sinistre compresa la nostra, a pensare che la globalizzazione sarebbe stata di segno occidentale e che la bandiera della democrazia sarebbe sventolata a Pechino e a Shanghai. E’ successo invece il contrario, la Cina è tutto fuorché democratica ma produce sempre di più e meglio mentre l’Italia punta ancora sul fascino antiquato del made in Italy piuttosto che sull’innovazione.
I fatti mostrano la loro proverbiale ostinazione anche quando registrano gli spostamenti dei container. Sette dei primi otto porti al mondo per tonnellaggio movimentato sono in Cina; Singapore (4°) costituisce l’eccezione. Il porto europeo più trafficato è Rotterdam, confuso al nono posto tra altre posizioni asiatiche e qualche intromissione australiana e statunitense. Alcuni decenni fa la lista era molto diversa, con un predominio delle due sponde dell’Atlantico. Spuntava ancora Genova. La classifica attuale è la fotografia più nitida della trasformazione della Cina in Fabbrica del Mondo. Si potrebbe obiettare che le merci movimentate siano destinate anche al mercato locale, così da ridurre l’impatto internazionale, come se i consumi interni assorbissero questa eclatante supremazia. In realtà, la grande maggioranza delle merci cinesi si dirige verso lidi stranieri. La Repubblica popolare è infatti dal 2009 il più grande esportatore al mondo, dopo avere insidiato e poi superato agevolmente il primato della Germania e degli Stati Uniti.
La sequenza logica che se ne ricava rasenta la banalità espositiva: i porti movimentano i container, che trasportano le merci, prodotte dalle fabbriche, generate dagli investimenti, stimolati dalle opportunità. Sembra di assistere alla famosa cantilena Alla fiera dell’Est.
- Details
- Hits: 1747
Vento dall'Est
La nuova via della seta
di Giovanna Baer
 Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente cinese XI Jinping hanno firmato a Roma il 23 marzo scorso un importante Memorandum d'intesa tra Italia e Cina sulla Belt and Road Initiative (BRI), un enorme programma di investimenti cinesi in infrastrutture lungo la cosiddetta Via della Seta: una definizione che comprende diverse antiche rotte commerciali, terrestri, marittime e fluviali di circa 8.000 chilometri, lungo le quali fin dai tempi di Erodoto si sono snodati gli scambi culturali e commerciali tra Oriente e Occidente. La firma del Memorandum ha reso la visita di Xi particolarmente attesa e rilevante. I media ne hanno ampiamente seguito la cronaca e discusso, per la magnitudine del progetto - in termini di portata economica e di durata temporale - ma soprattutto perché l'Italia è il primo Paese del G7 a partecipare ufficialmente alla BRI, e questa partnership potrebbe modificare la politica estera e mettere in crisi la storica alleanza con gli Stati Uniti - lasceremo da parte in questa analisi la questione della rete 5G perché articolata e meriterebbe un articolo a sé.
Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente cinese XI Jinping hanno firmato a Roma il 23 marzo scorso un importante Memorandum d'intesa tra Italia e Cina sulla Belt and Road Initiative (BRI), un enorme programma di investimenti cinesi in infrastrutture lungo la cosiddetta Via della Seta: una definizione che comprende diverse antiche rotte commerciali, terrestri, marittime e fluviali di circa 8.000 chilometri, lungo le quali fin dai tempi di Erodoto si sono snodati gli scambi culturali e commerciali tra Oriente e Occidente. La firma del Memorandum ha reso la visita di Xi particolarmente attesa e rilevante. I media ne hanno ampiamente seguito la cronaca e discusso, per la magnitudine del progetto - in termini di portata economica e di durata temporale - ma soprattutto perché l'Italia è il primo Paese del G7 a partecipare ufficialmente alla BRI, e questa partnership potrebbe modificare la politica estera e mettere in crisi la storica alleanza con gli Stati Uniti - lasceremo da parte in questa analisi la questione della rete 5G perché articolata e meriterebbe un articolo a sé.
One Belt One Road
Nel settembre del 2013 Xi Jinping ha tenuto un discorso in Kazakistan, all'università di Nazarbaev, dal titolo suggestivo: "Promuovere l'amicizia fra i nostri popoli e lavorare insieme per creare un luminoso futuro" (1). Vi sottolineava che "per forgiare legami economici più stretti, migliorare il livello di cooperazione ed espandere lo spazio di sviluppo nella regione euroasiatica, dovremmo scegliere un approccio innovativo e unire gli sforzi per costruire una cintura economica lungo la Via della Seta. Potremmo iniziare con investimenti in singole aree e congiungerle nel tempo per connettere l'intera regione".
- Details
- Hits: 1535
Robin contro l’output gap
di Carlo Clericetti
 Altro che Robin Hood, il nostro eroe è Robin Brooks. Che non è un ribelle che vive nascosto, anzi: è – pensate un po’ – un economista mainstream. Laurea a Yale, master alla London school, poi Fondo monetario (8 anni) e Goldman Sachs. E ora è capo economista all’Iif, Institute of International Finance, che magari non è molto conosciuto dal grande pubblico, ma è tra le più importanti lobby della finanza: basti sapere che ha rappresentato le banche nei negoziati sul regolamento di Basilea 3 e i creditori in quelli sul debito greco del 2011-12. Insomma, un personaggio che si muove nelle stanze del potere, il potere vero.
Altro che Robin Hood, il nostro eroe è Robin Brooks. Che non è un ribelle che vive nascosto, anzi: è – pensate un po’ – un economista mainstream. Laurea a Yale, master alla London school, poi Fondo monetario (8 anni) e Goldman Sachs. E ora è capo economista all’Iif, Institute of International Finance, che magari non è molto conosciuto dal grande pubblico, ma è tra le più importanti lobby della finanza: basti sapere che ha rappresentato le banche nei negoziati sul regolamento di Basilea 3 e i creditori in quelli sul debito greco del 2011-12. Insomma, un personaggio che si muove nelle stanze del potere, il potere vero.
E come mai ci piace tanto? Perché ha iniziato una battaglia contro l’utilizzo, da parte della Commissione europea e del Fondo monetario, dell’output gap, che è uno dei meccanismi infernali utilizzati per dare giudizi sull’economia di un paese e decidere i limiti della sua politica di bilancio. Brooks ha persino coniato un acronimo, CANOO, che sta per Campaign against Nonsense Output Gaps, ossia Campagna contro gli insensati output gaps, e produce grafici che mostrano come questo parametro sia completamente sballato e il suo utilizzo abbia effetti devastanti sulle politiche economiche.
Prima di mostrarveli ricordiamo in breve che cosa sia l’output gap. Quando un paese è in recessione, la grande maggioranza degli economisti, sia pure con varie sfumature, concordano sul fatto che la politica di bilancio debba essere espansiva, ossia che lo Stato debba spendere di più per sostenere l’economia. Negli anni passati non c’era questo largo consenso, ma questa è un’altra storia che sarebbe troppo lungo raccontare. Però siamo solo all’inizio del problema, perché, secondo la teoria economica dominante, la maggiore spesa può avere effetto solo quando il paese in questione è al di sotto del suo prodotto potenziale, cioè quello che si otterrebbe se tutti i fattori della produzione – lavoro, capitali – fossero utilizzati al meglio. Altrimenti, quella maggiore spesa non farebbe altro che far aumentare il debito e scatenare l’inflazione.
Page 277 of 612