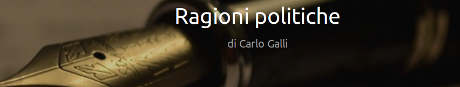Fai una donazione
Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________
- Details
- Hits: 1222

Tornanti. Una mappa
di Nuova Direzione

1) Premessa
L’epidemia di Covid-19, che ha investito l’intero pianeta ha costretto al blocco o a un fortissimo rallentamento tutte le economie occidentali, rappresenta un tornante storico che determina un “prima” ed un “dopo”. Una nuova fase sta avanzando con rapidità assolutamente imprevedibile e con pari incertezza. Una nuova fase esige di aggiornare le parole d’ordine.
Il presente testo rappresenta il contributo che Nuova Direzione propone alla discussione collettiva per la costruzione di una piattaforma di ispirazione socialista ed in grado di coniugare una prospettiva di difesa della indipendenza e sovranità democratica e nazionale con un chiaro orientamento egemonico imperniato su un blocco sociale coerente con questa. Sono necessarie per la fase chiarezza teorica e programmatica, da una parte, e la massima convergenza di forze e d’azione possibile, dall’altra. Ma la prima istanza, senza visione non c’è azione coerente, implica che l’eventuale soggetto, pur potendo allearsi tatticamente anche con forze diverse, dovrà avere una chiara e coerente linea politica. A questo fine le proposizioni che seguono.
La nostra economia non va riavviata, né rimessa in piedi, ma interamente “reimpostata”, ri-organizzata.
A questo fine dobbiamo fare un breve passo indietro per allargare lo sguardo.
2) Dove siamo
Gli sviluppi politici promossi nell’era neoliberale, e specificamente nella sua fase di più accentuata globalizzazione economica, a partire dagli anni ’90, hanno avuto come esito una radicale depoliticizzazione della popolazione.
- Details
- Hits: 1147
Da emergenza sanitaria a stato di eccezione politico?
di Geminello Preterossi
L'attitudine critica non può essere quella di negare o relativizzare il problema coronavirus, ma di denunciare abusi, irrazionalità, eccessi, logiche e rischi "di fondo". Bisognerà, poi, subito riorganizzarsi socialmente e politicamente
 Gli interventi di Giorgio Agamben sulle conseguenze politiche del coronavirus impongono alcune riflessioni. In generale, condivido la critica alla normalizzazione dell'emergenza, trasformata in "calamità" (anche quando si tratta, ed è la maggior parte dei casi, di questioni politiche, economiche, sociali e non certo di "oggettività" naturali o tecniche). Ora però il problema esiste e, soprattutto in Lombardia, ha creato una situazione drammatica dal punto di vista sanitario. Quindi una reazione mirata, ma adeguata, è necessaria. Certo, il rischio che si trasformi un'emergenza sanitaria reale in uno stato di eccezione politico c'è, è davanti ai nostri occhi. Delegare in toto agli esperti (che peraltro manifestano posizioni non sempre univoche) le scelte politiche è pericoloso: i tecnici devono fornire i dati da valutare, ma la decisione deve essere politica, perché solo così si può tenere conto della complessità dello scenario. Occorre saper distinguere, rendersi conto delle soluzioni che hanno funzionato e di quelle che non hanno funzionato, essere flessibili per aggiustare le strategie. Nessun fideismo emergenzialista, dunque. Abbiamo bisogno, piuttosto, di ragion pratica. La vita pubblica è cosa diversa da un laboratorio: altrimenti si trasforma la società intera in un “laboratorio”. Ciò, sia chiaro, non per ridimensionare il quadro, che è grave e preoccupante, ma per mantenere in funzione la capacità di valutare criticamente e deliberare di conseguenza (a proposito, siamo sicuri che le istituzioni rappresentative debbano eclissarsi, in un contesto del genere?). Inoltre, quando sarà passata questa buriana, bisognerà mettere in fila tutto: non solo errori, atteggiamenti ondivaghi e opachi, mancanze, ma la logica di fondo, i rischi politici che si corrono, le finalità perseguite dai “poteri indiretti” e il conto che verrà fatto pagare ai più deboli.
Gli interventi di Giorgio Agamben sulle conseguenze politiche del coronavirus impongono alcune riflessioni. In generale, condivido la critica alla normalizzazione dell'emergenza, trasformata in "calamità" (anche quando si tratta, ed è la maggior parte dei casi, di questioni politiche, economiche, sociali e non certo di "oggettività" naturali o tecniche). Ora però il problema esiste e, soprattutto in Lombardia, ha creato una situazione drammatica dal punto di vista sanitario. Quindi una reazione mirata, ma adeguata, è necessaria. Certo, il rischio che si trasformi un'emergenza sanitaria reale in uno stato di eccezione politico c'è, è davanti ai nostri occhi. Delegare in toto agli esperti (che peraltro manifestano posizioni non sempre univoche) le scelte politiche è pericoloso: i tecnici devono fornire i dati da valutare, ma la decisione deve essere politica, perché solo così si può tenere conto della complessità dello scenario. Occorre saper distinguere, rendersi conto delle soluzioni che hanno funzionato e di quelle che non hanno funzionato, essere flessibili per aggiustare le strategie. Nessun fideismo emergenzialista, dunque. Abbiamo bisogno, piuttosto, di ragion pratica. La vita pubblica è cosa diversa da un laboratorio: altrimenti si trasforma la società intera in un “laboratorio”. Ciò, sia chiaro, non per ridimensionare il quadro, che è grave e preoccupante, ma per mantenere in funzione la capacità di valutare criticamente e deliberare di conseguenza (a proposito, siamo sicuri che le istituzioni rappresentative debbano eclissarsi, in un contesto del genere?). Inoltre, quando sarà passata questa buriana, bisognerà mettere in fila tutto: non solo errori, atteggiamenti ondivaghi e opachi, mancanze, ma la logica di fondo, i rischi politici che si corrono, le finalità perseguite dai “poteri indiretti” e il conto che verrà fatto pagare ai più deboli.
- Details
- Hits: 1668
«Il mestiere di pensare» di Diego Marconi
di Donato Salzarulo
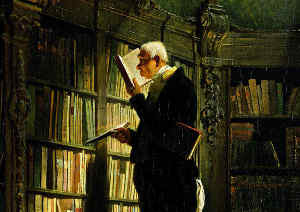 1.- «Povera, e nuda, vai Filosofia »
1.- «Povera, e nuda, vai Filosofia »
Qualche anno fa, un progetto ministeriale prevedeva di ridurre da tre a due anni l’insegnamento di filosofia nei Licei e di eliminarla dalle tabelle disciplinari di vari corsi di laurea perché – questa la singolare motivazione – trattasi di disciplina troppo specialistica. Mentre la matematica, la chimica, la fisica, ecc., per i cervelli di certi consulenti ministeriali, non lo sono.
Pur non facendo il filosofo di professione, ma rivendicando per me e per tutti gli uomini (e donne) la facoltà di pensare, ragionare, argomentare e conoscere, sia pure antologicamente, il patrimonio dei classici della filosofia, condivisi la levata di scudi che ci fu, quando il progetto fu reso noto. Anzi, fu proprio uno di loro a rivelarlo con un articolo su “La Repubblica” del 15 febbraio 2014.
Si tratta di Roberto Esposito che, per argomentare la necessità dell’insegnamento della filosofia, tra l’altro, scrisse: «La filosofia, oltre che indispensabile di per sé, lo è nei confronti degli altri saperi […] perché definisce le loro differenze, misura la tensione che passa tra i vari linguaggi. In quanto sapere critico, la filosofia impedisce la sovrapposizione di questioni eterogenee, delinea i confini dentro i quali esse assumono significato.»
Indispensabile di per sé vuol dire un sapere capace di ritagliarsi durante la sua storia secolare i propri oggetti di conoscenza che si chiamano “metafisica”, “gnoseologia”, “ontologia”, “logica”, “retorica”, “etica”, “estetica”, ecc. Oggi questi saperi sono diventate cattedre universitarie di “Storia della filosofia antica”, “medievale”, “moderna” e “contemporanea”, di “Filosofia della scienza”, “del linguaggio”, “del diritto”, “della politica”, “della storia”, “della morale”, “della religione”, e via elencando, a seconda delle Università.
- Details
- Hits: 1351

Politica-struttura del Ventunesimo secolo: Amazon, Google, Palantir e la CIA
di Daniele Burgio, Massimo Leoni e Roberto Sidoli
Pubblichiamo una parte del nuovo libro intitolato “Servizi segreti, guerre economiche e politica-struttura”, scritto da Daniele Burgio, Massimo Leoni e Roberto Sidoli e che verrà integralmente pubblicato online a maggio
 A volte si tende a separare l’attività di spionaggio dall’economia, dai profitti e dall’azione delle multinazionali: un errore che non era certo stato commesso da Norman Mailer nel suo geniale libro “Il fantasma di Harlot”, opera nella quale lo scrittore statunitense ventilava a livello narrativo (e forse non solo narrativo…) che nella CIA di Langley si fosse formato un nucleo e un gruppo interno supersegreto il quale, attraverso l’uso selettivo delle informazioni via via ottenute dall’agenzia, operava da decenni in campo finanziario acquisendo ingenti profitti equivalenti a miliardi di dollari.
A volte si tende a separare l’attività di spionaggio dall’economia, dai profitti e dall’azione delle multinazionali: un errore che non era certo stato commesso da Norman Mailer nel suo geniale libro “Il fantasma di Harlot”, opera nella quale lo scrittore statunitense ventilava a livello narrativo (e forse non solo narrativo…) che nella CIA di Langley si fosse formato un nucleo e un gruppo interno supersegreto il quale, attraverso l’uso selettivo delle informazioni via via ottenute dall’agenzia, operava da decenni in campo finanziario acquisendo ingenti profitti equivalenti a miliardi di dollari.
Passando dalla letteratura alla realtà storica, il tandem “economia-spionaggio” è emerso più volte nel corso degli ultimi due millenni: si parte dal trafugamento delle preziose uova di seta cinesi da parte dei monaci cristiani per conto dello stato bizantino, sotto il regno di Giustiniano e durante il sesto secolo, per arrivare mano a mano alla sottrazione ai cinesi dei loro segreti tecnologici nel processo di produzione della porcellana, furto avvenuto agli inizi del diciottesimo secolo, giungendo poi senza soluzione di continuità al nostro terzo millennio. Proprio negli ultimi decenni è venuta alla luce, con tutta evidenza, l’importanza e la diffusione di quella particolare e specifica regione del grande continente della politica-struttura, inteso come “espressione concentrata dell’economia” (Lenin, 1921) e che comprende al suo interno anche tutte le interazioni tra le attività statali di intelligence e la praxis multiforme dei processi produttivi, specialmente di natura tecnologica.1
- Details
- Hits: 1970
Farsi commissariare dalla Troika. Il sogno dei banchieri italiani
di Ex OPG Napoli
 Sabato scorso Il Sole 24 Ore ha aperto con una lunga intervista a Carlo Messina, Ceo di Intesa Sanpaolo. Si tratta di ben due pagine in cui Messina esplicita tutto ciò che pensa rispetto alla crisi economica ed espone il suo piano in 5 punti per farvi fronte.
Sabato scorso Il Sole 24 Ore ha aperto con una lunga intervista a Carlo Messina, Ceo di Intesa Sanpaolo. Si tratta di ben due pagine in cui Messina esplicita tutto ciò che pensa rispetto alla crisi economica ed espone il suo piano in 5 punti per farvi fronte.
Si tratta probabilmente del contributo più interessante uscito in queste settimane dopo il lungo editoriale di Mario Draghi sul Financial Times del 25 marzo.
È interessante per due motivi: innanzitutto perchè pochi come Messina sono in grado di sapere effettivamente come stanno le cose e poi, in secondo luogo, perché a parlare è uno degli uomini più influenti d’Italia.
Proviamo a darne una lettura critica, tenendo ben presente che a parlare non è un commentatore disinteressato ma un manager che è pagato diversi milioni di euro all’anno per fare gli interessi non delle cittadine e dei cittadini ma degli azionisti della più grande banca italiana.
Il debito pubblico è una scelta obbligata?
Cominciamo riportando questo estratto:
“In particolare, aggiungerei interventi a fondo perduto. I finanziamenti possono andare bene per superare le difficoltà del momento ma poi sono debiti, sia pure garantiti dallo Stato, che vanno restituiti.”
Messina in buona sostanza è perfettamente in linea con Mario Draghi: il pubblico dovrà assorbire in parte o in tutto il debito del settore privato (secondo lui in forma indiretta per mezzo di sovvenzioni).
- Details
- Hits: 2906
Carl Schmitt e il realismo politico
di Carlo Galli
 1. Quale realismo?
1. Quale realismo?
Mi piace credere che il mio modo di pensare la politica possa essere definito (lo è stato) “realismo critico”. Ora esporrò i motivi per cui mi distanzio dal realismo che definirei “acritico”, e in definitiva “non realistico”.
Nato – insieme al suo opposto, l’ “idealismo” – all’interno della disciplina politologica “Relazioni internazionali”, il termine “realismo politico”1 condivide con la scienza politica alcune debolezze epistemologiche: la prima è che esista una realtà “là fuori”, che questa realtà sia instabile e conflittuale, e che il mondo intellettuale si divida fra chi l’accetta com’è e chi pensa che la si possa cambiare. In sostanza, un’opposizione fra essere e dover essere (posizioni pre-moderne, come il tomismo, sono realistiche nel senso che ipotizzano una realtà oggettiva intrinsecamente ordinata; e lì il “dover essere” significa conoscere e rispettare la struttura logica, etica, ontologica del reale).
La seconda debolezza epistemologica sta nell’ipotizzare una sintonia fra natura umana individuale (psicologia) e natura umana collettiva (lo Stato), una convergenza fra antropologia e politica. Sintonia e convergenza nel segno della instabilità, dell’aggressività, della pericolosità dei singoli e degli aggregati umani – tutte caratteristiche “naturali” e oggettive, la cui modificazione è impossibile, o indesiderabile, o inutile, o da ottenere attraverso l’esercizio di rigide discipline individuali e collettive –. Gli “uomini rei” di Machiavelli e la “vita corta misera brutale e breve” di Hobbes – insomma, l’antropologia negativa e pessimistica – a fondamento di forme politiche autoritarie. Naturalmente a questo riguardo gli “idealisti” che condividono con i realisti le debolezze di cui parliamo, sostengono al contrario antropologie in vario grado positive.
- Details
- Hits: 966
La forza dei fatti e la debolezza della volontà
di Michele Castaldo
 Dunque l’Italia si avvia in ordine sparso alla riapertura di quasi tutte le attività. Vale la pena ragionare con fredda lucidità su quanto finora accaduto che fa da sfondo a quanto potrà accadere nell’immediato e prossimo futuro. Insisto molto sulla fredda lucidità, perché c’è un eccessivo vociare un po’ da tutte le parti che non favorisce la comprensione dei problemi che sono seri e gravi.
Dunque l’Italia si avvia in ordine sparso alla riapertura di quasi tutte le attività. Vale la pena ragionare con fredda lucidità su quanto finora accaduto che fa da sfondo a quanto potrà accadere nell’immediato e prossimo futuro. Insisto molto sulla fredda lucidità, perché c’è un eccessivo vociare un po’ da tutte le parti che non favorisce la comprensione dei problemi che sono seri e gravi.
Come sempre cerchiamo di partire dai fatti e il relazionarsi ad essi da parte di personaggi che rappresentano in vario modo le differenti realtà della società, fra cui la Chiesa Cattolica che riveste tuttora – anche se sempre meno – un ruolo di primo piano nelle relazioni con il cosiddetto mondo civile, ovvero quello della produzione, dell’economia, della cultura e dello Stato. Un potere terreno, inutile ribadirlo, enorme, con centinaia di milioni di aderenti a vari livelli, un vero e proprio popolo mondiale del quale bisogna tenere conto. Un popolo che di fronte a quanto sta accadendo, a proposito del Covid-19, è certamente impaurito nella sua stragrande maggioranza, mentre nelle alte sfere del mondo ecclesiastico c’è seria preoccupazione almeno quanta quella di banchieri, capitani di industrie e quanti ad essi collegati.
Su La Stampa di Torino di giovedì 23 aprile c’è una interessante intervista al cardinale Angelo Scola sulla quale è necessario appuntare l’attenzione, perché la sinistra, educata alla scuola dei mangiapreti della rivoluzione francese, è incapace di leggere nei rappresentanti il portato sociale dei rappresentati. Triste dirlo ma questo è.
- Details
- Hits: 1272
Scienza, storia, società. Riflessioni su epistemologia e politica
di Giorgio Matteoli
Tanto nel senso comune quanto tra gli specialisti si tende a considerare la scienza e la politica come due sfere indipendenti dell’attività umana, e gli scienziati come sostanzialmente immuni da qualsivoglia ideologia. Negli ultimi anni tuttavia è sorta da più parti, all’interno dei science studies, l’esigenza di ripensare la relazione tra la concretezza storico-politica della scienza e le sue fondamementali pretese di universalità, all’interno di un discorso che fosse al contempo epistemologico e politico. Il libro di Pietro Daniel Omodeo, Political Epistemology. The Problem of Ideology in Science Studies, uscito per Springer nel 2019, fornisce un utile quadro di riferimento per orientarsi in questi dibattiti recenti, e più in generale per riflettere criticamente sulle ideologie scientifiche e sul ruolo che la scienza occupa, o potrebbe occupare, all’interno della società
 Sono stati molti i dibattiti che negli ultimi anni hanno riportato in primo piano la questione del rapporto tra scienza e politica: da quello sulla “post-truth” (parola dell’anno nel 2016 secondo gli Oxford Dictionaries) e la cosiddetta “post-truth politics”, al problema degli effetti di una diffusione più o meno controllata di “fake news” nella sfera dell’opinione pubblica; dalle discussioni intorno all’opportunità o alla presunta preferibilità di una democrazia diretta contro gli spettri tecnocratici della democrazia rappresentativa, fino al ruolo politico effettivamente assunto dagli scienziati, tanto nei mezzi di comunicazione di massa quanto all’interno dei comitati tecnico-scientifici, rispetto alla gestione della crisi sanitaria attuale.
Sono stati molti i dibattiti che negli ultimi anni hanno riportato in primo piano la questione del rapporto tra scienza e politica: da quello sulla “post-truth” (parola dell’anno nel 2016 secondo gli Oxford Dictionaries) e la cosiddetta “post-truth politics”, al problema degli effetti di una diffusione più o meno controllata di “fake news” nella sfera dell’opinione pubblica; dalle discussioni intorno all’opportunità o alla presunta preferibilità di una democrazia diretta contro gli spettri tecnocratici della democrazia rappresentativa, fino al ruolo politico effettivamente assunto dagli scienziati, tanto nei mezzi di comunicazione di massa quanto all’interno dei comitati tecnico-scientifici, rispetto alla gestione della crisi sanitaria attuale.
Il problema del legame tra la scienza (e più in generale, la conoscenza) e la politica è ovviamente molto più antico di questi dibattiti, e costituisce di fatto uno dei rompicapo più complessi e persistenti, soprattutto a partire dall’età moderna, nella storia della cultura occidentale.
- Details
- Hits: 1537
Nazionalizzazioni, golden power e aiuti di stato
La partecipazione dello stato alla competizione intercapitalistica
di Domenico Moro
 L’attuale fase storica del modo di produzione capitalistico è caratterizzata da un aumento della concorrenza tra frazioni nazionali di capitale che viene accentuata dalla crisi del Covid-19, che si presenta come la più grave dal ‘29. L’elemento che sembra caratterizzare maggiormente questa fase è un revival dell’intervento statale nell’economia non sono sul piano del sostegno economico alle imprese in difficoltà ma anche in difesa della nazionalità delle imprese stesse. Infatti, la crisi determina una condizione per la quale le imprese, sia quelle quotate sia quelle non quotate, possono essere più facilmente acquisite e interi settori manifatturieri e economici potrebbero così passare in mani estere. Data la specifica situazione di difficoltà dell’economia italiana si assiste a un attivismo particolarmente marcato dello Stato italiano a difesa del proprio capitale nazionale. Tuttavia la tendenza è comune anche al resto della Ue, in Spagna, Francia e Germania ad esempio, e interessa un po’ tutti i Paesi a capitalismo avanzato. Del resto, la crisi del Covid-19 accentua una tendenza protezionistica commerciale e di difesa proprietaria del capitale nazionale che si stava già diffondendo da qualche tempo, non solo negli Usa di Trump ma anche in Europa, andando in direzione opposta rispetto alle correnti liberalizzatrici che avevano caratterizzato la fase della globalizzazione.
L’attuale fase storica del modo di produzione capitalistico è caratterizzata da un aumento della concorrenza tra frazioni nazionali di capitale che viene accentuata dalla crisi del Covid-19, che si presenta come la più grave dal ‘29. L’elemento che sembra caratterizzare maggiormente questa fase è un revival dell’intervento statale nell’economia non sono sul piano del sostegno economico alle imprese in difficoltà ma anche in difesa della nazionalità delle imprese stesse. Infatti, la crisi determina una condizione per la quale le imprese, sia quelle quotate sia quelle non quotate, possono essere più facilmente acquisite e interi settori manifatturieri e economici potrebbero così passare in mani estere. Data la specifica situazione di difficoltà dell’economia italiana si assiste a un attivismo particolarmente marcato dello Stato italiano a difesa del proprio capitale nazionale. Tuttavia la tendenza è comune anche al resto della Ue, in Spagna, Francia e Germania ad esempio, e interessa un po’ tutti i Paesi a capitalismo avanzato. Del resto, la crisi del Covid-19 accentua una tendenza protezionistica commerciale e di difesa proprietaria del capitale nazionale che si stava già diffondendo da qualche tempo, non solo negli Usa di Trump ma anche in Europa, andando in direzione opposta rispetto alle correnti liberalizzatrici che avevano caratterizzato la fase della globalizzazione.
Via libera agli aiuti di stato e alle nazionalizzazioni
In primo luogo va rilevato che la Commissione europea nell’ultimo mese ha molto allentato le normative che tradizionalmente facevano dell’opposizione agli aiuti di stato uno dei suoi pilastri, grazie alla comunicazione del 13 marzo, in cui si dà l’assenso a misure supplementari atte a porre rimedio a situazioni di grave turbamento dell’economia e si predispone la velocizzazione delle decisioni della Commissione stessa rispetto alle notifiche dei singoli Stati sugli aiuti da prestare alle imprese.
- Details
- Hits: 1266
Crisi climatica e trasformazione sociale al tempo del coronavirus
di Norbert Trenkle
 Perché la produzione capitalistica di ricchezza deve essere superata
Perché la produzione capitalistica di ricchezza deve essere superata
Uno degli strani effetti collaterali della crisi sanitaria è il fatto che essa, nel giro di poche settimane, ha contribuito al miglioramento del clima globale più di quanto non siano riuscite a fare tutte le politiche sul clima degli ultimi anni. A cause del fatto che la circolazione automobilistica nelle principali città è diminuita fin dell’80% mentre il traffico aereo si è drasticamente ridotto e molti impianti di produzione hanno cessato l’attività, secondo una stima del Global Carbon Project, le emissioni di CO2 potrebbero diminuire di circa del 5% nel 2020. Parrebbe perfino che anche il governo tedesco, nonostante le sue ben poco incisive misure di politica climatica, possa centrare l’obiettivo di una riduzione del 40% dei gas serra rispetto al 1990 (Süddeutsche Zeitung 24/3/2020). In ogni caso sarebbe vano sperare che la crisi sanitaria conduca ad una stabile riduzione delle emissioni nocive per l’ambiente e alla limitazione del riscaldamento globale. Il fatto è che questo temporaneo arresto delle attività economiche in gran parte del mondo non ha mutato in nulla la logica fondamentale del modo di produzione capitalistico, che è diretta dall’aumento illimitato e fine a se stesso della ricchezza astratta, rappresentata nel denaro. La compulsione alla crescita, generata da questa finalità autoreferenziale, non sarà certo abolita dalle misure adottate per combattere la pandemia, ma solo rallentata per un breve periodo di tempo. Nel medesimo frangente i governi e le banche centrali stanno facendo tutto il possibile per mitigare questa frenata, allo scopo di mantenere in moto, magari in maniera precaria, la dinamica economica, così da rilanciarla il più celermente possibile una volta revocate le misure di contenimento.
- Details
- Hits: 1207
Crisi sociale e pandemia
Riflessioni sulla barbarie del capitale
di Anderson Deo
 «So che nulla sarà come questa
«So che nulla sarà come questa
mattina o dopodomani
resistendo nella bocca della notte un gusto di sole»
(Nulla sarà come prima/ Milton Nascimento e Beto Guedes)
Una frase è stata ripetuta esaustivamente dalle grandi corporazioni dei media su scala mondiale: Nulla sarà come prima! Come una specie di mantra, tale espressione indica che la pandemia del nuovo coronavirus produrrà cambiamenti significativi, anche profondi, in diversi livelli della vita e, pertanto, delle relazioni sociali in tutta l’umanità.
La prima questione che vorrei affrontare è che la storia ci insegna che nessuna formazione sociale, nessun modo di produzione è mai entrato in collasso senza che ci fossero forze sociali organizzate a spingere tali processi. Trattandosi del modo di produzione capitalistico, nel corso del XX secolo, di fronte ai vari momenti di manifestazione della sua crisi strutturale e sistemica, questa forma sociale si è ristrutturata su nuove basi e contraddizioni, per riprodurre gli elementi fondanti della sua socialità. Pertanto, per quanto ne capisca, la pandemia di per sé non dà origine a nessuna forma di rivoluzione che punti al superamento del capitalismo o a una possibile forma di transizione socialista. Al contrario, la COVID-19/SARS 2, sembra essere l’espressione radicalizzata della barbarie, alla quale è sottomessa l’umanità, e che si approfondisce, sempre più, di fronte all’autocrazia del capitale finanziario mondializzato sull’umanità.
- Details
- Hits: 2406

Default totale. Per un’uscita anticapitalistica dalla crisi
di Giulio Palermo*
 In questo articolo, propongo una riflessione ad ampio raggio sul ruolo che può avere il ripudio del debito pubblico in Europa in questa crisi economica e finanziaria. Ben inteso, la crisi è mondiale e l’Europa non ne è certo l’epicentro. Anzi, l’Unione europea sta mostrando la sua subalternità nei rapporti imperialistici mondiali e la sua impreparazione rispetto a questa accelerazione delle contraddizioni che già viveva prima del coronavirus.
In questo articolo, propongo una riflessione ad ampio raggio sul ruolo che può avere il ripudio del debito pubblico in Europa in questa crisi economica e finanziaria. Ben inteso, la crisi è mondiale e l’Europa non ne è certo l’epicentro. Anzi, l’Unione europea sta mostrando la sua subalternità nei rapporti imperialistici mondiali e la sua impreparazione rispetto a questa accelerazione delle contraddizioni che già viveva prima del coronavirus.
Dallo scoppio della crisi del debito pubblico europeo, nel 2009, la strategia del capitale finanziario è stata quella di isolare e colpire gli stati, uno a uno, per costringerli ad accentuare lo sfruttamento dei lavoratori. Ora questa strategia è saltata. Ora è l’intero capitale finanziario europeo ad essere in crisi e il suo salvataggio richiede un forte aumento del debito pubblico di tutti gli stati europei. Molti dei quali, subito dopo i salvataggi, in un contesto di blocco produttivo senza precedenti nella storia del capitalismo, si ritroveranno, tutti assieme, con livelli di debito tecnicamente inesigibili.
Questo riduce drasticamente i margini di attuazione del vecchio motto “divide et impera”. Il capitale finanziario dovrà colpire simultaneamente gli stati in crisi di solvibilità e questo è oggettivamente un punto di debolezza per il capitale. Ma la sua debolezza principale è che, in questa fase, la crisi colpisce innanzi tutto le banche e le imprese e non è affatto detto che gli stati dell’Unione possano o debbano salvarle.
In questo passaggio decisivo della crisi del capitale, è importante esplicitare gli interessi della classe lavoratrice che, come sempre, subisce le decisioni senza poter prendere parola. Anche se non è certo sul terreno della finanza pubblica che i lavoratori sono abituati a lottare, è proprio da qui che proviene l’attacco frontale che il capitale finanziario sta sferrando contro di loro.
- Details
- Hits: 2112
Costruire il proprio destino
Giulio Gisondi intervista Vladimiro Giacché
 Meno di un mese fa Giuseppe Conte affermava “faremo da soli”, qualora la scelta per l’Italia fosse stata quella di ricorrere al Meccanismo Europeo di Stabilità. La decisione del Consiglio europeo del 23 aprile è stata, invece, proprio quella di ricorrere al MES, alla BEI, al fondo per la disoccupazione SURE, con l’ipotesi, ancora poco chiara, d’istituire un Recovery Fund temporaneo, finanziato dai singoli Stati e che dia, non si sa bene se prestiti o trasferimenti ai paesi che ne necessitano. Ne abbiamo discusso con Vladimiro Giacchè, Presidente del Centro Europa Ricerche, dalla metà degli anni Novanta nel settore bancario e finanziario, nonché storico della filosofia e autore di saggi e monografie tra cui La fabbrica del falso. Strategie della menzogna nella politica contemporanea (2008), Anschluss. L’annessione: l’unificazione della Germania e il futuro dell’Europa (2013, nuova ed. 2019).
Meno di un mese fa Giuseppe Conte affermava “faremo da soli”, qualora la scelta per l’Italia fosse stata quella di ricorrere al Meccanismo Europeo di Stabilità. La decisione del Consiglio europeo del 23 aprile è stata, invece, proprio quella di ricorrere al MES, alla BEI, al fondo per la disoccupazione SURE, con l’ipotesi, ancora poco chiara, d’istituire un Recovery Fund temporaneo, finanziato dai singoli Stati e che dia, non si sa bene se prestiti o trasferimenti ai paesi che ne necessitano. Ne abbiamo discusso con Vladimiro Giacchè, Presidente del Centro Europa Ricerche, dalla metà degli anni Novanta nel settore bancario e finanziario, nonché storico della filosofia e autore di saggi e monografie tra cui La fabbrica del falso. Strategie della menzogna nella politica contemporanea (2008), Anschluss. L’annessione: l’unificazione della Germania e il futuro dell’Europa (2013, nuova ed. 2019).
* * * *
Dott. Giacchè, come valuta le misure adottate dall’ultimo Consiglio Europeo? Perché non liberare la BCE dal divieto di monetizzare gli Stati, come stanno facendo le maggiori banche centrali del mondo?
Si è passati dal proclamato rifiuto di utilizzare uno strumento come il MES che non ha senso in questo contesto, perché basato sul debito e perché a noi porterebbe molto poco denaro rispetto al fabbisogno che si è creato a seguito di quest’emergenza (stiamo parlando di qualcosa come 37 miliardi di euro al massimo), all’accettazione di un pacchetto di strumenti che include il MES e in cui l’aspetto comune è che tutti comportano un aumento del debito. Questo vale per il MES, per la BEI e anche per il fondo di assicurazione SURE, che è sostanzialmente diverso da quello che fu proposto dall’Italia qualche anno fa.
- Details
- Hits: 1527
Covid19 Lockdown
di Giovanna Cracco
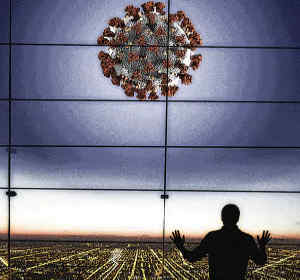 Un rapporto dei servizi segreti, indirizzato alla presidenza del Consiglio e ai ministri competenti, segnala la possibilità di problemi di ordine pubblico nel Sud Italia nel caso l’epidemia da coronavirus dovesse allargarsi anche a quella parte del Paese. È ciò che riporta Fabio Martini in un articolo pubblicato il 26 marzo su La Stampa (1). “Si tratta di un report top secret” scrive Martini, “ma da quel che trapela il pericolo segnalato è quello di un’escalation, che partendo dalla fragilità e dal possibile collasso delle strutture ospedaliere, possa portare inizialmente a ribellioni legate alla carenza di assistenza e aggravate davanti a casi di «raccomandazioni», che in alcune realtà hanno una loro consistenza. E l’ultimo anello di questa escalation nel Sud potrebbe determinarsi con interferenze sempre possibili da parte della criminalità organizzata”.
Un rapporto dei servizi segreti, indirizzato alla presidenza del Consiglio e ai ministri competenti, segnala la possibilità di problemi di ordine pubblico nel Sud Italia nel caso l’epidemia da coronavirus dovesse allargarsi anche a quella parte del Paese. È ciò che riporta Fabio Martini in un articolo pubblicato il 26 marzo su La Stampa (1). “Si tratta di un report top secret” scrive Martini, “ma da quel che trapela il pericolo segnalato è quello di un’escalation, che partendo dalla fragilità e dal possibile collasso delle strutture ospedaliere, possa portare inizialmente a ribellioni legate alla carenza di assistenza e aggravate davanti a casi di «raccomandazioni», che in alcune realtà hanno una loro consistenza. E l’ultimo anello di questa escalation nel Sud potrebbe determinarsi con interferenze sempre possibili da parte della criminalità organizzata”.
Lo stesso giorno su Repubblica, edizione Palermo, Claudia Brunetto e Francesco Patané segnalano un “pomeriggio di tensione all’interno del supermercato Lidl di viale Regione Siciliana per il tentativo di una quindicina di persone di scappare con i carrelli pieni senza pagare la spesa […] sul posto sia polizia che carabinieri hanno ricondotto alla ragione la quindicina di clienti […] Si tratta di famiglie palermitane provenienti dal Cep, dallo Zen e da Cruillas che dopo una lunga trattativa con le forze dell’ordine hanno ammesso di non avere più soldi per pagare la spesa perché rimaste senza possibilità di lavorare dopo l’inizio della quarantena. Carabinieri e polizia sono riusciti a convincere le famiglie in difficoltà a lasciare la merce nel supermercato. Nessuno è stato denunciato” (2).
Come si è potuti arrivare a questa situazione, per di più in un tempo decisamente breve (3), in una liberaldemocrazia a capitalismo avanzato del XXI secolo?
Legge, disciplina, sicurezza
L’epidemia da coronavirus ha prodotto, sui quotidiani e in rete, una serie di analisi e riflessioni che ne hanno seguito l’evoluzione, modificando anche nel tempo la chiave di lettura, com’è normale che sia quando si cerca di capire una situazione nuova e in divenire.
- Details
- Hits: 1289
Cercare ancora. Il capitalismo, la tecnica, l’ecologia e la sinistra scomparsa. L’attualità di Claudio Napoleoni
di Lelio Demichelis
 Da dove iniziare, volendo recuperare, soprattutto ora, il pensiero e l’opera – complessa, molteplice, culturalmente alta – di Claudio Napoleoni?
Da dove iniziare, volendo recuperare, soprattutto ora, il pensiero e l’opera – complessa, molteplice, culturalmente alta – di Claudio Napoleoni?
Lo faremo concentrandoci su due suoi temi forti – trascurandone per necessità molti altri, come la questione della pace e della guerra, di Dio e della laicità (e il suo voler ripensare il rapporto tra politica religione) o le divergenze con Rodano e le critiche a Sraffa. Due temi che ci coinvolgono direttamente avendo dedicato ad essi, in questi anni, le nostre attività di analisi e di ricerca: il tema della tecnica, intesa come sistema/meccanismo integrato e integrante di uomini e macchine[i]; e quello, strettamente connesso/dipendente dell’alienazione[ii].
Partiamo dall’alienazione. Napoleoni scriveva così, nel 1988 – pur non accettando pienamente (e neppure noi, oggi), la definizione ingraiana di allora delle nuove alienazioni (“perché credo che non ci sia niente di nuovo a questo riguardo… è sempre la stessa, vecchia cosa che il marxismo ha già analizzato…”[iii]): l’alienazione è cioè “il piano in cui si riprende la tematica dell’inclusione dell’uomo moderno dentro meccanismi, non importa se pubblici o privati, che lo dominano, ne espropriano l’autonomia, ne fanno l’elemento di una macchina; [ma] è anche il piano in cui si parla di distruzione della natura e di questione femminile”.
Uscire da questa alienazione doveva allora diventare il compito principale della politica in senso lato e dalla sinistra in senso specifico. Compito che “non è tanto la lotta alla concentrazione del potere economico, quanto l’assumere il problema dell’unificazione nell’alienazione di quella che appare in maniera immediata e sociologica, come la frantumazione sociale”[iv].
- Details
- Hits: 1188
La Covid19 Economics e il trionfo europeo dei Chicago Boys
di Sargent Pepper
Effimera è venuta in possesso di alcune lettere scritte da un conservatore americano lobbista a Bruxelles e amante dei Beatles – che, per rispetto della privacy, abbiamo ribattezzato con uno pseudonimo: Sargent Pepper. Sono lettere indirizzate a un suo anziano collega ricoverato in una casa di riposo … In tempi di corona virus i postini a volte si disfano della corrispondenza per evitare luoghi pericolosi come le case di cura lombarde, ove è facile rimanere contagiati. Hans Iacob Stoer l’ha trovata e ora Effimera pubblica la traduzione del testo apparso a Gottingen in lingua inglese, traduzione del prof. Ferrante Pallavicino
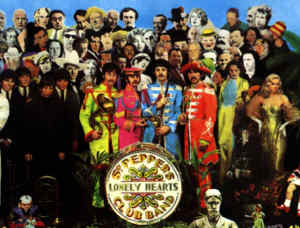 “See the worst thing about doing this
“See the worst thing about doing this
Doing something like this
Is I think that at first people sort of are a bit suspicious
‘You know, come on, what are you up to?’
The Beatles, A day in the life, 1967
1. Caro XXXXX è difficile immaginare il futuro quando si resta a casa a guardare dalle finestre.
È ancora più difficile quando si è in preda ad un bombardamento mediatico che ripete incalzante ritornelli insopportabili.
Fra questi ce ne sono alcuni che abbiamo costruito con dovizia proprio noi: i Chicago Boys.
Ed io sono uno di loro che, come tanti, ha trovato lavoro in Europa. Faccio parte di quel mondo di confine fra i funzionari di Bruxelles e le Università in cui si insegnano soprattutto le nostre teorie economiche. Teorie economiche che dominano la vostra visione politica. È ciò di cui mi hai chiesto di parlare durante la nostra ultima telefonata, e allora, sperando che possa mantenere vivo il tuo antico senso critico, parliamone, ricorrendo alle nostra amatissima carta da lettere.
2. Siamo in deflazione da molto tempo, soprattutto in Europa: siamo cioè in una situazione di diminuzione generale del livello dei prezzi. La deflazione deriva dalla debolezza della domanda di beni e servizi, cioè deriva da un freno nella spesa di consumatori e imprese.
Qualche dato: l’inflazione della zona euro a marzo è calata di mezzo punto percentuale rispetto al mese precedente, scendendo dall’1,2% allo 0,7%: cibo, alcol e tabacco hanno il tasso annuale più alto (2,4% rispetto al 2,1% di febbraio), seguono i servizi (1,3% dall’1,6% del mese precedente), i beni industriali non energetici (stabili allo 0,5%) e l’energia (-4,3% dal -0,3% di febbraio).
- Details
- Hits: 1703
Paura, governo, sovranità e coronavirus
di Alessandro Visalli
 Quello che segue è un intervento pubblicato sul sito di Nuova Direzione sulla crisi da coronavirus e la dinamica conseguente.
Quello che segue è un intervento pubblicato sul sito di Nuova Direzione sulla crisi da coronavirus e la dinamica conseguente.
In sintesi:
La crisi in corso comporta l'effettivo rischio che, se non è controllata e ridotta, produca un cambio nella forma politica, da quella che chiamo "sovranità neoliberale", e post-democratica, nella quale viviamo, ad una "sovranità iperliberista", direttamente anti-democratica.
Questa paura diffusa, però se mal indirizzata rischia di usare inconsapevolmente strutture neoliberali per inibire l'autodifesa sociale e farci cadere in uno 'stato di eccezione' reale, per disperazione e stanchezza. Se tra le tecniche dello "stop and go", del "massive boming" di tamponi, e del "rintraccia ed isola" tradizionale, scegliamo di fatto il primo per paura del "rintraccia" del terzo, nella pratica impossibilità di dare adeguata massa al secondo (che comporterebbe una militarizzazione della vita), allora avremo continui "Stop", sempre più duri, e finiremo per disgregare società ed economia. Alla fine il modello "Elysium" al quale tendiamo si compirà completamente.
Ma il "go", allora va calibrato con saggezza, e combinato con il "rintraccia ed isola" al giusto livello di ampiezza e solidità tecnica (che non è solo tecnologica, ma soprattutto organizzativa ed umana), perché sia sostenibile nel medio e lungo periodo senza ricadere. Questa è la posta dalla quale dipende anche l'arresto delle conseguenze anti-democratiche della paura.
La paura non si combatte facendo "lo struzzo", ma ponendo in essere quelle difese efficaci, sapendone sopportare il prezzo, al fine di non dover pagare quello maggiore.
- Details
- Hits: 925
L’ossimoro che sfugge al governo italiano: la forza della sua debolezza
di Alberto Bradanini
 Rahm Emanuel, capo dello staff di Barak Obama, affermava nel 2008 che “occorre evitare che una grave crisi vada sprecata. Essa offre l’opportunità per fare cose che prima non si potevano fare”. Non è un’immagine originale, va detto. Alcuni anni prima l’illustre monetarista della scuola di Chicago, Milton Friedman, aveva rilevato che “le alternative alle politiche esistenti vanno conservate, perché a un certo punto il politicamente impossibile diventa politicamente inevitabile”.
Rahm Emanuel, capo dello staff di Barak Obama, affermava nel 2008 che “occorre evitare che una grave crisi vada sprecata. Essa offre l’opportunità per fare cose che prima non si potevano fare”. Non è un’immagine originale, va detto. Alcuni anni prima l’illustre monetarista della scuola di Chicago, Milton Friedman, aveva rilevato che “le alternative alle politiche esistenti vanno conservate, perché a un certo punto il politicamente impossibile diventa politicamente inevitabile”.
Davanti a una scena nebulosa, sia per la futura convivenza con il virus sia per il destino della nostra economia, ecco prendere corpo un catalogo di scelte fino a ieri politicamente o tecnicamente impraticabili e affrontare i guai dell’economia e della politica.
Il luogo dove il Paese reputa di trovare un’illusoria soluzione alle sue pene non è situato sul nostro territorio tuttavia, ma nella cosiddetta Unione Europea (il termine Unione merita la sottolineatura), poiché a tale tecnostruttura il ceto politico-finanziario italiano ha incautamente consegnato nei decenni scorsi una preziosa quantità di democrazia istituzionale e di autonomia monetaria. Non solo, poiché sin dagli anni ’50 del secolo scorso, sedotta dalla fiaba infantile degli Stati Uniti d’Europa, un’Italia dimessa ha devoluto l’iniziativa politica ai paesi europei dominanti, Germania e Francia, nella rinuncia a disegnare una progettualità centrata su legittimi interessi nazionali.
Il primo gigantesco deficit che investe la cosiddetta Unione Europea (Ue) è il deficit di democrazia. Gli organismi europei che anche oggi decidono del nostro futuro non rispondono a sufficienza al principio democratico.
- Details
- Hits: 4082
Hegel e Marx: dall'idealismo al materialismo storico. Una risposta a Fusaro e Gentile
di Concetto Solano
 Mandare in soffitta Marx è un’ambizione che ha accomunato, nel tempo, reazionari e progressisti, revisionisti e sedicenti “marxisti”. In anni recenti si è andato rafforzando il velenoso tentativo di liquidare Marx adagiandolo sul letto di Procuste di Hegel, con il duplice scopo di dimostrare che Marx è inferiore al maestro e il Marx che si professa non hegeliano è, invece, un metafisico che, applicando la dialettica hegeliana alla materia della vita, approda a tutta una serie di contraddizioni inestricabili. In conclusione, Marx sarebbe un filosofo da strapazzo che oscillerebbe tra “autofraintendimenti ed equivoci di varia natura”[1] frutto di “un’ambiguità che perseguiterà Marx”[2] nel corso della sua vita intellettuale.
Mandare in soffitta Marx è un’ambizione che ha accomunato, nel tempo, reazionari e progressisti, revisionisti e sedicenti “marxisti”. In anni recenti si è andato rafforzando il velenoso tentativo di liquidare Marx adagiandolo sul letto di Procuste di Hegel, con il duplice scopo di dimostrare che Marx è inferiore al maestro e il Marx che si professa non hegeliano è, invece, un metafisico che, applicando la dialettica hegeliana alla materia della vita, approda a tutta una serie di contraddizioni inestricabili. In conclusione, Marx sarebbe un filosofo da strapazzo che oscillerebbe tra “autofraintendimenti ed equivoci di varia natura”[1] frutto di “un’ambiguità che perseguiterà Marx”[2] nel corso della sua vita intellettuale.
Nel fiorente campo del revisionismo filosofico antimarxista spicca Fusaro, autore di Marx idealista. La chiave di lettura di Fusaro è, per sua stessa ammissione, la medesima che adottò Giovanni Gentile a fine Ottocento, per il quale Marx era un hegeliano comunista e la critica ad Hegel era una critica aporetica.[3]
Ci occuperemo, quindi, di Fusaro, esaminando, oltre che la copia sbiadita, anche l’originale, prodotto da Gentile con la sua Filosofia di Marx. L’intento, apertamente dichiarato da Gentile, è quello di colpire Marx, la teoria del materialismo storico, “da lui messa a leva d’una gravissima dottrina sociale”,[4] e “tutto lo scheletro insomma di quella filosofia, che si vuole insita nella concezione materialistica della storia, posta a fondamento della dottrina comunista”.[5]
- Details
- Hits: 1448
Editoriale n. 1 di Officina Primo Maggio
di Redazione
Qui il manifesto della nuova rivista e qui l'indice del primo numero
 Scrive Sarah Lazare nel numero di In These Times del 12 marzo: «Pensavamo che il nostro sistema fosse caratterizzato da precarietà e senso di paura dei lavoratori, il Coronavirus ci ha fatto capire che è stato costruito così deliberatamente».
Scrive Sarah Lazare nel numero di In These Times del 12 marzo: «Pensavamo che il nostro sistema fosse caratterizzato da precarietà e senso di paura dei lavoratori, il Coronavirus ci ha fatto capire che è stato costruito così deliberatamente».
È vero. Tutte le caratteristiche negative del nostro tempo, in termini di sistema capitalistico in generale e in termini di sistema-Italia, stanno venendo a galla in maniera più chiara e più comprensibile di quanto abbiano potuto fare le migliaia di analisi e di denunce degli ultimi vent’anni.
Noi cominciamo qui la nostra avventura di Officina Primo Maggio. Eravamo pronti a uscire quando è partita l’emergenza. Far finta di nulla era ridicolo, mettersi a fare grandi analisi, tanti lo facevano, meglio di quanto avremmo potuto fare noi. Vorremmo provare allora a cambiare gioco e a pensare che cosa di positivo potrebbe nascere nella testa della gente, perché se c’è un dato certo è che il “pensiero unico” con il Coronavirus è andato in frantumi, e almeno su un paio di cose dovrebbe avere qualche difficoltà a ricostruire la sua compattezza di prima.
Primo, il ruolo dello stato e del servizio pubblico in generale.
Il problema però non dobbiamo guardarlo solo con l’ottica dell’emergenza: anche il più accanito neoliberale oggi è disposto a invocare uno stato autorevole, un comando centralizzato, una sanità pubblica efficace per combattere un virus. No, dobbiamo ripensare il ruolo dello stato da dove lo avevamo lasciato con Primo Maggio, e precisamente da quando ci siamo posti il problema dello smantellamento del welfare state. Quello che stava accadendo ce lo avevano spiegato Fox Piven e Cloward: non era tanto la demolizione del welfare quanto la sua trasformazione in sistema di regolazione e controllo.
- Details
- Hits: 2165
La ricostruzione di una ipotesi comunista per la società del XXI secolo
di Laboratorio 21
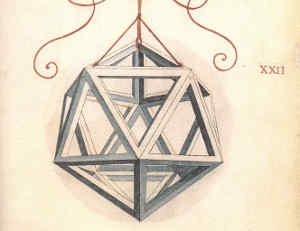 1. La sinistra radicale e i comunisti stanno vivendo quello che, in Europa e soprattutto in Italia, è il periodo peggiore della loro storia. Ciò appare paradossale se pensiamo alla profonda crisi strutturale del modo di produzione capitalistico in atto, che dovrebbe fornire argomenti alla sua critica. La verità è che la stessa identità comunista ha necessità di essere ridefinita: cosa vuol dire essere comunisti oggi e soprattutto cosa è il comunismo? La risposta a queste domande e la ripresa del movimento comunista richiedono tempo e soprattutto non possono avvenire mediante scorciatoie politicistiche o ideologico-dogmatiche. Si può risalire la china solo con un lungo e radicale lavoro di rielaborazione della storia del comunismo novecentesco e di comprensione del modo di produzione capitalistico e della società che vi sorge sopra.
1. La sinistra radicale e i comunisti stanno vivendo quello che, in Europa e soprattutto in Italia, è il periodo peggiore della loro storia. Ciò appare paradossale se pensiamo alla profonda crisi strutturale del modo di produzione capitalistico in atto, che dovrebbe fornire argomenti alla sua critica. La verità è che la stessa identità comunista ha necessità di essere ridefinita: cosa vuol dire essere comunisti oggi e soprattutto cosa è il comunismo? La risposta a queste domande e la ripresa del movimento comunista richiedono tempo e soprattutto non possono avvenire mediante scorciatoie politicistiche o ideologico-dogmatiche. Si può risalire la china solo con un lungo e radicale lavoro di rielaborazione della storia del comunismo novecentesco e di comprensione del modo di produzione capitalistico e della società che vi sorge sopra.
2. Quella della sinistra radicale e dei comunisti è una profonda crisi, inserita all’interno di una fase di grande trasformazione dell’economia e della società dell’Italia e dell’Europa a sua volta inserita in una grande trasformazione del capitalismo a livello globale. I cambiamenti in atto nella struttura socio-economica hanno avuto conseguenze sulla sovrastruttura politica, determinando la crisi del bipolarismo tra centro-destra e centro sinistra – che in Italia si basava su coalizioni ruotanti attorno a Forza Italia-Partito delle libertà e al Pds-Ds-Pd. Nello stesso tempo lo spazio un tempo occupato dai partiti “centrali” è stato occupato, da una parte, da forze cosiddette populiste come il M5s e la Lega, che hanno drenato gran parte del voto della sinistra radicale e comunista e soprattutto di ampi settori di classe lavoratrice, e, dall’altra parte, dall’astensionismo di massa.
- Details
- Hits: 1547
Dal coronavirus al debito
di Alessandro Somma
Come l’emergenza sanitaria consolida le relazioni di potere tra Paesi europei
 Rapporto di debito e governance europea
Rapporto di debito e governance europea
Se dal punto di vista formale il rapporto di scambio è una relazione tra pari, lo stesso non può dirsi per il rapporto di debito. Esso è sempre una relazione tra diseguali: tra un creditore egemone e un debitore subalterno, il primo interessato a protrarre nel tempo lo stato di soggezione per assicurarsi un regolare flusso di denaro, ma anche e soprattutto per mantenere a lungo il controllo sul secondo. Questo vale per le persone, ma non solo per esse: pure le comunità politiche, inclusi evidentemente gli Stati, utilizzano il debito per esercitare potere. E anche in questo caso il rapporto debitorio costituisce un dispositivo di governo della produzione e riproduzione di soggettività[1], quelle individuali esattamente come quelle collettive.
L’Unione europea ha elevato il rapporto di debito a paradigma delle relazioni tra gli Stati membri. Lo ha fatto alimentando politiche monetarie e di bilancio concepite ad arte per riservare ad alcuni Paesi lo status di creditori e imprigionare altri nel ruolo di debitori. Certo, tutti gli Stati sono debitori, se non altro perché l’indebitamento sovrano si è imposto come espediente attraverso cui il capitalismo ha guadagnato tempo: ha consentito di finanziare il welfare e di rimandare così la sua crisi in quanto ordine in costante frizione con la democrazia[2]. Non tutti sono però debitori allo stesso modo: alcuni Paesi sono capaci di controllare la produzione della disciplina monetaria e di bilancio e di utilizzarla per rendere cronica e irreversibile la condizione di inferiorità degli altri Paesi[3].
- Details
- Hits: 1989
Lenin e il movimento operaio italiano
Analisi storica e prospettive attuali
di Alessandro Mustillo
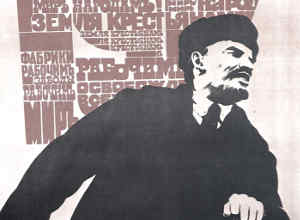 Prima di addentrarci nell’analisi del rapporto tra Lenin e il movimento operaio italiano c’è da chiedersi se oltre alla valenza storiografica di queste vicende, l’argomento sia utile a fornire ancora oggi insegnamenti validi per chi è impegnato nella ricostruzione del movimento comunista in Italia, in linea con l’obiettivo che l’Ordine Nuovo si è dato per questo speciale. Certo in un articolo di taglio storico il compito di attualizzare è quello più difficile e complesso, e per questa ragione alcuni aspetti propriamente cronologici saranno sacrificati a una lettura più argomentativa.
Prima di addentrarci nell’analisi del rapporto tra Lenin e il movimento operaio italiano c’è da chiedersi se oltre alla valenza storiografica di queste vicende, l’argomento sia utile a fornire ancora oggi insegnamenti validi per chi è impegnato nella ricostruzione del movimento comunista in Italia, in linea con l’obiettivo che l’Ordine Nuovo si è dato per questo speciale. Certo in un articolo di taglio storico il compito di attualizzare è quello più difficile e complesso, e per questa ragione alcuni aspetti propriamente cronologici saranno sacrificati a una lettura più argomentativa.
Oltre la retorica, e il rifugio nella comodità della tradizione, la risposta alla domanda iniziale, va ricercata immergendosi in un’analisi parallela delle posizioni di allora e del mutamento del contesto in termini economici, storici, politici tra la società di inizio ‘900 e quella del secondo decennio del XXI secolo.
Analizzare il rapporto tra Lenin e il movimento operaio italiano significa lambire la questione centrale e tutt’ora aperta, del fallimento della Rivoluzione in Occidente – ossia nei Paesi a capitalismo avanzato, al vertice della catena imperialista internazionale – in uno dei suoi potenziali avamposti. Lambire e non centrare, perché analizzare la questione da questo lato prospettico impone di concentrarsi sull’aspetto soggettivo e organizzativo e trascurare l’aspetto oggettivo degli elementi attraverso i quali le classi dominanti all’interno dei paesi imperialistici riescono a rendere le classi subalterne compartecipi agli interessi di esse.
L’attualità delle vicende in oggetto risiede – nel giudizio di chi scrive – negli aspetti di forte similitudine tra il contesto dell’inizio del ‘900 e la società di oggi.
- Details
- Hits: 4466
Classe, nazione e crisi
di Giovanni Iozzoli
Mimmo Porcaro, I senza patria, Meltemi, Milano, 2020, p. 217, € 18,00
 Le parole “sovranità/sovranismo”, sono tra le più utilizzate nel dibattito politico contemporaneo. Pur godendo di solidi agganci dentro l’impianto costituzionale del 1948, questi termini sono diventate bandiere – peraltro fasulle – nelle mani delle ignobili destre italiane. Sul terreno delle parole, delle categorie, del linguaggio, si combattono da sempre battaglie cruciali per l’egemonia o la vittoria ideologica. Fino ad arrivare a perversi rovesciamenti di senso – basti pensare al termine “riformismo”, diventato negli anni ’90 bandiera neo-liberista, e definitivamente acquisito a quel campo.
Le parole “sovranità/sovranismo”, sono tra le più utilizzate nel dibattito politico contemporaneo. Pur godendo di solidi agganci dentro l’impianto costituzionale del 1948, questi termini sono diventate bandiere – peraltro fasulle – nelle mani delle ignobili destre italiane. Sul terreno delle parole, delle categorie, del linguaggio, si combattono da sempre battaglie cruciali per l’egemonia o la vittoria ideologica. Fino ad arrivare a perversi rovesciamenti di senso – basti pensare al termine “riformismo”, diventato negli anni ’90 bandiera neo-liberista, e definitivamente acquisito a quel campo.
Esiste in Italia una rete di soggettività ascrivibili al cosidetto “sovranismo costituzionale”: un’area composita che sostiene la tesi secondo cui la crisi sistemica della globalizzazione e degli assetti post-’89, apre larghi spazi ad un recupero delle categorie di Nazione e Sovranità, nella prospettiva di un’inveramento radicale della Costituzione o addirittura di una ripresa della lotta anticapitalistica. Senza entrare nel labirintico dibattito sulla “questione nazionale” dentro la moderna storia d’Italia – che ci condurrebbe in una giungla storiografica e filosofica che da Machiavelli porta a Mazzini, Gramsci, Togliatti, Bobbio, passando per gli snodi cruciali dell’Unità d’Italia, del fascismo, dell’8 settembre, della Resistenza -, queste tesi vanno comunque vagliate con attenzione, specie in uno scenario mondiale fortemente destabilizzato. A cominciare dalla crisi di egemonia degli USA e dalla caduta di legittimità degli organismi globali e delle nuove statualità sovranazionali, Unione Europea in testa. Persino la pandemia in atto acuisce le criticità del globalismo e rimette in discussione tutte le tessere del complicato mosaico internazionale. Mimmo Porcaro, nel suo libro, affronta senza timidezze questi aggrovigliati nodi, provando a definire l’agenda e le ragioni di un discorso sovranista e costituzionale.
- Details
- Hits: 1717
"Una spesa pubblica timida oggi significa recessione devastante e un debito pubblico più alto dopo"
L'Antidiplomatico intervista Antonella Stirati
Intervista alla Professoressa di Economia Politica di Roma Tre: "Ci sono grossi problemi all’interno dell’eurozona, non ha portato a più coesione, al contrario aumentato diseguaglianze territoriali e sociali. Se questo processo continua a generare così tanta diseguaglianza, e problemi nella gestione di crisi ricorrenti, difficilmente può essere sostenibile."
 Mes, Bei, Sure e una promessa di un Fondo - il cosiddetto Recovery Fund - da legare al bilancio europeo con prospettive al momento di difficile previsione vista la nota astiosità dei paesi membri che lo dovrebbero lanciare. Mentre Olanda e Austria parlano di “prestiti”, la Germania "non c'è accordo su come finanziare il fondo", la Francia tace e l’Italia esulta. Questo, in estrema sintesi, il Consiglio europeo di ieri che doveva dare “risposte storiche” ed è stato invece l’ennesimo temporeggiamento dinanzi una crisi economica che si prospetta devastante.
Mes, Bei, Sure e una promessa di un Fondo - il cosiddetto Recovery Fund - da legare al bilancio europeo con prospettive al momento di difficile previsione vista la nota astiosità dei paesi membri che lo dovrebbero lanciare. Mentre Olanda e Austria parlano di “prestiti”, la Germania "non c'è accordo su come finanziare il fondo", la Francia tace e l’Italia esulta. Questo, in estrema sintesi, il Consiglio europeo di ieri che doveva dare “risposte storiche” ed è stato invece l’ennesimo temporeggiamento dinanzi una crisi economica che si prospetta devastante.
Come AntiDiplomatico abbiamo chiesto un commento alla Professoressa Antonella Stirati, ordinaria di Economia Politica all’Università Roma Tre, nonché firmataria insieme ad altri 100 accademici su Micromega di una lettera appello rivolta al governo italiano per non ratificare quanto pattuito il 9 aprile all’Eurogruppo.
* * * *
Professoressa Stirati, in una lettera pubblicata da MicroMega insieme a 100 colleghi avevate chiesto al governo italiano di non firmare l'accordo uscito dall'Eurogruppo. Ieri il Consiglio europeo ha invece ratificato di fatto quanto pattuito il 9 aprile. Perché è così negativo per il futuro dell'Italia?
A.S.: In quella lettera appello giudicavamo il documento uscito nello scorso incontro europeo in modo negativo sia per rilevarne l’insufficienza delle dimensioni quantitative dell’accordo raggiunto – i soldi banalmente messi a disposizione per l’intervento – sia per sottolineare l’inadeguatezza della natura stessa delle misure, perché si tratta comunque sempre di prestiti che graveranno sui bilanci pubblici nazionali e quindi sono un problema per l’Italia e tanti altri paesi europei.
Page 240 of 616