"La passione della ragione"
recensione di Claudia Rotondi*
Bellofiore R. (2024), La passione della ragione. Scienza economica e teoria critica in Claudio Napoleoni, Milano: Mimesis, pp. 586, ISBN: 9791222313948
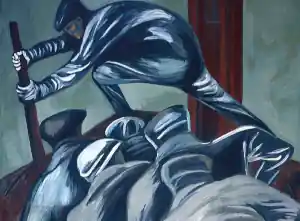 Una premessa. Per leggere questo volume occorre avere passione per la ragione, passione per il ragionare. Con questo viatico vi si può accostare anche chi non è esperto di Claudio Napoleoni o dei lavori di Riccardo Bellofiore su Napoleoni ma ha “passione” per il metodo nello studio dell’economia, per l’economia intesa come scienza sociale, per la ricerca di senso nell’esercizio della propria professione.
Una premessa. Per leggere questo volume occorre avere passione per la ragione, passione per il ragionare. Con questo viatico vi si può accostare anche chi non è esperto di Claudio Napoleoni o dei lavori di Riccardo Bellofiore su Napoleoni ma ha “passione” per il metodo nello studio dell’economia, per l’economia intesa come scienza sociale, per la ricerca di senso nell’esercizio della propria professione.
Il volume scritto da Riccardo Bellofiore è diviso in due parti. La prima parte è la riedizione – con modifiche e integrazioni – del testo dallo stesso titolo pubblicato nel 1991 per Unicopli e comprende cinque saggi redatti tra il dicembre 1985 e il febbraio 1991. La seconda parte riprende, anche in questo caso integrandoli, sette saggi scritti tra il 1992 e il 2024. Un testo impegnativo, frutto di oltre quarant’anni di studi attorno al complesso rapporto di Claudio Napoleoni con l’economia intesa come scienza sociale e dunque con tutto ciò che ruota attorno a questa concezione: con la teoria economica, con la storia dell’analisi e del pensiero economico, con la politica economia, con la metodologia della ricerca, con la filosofia. Il tanto tempo dedicato al pensiero di questo autore ha dato i suoi visibili frutti e i saggi compongono un insieme articolato che riflette anche i diversi accenti che Bellofiore ha voluto e saputo dare alle sue analisi.
Ripercorrere sia pure sinteticamente i tanti capitoli del volume aiuta a cogliere l’unità sottostante alla apparente frammentarietà.
Il primo capitolo della prima parte ci parla di Napoleoni “economista critico”, autore di un pensiero volutamente “radicale” perché, come ricorda Bellofiore, teso ad andare alla radice delle questioni. Qui possiamo ricostruire il suo percorso scientifico così come scandito da fasi individuate e denominate da Bellofiore: “Dalla guerra alla ricostruzione”; “Gli anni Cinquanta e il Dizionario di Economia Politica”; “Il periodo della Rivista Trimestrale”; “Il ritorno a Marx e il dibattito sulle riforme”; “La critica della teoria del valore”; “Oltre la centralità dell’economico”; “Scienza e critica”.
Ne emerge l’immagine di uno studioso che ha intensamente abitato la dimensione politica di tutto il periodo storico in cui ha vissuto sempre legando discussioni teoriche e impegno civile anche grazie alla sua ammirevole “capacità di sfuggire alla seduzione dello specialismo” (Bellofiore, 2024, p. 61).
Il secondo capitolo riprende i ragionamenti di Napoleoni sulla teoria dello sviluppo capitalistico. Si collocano qui le sue discussioni con Franco Rodano a partire dalle tesi sostenute da Piero Sraffa in Produzione di merci a mezzo di merci, il cui manoscritto viene dato a Napoleoni da Raffaele Mattioli. Il testo di Sraffa fornisce lo spunto per interessanti confronti su una supposta crisi generale della teoria economica sia di impostazione neoclassica che classico-marxiana: si tratta di una riflessione che lo impegna in particolare tra il 1960 e il 1974.
Il capitolo su “Marx dopo Marx” considera il possibile spartiacque dei primi anni Settanta in cui Napoleoni approda a una diversa valutazione della teoria del valore di Marx, con una svolta sia teorica che politica che prende le mosse da una autocritica o, forse meglio, da una ulteriore problematizzazione della teoria marxiana. Il valore resta il punto di riferimento imprescindibile per la comprensione e per l’analisi scientifica del capitalismo ma la sua definizione va riletta alla luce dei mutati caratteri del capitalismo. L’analisi di Bellofiore aiuta a ricostruire questo percorso con riferimenti puntuali agli incontri personali, agli autori e agli scritti più significativi che segnano l’approdo di Napoleoni alla delineazione di un nuovo programma di ricerca, e al suo successivo abbandono.
Nel capitolo dedicato a “Le avventure dell’alienazione” Bellofiore si sofferma sul noto Discorso sull’economia politica, un testo che fin dalla sua pubblicazione nel 1985 e per anni ha suscitato molte discussioni, un testo in cui economia, filosofia, politica sono strettamente correlate. Bellofiore muove qui la sua critica al testo di Napoleoni e al suo riesame delle teorie marxiane proprio dal triplice punto di vista: economico, filosofico, politico. È un tema che viene ripreso anche nel sesto capitolo della seconda parte dal titolo “Quale economia politica dopo Sraffa”.
Il quinto e ultimo capitolo di questa prima parte guarda alla “modernità in questione” dando un posto ai saggi di Napoleoni sulla laicità della politica e ad altri suoi ultimi scritti da cui si può inferire una interessante riflessione sulla modernità che, sottolinea Bellofiore, è costellata da dubbi e interrogativi proprio perché è rimasta aperta, interrotta dalla morte del suo autore.
La seconda parte del volume si apre con un saggio intitolato “Quale Napoleoni?” in cui Bellofiore ragiona sui tanti livelli presenti nelle riflessioni di Napoleoni: quello della rigorosa analisi scientifica; quello relativo alla immanenza di una domanda politica; quello della ricerca di un fondamento filosofico che supporti le categorie analitiche. È il Napoleoni economista politico e, in quanto tale, scienziato sociale che sa e che vuole cambiare la propria domanda di ricerca in relazione ai problemi che sente di dovere indagare. Si ritrova qui una divisione in fasi del pensiero di Napoleoni diversa da quella presentata nella prima parte ma non incompatibile con la stessa. Bellofiore individua una fase smithiana, una ricardiana, una schumpeteriana, un intermezzo marcusiano e infine una fase heideggeriana: si tratta di fasi di ricerca e di risposta che aiutano a comprendere, appunto, di fronte a “quale Napoleoni” ci si ritrovi, a quali problemi aperti, a quali possibili sviluppi del pensiero.
Il secondo capitolo dal bel titolo “Piedi a terra, testa ben alta. Dalla Ricostruzione alla Svimez e alla Sispe” è scritto da Bellofiore con Giancarlo Beltrame. Qui viene tracciata la fase della presenza di Napoleoni alla Svimez e l’esperienza della prima e della seconda SISPE, la Scuola italiana di Scienze politiche ed economiche ridenominata poi Scuola Italiana di Storia del Pensiero Economico. In queste pagine la sua riflessione sul metodo e sulla didattica dell’economia si collega ad una più ampia sullo stato della scienza economica e consente di cogliere l’importanza che Napoleoni attribuisce alla storia nella formazione di chi si occupa di economia anche al di fuori dello stretto ambito universitario.
Il terzo capitolo si sofferma sul tema del “pensare il proprio tempo” e, come definito nel sottotitolo, si incentra sull’ateismo positivo e l’uscita dal capitalismo in Claudio Napoleoni e Franco Rodano, guardando al periodo che va dalla fondazione della Rivista Trimestrale agli ultimi scritti. Bellofiore, consapevole della delicatezza dell’argomento che ha dato luogo a letture differenti, si ripromette di ricostruire il più fedelmente possibile le tappe di questa vicenda proponendo anche “alcune considerazioni critiche sui nodi della controversia, tanto in merito alla questione del giudizio sul pensiero di Marx nel suo intreccio di dimensioni (economica, filosofica, politica), quanto in merito al ‘dilemma della laicità’ dell’azione politica” (p. 380).
Nel capitolo sul “valore del valore” Bellofiore riprende, a partire dagli scritti di Claudio Napoleoni, la discussione che si svolge sul pensiero di Marx in Italia tra anni Sessanta e anni Settanta del Novecento e la considera anche alla luce della sua rilettura monetaria della teoria del valore di Marx.
Il saggio sulla teoria del valore come teoria della crisi ripropone il dialogo a distanza su questo tema tra Claudio Napoleoni e Paul Sweezy.
Il capitolo conclusivo del volume, dal significativo titolo “Critica dell’economia politica” evidenzia, come recita il sottotitolo, continuità e rotture nel discorso di politica economica di Claudio Napoleoni, riprendendo i suoi interventi sulla politica economica che – anche se in genere poco valorizzati – hanno invece sempre caratterizzato la sua vita in relazione alla grande importanza da lui assegnata alla politica.
Pur senza soffermarmi su un tema in particolare, ne vorrei segnalare alcuni che ho trovato di particolare interesse. Il primo è quello della formazione e, al suo interno, della rilevanza assegnata alla storia del pensiero economico. Bellofiore ripercorre le esperienze di Napoleoni alla Svimez e alla Sispe in cui l’insegnamento non è mera esposizione di contenuti già noti ma stimolo alla stessa attività di ricerca. Alla Svimez Napoleoni insegna nei diversi anni un po’ di tutto (p. 343): dalla teoria della produzione, quella delle forme di mercato; dalla programmazione lineare alle interdipendenze strutturali; dalla macro pre-keynesiana e keynesiana al modello di von Neumann. La storia del pensiero economico, soprattutto nei primi anni, è molto presente e diventa protagonista assoluta alla Sispe con i corsi su Smith, Ricardo, Marx, Walras, Sraffa. È un passaggio che si evidenzia anche nella intitolazione della Scuola che cambiando denominazione anche se non acronimo SISPE nel 1972-73 diventa – come ricordato poco sopra – “Scuola Italiana di Storia del Pensiero Economico”.
Riccardo Bellofiore menziona anche un altro tema che viene trattato da Napoleoni in un modo originale, quello delle donne che come i giovani, in quanto soggetti esterni alla produzione, potrebbero spezzare la logica totalizzante del capitale. È un tema sfiorato nel primo capitolo sia della prima che della seconda parte che può costituire uno spunto di riflessione anche se, oggi, da ripensare alla luce delle trasformazioni che hanno caratterizzato il mondo del lavoro rispetto all’inizio degli anni Ottanta, momento in cui Napoleoni si esprime in questo senso. Scrive Bellofiore: “la via d’uscita da questa impasse è vista da Napoleoni nell’estendersi dell’elemento ‘femminile’ della storia e della società, cioè dei valori della riproduzione, a scapito dell’elemento ‘maschile’, che si esprime nella produzione di cose e nel dominio sul mondo. Napoleoni si ricollega così alle tematiche messe al centro della loro azione dal movimento delle donne” (p. 60) e vede nelle donne, così come nei giovani, dei soggetti potenzialmente esterni alla logica del dominio.
Un ulteriore e ultimo aspetto che voglio segnalare è quello relativo alle riflessioni che Napoleoni elabora in particolare dopo il fallimento del referendum sulla scala mobile del 1985. È noto che il risultato contribuisce a dirigere i suoi ragionamenti verso considerazioni che riguardano sia il carattere del lavoro capitalistico, sia la situazione di alienazione e di perdita della soggettività legata all’affermarsi dell’età della tecnica.
Scrive Napoleoni che, anche se la tecnica è un elemento irreversibile non bisogna rinunciare alla ricerca di nuove soluzioni, a un utilizzo del progresso tecnologico che non sia un fine ma uno strumento di benessere per l’individuo, a un rapporto con la natura che non sia di dominio. Mi pare uno spunto di ricerca tutt’altro che datato, che potrebbe in modo proficuo essere ulteriormente ripreso e irrobustito.
Definisco anche in questo caso l’idea di Napoleoni uno spunto di ricerca e non una “eredità”. Per usare una espressione cara a Riccardo Bellofiore, potrei usare anche il termine “lezione”. Oltre a questa e ad altre lezioni di Napoleoni – sottese a tutto il volume – mi pare di poterne individuare una che le sovrasta – e che anche Bellofiore ha certamente assorbito: quella del “procedere oltre e altrimenti”, del trovare un diverso punto di partenza nella ricerca di un più soddisfacente approdo, sempre ponendo al centro il gusto di ragionare o, per riprendere il titolo, la passione della ragione. C’è, infine, un apprezzabile caratteristica nel percorso di ricerca di Napoleoni, nel suo rimettere in discussione le posizioni da lui stesso sostenute ed è la totale assenza di atteggiamenti rinunciatari: l’economista critico ha proprio nella critica un punto di coerenza inattaccabile.






































