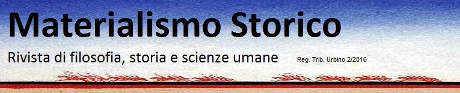Fai una donazione
Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________
- Details
- Hits: 2188
Covid: il terrore giustifica i mezzi
di Leonardo Mazzei
 Chi ci segue sa quel che pensiamo del Covid. Primo, l’epidemia c’è, ma non è né la peste né la spagnola. Secondo, l’emergenza sanitaria c’è, ma al 90% è frutto dei tagli alla sanità targati euro(pa). Terzo, i morti ci sono, ma la quasi totalità è deceduta col Covid, non di Covid, e talvolta pure senza Covid. Quarto, e ben più importante, il virus è esattamente quel che lorsignori aspettavano per far passare, grazie alla paura diffusa h24 dai media, progetti e misure che avrebbero avuto ben altra opposizione in tempi normali.
Chi ci segue sa quel che pensiamo del Covid. Primo, l’epidemia c’è, ma non è né la peste né la spagnola. Secondo, l’emergenza sanitaria c’è, ma al 90% è frutto dei tagli alla sanità targati euro(pa). Terzo, i morti ci sono, ma la quasi totalità è deceduta col Covid, non di Covid, e talvolta pure senza Covid. Quarto, e ben più importante, il virus è esattamente quel che lorsignori aspettavano per far passare, grazie alla paura diffusa h24 dai media, progetti e misure che avrebbero avuto ben altra opposizione in tempi normali.
Senza questo quarto e determinante aspetto, senza il decisivo fattore P (come paura), non si spiegherebbe quasi nulla di quel che sta accadendo. Tantomeno verrebbero accettate narrazioni al limite dell’assurdo, limitazioni di ogni forma di libertà, una censura di fatto applicata non solo ai “dissidenti”, ma pure alla più piccola sbavatura (vedi il caso Crisanti) nella narrazione ufficiale.
Già, il racconto ufficiale… Ma quanto è coerente questo racconto? Ecco una bella domanda alla quale vale la pena di dedicarsi. Lo faremo con una serie di esempi, che ci porteranno ad una conclusione che già anticipiamo: la narrazione ufficiale è tanto coerente nei fini (terrorizzare, terrorizzare, terrorizzare), quanto incoerente nei fatti e nelle tesi che utilizza per generare quel terrore. Anzi, da questo punto di vista, essa fa acqua da tutte le parti.
- La bufala del lockdown che “ci protegge”
Ci siamo già occupati di questa leggenda in primavera, quando, sulla base di dati ufficiali, dimostrammo quanto l’andamento dell’epidemia nei singoli paesi apparisse piuttosto indifferente alle diverse forme di contenimento adottate.
- Details
- Hits: 2022
L’assalto al cielo e il “mondo nuovo”
di Daniele Burgio, Massimo Leoni e Roberto Sidoli
Pubblichiamo il capitolo undicesimo “L’assalto al cielo e il “mondo nuovo” tratto dal libro Il prometeismo sdoppiato: Nietzsche o Marx? di Daniele Burgio, Massimo Leoni e Roberto Sidoli
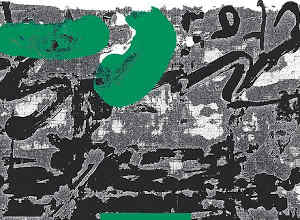 La principale modalità operativa assunta all’interno del mondo occidentale del prometeismo di matrice collettivistico durante gli ultimi due secoli, a partire dal 1789 e dalla rivoluzione francese, è costituita dalla titanica lotta collettiva condotta da frazioni più o meno consistenti di operai e lavoratori salariati (oltre che di intellettuali) e tesa ad abbattere i rapporti di produzione classisti lottando con gravi problemi, contraddizioni interne più o meno acute e soprattutto contro nemici assai più potenti sul piano materiale per creare e costruire un “mondo nuovo”: ossia una formazione economico-sociale di matrice cooperativa e socialista, in una linea rossa che parte dagli Arrabbiati guidati da Jacques Roux e dalla congiura degli Eguali da Babeuf-Buonarroti per arrivare mano a mano all’inizio del nostro terzo millennio.
La principale modalità operativa assunta all’interno del mondo occidentale del prometeismo di matrice collettivistico durante gli ultimi due secoli, a partire dal 1789 e dalla rivoluzione francese, è costituita dalla titanica lotta collettiva condotta da frazioni più o meno consistenti di operai e lavoratori salariati (oltre che di intellettuali) e tesa ad abbattere i rapporti di produzione classisti lottando con gravi problemi, contraddizioni interne più o meno acute e soprattutto contro nemici assai più potenti sul piano materiale per creare e costruire un “mondo nuovo”: ossia una formazione economico-sociale di matrice cooperativa e socialista, in una linea rossa che parte dagli Arrabbiati guidati da Jacques Roux e dalla congiura degli Eguali da Babeuf-Buonarroti per arrivare mano a mano all’inizio del nostro terzo millennio.
Come sottoprodotto di tale fenomeno politico-sociale, inoltre, un’altra forma importante di espressione non teorica del prometeismo rosso si è sostanziata nella speranza collettiva riposta da segmenti più o meno ampi delle masse popolari occidentali, ivi compresa la Russia, rispetto a leader politici ed “eroi rossi” (Ernst Bloch) ritenuti in possesso di eccezionali doti politiche, intellettuali e morali, tali da trasformarli più o meno completamente in supereroi agli occhi dei suoi seguaci.
Partiamo comunque dall’analisi del “prometeismo della rivolta”, ossia del titanismo insito nei processi insurrezionali popolari che sono stati purtroppo sbaragliati e annientati nel mondo occidentale, immediatamente al loro sorgere oppure dopo solo un breve istante storico di conquista del potere, dopo solo una “breve estate” (H. M. Enzensberger) di inebriante vittoria.
- Details
- Hits: 1382
Puntare tutto sul Recovery Fund può essere fatale per l’Italia
di Enrico Grazzini
 Per una volta Federico Fubini, il vice-direttore ad personam del Corriere della Sera che è contemporaneamente un esperto di finanza e un europeista convinto, ha ragione. L’Unione Europea, nonostante le fanfare europeiste, nonostante i proclami superottimistici del ministro dell’economia Roberto Gualtieri, è ancora una volta bloccata. E purtroppo non è assolutamente detto che il Recovery Fund Europeo da 750 miliardi di euro, altrimenti chiamato Next Generation EU, alla fine sarà realmente realizzato. Gli incidenti di percorso possono essere molti, alcuni già visibili, altri imprevedibili. Il futuro dell’Italia è appeso al filo del Recovery Fund, RF, e ai 209 miliardi che il nostro Paese potrebbe cominciare (forse) a spendere nella seconda metà del prossimo anno per rilanciare un’economia moribonda e una società spossata dalla crisi causata dal Covid-19. Tuttavia, Fubini spiega che potrebbero capitare delle brutte sorprese. Il governo Conte aspetta gli “aiuti” dell’Unione Europea come una manna dal cielo ma non è certo che la manna cadrà davvero. È per questo validissimo motivo che il governo dovrebbe cominciare a svegliarsi per trovare e creare anche autonomamente i soldi indispensabili per combattere la crisi.
Per una volta Federico Fubini, il vice-direttore ad personam del Corriere della Sera che è contemporaneamente un esperto di finanza e un europeista convinto, ha ragione. L’Unione Europea, nonostante le fanfare europeiste, nonostante i proclami superottimistici del ministro dell’economia Roberto Gualtieri, è ancora una volta bloccata. E purtroppo non è assolutamente detto che il Recovery Fund Europeo da 750 miliardi di euro, altrimenti chiamato Next Generation EU, alla fine sarà realmente realizzato. Gli incidenti di percorso possono essere molti, alcuni già visibili, altri imprevedibili. Il futuro dell’Italia è appeso al filo del Recovery Fund, RF, e ai 209 miliardi che il nostro Paese potrebbe cominciare (forse) a spendere nella seconda metà del prossimo anno per rilanciare un’economia moribonda e una società spossata dalla crisi causata dal Covid-19. Tuttavia, Fubini spiega che potrebbero capitare delle brutte sorprese. Il governo Conte aspetta gli “aiuti” dell’Unione Europea come una manna dal cielo ma non è certo che la manna cadrà davvero. È per questo validissimo motivo che il governo dovrebbe cominciare a svegliarsi per trovare e creare anche autonomamente i soldi indispensabili per combattere la crisi.
Attualmente l’opposizione al Recovery Fund da 750 miliardi viene, come noto, da Polonia e Ungheria, i Paesi amici del sovranista Matteo Salvini, capo supremo della Lega: i due Paesi dell’est Europa bloccano un processo di finanziamento della UE che, forse per la prima volta da quando è nato l’euro, è favorevole al nostro interesse nazionale.
- Details
- Hits: 2496
Strategie di sopravvivenza del sistema finanziario
Verso il nulla che avanza
di Francesco Cappello
 Le banche centrali a partire dalla crisi del 2007/08 nel tentativo di stabilizzare il sistema finanziario, in equilibrio intrinsecamente precario, hanno creato e immesso enormi quantità di moneta nei suoi circuiti, al fine di far quadrare bilanci pericolosamente squilibrati. Ad oggi, nel complesso, più di 30 mila miliardi di dollari la moneta a vario titolo creata (1) e immessa nel sistema finanziario, destinata a crescere a ritmi vertiginosi.
Le banche centrali a partire dalla crisi del 2007/08 nel tentativo di stabilizzare il sistema finanziario, in equilibrio intrinsecamente precario, hanno creato e immesso enormi quantità di moneta nei suoi circuiti, al fine di far quadrare bilanci pericolosamente squilibrati. Ad oggi, nel complesso, più di 30 mila miliardi di dollari la moneta a vario titolo creata (1) e immessa nel sistema finanziario, destinata a crescere a ritmi vertiginosi.
La moneta dal 1971 è moneta fiat, non più legata all’oro (fine del gold standard). Essa si crea dal nulla a volontà. Non è “risorsa” scarsa. Non ha quindi valore intrinseco.
Come fare a conferirglielo?
Sorgente e ruolo dell’inflazione finanziaria
Come è noto alle banche centrali di molti paesi inclusi quelli dell’Unione Europea è stata preclusa la possibilità di finanziare direttamente gli Stati; sono perciò le banche private a fare da intermediare comprando i titoli emessi dallo stato. Esse utilizzano allo scopo moneta creata appositamente dalle banche centrali. Nel contesto europeo le banche private fanno da intermediarie tra la BCE e gli Stati.
- Details
- Hits: 2340
Non c'è più tempo per le incertezze
di Alessandro Pascale
Pubblichiamo un contributo di Alessandro Pascale sull'unità dei comunisti
 Recentemente si è assistito ad un breve ma intenso dibattito a distanza sulla questione dell'unità dei comunisti. Avviato da Norberto Natali, è stato portato avanti teoreticamente da Eros Barone, suscitando una controproposta molto pragmatica di Burgio, Sidoli e Leoni. Le proposte operative di questi ultimi non sembrano per ora essere state seriamente prese in considerazione dalle organizzazioni esistenti, almeno non apparentemente... Natali e Barone hanno posto una serie di paletti sul cerchio in cui si dovrebbero includere i comunisti effettivamente tali, ma per chi sa leggere i bizantinismi della politica, nonostante l'apparente apertura, anche le proposte operative di Sidoli e compagni tendono nei fatti a chiudere entro un adeguato perimetro le forze di cui si auspica un'unità d'azione.
Recentemente si è assistito ad un breve ma intenso dibattito a distanza sulla questione dell'unità dei comunisti. Avviato da Norberto Natali, è stato portato avanti teoreticamente da Eros Barone, suscitando una controproposta molto pragmatica di Burgio, Sidoli e Leoni. Le proposte operative di questi ultimi non sembrano per ora essere state seriamente prese in considerazione dalle organizzazioni esistenti, almeno non apparentemente... Natali e Barone hanno posto una serie di paletti sul cerchio in cui si dovrebbero includere i comunisti effettivamente tali, ma per chi sa leggere i bizantinismi della politica, nonostante l'apparente apertura, anche le proposte operative di Sidoli e compagni tendono nei fatti a chiudere entro un adeguato perimetro le forze di cui si auspica un'unità d'azione.
Non ho mai amato molto i sotterfugi, e preferisco i discorsi chiari ed espliciti. Nell'opera In difesa del socialismo reale(poi diventata nella II edizione Storia del Comunismo) ho svolto un'analisi abbastanza chiara e netta sui pregi e sui difetti della storia del movimento comunista italiano; pur essendo partito da una posizione scevra da pregiudizi, in molti casi mi sono trovato, studiando, a rimodulare in maniera consistente certi giudizi storici e politici pre-esistenti. Quel che ho capito, e che viene ben espresso dal tenore degli interventi citati, è che abbiamo un patrimonio enorme alle spalle, che dobbiamo saper utilizzare criticamente per comprendere fino in fondo gli errori che abbiamo commesso tutti nel passato, al fine di ricostruire un'organizzazione con fondamenta più solide.
- Details
- Hits: 1535
Capitalismo e democrazia, catastrofe o rivoluzione
di Paolo Ortelli
- Wolfgang Streeck, Jürgen Habermas, Oltre l’austerità. Disputa sull’Europa, a cura di Giorgio Fazio, Castelvecchi, Roma 2020.
- Emiliano Brancaccio, Non sarà un pranzo di gala. Crisi, catastrofe, rivoluzione, a cura di Giacomo Russo Spena, Meltemi, Milano 2020.
 «Se, in nome della giustizia e della libertà di restituire significato e unità alla vita, fossimo mai chiamati a sacrificare una quota di efficienza nella produzione, di economia nel consumo, o di razionalità nell’amministrazione, ebbene una civiltà industriale potrebbe permetterselo.»
«Se, in nome della giustizia e della libertà di restituire significato e unità alla vita, fossimo mai chiamati a sacrificare una quota di efficienza nella produzione, di economia nel consumo, o di razionalità nell’amministrazione, ebbene una civiltà industriale potrebbe permetterselo.»
Karl Polanyi[1]
È da almeno dieci anni che una minoranza di studiosi sociali invoca la necessità di un cambio di paradigma economico, una minoranza che si è rinfoltita con qualche ritardo rispetto allo sgretolamento del sistema sociale che ha governato i destini del mondo negli ultimi quarant’anni. Ci è voluto un decennio di stagnazione perché tornassimo «tutti (nuovamente) keynesiani», realizzando però che ormai abbiamo perso il controllo sulle leve necessarie per applicare politiche keynesiane.
Oggi che la pandemia di Covid-19 sta facendo sentire le sue incommensurabili conseguenze economiche, anche nell’establishment istituzionale e accademico si parla finalmente di cambiare paradigma. Ma forse è a quei pochi capaci di uscire dal coro già in tempi non sospetti che dovremmo rivolgerci per trovare la bussola in questa crisi, la quale rischia di rivelarsi tanto più disastrosa quanto più, dopo lo shock pandemico, ci si illuderà di poter “tornare alla normalità”. Attenzione però, potremmo scoprire che capitalismo e democrazia sono ormai irreversibilmente incompatibili.
Wolfgang Streeck ed Emiliano Brancaccio sono tra gli studiosi sociali che hanno offerto gli strumenti analitici più preziosi in quest’epoca incerta e minacciosa.
- Details
- Hits: 1206
Venezuela, geopolitica post-elettorale
di Geraldina Colotti
 Mentre è in corso la farsa dell’autoproclamato con la sua “consultazione popolare”, le reazioni alle parlamentari, che si sono svolte in Venezuela il 6 di dicembre, fotografano la contesa geopolitica per come si va configurando in questo scorcio del 2020. Un anno segnato dalla pandemia da coronavirus, che ha già provocato 1,57 milioni di morti (3.000 al giorno solo negli USA), quasi mezzo milione in Europa.
Mentre è in corso la farsa dell’autoproclamato con la sua “consultazione popolare”, le reazioni alle parlamentari, che si sono svolte in Venezuela il 6 di dicembre, fotografano la contesa geopolitica per come si va configurando in questo scorcio del 2020. Un anno segnato dalla pandemia da coronavirus, che ha già provocato 1,57 milioni di morti (3.000 al giorno solo negli USA), quasi mezzo milione in Europa.
Un’Europa stretta nella gabbia della Ue, la cui cifra ricompatta, per l’occasione, gli interessi di banchieri, affaristi e grandi imprenditori a scapito dei settori popolari, ribadendo la stratificazione gerarchica esistente fra i suoi stessi membri. Un’Europa che vuole avere la sua fetta di torta, restando però sotto l’ombrello (Nato) del Grande Fratello nordamericano.
Il ministro degli Esteri russo, Serguéi Lavrov, ha sintetizzato adeguatamente la situazione, commentando la decisione del blocco regionale di imporre una nuova tornata di sanzioni alla Russia senza passare per gli organismi dell’ONU. L’Unione Europea – ha detto – ha rinunciato a essere uno dei poli di un sistema multipolare, continuando ad agire nell’orbita di Washington: “La politica della Germania – ha aggiunto – ci conferma che così vuole attuare Berlino, sempre che mantenga la leadership dell’Unione Europea”.
Su richiesta degli Stati Uniti, facendo riunioni a porte chiuse, la UE cerca di screditare l’ONU mediante il “meccanismo generico di imporre sanzione per violazione dei diritti umani”, ha denunciato il capo della diplomazia russa.
- Details
- Hits: 2514
Dopo Trump?
di Raffaele Sciortino
Avvertenza: nonostante l’assertività della comunicazione scritta, quanto segue intende presentare una serie di ipotesi di lettura di una dinamica complessa e aperta a più esiti
 “I marxisti, non potendo oggi essere protagonisti della storia,
“I marxisti, non potendo oggi essere protagonisti della storia,
nulla di meglio possono augurare che la catastrofe,
sociale, politica e bellica,
della signoria americana sul mondo capitalistico”
Bordiga, 1952
Oggi e ieri
Nulla dice di più sullo stato del mondo attuale del fatto che gli Stati Uniti sempre più si presentano come una equazione impossibile. Il primo paese mercantile-capitalistico puro nella storia - privo di un passato premoderno - si divincola tra la crisi del suo comando globale e l’impossibilità di ripristinarlo nella cornice consueta dell’ordine internazionale liberale, tra spinte anti-globalizzazione e destino che ne fa la nazione “indispensabile”, per sé e per le altre, del sistema mondiale, tra crescente polarizzazione interna e aleatorietà di qualunque nuovo patto sociale che possa ricostruire un grande consenso, tra scarico dei costi all’esterno e montante riottosità di alleati e avversari a sostenerli al modo di prima.
Le elezioni di novembre sono l’ennesima conferma di questo paradosso, degno di una configurazione quasi imperiale: il disordine nel ventre della bestia oggi non equivale di per sé al benessere del resto del mondo, così come, nel passato, ogni ricomposizione interna, sociale e politica, progressista è sempre stata ricetta per disastri. Dalla guerra civile, compimento dell’emancipazione nazionale borghese, sono venuti fuori i robber barons e il decollo imperialista e nessuna soluzione alla questione dei neri. Dal New Deal e dall’alleanza “democratica” nella seconda guerra imperialista è nata la spinta decisiva al dominio mondiale; dal compromesso sociale fordista è scaturito il consenso alla Guerra Fredda e all’aggressione al Vietnam.
- Details
- Hits: 1361
Il governo balla sul Mes
di Dante Barontini - Emiliano Brancaccio*
 Se dobbiamo stare alle grida mediatiche, il governo è sull’orlo della crisi. Il che sarebbe una novità, a pochi giorni dalla fine dell’anno e dunque dall’approvazione della “legge di stabilità”, la più importante di tutte le leggi perché definisce – per l’anno successivo – come lo Stato italiano finanzierà le proprie attività (tutte, quelle normali e quelle “eccezionali”) e dove troverà le risorse per farlo.
Se dobbiamo stare alle grida mediatiche, il governo è sull’orlo della crisi. Il che sarebbe una novità, a pochi giorni dalla fine dell’anno e dunque dall’approvazione della “legge di stabilità”, la più importante di tutte le leggi perché definisce – per l’anno successivo – come lo Stato italiano finanzierà le proprie attività (tutte, quelle normali e quelle “eccezionali”) e dove troverà le risorse per farlo.
La novità, nella legge di stabilità di quest’anno, è che oltre alla normale leva fiscale (le tasse su imprese e cittadini) si potrà calcolare anche qualche contributo europeo, nell’ottica del Recovery Fund o Next generation Eu, se e quando a Bruxelles si riuscirà a superare il veto di Polonia e Ungheria (ci stanno lavorando intensamente, pare).
Ci sono insomma decine di miliardi da gestire e questo scatena gli appetiti dentro e fuori la maggioranza di governo. C’è chi vorrebbe qualcosa anche stando all’opposizione (Forza Italia in primo luogo, ma non solo), chi vedere una fetta troppo piccola se proporzionata al suo basso bacino elettorale – Renzi, insomma – e poi Confindustria, che pretende per sé e le imprese che rappresenta l’intera posta, senza lasciare neanche uno spillo alle politiche sociali.
Anche tra Pd e Cinque Stelle, inevitabilmente, si è aperta la rissa per la stessa, con in più la complicazione di una “cabina di regia” che Conte vorrebbe capitanare insieme a Gualtieri e Patuanelli (quindi con criterio politicamente equanime), ma ricorrendo all’ennesima task force di “esperti” e “manager”. Il che sottrae certamente ai ministeri competenti una buona parte dei progetti da finanziare e del potere che ne deriva.
- Details
- Hits: 1401

“Una ruota quadrata”: alcune linee del Rapporto del CENSIS sulla situazione del paese
di Eros Barone
 “Il sistema-Italia è una ruota quadrata che non gira: avanza a fatica, suddividendo ogni rotazione in quattro unità, con un disumano sforzo per ogni quarto di giro compiuto, tra pesanti tonfi e tentennamenti. Mai lo si era visto così bene come durante quest’anno eccezionale, sotto i colpi sferzanti dell’epidemia. Privi di un Churchill a fare da guida nell’ora più buia, capace di essere il collante delle comunità, il nostro modello individualista è stato il migliore alleato del virus, unitamente ai problemi sociali di antica data. E di certo la rissosità della politica e i conflitti interistituzionali non aiutano. Così come nell’emergenza abbiamo trascurato i malati “ordinari”, uno degli effetti provocati dall’epidemia è di aver coperto sotto la coltre della paura e dietro le reazioni suscitate dallo stato d’allarme le nostre annose vulnerabilità e i nostri difetti strutturali, del tutto evidenti oggi nelle debolezze del sistema ‒ l’epidemia ha squarciato il velo: il re è nudo! ‒ e pronti a ripresentarsi il giorno dopo la fine dell’emergenza più gravi di prima”.
“Il sistema-Italia è una ruota quadrata che non gira: avanza a fatica, suddividendo ogni rotazione in quattro unità, con un disumano sforzo per ogni quarto di giro compiuto, tra pesanti tonfi e tentennamenti. Mai lo si era visto così bene come durante quest’anno eccezionale, sotto i colpi sferzanti dell’epidemia. Privi di un Churchill a fare da guida nell’ora più buia, capace di essere il collante delle comunità, il nostro modello individualista è stato il migliore alleato del virus, unitamente ai problemi sociali di antica data. E di certo la rissosità della politica e i conflitti interistituzionali non aiutano. Così come nell’emergenza abbiamo trascurato i malati “ordinari”, uno degli effetti provocati dall’epidemia è di aver coperto sotto la coltre della paura e dietro le reazioni suscitate dallo stato d’allarme le nostre annose vulnerabilità e i nostri difetti strutturali, del tutto evidenti oggi nelle debolezze del sistema ‒ l’epidemia ha squarciato il velo: il re è nudo! ‒ e pronti a ripresentarsi il giorno dopo la fine dell’emergenza più gravi di prima”.
Questo è l’‘incipit’ del 54° Rapporto del CENSIS sulla situazione del paese: una rappresentazione sobriamente documentata e giustamente impietosa della odierna realtà italiana, delineata da un intellettuale organico di una delle poche frazioni intelligenti della borghesia italiana, il sociologo cattolico Giuseppe De Rita. Invitando a leggerlo nella sua interezza, ne fornisco, più che una sintesi, alcuni estratti particolarmente significativi che dovrà tenere ben presenti chiunque si cimenti con i problemi di un lavoro politico serio all’interno del movimento di classe.
- Details
- Hits: 2010
Lo spieghìno: Il “nuovo” MES riformato? È peggio di quello vecchio
di Thomas Fazi
 Come nelle più prevedibili delle sceneggiature hollywoodiane, proprio quando il mostro sembrava ormai morto, eccolo rialzarsi per un (ultimo?) colpo di scena.
Come nelle più prevedibili delle sceneggiature hollywoodiane, proprio quando il mostro sembrava ormai morto, eccolo rialzarsi per un (ultimo?) colpo di scena.
Fino all’altro giorno, infatti, erano in molti a dare per morto il MES. Per chiarezza: qui non stiamo parlando del cosiddetto “MES sanitario”, ovvero della nuova linea di credito dalle “condizionalità limitate” riservata agli Stati per le spese sanitarie, che continua ad essere oggetto di un accesso dibattito e di cui abbiamo parlato in più occasioni, ma del Meccanismo europeo di stabilità nella sua accezione più ampia, in quanto organo intergovernativo permanente che esiste dal 2011 e la cui funzione fondamentale è quella di «concedere, sotto precise condizioni, assistenza finanziaria ai paesi membri che trovino temporanee difficoltà nel finanziarsi sul mercato». Parliamo in sostanza dell’organo impiegato (insieme ai suoi predecessori, il FESF e l’EFSM) nel “salvataggio finanziario”, per usare un eufemismo, in cambio di “riforme”, per usare un altro eufemismo, di Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Cipro.
Per capire di cosa parliamo può essere utile richiamare un episodio che riguarda Klaus Regling, il direttore generale del MES, che, come ricorda Carlo Clericetti, «dispone di amplissimi poteri e le cui azioni, secondo una esplicita previsione dello statuto del fondo, non possono essere contestate in nessun modo, nemmeno per via giudiziaria». Nel suo libro di memorie Adulti nella stanza, l’ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis racconta che nel tentativo di ottenere un rinvio al soffocante pagamento delle rate dei prestiti si rivolse direttamente a Regling. «Per pagare la rata nei termini stabiliti non avrei i soldi per stipendi e pensioni», gli disse Varoufakis. E Regling, senza battere ciglio, rispose: «E allora non pagare stipendi e pensioni». Questo tanto per inquadrare il plenipotenziario capo del MES.
- Details
- Hits: 1593
Denaro senza valore - Cap. XV
di Robert Kurz
La fine del movimento di espansione interno, la crisi mondiale della terza rivoluzione industriale e l’imbarazzo del positivismo della sinistra
 Presentiamo qui un capitolo tratto da Geld ohne Wert (tr.it: Denaro senza Valore),1 l’ultimo libro importante di Robert Kurz uscito quando l’autore era ancora in vita (il libro è del 2011, Kurz ci ha lasciati l’anno seguente a causa di un errore durante una operazione chirurgica). Questa prematura quanto incredibile morte ha sfortunatamente interrotto una importante riflessione in itinere che, con ogni probabilità, avrebbe avuto ancora molto da dire. Kurz infatti al momento della sua morte aveva “solo” 68 anni e, considerando la sua notevole prolificità, tutto lascia pensare che la sua produzione si sarebbe tutt’altro che interrotta in questo punto. Nella prefazione del libro in questione, per esempio, annunciava l’uscita successiva di una serie di testi che avrebbero dovuto approfondire temi legati alla critica dell’economia politica.2
Presentiamo qui un capitolo tratto da Geld ohne Wert (tr.it: Denaro senza Valore),1 l’ultimo libro importante di Robert Kurz uscito quando l’autore era ancora in vita (il libro è del 2011, Kurz ci ha lasciati l’anno seguente a causa di un errore durante una operazione chirurgica). Questa prematura quanto incredibile morte ha sfortunatamente interrotto una importante riflessione in itinere che, con ogni probabilità, avrebbe avuto ancora molto da dire. Kurz infatti al momento della sua morte aveva “solo” 68 anni e, considerando la sua notevole prolificità, tutto lascia pensare che la sua produzione si sarebbe tutt’altro che interrotta in questo punto. Nella prefazione del libro in questione, per esempio, annunciava l’uscita successiva di una serie di testi che avrebbero dovuto approfondire temi legati alla critica dell’economia politica.2
Geld ohne Wert è uno dei molti testi kurziani purtroppo ancora non tradotti in lingua italiana. In questo libro, che è la rielaborazione e ampliamento di una conferenza che avrebbe dovuto tenere in un convegno dal titolo “Magia del denaro. La sua razionalità e la sua irrazionalità” a Brema nel Marzo 2011, Kurz prova a proporre una nuova interpretazione della critica dell’economia politica, elaborando quattro grandi temi – in parte già affrontati in testi precedenti. Il primo di questi riguarda la questione delle società premoderne (o precapitalistiche, che secondo la lettura kurziana è praticamente la stessa cosa), per le quali cerca di delineare la differenza di fondo con quella moderna (o capitalistica). Interpretare le società precedenti alla nostra con gli stessi parametri con cui interpretiamo questa è un errore e una scorrettezza da un punto di vista metodologico, che non rende possibile la comprensione né dell’una né delle altre.
- Details
- Hits: 1309
Il Tronti di "Operai e capitale"
di Bollettino Culturale
 Gli anni Sessanta e Settanta furono gli anni della nascita della “Nuova Sinistra”, una fase contraddistinta dall'emergere di dibattiti ed eterodossie marxiste che entravano in rotta di collisione con i partiti comunisti dei rispettivi paesi. In questi vent'anni travagliati, emerse in Italia un'esperienza teorico-politica estremamente innovativa: l'operaismo.
Gli anni Sessanta e Settanta furono gli anni della nascita della “Nuova Sinistra”, una fase contraddistinta dall'emergere di dibattiti ed eterodossie marxiste che entravano in rotta di collisione con i partiti comunisti dei rispettivi paesi. In questi vent'anni travagliati, emerse in Italia un'esperienza teorico-politica estremamente innovativa: l'operaismo.
L’operaismo si sviluppò nelle lotte che hanno caratterizzato il nostro paese in quegli anni, sfidando da sinistra l’egemonia del PCI sul movimento operaio italiano.
Brevemente, è doveroso ricordare che l’operaismo non nasce con Tronti ma dentro l’esperienza dei Quaderni Rossi di Raniero Panzieri, esponente dell’ala sinistra del PSI.
Nel 1964 una parte rilevante dei Quaderni Rossi, tra cui Tronti, Toni Negri e Asor Rosa, si staccò per dare vita alla rivista Classe Operaia. L’esperienza della rivista terminò nel 1967. Una parte di questi intellettuali seguì una strategia entrista, tornando nel PCI (tra cui Tronti), altri esponenti dell’operaismo confluirono in esperienze della sinistra extraparlamentare come Lotta Continua e Potere Operaio (tra cui Toni Negri).
Lo scopo del testo è riflettere sul libro di Mario Tronti “Operai e Capitale”, uscito un anno prima della fine dell’esperienza di Classe Operaia, nel 1966, e diventato un classico della Nuova Sinistra e che condensa le tesi dell’operaismo degli anni '60.
La tesi principale degli operaisti era che lo sviluppo capitalista costituiva una risposta alle lotte della classe operaia. Gli operaisti si ribellarono ad una lettura del Capitale per cui, in nome dell'economia politica, il capitale diventava oggetto della storia. Al contrario, Tronti affermava il primato del rapporto di classe sulla strutturazione della borghesia come classe. La classe operaia era tale prima dei suoi sfruttatori.
- Details
- Hits: 2270
Come siamo arrivati fin qui? Il contagio di un’idea di salute
di Stefania Consigliere e Cristina Zavaroni*
 1. Cronache di una primavera e di un autunno
1. Cronache di una primavera e di un autunno
Nei primi giorni di maggio, sul finire della cosiddetta fase 1, in un lungo post intitolato Ammalarsi di paura, analizzavamo l’inaudita gravità della situazione lombarda con gli strumenti dell’antropologia medica e dell’etnopsichiatria e proponevamo di includere fra le concause di quel disastro anche l’effetto nocebo indotto dal «terrore a mezzo stampa». Come molti testi nati in quei mesi, anche quello, in qualche modo, si era scritto da sé in tempi rapidissimi, in una sorta di stato non ordinario di coscienza indotto dal trattenimento casalingo.
Subito dopo, la fase 2 ha portato nuove questioni, nuove angosce, un’enorme stanchezza e un diverso registro di visibilità. Lungo l’estate il moto emotivo collettivo è andato nella direzione di un certo oblio: sperando che tanto la pandemia quanto il governo fossero in remissione, non abbiamo avuto voglia di fare i conti con ciò che avevamo appena vissuto. Troppo faticoso da elaborare e poi il virus non c’è quasi più, pensiamo a ripartire…
Quando la storia attraversata è traumatica e carica di angoscia, può capitare, sia ai singoli che a intere collettività, di aver voglia di pensare ad altro e “guardare avanti”, nel tentativo ambiguo di alleviare il carico emotivo senza fare i conti con le responsabilità. Luca Casarotti ha descritto questo processo, per un tutt’altro momento storico, nel suo discorso per il 25 aprile 2018. Dal punto di vista psicologico si capisce bene il perché di questa strategia, che però, alla lunga, è fallimentare e collusiva.
- Details
- Hits: 1359
Oggi la BCE sta finalmente facendo il suo dovere. Ma per quanto?
di Stephanie Kelton
Prefazione all’edizione italiana de Il mito del deficit. La teoria monetaria moderna per un’economia al servizio del popolo di Stephanie Kelton (Fazi Editore, 2020)
 Care lettrici e cari lettori italiani,
Care lettrici e cari lettori italiani,
In questo libro utilizzo le lenti della teoria monetaria moderna (Modern Monetary Theory, MMT) per mostrare che, contrariamente a quanto gli economisti mainstream e i politici ci raccontano da decenni, i governi che emettono la propria valuta (che detengono, cioè, la sovranità monetaria) non possono mai “finire i soldi”, né possono diventare insolventi (fare default) sui titoli di debito emessi nella loro stessa valuta. A dire il vero non hanno neanche bisogno di emettere titoli di Stato per finanziare i propri deficit di bilancio. Né hanno bisogno di ricorrere alla tassazione per finanziare le proprie spese. Questo perché, in quanto emittenti di valuta, a differenza delle famiglie e delle imprese, che sono dei semplici utilizzatori di valuta, gli Stati che dispongono della sovranità monetaria possono semplicemente creare “dal nulla” tutto il denaro di cui hanno bisogno. Questi governi, dal punto di vista tecnico, hanno una capacità di spesa illimitata nella propria valuta: possono cioè acquistare senza limiti tutti i beni e servizi disponibili nella valuta nazionale. (Come spiego nel libro, questo non implica che i governi che emettono la propria valuta debbano spendere o incorrere in deficit senza limiti; esistono dei limiti, solo che non sono di natura finanziaria).
Comprendere questa semplice verità equivale a fare un vero e proprio salto di paradigma, perché significa che la maggior parte dei paesi – e in particolare le nazioni industrializzate tecnicamente avanzate e altamente sviluppate che spendono, tassano e prendono in prestito nelle proprie valute inconvertibili (e adottano un regime di cambio fluttuante) – possono “permettersi” (letteralmente) di fare molto di più per incrementare il benessere dei propri cittadini e più in generale per perseguire qualunque obiettivo politico scelgano di prefissarsi (penso per esempio alla mitigazione del cambiamento climatico) di quanto comunemente si creda.
- Details
- Hits: 1198
Marx e la cartina di tornasole dell’autoemancipazione
di Fabio Ciabatti
Dan Swain, None So Fit to Break the Chains. Marx’s Ethics of Self-Emancipation, Haymarket Books, Chicago 2020. pp. 224, 33,00 euro
 “L’emancipazione della classe operaia deve essere opera dei lavoratori stessi”. Questa famosa affermazione di Marx appare inequivocabile. Basta però, per alimentare qualche dubbio, accostare questa citazione a un altro famoso passaggio in cui il Moro di Treviri parla dell’“organizzazione dei proletari in classe e quindi in partito politico”. Si può così concludere che l’emancipazione della classe operaia è sostanzialmente opera del Partito comunista. Peccato che, come si evince dall’intero corpus marxiano e come è stato chiarito esplicitamente in una lettera dal diretto interessato, Marx quando parla di partito si riferisce generalmente al partito della classe in senso eminentemente storico, non a una qualche specifica organizzazione politica.
“L’emancipazione della classe operaia deve essere opera dei lavoratori stessi”. Questa famosa affermazione di Marx appare inequivocabile. Basta però, per alimentare qualche dubbio, accostare questa citazione a un altro famoso passaggio in cui il Moro di Treviri parla dell’“organizzazione dei proletari in classe e quindi in partito politico”. Si può così concludere che l’emancipazione della classe operaia è sostanzialmente opera del Partito comunista. Peccato che, come si evince dall’intero corpus marxiano e come è stato chiarito esplicitamente in una lettera dal diretto interessato, Marx quando parla di partito si riferisce generalmente al partito della classe in senso eminentemente storico, non a una qualche specifica organizzazione politica.
In altri termini, il concetto di partito, almeno nella sua accezione dominante nell’opera marxiana, coincide con il “movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti”.1 Un movimento che si costituisce come parte, la parte proletaria in lotta con quella borghese, ponendosi l’obiettivo politico di abbattere il modo di produzione dominante e per fare ciò si cristallizza temporaneamente in specifiche organizzazioni. Saremmo però dei materialisti assai bizzarri se pensassimo che importanti sviluppi storici, come la centralità assunta dal partito nelle vicende novecentesche, siano dipesi dalla cattiva interpretazione di alcuni testi, fossero anche quelli di Marx.
La citazione con cui abbiamo aperto testimonia che l’intera opera marxiana è pervasa da un impegno etico-politico nei confronti della rivoluzione intesa come autoemancipazione del proletariato.2
- Details
- Hits: 1472
Una contraddizione tra materia e forma
di Claus Peter Ortlieb
Sull'importanza della produzione di plusvalore relativo ai fini della dinamica della crisi
 Mentre l'economia politica in carica ritiene di stare osservando solo il lato materiale del modo di produzione capitalistico, e si interessa di magnitudini quali la crescita "reale" del prodotto interno lordo, oppure del reddito "effettivo" - tutte cose che, tuttavia, sono mediate dai loro valori in denaro - la maggioranza dei testi che si legano alla teoria del valore lavoro analizza il medesimo processo di produzione in relazione alla massa di valore e di plusvalore che viene realizzata in quel processo. Entrambe la parti, sembrano partire implicitamente dal principio secondo cui si tratti solo di differenti unità di misura della ricchezza. Viceversa, questo testo parte, con Marx, dal duplice concetto di ricchezza nel capitalismo, storicamente specifico, che viene rappresentato nel duplice carattere della merce e del lavoro. Il valore, come forma dominante di ricchezza nel capitalismo, si contrappone alla ricchezza materiale, alla cui forma specifica il capitale è di fatto indifferente, ma alla quale continua ad essere indispensabile in quanto portatore del valore. Ora, con l'aumentare della produttività, queste due forme di ricchezza entrano necessariamente a far parte di un'evoluzione divergente; ed era a partire da questo che Marx poteva parlare del capitale come «contraddizione in processo». Ed è tale contraddizione che vado qui ad esaminare. L'obiettivo è quello di mettere alla prova le argomentazioni del saggio di Robert Kurz (del 1986), che ha fondato la teoria della crisi dell'ex Krisis, contro quanto meno alle argomentazioni più serie contrarie a quelle formulate da Kurz.
Mentre l'economia politica in carica ritiene di stare osservando solo il lato materiale del modo di produzione capitalistico, e si interessa di magnitudini quali la crescita "reale" del prodotto interno lordo, oppure del reddito "effettivo" - tutte cose che, tuttavia, sono mediate dai loro valori in denaro - la maggioranza dei testi che si legano alla teoria del valore lavoro analizza il medesimo processo di produzione in relazione alla massa di valore e di plusvalore che viene realizzata in quel processo. Entrambe la parti, sembrano partire implicitamente dal principio secondo cui si tratti solo di differenti unità di misura della ricchezza. Viceversa, questo testo parte, con Marx, dal duplice concetto di ricchezza nel capitalismo, storicamente specifico, che viene rappresentato nel duplice carattere della merce e del lavoro. Il valore, come forma dominante di ricchezza nel capitalismo, si contrappone alla ricchezza materiale, alla cui forma specifica il capitale è di fatto indifferente, ma alla quale continua ad essere indispensabile in quanto portatore del valore. Ora, con l'aumentare della produttività, queste due forme di ricchezza entrano necessariamente a far parte di un'evoluzione divergente; ed era a partire da questo che Marx poteva parlare del capitale come «contraddizione in processo». Ed è tale contraddizione che vado qui ad esaminare. L'obiettivo è quello di mettere alla prova le argomentazioni del saggio di Robert Kurz (del 1986), che ha fondato la teoria della crisi dell'ex Krisis, contro quanto meno alle argomentazioni più serie contrarie a quelle formulate da Kurz.
- Details
- Hits: 1683
Questo presepe non ci piace
di Geminello Preterossi
 I dpcm sono ormai armi di distrazione di massa: per distogliere l’attenzione dai problemi veri, cioè dai fallimenti di governo e regioni, si fa propaganda, scaricando sui cittadini le colpe e creando falsi miti. Ad esempio, quello del Ferragosto devastante. Peccato che l’impennata dei positivi sia cominciata un mese e mezzo dopo, a seguito della riapertura delle scuole. L’inadeguata gestione di tale riapertura e il crack dei trasporti pubblici super-affollati sono, in tutta evidenza, le cause principali del ritorno del coronavirus, insieme all’arrivo della stagione autunnale. Cosi come davanti ai nostri occhi è la vergogna della totale disorganizzazione della sanità territoriale, che causa l’ospedalizzazione della malattia. È incredibile che le persone siano abbandonate a se stesse a casa, che non vi siano certezze diagnostiche celeri né protocolli terapeutici chiari, che non si sia provveduto a mobilitare i medici di famiglia (dotandoli degli opportuni presidi di sicurezza). Non sarà che l’alto numero dei decessi, in Italia, è anche l’effetto del fallimento radicale della sanità, in particolare di quella territoriale, che impedisce di curare adeguatamente le persone a casa, facendole affollare in ospedale, magari quando è tardi?
I dpcm sono ormai armi di distrazione di massa: per distogliere l’attenzione dai problemi veri, cioè dai fallimenti di governo e regioni, si fa propaganda, scaricando sui cittadini le colpe e creando falsi miti. Ad esempio, quello del Ferragosto devastante. Peccato che l’impennata dei positivi sia cominciata un mese e mezzo dopo, a seguito della riapertura delle scuole. L’inadeguata gestione di tale riapertura e il crack dei trasporti pubblici super-affollati sono, in tutta evidenza, le cause principali del ritorno del coronavirus, insieme all’arrivo della stagione autunnale. Cosi come davanti ai nostri occhi è la vergogna della totale disorganizzazione della sanità territoriale, che causa l’ospedalizzazione della malattia. È incredibile che le persone siano abbandonate a se stesse a casa, che non vi siano certezze diagnostiche celeri né protocolli terapeutici chiari, che non si sia provveduto a mobilitare i medici di famiglia (dotandoli degli opportuni presidi di sicurezza). Non sarà che l’alto numero dei decessi, in Italia, è anche l’effetto del fallimento radicale della sanità, in particolare di quella territoriale, che impedisce di curare adeguatamente le persone a casa, facendole affollare in ospedale, magari quando è tardi?
Tutto ciò viene rimosso, e l’attenzione spostata, fin dalla primavera scorsa, via via su obiettivi fittizi: sui riders (anche se solitari), la movida, i giovani, il Natale con i parenti (persino quelli stretti, se abitano in un’altra regione, pur gialla), la Messa di Mezzanotte (notoriamente, il virus si sveglia a quell’ora).
- Details
- Hits: 3906
Centomila miliardi di asset finanziano 18.500 miliardi di Pil
Il rischio americano è tutto qui
di Maurizio Novelli, Lemanik
Lo stock di azioni e titoli di debito che finanziano l’economia Usa ha raggiunto questa cifra stratosferica. E circa 10-12.000 miliardi di dollari di risparmio estero di Cina, Giappone ed Europa contribuiscono a quel sostegno, sottraendo risorse alle loro economie. Un circolo vizioso da cui si esce con ricette che Wall Street certo non gradisce
 Mentre si avvia il cambio di amministrazione negli Stati Uniti, i mercati finanziari sono impegnati nella costruzione della piu’ grande bolla speculativa di sempre, in un contesto economico particolarmente disastrato. I postumi della crisi economica non saranno così facili da superare per le economie occidentali e il danno richiederà molto tempo per essere riparato, anche se la frenesia speculativa dei mercati cerca di far credere che non sarà così.
Mentre si avvia il cambio di amministrazione negli Stati Uniti, i mercati finanziari sono impegnati nella costruzione della piu’ grande bolla speculativa di sempre, in un contesto economico particolarmente disastrato. I postumi della crisi economica non saranno così facili da superare per le economie occidentali e il danno richiederà molto tempo per essere riparato, anche se la frenesia speculativa dei mercati cerca di far credere che non sarà così.
Le azioni dei policy makers stanno creando due economie tra loro contrapposte, quella della finanza e quella reale, con il rischio che si possano separare pericolosamente tra loro in modo irreversibile, producendo una ripresa economica a forma di K: il 10% più ricco della popolazione si trova sulla linea superiore della K e il rimanente 90% in quella inferiore, fino a creare in prospettiva l’instabilità sociale prodotta dalla disuguaglianza.
Il livello raggiunto dallo stock di asset finanziari detenuti dagli investitori e circolanti nell’economia americana a fine 2019 era pari a 5,6 volte il Pil Usa, ma in considerazione del recente aumento del debito interno per fronteggiare la crisi economica, dovrebbe essere salito a ben oltre 6 volte il PIL (in UE tale livello è inferiore a 3 volte). In sostanza, il Pil USA vale oggi circa 18.500 miliardi di dollari ma le attività finanziarie (azioni, obbligazioni e titoli cartolarizzati di ogni tipo) che lo rappresentano e servono a finanziarlo hanno raggiunto la cifra astronomica di oltre 100.000 miliardi di dollari (derivati esclusi!).
- Details
- Hits: 1534
Guerra commerciale USA-Cina: il vero ladro finalmente smascherato
di Rémy Herrera, Zhiming Long, Zhixuan Feng e Bangxi Li*
Pubblicato su “Materialismo Storico. Rivista di filosofia, storia e scienze umane", n° 1/2020, a cura di Stefano G. Azzarà, pp. 177-190, licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0

- Details
- Hits: 1618
La Dialettica della Natura di Engels nell'antropocene
di John Bellamy Foster
 Nel capitolo «Parte avuta dal lavoro nel processo di umanizzazione della scimmia» del suo Dialettica della natura, Friedrich Engels affermava: «Ogni cosa influenza ed è influenzata da ogni altra cosa» [1]. Oggi, a duecento anni dalla sua nascita, Engels si può considerare uno dei fondatori del pensiero ecologico moderno. Se la teoria della frattura metabolica di Karl Marx è alla base dell'ecologia odierna ispirata al materialismo storico, resta pur vero che il contributo di Engels alla nostra comprensione del problema ecologico nel suo insieme rimane indispensabile - un contributo basato sulle sue approfondite ricerche sul metabolismo universale della natura, che rafforzarono e ampliarono l'analisi di Marx. Come afferma Paul Blackledge in un recente studio del pensiero di Engels, «La concezione di Engels di una dialettica della natura apre uno spazio attraverso il quale le crisi ecologiche» possono essere ricondotte alla «natura alienata delle relazioni sociali capitaliste» [2]. È proprio in virtù della completezza del suo approccio alla dialettica della natura e della società che l'opera di Engels può contribuire a chiarire le sfide epocali che l'umanità deve fronteggiare nell'antropocene, e la crisi ecologica planetaria che caratterizza l'epoca attuale.
Nel capitolo «Parte avuta dal lavoro nel processo di umanizzazione della scimmia» del suo Dialettica della natura, Friedrich Engels affermava: «Ogni cosa influenza ed è influenzata da ogni altra cosa» [1]. Oggi, a duecento anni dalla sua nascita, Engels si può considerare uno dei fondatori del pensiero ecologico moderno. Se la teoria della frattura metabolica di Karl Marx è alla base dell'ecologia odierna ispirata al materialismo storico, resta pur vero che il contributo di Engels alla nostra comprensione del problema ecologico nel suo insieme rimane indispensabile - un contributo basato sulle sue approfondite ricerche sul metabolismo universale della natura, che rafforzarono e ampliarono l'analisi di Marx. Come afferma Paul Blackledge in un recente studio del pensiero di Engels, «La concezione di Engels di una dialettica della natura apre uno spazio attraverso il quale le crisi ecologiche» possono essere ricondotte alla «natura alienata delle relazioni sociali capitaliste» [2]. È proprio in virtù della completezza del suo approccio alla dialettica della natura e della società che l'opera di Engels può contribuire a chiarire le sfide epocali che l'umanità deve fronteggiare nell'antropocene, e la crisi ecologica planetaria che caratterizza l'epoca attuale.
In corsa verso la rovina
La rilevanza contemporanea della critica ecologica di Engels può essere colta a partire da un celebre commento del 1940 di Walter Benjamin, citato sovente dagli ecosocialisti, tratto dai «Paralipomeni» (o note a margine) delle sue «Tesi sul concetto di storia».
- Details
- Hits: 1179
Pandemia e medicina del territorio
di Visconte Grisi
 Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo testo del compagno Visconte Grisi, che nasce anche dalla sua lunga esperienza di medico di base e medico scolastico. Tra i suoi molti spunti che andrebbero ripresi e discussi a fondo, ne sottolineiamo in particolare due, sui quali già ci siamo espressi e su cui non sarà mai inutile ritornare: 1) lo smantellamento pressoché completo delle attività strutturate di medicina preventiva e di medicina del territorio va considerato un vero e proprio crimine sociale compiuto dalla classe dominante, in combutta tra la sua componente economica e quella politica – complici il sistema universitario e il baraccone massmediatico che l’hanno messa in pratica e difesa; 2) un’inversione di tendenza è possibile soltanto se i lavoratori e le lavoratrici riprenderanno con determinazione nelle proprie mani la difesa della propria salute ispirandosi alle importanti tradizioni di lotta del passato – tradizioni che invitiamo i più giovani a studiare, perché c’è tanto da imparare.
Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo testo del compagno Visconte Grisi, che nasce anche dalla sua lunga esperienza di medico di base e medico scolastico. Tra i suoi molti spunti che andrebbero ripresi e discussi a fondo, ne sottolineiamo in particolare due, sui quali già ci siamo espressi e su cui non sarà mai inutile ritornare: 1) lo smantellamento pressoché completo delle attività strutturate di medicina preventiva e di medicina del territorio va considerato un vero e proprio crimine sociale compiuto dalla classe dominante, in combutta tra la sua componente economica e quella politica – complici il sistema universitario e il baraccone massmediatico che l’hanno messa in pratica e difesa; 2) un’inversione di tendenza è possibile soltanto se i lavoratori e le lavoratrici riprenderanno con determinazione nelle proprie mani la difesa della propria salute ispirandosi alle importanti tradizioni di lotta del passato – tradizioni che invitiamo i più giovani a studiare, perché c’è tanto da imparare.
* * * *
La diffusione della pandemia di Covid-19 ha messo in luce, nel nostro come in altri paesi, le carenze disastrose di una medicina pubblica sottoposta da decenni a tagli nei finanziamenti e a processi sempre più accelerati di privatizzazione.
In questo intervento vogliamo mettere però in evidenza i danni clamorosi provocati dallo smantellamento, ormai quasi completo, operato nei confronti della medicina del territorio.
- Details
- Hits: 2356
La crisi del populismo di sinistra e il socialismo possibile
di Carlo Formenti
Pubblichiamo una sintesi dell’ultimo paragrafo del capitolo conclusivo de “Il capitale vede rosso” di Carlo Formenti, un pamphlet appena uscito per i tipi di Meltemi. Nel volume l’autore chiarisce il proprio pensiero sui temi del populismo e della sovranità nazionale, propone il concetto di “socialismo possibile” allo scopo di ridefinire un’idea di socialismo del secolo XXI emancipata dai dogmatismi della tradizione marxista e ragiona sulla possibilità di rivitalizzare il progetto socialista nei Paesi occidentali e sul blocco sociale su cui lo si potrebbe fondare
 Prendo le mosse da una considerazione: le sinistre populiste occidentali, pur avendo contribuito a riesumare la parola socialismo che il crollo del Muro e quarant’anni di controrivoluzione liberista avevano rimosso dal lessico della politica, avanzano proposte simili alle politiche socialdemocratiche del trentennio glorioso. Nel secolare dibattito su riforme e rivoluzione costoro sembrano dunque collocarsi nel campo riformista. È pur vero che il dibattito interno alla socialdemocrazia tedesca di fine 800/primo 900 su riforme e rivoluzione – oggi ripreso in ambito latinoamericano in relazione alle esperienze bolivariane – ha stemperato questa opposizione assoluta: sia Engels che Luxemburg avevano ribadito che la vera differenza è fra coloro che considerano le riforme come un fine in sé e chi le concepisce come uno strumento per preparare la rivoluzione. Resta il fatto che parliamo di programmi politici che, almeno a un primo esame, appaiono compatibili sia con il modo di produzione capitalista che con i suoi assetti istituzionali. Ma è davvero così?
Prendo le mosse da una considerazione: le sinistre populiste occidentali, pur avendo contribuito a riesumare la parola socialismo che il crollo del Muro e quarant’anni di controrivoluzione liberista avevano rimosso dal lessico della politica, avanzano proposte simili alle politiche socialdemocratiche del trentennio glorioso. Nel secolare dibattito su riforme e rivoluzione costoro sembrano dunque collocarsi nel campo riformista. È pur vero che il dibattito interno alla socialdemocrazia tedesca di fine 800/primo 900 su riforme e rivoluzione – oggi ripreso in ambito latinoamericano in relazione alle esperienze bolivariane – ha stemperato questa opposizione assoluta: sia Engels che Luxemburg avevano ribadito che la vera differenza è fra coloro che considerano le riforme come un fine in sé e chi le concepisce come uno strumento per preparare la rivoluzione. Resta il fatto che parliamo di programmi politici che, almeno a un primo esame, appaiono compatibili sia con il modo di produzione capitalista che con i suoi assetti istituzionali. Ma è davvero così?
La verità è che, mentre il modo di produzione fordista poteva permettersi il compromesso keynesiano fra capitale e lavoro, il capitalismo contemporaneo non intende in alcun modo rinunciare ai frutti delle vittorie ottenute dagli anni Ottanta a oggi.
- Details
- Hits: 1426
Riflessioni pandemiche
di Nico Maccentelli
 Trovo le polemiche interne alla sinistra di classe sul lockdown del tutto fuorvianti. Le accuse reciproche di negazionismo da una parte e dall’altra di sudditanza ai dettami imposti dal regime in materia di salute pubblica non colgono la questione essenziale che è un passaggio epocale, direi antropologico e non solo economico di crisi del capitalismo.
Trovo le polemiche interne alla sinistra di classe sul lockdown del tutto fuorvianti. Le accuse reciproche di negazionismo da una parte e dall’altra di sudditanza ai dettami imposti dal regime in materia di salute pubblica non colgono la questione essenziale che è un passaggio epocale, direi antropologico e non solo economico di crisi del capitalismo.
Un passaggio nel quale la democrazia borghese, ma più profondamente le relazioni sociali, sta subendo un mutamento non certo temporaneo e in cui si evidenzia l’incapacità del capitalismo (ma direi anche la volontà delle classi dirigenti) di affrontare la pandemia e la crisi del capitale che si accresce in questo frangente. Un sistema che cade definitivamente nella barbarie darwiniana del più forte che sopprime i più deboli, che fa la guerra, che si impone con una violenza organizzata di cui la democrazia è ormai solo un vuoto involucro.
Che siamo al crepuscolo di questo modo di produzione e di consumo lo dicono tanti segnali e di certo non occorreva la pandemia per confermarlo. Ma noi comunisti siamo sempre stati della cassandre inascoltate…
Vediamo allora di mettere alcuni punti fermi, in modo sintetico.
1. Ho scritto poc’anzi dell’incapacità del capitalismo di far fronte a questa ecatombe e aggiungo la sola volontà demenziale e direi suicida di riproporre la legge del più forte al netto di tutta la demagogia spicciola tra balconi, bandierine e Mattarella.
Laddove occorrerebbe una spinta rivoluzionaria della politica nel non farsi tirare la giacchetta da chicchessia e nel non guadare in faccia a nessuno, la classe politica sceglie ancora una volta l’egemonia delle oligarchie economiche.
- Details
- Hits: 1674
200 anni di Engels: per una nuova lettura della “Dialettica della natura”
di Gabriele Schimmenti
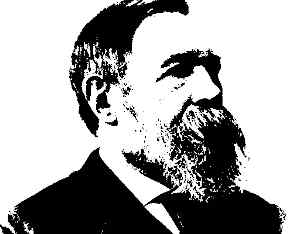 Nell’anno del bicentenario di Engels, vale ancora la pena di tornare a discutere del Generale e di tenere a mente come la sua attività teorica, nelle ultime fasi della sua produzione, si fosse concentrata sul progetto incompleto di una “Dialettica della natura”. Il libro di Kaan Kangal, “Friedrich Engels and the Dialectics of Nature” (Palgrave Macmillan 2020), affronta le intenzioni, i fini, le procedure, le tesi e la storia degli effetti dell’“opera” in questione, invitandoci a ritornare ad Engels senza cadere vittima delle stratificate maldicenze sul suo conto. Solo in questo modo, da una nuova lettura di Engels, sarà possibile osservare i meriti e i limiti del progetto di una “Dialettica della natura”, del suo discorso e delle sue intenzioni.
Nell’anno del bicentenario di Engels, vale ancora la pena di tornare a discutere del Generale e di tenere a mente come la sua attività teorica, nelle ultime fasi della sua produzione, si fosse concentrata sul progetto incompleto di una “Dialettica della natura”. Il libro di Kaan Kangal, “Friedrich Engels and the Dialectics of Nature” (Palgrave Macmillan 2020), affronta le intenzioni, i fini, le procedure, le tesi e la storia degli effetti dell’“opera” in questione, invitandoci a ritornare ad Engels senza cadere vittima delle stratificate maldicenze sul suo conto. Solo in questo modo, da una nuova lettura di Engels, sarà possibile osservare i meriti e i limiti del progetto di una “Dialettica della natura”, del suo discorso e delle sue intenzioni.
Nei manoscritti de L’ideologia tedesca, Marx ed Engels scrissero che
conosciamo una sola scienza, quella della storia. La storia può essere considerata sotto due aspetti, ed essere suddivisa in storia della natura e storia degli uomini. Tuttavia, questi aspetti sono inseparabili: finché esistono uomini, la storia della natura e la storia degli uomini si condizionano reciprocamente.[1]
Sebbene la ricerca più recente ci mostri come entrambi i sodali fossero versati nella storia naturale (come mostrato ad esempio di recente, relativamente a Marx, dai lavori John Bellamy Forster o di Kohei Saito), è stato Engels che ha dedicato la maggior parte della sua ad un progetto in cui la natura assumeva un ruolo centrale, ovvero la cosiddetta Dialettica della natura.
Page 210 of 612