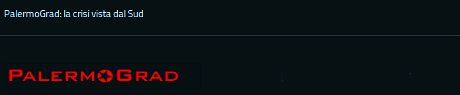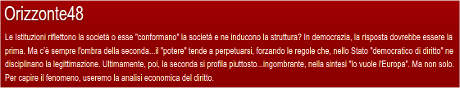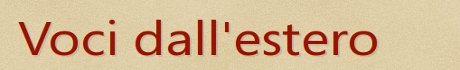Fai una donazione
Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________
- Details
- Hits: 3733
Uscire dall’economia. Prove di dialogo fra Decrescita e Critica del Valore
di Massimo Maggini
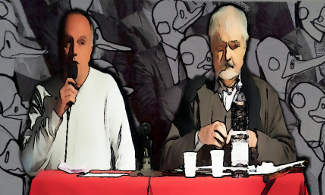 Nel novembre 2014 è uscito per le edizioni Mimesis il libro Uscire dall’economia – un dialogo fra decrescita e critica del valore: letture della crisi e percorsi di liberazione, tratto da un incontro avvenuto in Francia nel 2011 fra Serge Latouche e Anselm Jappe.
Nel novembre 2014 è uscito per le edizioni Mimesis il libro Uscire dall’economia – un dialogo fra decrescita e critica del valore: letture della crisi e percorsi di liberazione, tratto da un incontro avvenuto in Francia nel 2011 fra Serge Latouche e Anselm Jappe.
Il libro ha avuto un buon successo, tanto da meritarsi anche un’edizione francese ampliata, uscita nel 2015 per le edizioni Libre & Solidaire, dal titolo Pour en finir avec l’économie – Décroissance et critique de la valeur.
Qui presentiamo l’introduzione all’edizione italiana, introduzione che ha avuto uno strano destino: elaborata seguendo anche le indicazioni degli autori, non ha incontrato i favori di Anselm Jappe per quanto riguarda l’edizione francese. Non essendoci né i tempi né le basi per modificarla senza aprire un lungo dibattito, l’introduzione che trovate qui sotto è apparsa, tradotta, praticamente in versione integrale, solo grazie ad un “sotterfugio” di Serge Latouche, che ha proposto di pubblicarla facendola anticipare da una avvertenza dove si dice che l’autore si prende interamente la responsabilità di quello che è scritto.
- Details
- Hits: 2260
Borghesia mafiosa e postfordista
Note sull'ultimo libro di Vincenzo Scalia
di Marco Palazzotto
Pubblichiamo la recensione di Marco Palazzotto del libro di Vincenzo Scalia che sarà presentato a Palermo il prossimo 12 aprile ai Cantieri Culturali della Zisa. Qui maggiori informazioni
 Sono passati quasi 30 anni dalla pubblicazione del famoso articolo I professionisti dell’antimafia di Leonardo Sciascia sul Corriere della Sera del 10 gennaio 1987. Al netto delle polemiche scaturite intorno alla figura di Paolo Borsellino, la tesi di fondo dell’articolo era quella che in Sicilia il modo migliore per fare carriera era dichiararsi antimafioso.
Sono passati quasi 30 anni dalla pubblicazione del famoso articolo I professionisti dell’antimafia di Leonardo Sciascia sul Corriere della Sera del 10 gennaio 1987. Al netto delle polemiche scaturite intorno alla figura di Paolo Borsellino, la tesi di fondo dell’articolo era quella che in Sicilia il modo migliore per fare carriera era dichiararsi antimafioso.
Oggi potremmo parlare di Imprenditori morali, come li chiama Vincenzo Scalia, sociologo e criminologo palermitano prestato all’università britannica, autore della raccolta di saggi: “Le filiere Mafiose – Criminalità organizzata, rapporti di produzione, antimafia” edito da Ediesse e in distribuzione da pochi giorni.
Riprendendo la teorizzazione di Howard Becker che sosteneva che un fenomeno sociale viene classificato come crimine nella misura in cui suscita l’attenzione e la reazione della società, Vincenzo Scalia afferma che “gli imprenditori morali rappresentano una figura-ponte, nella misura in cui orientano l’attenzione dell’opinione pubblica, definiscono il fenomeno, elaborano le strategie di intervento, tracciano i principi che devono guidare l’intervento sul fenomeno sociale oggetto dell’attenzione”. Uno dei pregi del testo Le filiere mafiose è quello di evidenziare la profonda diversità dell’autore rispetto al panorama dei professionisti dell’antimafia e degli imprenditori morali che imperversano sui nostri giornali e le nostre tribune politiche da più di 30 anni.
- Details
- Hits: 2726
Michel Foucault: scrittura di sé e sperimentazione
di Daniele Lorenzini
In quella Svezia in cui dovevo parlare un linguaggio che mi era straniero, ho compreso che potevo abitare il mio linguaggio – con la sua fisionomia d’improvviso peculiare – come il luogo più segreto e più sicuro della mia residenza in quel luogo senza luogo che rappresenta il paese straniero nel quale ci si trova. […] Credo che sia stato questo a farmi venire voglia di scrivere. Dal momento che la possibilità di parlare mi era negata, ho scoperto il piacere di scrivere. Michel Foucault, Entretien avec Claude Bonnefoy, 1968[1]
Cinquant’anni fa Michel Foucault pubblicava Le parole e le cose
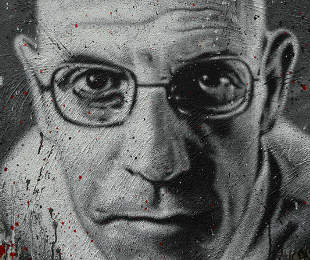 In che modo Michel Foucault ha concepito e praticato l’articolazione tra ciò che ha chiamato “soggettivazione” (il processo di costituzione della soggettività) e la scrittura, anche dal punto di vista personale – ovvero in relazione alla propria pratica di scrittura e alla costituzione della propria soggettività? È a questa domanda che mi propongo di rispondere, senza pretendere di fornire una risposta univoca o definitiva, ma cercando di mettere in luce la tensione che appare, in particolare nei testi degli ultimi anni di vita di Foucault, tra due grandi “modelli” del rapporto soggettivazione-scrittura: da una parte, il modello della scrittura come pratica di de-soggettivazione, come strumento utilizzato per “svincolarsi” (se déprendre) da se stessi e dalla propria “forma-soggetto”; d’altra parte, il modello della scrittura come esercizio spirituale la cui funzione è “ethopoietica”, cioè come strumento di costruzione “positiva” di sé – di soggettivazione, dunque, piuttosto che di de-soggettivazione.
In che modo Michel Foucault ha concepito e praticato l’articolazione tra ciò che ha chiamato “soggettivazione” (il processo di costituzione della soggettività) e la scrittura, anche dal punto di vista personale – ovvero in relazione alla propria pratica di scrittura e alla costituzione della propria soggettività? È a questa domanda che mi propongo di rispondere, senza pretendere di fornire una risposta univoca o definitiva, ma cercando di mettere in luce la tensione che appare, in particolare nei testi degli ultimi anni di vita di Foucault, tra due grandi “modelli” del rapporto soggettivazione-scrittura: da una parte, il modello della scrittura come pratica di de-soggettivazione, come strumento utilizzato per “svincolarsi” (se déprendre) da se stessi e dalla propria “forma-soggetto”; d’altra parte, il modello della scrittura come esercizio spirituale la cui funzione è “ethopoietica”, cioè come strumento di costruzione “positiva” di sé – di soggettivazione, dunque, piuttosto che di de-soggettivazione.
La scrittura come esperienza di de-soggettivazione
Per descrivere il primo modello, farò riferimento a una serie di testi e di interviste dal tono fortemente “autobiografico”, nei quali Foucault parla del proprio modo di fare ricerca in ambito storico-filosofico e del proprio rapporto con la scrittura.
- Details
- Hits: 2724
Così l’austerità ha distrutto l’Europa
Thomas Fazi
Diversi studi hanno concluso che lo stato comatoso dell’economia europea – con tutte le sue ricadute sociali – è una conseguenza diretta delle politiche di austerità
 Il fallimento delle politiche implementate in Europa dal 2010 in poi – un connubio di austerità fiscale, riforme strutturali (di impronta marcatamente neoliberista) e politiche monetarie espansive – è ormai sotto gli occhi di tutti. Oggi, a inizio 2016 – otto anni dopo lo scoppio della crisi finanziaria – il PIL reale dell’eurozona è ancora inferiore al picco pre-crisi (marzo 2008). Quello della Spagna è inferiore del 4,5 per cento. Quello del Portogallo del 6,5 per cento. Anche quei paesi che registrano tassi di crescita superiori alla media europea non se la cavano molto bene: il PIL reale della Germania, per esempio, è aumentato solo del 5,5 per cento rispetto al livello del 2008; quello della Francia del 2,7 per cento. Gli Stati Uniti, dal canto loro, hanno registrato un incremento superiore al 10 per cento.
Il fallimento delle politiche implementate in Europa dal 2010 in poi – un connubio di austerità fiscale, riforme strutturali (di impronta marcatamente neoliberista) e politiche monetarie espansive – è ormai sotto gli occhi di tutti. Oggi, a inizio 2016 – otto anni dopo lo scoppio della crisi finanziaria – il PIL reale dell’eurozona è ancora inferiore al picco pre-crisi (marzo 2008). Quello della Spagna è inferiore del 4,5 per cento. Quello del Portogallo del 6,5 per cento. Anche quei paesi che registrano tassi di crescita superiori alla media europea non se la cavano molto bene: il PIL reale della Germania, per esempio, è aumentato solo del 5,5 per cento rispetto al livello del 2008; quello della Francia del 2,7 per cento. Gli Stati Uniti, dal canto loro, hanno registrato un incremento superiore al 10 per cento.
L’eurozona nel complesso registra un tasso di crescita annuale stagnante – inferiore al 2 per cento – dall’inizio del 2012; oggi si aggira intorno all’1,6 per cento. Nel 2017 è prevista una lievissima accelerazione. Nello stesso periodo (2012-16), molti paesi – tra cui la Grecia, l’Italia ed il Portogallo – hanno registrato tassi di crescita vicini o inferiori a zero. Le politiche “non convenzionali” della BCE – quantitative easing, tassi di interesse negativi, ecc. –, per motivi ampiamente trattati su queste pagine, non hanno favorito la ripresa, né lo faranno in futuro.
- Details
- Hits: 2387
Logica del limite
Per una etica della complessità
Pierluigi Fagan
 Vi ricordate l’apeiron? Iniziando le prime pagine di una qualsiasi storia della filosofia occidentale, dopo Talete e semmai qualche accenno alla sapienza arcaica, vi trovate Anassimandro. Di costui c’è arrivato un solo, piccolo, frammento che dice che l’inizio di tutte le cose è l’apeiron. Fiumi di parole sono state scritte su questo concetto e prima ancora sulla sua traducibilità ma in sostanza, sembrerebbe che la questione sia abbastanza semplice. Se la cosa è ciò di cui possiamo dire, vedere, toccare, pensare i contorni, cioè i limiti, prima della cosa c’è l’apeiron, ciò di cui non si può dire, vedere, toccare, pensare i limiti. Prima di partire per la tangenziale dell’infinito però, dovremmo sostare un attimo sul punto stretto. L’apeiron è un concetto negativo in relazione alla cosa, è la non-cosa, quello da cui proviene la cosa, lo cosa è un ritaglio di qualcosa di precedente più grande. Dire, fare, toccare, pensare la cosa significa dargli i limiti. Prima c’è l’apeiron, dopo c’è la cosa, la cosa introduce il concetto di limite. Su questo pensiero potremmo indugiare a lungo perdendoci in una nuvola di rimandi del prima (Esiodo, il Rg Veda) e del dopo (su fino ad Heidegger) ma andremo oltre perché a noi, qui, non interessa l’apeiron ma il concetto di limite. Diremo solo che, in sostanza, Anassimandro fonda una branca del pensiero filosofico, quella che poi Aristotele sistematizzatore del pensiero greco, chiamerà filosofia prima e noi oggi -ontologia-, discorso (logos) su ciò che è (ontos), discorso sulla cosa.
Vi ricordate l’apeiron? Iniziando le prime pagine di una qualsiasi storia della filosofia occidentale, dopo Talete e semmai qualche accenno alla sapienza arcaica, vi trovate Anassimandro. Di costui c’è arrivato un solo, piccolo, frammento che dice che l’inizio di tutte le cose è l’apeiron. Fiumi di parole sono state scritte su questo concetto e prima ancora sulla sua traducibilità ma in sostanza, sembrerebbe che la questione sia abbastanza semplice. Se la cosa è ciò di cui possiamo dire, vedere, toccare, pensare i contorni, cioè i limiti, prima della cosa c’è l’apeiron, ciò di cui non si può dire, vedere, toccare, pensare i limiti. Prima di partire per la tangenziale dell’infinito però, dovremmo sostare un attimo sul punto stretto. L’apeiron è un concetto negativo in relazione alla cosa, è la non-cosa, quello da cui proviene la cosa, lo cosa è un ritaglio di qualcosa di precedente più grande. Dire, fare, toccare, pensare la cosa significa dargli i limiti. Prima c’è l’apeiron, dopo c’è la cosa, la cosa introduce il concetto di limite. Su questo pensiero potremmo indugiare a lungo perdendoci in una nuvola di rimandi del prima (Esiodo, il Rg Veda) e del dopo (su fino ad Heidegger) ma andremo oltre perché a noi, qui, non interessa l’apeiron ma il concetto di limite. Diremo solo che, in sostanza, Anassimandro fonda una branca del pensiero filosofico, quella che poi Aristotele sistematizzatore del pensiero greco, chiamerà filosofia prima e noi oggi -ontologia-, discorso (logos) su ciò che è (ontos), discorso sulla cosa.
- Details
- Hits: 4580
Contraddizione, crisi sistemica e direzione per il cambiamento
Intervista a Wang Hui
 Wang Hui è uno dei più importanti intellettuali critici della Cina. Una figura di spicco della ” nuova sinistra cinese”. Il suo lavoro ha cercato di tracciare le condizioni intellettuali e politiche della Cina contemporanea. Contro la ristrutturazione neoliberale della Cina, e dei suoi propagandisti ufficiali, il lavoro di Wang ha continuato a impegnarsi per un progetto di ala sinistra il cui scopo è stato fare un bilancio della storia e delle conseguenze della modernità cinese.
Wang Hui è uno dei più importanti intellettuali critici della Cina. Una figura di spicco della ” nuova sinistra cinese”. Il suo lavoro ha cercato di tracciare le condizioni intellettuali e politiche della Cina contemporanea. Contro la ristrutturazione neoliberale della Cina, e dei suoi propagandisti ufficiali, il lavoro di Wang ha continuato a impegnarsi per un progetto di ala sinistra il cui scopo è stato fare un bilancio della storia e delle conseguenze della modernità cinese.
In questa intervista con la rivista “Foreign Theoretical Trends”, pubblicata originariamente in cinese e inclusa come appendice nel saggio “China ‘s Twentieth Century”, di recente pubblicazione, Wang disserta sulle linee di sviluppo in Cina e in tutto il Sud del mondo, sul patrimonio intellettuale e politico del maoismo, e sulle speranze di un nuovo movimento anti – capitalistica a livello globale.
* * *
Foreign Theoretical Trends (di seguito, “Tendenze”): L’attuale dura crisi del capitalismo globale costituisce un punto di svolta storico per la Cina e il mondo. Quali cambiamenti pensa che ciò porterà nell’ordine internazionale? Per quanto riguarda le opzioni della Cina nel nuovo ordine mondiale, alcuni pensano che, poiché la scala della produzione manifatturiera cinese continua a crescere, proseguendo su questa strada la Cina potrà entrare nel club degli stati capitalisti sviluppati.
- Details
- Hits: 3335
Una sottile lotta di tutti contro tutti*
Camilla Panichi intervista Francesco Pecoraro
 Quando ho terminato La vita in tempo di pace (Ponte alle Grazie, 2013) di Francesco Pecoraro, ho avuto la netta impressione di essere di fronte a un romanzo italiano senza precedenti. Ho deciso di intervistare l’autore. Ci siamo incontrati alcuni mesi fa a Roma in un giorno di diluvio universale che ricordava quello raccontato nel romanzo; ne è nata una conversazione di tre ore, da cui ho selezionato le seguenti parti. Francesco Pecoraro è autore anche di una raccolta di racconti, Dove credi di andare(Mondadori 2007); le prose inizialmente pubblicate sul suo blog con lo pseudonimo di Tashtego sono state raccolte nel volume Questa e altre preistorie (Le Lettere, 2008). Con La vita in tempo di pace Pecoraro ha vinto il premio Mondello, il Premio Volponi e il Premio Viareggio (cp). C = Camilla Panichi, P = Francesco Pecoraro.
Quando ho terminato La vita in tempo di pace (Ponte alle Grazie, 2013) di Francesco Pecoraro, ho avuto la netta impressione di essere di fronte a un romanzo italiano senza precedenti. Ho deciso di intervistare l’autore. Ci siamo incontrati alcuni mesi fa a Roma in un giorno di diluvio universale che ricordava quello raccontato nel romanzo; ne è nata una conversazione di tre ore, da cui ho selezionato le seguenti parti. Francesco Pecoraro è autore anche di una raccolta di racconti, Dove credi di andare(Mondadori 2007); le prose inizialmente pubblicate sul suo blog con lo pseudonimo di Tashtego sono state raccolte nel volume Questa e altre preistorie (Le Lettere, 2008). Con La vita in tempo di pace Pecoraro ha vinto il premio Mondello, il Premio Volponi e il Premio Viareggio (cp). C = Camilla Panichi, P = Francesco Pecoraro.
* * *
C: La tua formazione è di architetto. Come sei arrivato alla scrittura e quanto è stata determinante l’esperienza di scrittura sul blog? (link: http://tash-tego.blogspot.it/)
P: Ho iniziato a scrivere negli anni Ottanta, essenzialmente versi. Da un certo momento in poi, all’inizio degli anni Novanta ho cominciato a produrre prosa. Assieme a molto materiale sparso, scrissi un piccolo libro, mai pubblicato, di riflessioni sull’Isola, di cui alcuni spunti mi sono poi serviti per i capitoli Sofrano e Il senso del mare della Vita in tempo di pace.
- Details
- Hits: 2374
Toh, il "mercato" impone la decisione politica in €uropa (quindi in Italia)
di Quarantotto
 1. Oggi più che mai, di fronte allo "stravagante" stupore mostrato dai media mainstream circa l'influenza del settore privato sulle decisioni politico-economiche, (cioè di livello legislativo), adottate dal settore pubblico, conviene rammentare l'analisi compiuta da Galbraith e riportata in un recente post.
1. Oggi più che mai, di fronte allo "stravagante" stupore mostrato dai media mainstream circa l'influenza del settore privato sulle decisioni politico-economiche, (cioè di livello legislativo), adottate dal settore pubblico, conviene rammentare l'analisi compiuta da Galbraith e riportata in un recente post.
Ve ne faccio una sintesi per linee essenziali che renda conto della istituzionalizzazione di tale influenza, al di là della questione del complesso militare-industriale (particolarmente influente negli USA per ben note ragioni strategiche internazionali):
"Che il settore privato stia conquistando un ruolo predominante rispetto al settore pubblico è evidente. Meglio sarebbe discuterne in modo comprensibile.
Per la verità, parlare del mito della contrapposizione di pubblico e privato non è molto originale dal momento che la prima assai autorevole testimonianza in questo senso risale niente meno che al presidente Dwight D. Eisenhower, con le sue denunce dello strapotere del complesso militare-industriale.
...
- Details
- Hits: 3174
Meno lavoro o più lavoro nell’età microelettronica?
Un problema annoso ancora irrisolto
di Giovanni Mazzetti
Quaderno Nr. 1/2016 a cura del Centro Studi e Iniziative per la riduzione del tempo individuale di lavoro e per la redistribuzione del lavoro sociale complessivo. Con questo saggio inizia l’attività di formazione on-line da parte del Centro Studi. Si prevede la pubblicazione a cadenza almeno mensile di documenti che in qualche modo inquadrino in modo semplice il problema della necessità di redistribuire il lavoro
 Il presente saggio, di marzo 2016, Meno lavoro o più lavoro nell’età microelettronica?, riprende un tema che è stato recentemente approfondito dal libro di Riccardo Staglianò Al posto tuo (Einaudi 2016), nel quale è stata fornita una forte conferma della tesi a suo tempo enunciata nelle ricerche del Centro. In un serrato confronto con le tesi di Adam Schaff e di Paola Manacorda, si cerca di rispondere al quesito posto dal titolo, dimostrando che la società incontrerà crescenti difficoltà a riprodurre il rapporto di lavoro salariato. Le vicende degli ultimi trent’anni dimostrano la fondatezza di questa ipotesi, ulteriormente suffragata della moltitudine di esempi contenuti nel lavoro dello Staglianò.
Il presente saggio, di marzo 2016, Meno lavoro o più lavoro nell’età microelettronica?, riprende un tema che è stato recentemente approfondito dal libro di Riccardo Staglianò Al posto tuo (Einaudi 2016), nel quale è stata fornita una forte conferma della tesi a suo tempo enunciata nelle ricerche del Centro. In un serrato confronto con le tesi di Adam Schaff e di Paola Manacorda, si cerca di rispondere al quesito posto dal titolo, dimostrando che la società incontrerà crescenti difficoltà a riprodurre il rapporto di lavoro salariato. Le vicende degli ultimi trent’anni dimostrano la fondatezza di questa ipotesi, ulteriormente suffragata della moltitudine di esempi contenuti nel lavoro dello Staglianò.
Una varietà di teorie, una contraddizione o un malinteso?
Possono due studiosi che fanno riferimento ad un medesimo sistema teorico, giungere a conclusioni addirittura opposte nell'analisi delle conseguenze di lungo periodo del diffondersi della microelettronica? In altre parole, è giusto che esistano molte e diverse teorie dell'età microelettronica o è possibile e necessario giungere ad un'unica teoria, pur con le inevitabili differenze di accento su questo o quell'aspetto del problema, su questa o quella mediazione? E cioè, il giungere a conclusioni analitiche opposte, pur battendo la stessa via, non è forse il segno di una contraddizione nella rappresentazione teorica che le sostiene?
- Details
- Hits: 2851
Il passaggio dialettico a un’opera aperta
Sandro Mezzadra
Assente da decenni dagli scaffali, torna nelle librerie il libro del filosofo Helmut Reichelt «La struttura logica del concetto di capitale» (manifestolibri). Un saggio ritenuto ormai un classico che ha aperto la strada a una «nuova lettura» di Karl Marx
 Tra le diverse forme che assunse negli anni Sessanta del Novecento, e in particolare attorno al 1968, il «ritorno a Marx» in Europa, ve ne sono almeno due che hanno continuato a esercitare una grande influenza nei dibattiti critici internazionali: la rilettura del Capitale promossa da Louis Althusser e l’operaismo italiano. Meno nota, quantomeno in Italia, è un’altra linea interpretativa, che si è venuta formando nella Repubblica Federale Tedesca – dall’interno della Scuola di Francoforte ma anche in polemica con i suoi esiti – e che ha finito per consolidare una specifica variante del «marxismo occidentale».
Tra le diverse forme che assunse negli anni Sessanta del Novecento, e in particolare attorno al 1968, il «ritorno a Marx» in Europa, ve ne sono almeno due che hanno continuato a esercitare una grande influenza nei dibattiti critici internazionali: la rilettura del Capitale promossa da Louis Althusser e l’operaismo italiano. Meno nota, quantomeno in Italia, è un’altra linea interpretativa, che si è venuta formando nella Repubblica Federale Tedesca – dall’interno della Scuola di Francoforte ma anche in polemica con i suoi esiti – e che ha finito per consolidare una specifica variante del «marxismo occidentale».
I lavori di Alfred Schmidt, Hans-Georg Backhaus, Helmut Reichelt, che sono all’origine di questa linea interpretativa, sono stati almeno in parte tempestivamente tradotti in Italia, e hanno contribuito ad alimentare la discussione (accademica e non) su Marx negli anni Settanta. Ma nella temperie del decennio successivo, quando la restaurazione imperante nel nostro Paese ha nei fatti bandito Marx e il marxismo dalle Università e dai cataloghi delle grandi case editrici, di questi autori si sono un po’ perse le tracce. E non ha ricevuto particolare attenzione il progressivo emergere, a cui ha dato un contributo fondamentale il lavoro di Michael Heinrich (la sua introduzione ai tre libri del Capitale è stata tradotta nel 2012 in inglese, per la Monthly Review Press), di quella che oggi viene definita Neue Marx-Lektüre, «nuova lettura di Marx». Tanto in Germania quanto nel mondo anglofono (e in particolare negli Stati Uniti) questa particolare interpretazione di Marx è al contrario al centro di vivaci dibattiti, con esiti che possono talvolta apparire sorprendenti.
- Details
- Hits: 3330

Il riassetto capitalistico del governo Renzi
di Pasquale Cicalese
 Forse era meglio il fiscalista di Sondrio, almeno non ci si trastullava con la concezione nuova di “sinistra”. Ma di certo questo governo, a livello economico, somiglia molto all’ultima versione di Berlusconi. Vediamo perché. Il mentore della politica economica dell’imprenditore di Arcore è stato Giulio Tremonti. Socialista, liberista prima e poi nostalgico dell’intervento pubblico dell’economia. Costui, dopo la crisi mondiale del 2007, attua una svolta. Cerca di tessere una rete di capitalismo di stato con l’apporto di fondi sovrani, in primis cinesi. La sua strategia si basava sulla mobilitazione del risparmio per farlo passare dalla finanza speculativa all’economia reale. Strumenti di questa strategia, volta agli investimenti e ad una nuova industrializzazione, erano le grandi imprese semi privatizzate di Stato, fondi sovrani esteri, la Cassa Depositi e Prestiti e il risparmio degli italiani. Qualcosa del genere sembra attuare Renzi, con una differenza. Quest’ultimo dà più spazio alle poche multinazionali private italiane e al quarto capitalismo delle medie imprese internazionalizzate e opera a tutto campo. Inoltre, Tremonti aveva come target specifico, anche a livello valoriale, le micro e piccole imprese del nord, Renzi predilige le medie grandi aziende.
Forse era meglio il fiscalista di Sondrio, almeno non ci si trastullava con la concezione nuova di “sinistra”. Ma di certo questo governo, a livello economico, somiglia molto all’ultima versione di Berlusconi. Vediamo perché. Il mentore della politica economica dell’imprenditore di Arcore è stato Giulio Tremonti. Socialista, liberista prima e poi nostalgico dell’intervento pubblico dell’economia. Costui, dopo la crisi mondiale del 2007, attua una svolta. Cerca di tessere una rete di capitalismo di stato con l’apporto di fondi sovrani, in primis cinesi. La sua strategia si basava sulla mobilitazione del risparmio per farlo passare dalla finanza speculativa all’economia reale. Strumenti di questa strategia, volta agli investimenti e ad una nuova industrializzazione, erano le grandi imprese semi privatizzate di Stato, fondi sovrani esteri, la Cassa Depositi e Prestiti e il risparmio degli italiani. Qualcosa del genere sembra attuare Renzi, con una differenza. Quest’ultimo dà più spazio alle poche multinazionali private italiane e al quarto capitalismo delle medie imprese internazionalizzate e opera a tutto campo. Inoltre, Tremonti aveva come target specifico, anche a livello valoriale, le micro e piccole imprese del nord, Renzi predilige le medie grandi aziende.
Come si esplicita questa strategia? Si è iniziato con l’Enel, a cui è stata affidata la realizzazione della digitalizzazione del Paese, un investimento di circa 2,5 miliardi che verrà conseguito con altri operatori privati. Poi c’è la privatizzazione di Ferrovie dello Stato, ancora non attuata per divergenze se la rete ferroviaria debba rimanere pubblica o privatizzata anch’essa.
- Details
- Hits: 2295
Handelsblatt: l’irreale “real estate” tedesco
di Simon Book, Jens Munchrath e Reiner Rachel
L’ambiente di tassi d’interesse negativi e la mancanza di investimenti profittevoli sta spingendo investitori e banche dei paesi core, e della Germania in particolare, in una gigantesca bolla immobiliare. I prezzi delle case raddoppiano di anno in anno, gli acquirenti comprano immobili alla cieca senza nemmeno metterci piede e le banche fanno prestiti a tasso quasi nullo senza verificare la solvibilità dei mutuatari, in quella che sembra la riedizione mitteleuropea della bolla dei subprime. L’unico modo per fermare la corsa dei prezzi è alzare i tassi di interesse, ma la BCE nel tentativo di “salvare il soldato euro” sta caparbiamente andando in direzione opposta. Che la nemesi dell’euro stia arrivando sotto forma di bolla immobiliare? Da Handelsblatt
 Jaguar, Maserati e Mercedes pulitissime costeggiano l’acciottolato, riflettendo il sole. Uomini e donne benestanti attraversano il marciapiede in cappotti e cappelli pregiati, con cani di razza al seguito.
Jaguar, Maserati e Mercedes pulitissime costeggiano l’acciottolato, riflettendo il sole. Uomini e donne benestanti attraversano il marciapiede in cappotti e cappelli pregiati, con cani di razza al seguito.
Dietro di loro, ci sono irresistibili ville storiche – stucchi classici con grandi ingressi, nicchie e pavimenti di parquet brillanti, torrette maestose e giardini panoramici.
Benvenuti nell’idilliaca Potsdam, l’opulenta ex residenza dei re di Prussia. Al confine sud-occidentale di Berlino, Potsdam è la capitale dello stato orientale del Brandeburgo ed una città molto calda nel surriscaldato boom immobiliare della Germania.
Da un maestoso maniero in riva al lago sulla pittoresca Heiliger See, Anja Farke gestisce l’agenzia di Potsdam del mediatore immobiliare Engel & Völkers. Proprio lungo la strada, la signora Farke sta facendo vedere un’altra spaziosa villa, in una bella tonalità di rosa. La venderà per non meno di 3 milioni di euro, o 3,3 milioni di dollari, assicura.
La signora Farke è abituata a lavorare con successo con i milionari. E’ elegante e cortese, informalmente chic, consapevole di sé ma riservata.
- Details
- Hits: 2712
Prime donne, capi e capetti
Il Pd tra referendum e amministrative
di Giorgio Salerno
 Questo mese appena trascorso è stato contrassegnato da un’infinità di fatti politici, alcuni gravi e drammatici come l’assassinio del giovane Regeni e l’attentato all’aeroporto ed alla metropolitana di Bruxelles, altri quasi comici come le primarie del PD e le polemiche che ne sono seguite grazie anche alla ‘performance’ di due prime donne come Ignazio Marino a Roma ed Antonio Bassolino a Napoli.
Questo mese appena trascorso è stato contrassegnato da un’infinità di fatti politici, alcuni gravi e drammatici come l’assassinio del giovane Regeni e l’attentato all’aeroporto ed alla metropolitana di Bruxelles, altri quasi comici come le primarie del PD e le polemiche che ne sono seguite grazie anche alla ‘performance’ di due prime donne come Ignazio Marino a Roma ed Antonio Bassolino a Napoli.
Per non parlare della donna per antonomasia del PD, la soave Maria Elena Boschi che, dopo aver difeso appassionatamente il papà per lo scandalo della Banca Etruria, “Mio padre è una brava persona”, ora se lo trova indagato per bancarotta fraudolenta. Se la cosa non fosse seria verrebbe da ridere di gusto.
Un mese segnato anche dalla “bomba” dell’intervista di D’Alema al Corriere della Sera dell’11 marzo, da un quadro economico preoccupante con un debito pubblico in crescita ed i prezzi in discesa con una deflazione che non si arresta, con il referendum sulle “trivelle” accompagnato da ulteriori polemiche entro il PD dopo la decisione di Renzi di non schierare il Partito a favore del Si, nonchè la condanna di Verdini a due anni per le vicende della Scuola dei Marescialli a Firenze.
- Details
- Hits: 3144
I primi cedimenti del feticismo delle merci
di Daniele Vazquez
 Nel 1970 Fredy Perlman, nel numero 6 della rivista “Telos” rivalutava le teorie dello storico ed economista sovietico Isaak Rubin per cui tutta l’opera di Marx non sarebbe “una serie sconnessa di episodi, ciascuno con un problema che sarà abbandonato poi in seguito”1. Dai Manoscritti del 1844 fino al Capitale, dal giovane Marx idealista al Marx maturo e realista, vi sarebbe una fondamentale continuità. Marx ha cambiato e affinato concetti, modificato terminologia, ma non ha mai abbandonato la direzione dei suoi studi e il suo stile, inseguendo un capovolgimento, un quid pro quo che per Rubin è “La teoria del feticismo della merce […] la base dell’intero sistema economico di Marx, e in particolare della sua teoria del valore”2. Perlman cita diverse volte un passaggio dei Manoscritti: “L’alienazione dell’operaio nel suo prodotto significa non solo che il suo lavoro diventa un oggetto, qualcosa che esiste all’esterno, ma esso esiste fuori di lui, indipendente da lui, a lui estraneo, e diventa di fronte a lui una potenza per se stante; significa che la vita che egli ha dato all’oggetto, gli si contrappone ostile ed estranea”3.
Nel 1970 Fredy Perlman, nel numero 6 della rivista “Telos” rivalutava le teorie dello storico ed economista sovietico Isaak Rubin per cui tutta l’opera di Marx non sarebbe “una serie sconnessa di episodi, ciascuno con un problema che sarà abbandonato poi in seguito”1. Dai Manoscritti del 1844 fino al Capitale, dal giovane Marx idealista al Marx maturo e realista, vi sarebbe una fondamentale continuità. Marx ha cambiato e affinato concetti, modificato terminologia, ma non ha mai abbandonato la direzione dei suoi studi e il suo stile, inseguendo un capovolgimento, un quid pro quo che per Rubin è “La teoria del feticismo della merce […] la base dell’intero sistema economico di Marx, e in particolare della sua teoria del valore”2. Perlman cita diverse volte un passaggio dei Manoscritti: “L’alienazione dell’operaio nel suo prodotto significa non solo che il suo lavoro diventa un oggetto, qualcosa che esiste all’esterno, ma esso esiste fuori di lui, indipendente da lui, a lui estraneo, e diventa di fronte a lui una potenza per se stante; significa che la vita che egli ha dato all’oggetto, gli si contrappone ostile ed estranea”3.
Nei Grundrisse troviamo lo stesso modo di incedere del discorso nel capitolo sul processo di circolazione del capitale a proposito del lavoro oggettivato che si presenta come mezzo di sussistenza del lavoratore: “Tutti i momenti che si contrapponevano alla forza-lavoro viva come forze estranee, estrinseche, e che, sotto certe condizioni da essa stessa indipendenti, la consumavano, la utilizzavano, sono ora poste come prodotto della stessa forza-lavoro viva“4 , anche se “il prodotto del lavoro, il lavoro oggettivato a cui proprio il lavoro vivo ha dato una propria anima, si fissi poi di fronte ad esso stesso come un potere altrui”5.
- Details
- Hits: 3151
La scienza economica dominante come religione pubblica
di Nicolò Bellanca
Plasmando i nostri modelli mentali e le nostre azioni, l’odierna teoria economica dominante si rivela in grado di convertirci, operando come una religione pubblica. Senza tenere in adeguato conto questa sua capacità si capisce poco dell’affermazione planetaria del neoliberismo. Una riflessione a partire dagli ultimi libri di Mauro Gallegati
 In quest’articolo non esaminerò tutte le argomentazioni degli ultimi due libri di Mauro Gallegati. Mi concentrerò su una sua tesi particolarmente incisiva e provocatoria: «nonostante esteriormente assomigli alla fisica, e nonostante il presunto equipaggiamento di molte leggi, l’economia non è una scienza»,[1] e anzi «assomiglia a una religione».[2]
In quest’articolo non esaminerò tutte le argomentazioni degli ultimi due libri di Mauro Gallegati. Mi concentrerò su una sua tesi particolarmente incisiva e provocatoria: «nonostante esteriormente assomigli alla fisica, e nonostante il presunto equipaggiamento di molte leggi, l’economia non è una scienza»,[1] e anzi «assomiglia a una religione».[2]
L’odierna teoria economica mainstream è caratterizzata, in linea generale, dalle seguenti assunzioni di base: agente rappresentativo (i consumatori o le imprese sono tutti identici, e quindi basta studiare l’agente-tipo), perfetta razionalità degli agenti (chiamata talvolta “olimpica”, poiché esprime requisiti che soltanto un dio potrebbe possedere), aspettative razionali (gli agenti usano le informazioni in modo efficiente, formulando quindi le previsioni più corrette) e scelte fondate sulla massimizzazione di una funzione obiettivo (l’agente individua e seleziona l’alternativa migliore tra quelle disponibili).[3]
La macroeconomia è quella parte della disciplina che (tra l’altro) dovrebbe spiegare le crisi, e quindi oggi la Grande recessione.
I macroeconomisti mainstream sostengono che la loro teoria dev’essere una versione aggregata della teoria dell’equilibrio generale, stabilendo uno sconcertante apriori metodologico per il quale l’equilibrio è il canone per studiare tutto quello che nega l’equilibrio: sentieri dinamici, processi innovativi, instabilità e crisi.
- Details
- Hits: 3111
Guerra terrorismo e diritti umani. La nascita dello Stato islamico
di Ferdinando Imposimato
 Negli ultimi decenni un governo mondiale invisibile, ma reale e concreto, muove le fila dei governi nazionali, dei centri di potere economico e militare, e, con media subalterni, alimenta il terrorismo. E lo fa per giustificare nuove guerre per un nuovo ordine planetario contro Stati detentori di risorse energetiche, per stravolgere le costituzioni e giustificare interventi militari di grandi potenze in aree strategiche del pianeta. Emblematica è stata la guerra all’Iraq del 2003 di Usa, Gran Bretagna e Francia: non fu guerra contro il terrorismo di Saddam Hussein, ma di conquista. Non fu effetto dell’11 settembre 2001 in quanto fu decisa prima dell’attacco alle torri gemelle. Ed è stata proprio quella guerra la causa della crisi e del dilagare del terrorismo nel mondo1.
Negli ultimi decenni un governo mondiale invisibile, ma reale e concreto, muove le fila dei governi nazionali, dei centri di potere economico e militare, e, con media subalterni, alimenta il terrorismo. E lo fa per giustificare nuove guerre per un nuovo ordine planetario contro Stati detentori di risorse energetiche, per stravolgere le costituzioni e giustificare interventi militari di grandi potenze in aree strategiche del pianeta. Emblematica è stata la guerra all’Iraq del 2003 di Usa, Gran Bretagna e Francia: non fu guerra contro il terrorismo di Saddam Hussein, ma di conquista. Non fu effetto dell’11 settembre 2001 in quanto fu decisa prima dell’attacco alle torri gemelle. Ed è stata proprio quella guerra la causa della crisi e del dilagare del terrorismo nel mondo1.
L’attacco all’Iraq per una lotta al terrorismo fu smentito dopo decenni sia dall’ex presidente George Bush sia da Tony Blair, che hanno ammesso «l’errore». Il 2 dicembre 2008, Bush, in un’intervista alla rete tv ABC, ammise l’errore della guerra all’Iraq, «viziata da informazioni di servizi di intelligence infondate» sulla presenza di armi di distruzione di massa in Iraq.
Oggi sappiamo con certezza che sono stati ammazzati in Iraq più di un milione di civili, è stato bruciato più di un trilione di dollari e la crisi economica che sconvolge il mondo intero è la tragica conseguenza di una guerra ingiusta spacciata per lotta al terrorismo. In Iraq non c’erano armi di distruzione di massa.
- Details
- Hits: 3274
Politiche espansive e crescita debole. Siamo in una stagnazione secolare?
di Vittorio Daniele
 1. Una lunga convalescenza
1. Una lunga convalescenza
Da qualche anno, le Banche centrali delle principali economie mondiali (Stati Uniti, Eurozona e Giappone) stanno attuando politiche fortemente espansive. La base monetaria, sotto forma di liquidità o di riserve detenute dalle banche commerciali, è aumentata enormemente: negli Stati Uniti, all’inizio del 2016, era quattro volte quella del 2008. La BCE ha adottato una serie di misure espansive, finanziando a basso costo il sistema bancario e attuando un programma di acquisto di attività (quantitative easing) di 80 miliardi di euro mensili per una durata prevista di due anni.
Si tratta di un’iniezione di liquidità senza precedenti, che ha fatto scendere i tassi d’interesse a breve e a lungo termine a valori prossimi allo zero (e, in alcuni casi, negativi, come in Giappone o in Europa). Ciò avrebbe dovuto stimolare gli investimenti e, dunque, i consumi e il reddito. I risultati sono, però, largamente inferiori alle attese. Nell’Eurozona, i dati sul Pil e sull’inflazione mostrano, infatti, come la ripresa sia molto debole. Anche negli Stati Uniti, dove la crescita è più elevata di quella europea, il Pil rimane al di sotto del potenziale (Fig. 1).
- Details
- Hits: 3941
Katechon/Interregno
Dario Gentili
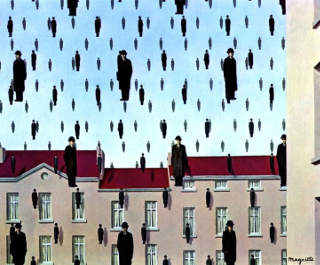 1. Quello della crisi dello Stato-nazione è, ormai da tempo, un motivo ricorrente. Il suo refrain è diventato insistente soprattutto dopo il 1989, ma come un rumore di fondo ha attraversato tutto il Novecento. Ha animato tanto il discorso delle grande ideologie internazionaliste quanto quello della globalizzazione economica, del libero mercato su scala planetaria. Oggi è proprio quest’ultimo discorso a ripetere con più vigore il motivo della crisi dello Stato (salvo poi ricordarsi dello Stato quando, come in seguito alla crisi del 2008, si è trattato di pagare i debiti delle banche e degli istituti di credito). Ne è la controprova che, in alcuni casi, un certo pensiero anti-capitalista e anti-liberista ha addirittura attribuito allo Stato un ruolo di resistenza, un argine allo strapotere economico – e pertanto la piccola Grecia, proprio in quanto Stato, è diventata la scorsa estate la portatrice di un ritorno della politica. In realtà, credo che sia l’auspicato ritorno dello Stato sia il suo de profundis siano entrambi espressione di una questione politica – o più schiettamente geopolitica – che va ben al di là delle sorti dello Stato. Si tratta nondimeno della configurazione che la politica deve assumere nell’epoca del dominio della ragione neoliberale.
1. Quello della crisi dello Stato-nazione è, ormai da tempo, un motivo ricorrente. Il suo refrain è diventato insistente soprattutto dopo il 1989, ma come un rumore di fondo ha attraversato tutto il Novecento. Ha animato tanto il discorso delle grande ideologie internazionaliste quanto quello della globalizzazione economica, del libero mercato su scala planetaria. Oggi è proprio quest’ultimo discorso a ripetere con più vigore il motivo della crisi dello Stato (salvo poi ricordarsi dello Stato quando, come in seguito alla crisi del 2008, si è trattato di pagare i debiti delle banche e degli istituti di credito). Ne è la controprova che, in alcuni casi, un certo pensiero anti-capitalista e anti-liberista ha addirittura attribuito allo Stato un ruolo di resistenza, un argine allo strapotere economico – e pertanto la piccola Grecia, proprio in quanto Stato, è diventata la scorsa estate la portatrice di un ritorno della politica. In realtà, credo che sia l’auspicato ritorno dello Stato sia il suo de profundis siano entrambi espressione di una questione politica – o più schiettamente geopolitica – che va ben al di là delle sorti dello Stato. Si tratta nondimeno della configurazione che la politica deve assumere nell’epoca del dominio della ragione neoliberale.
Posta in questi termini – nei termini appunto del dominio di una razionalità di matrice economica che ha assunto prerogative politiche di governo –, la questione di una alternativa “politica” al neoliberalismo è affrontata dal pensiero filosofico e politico o sul piano del potere o su quello del governo.
- Details
- Hits: 2403
Rivoluzione colorata a ritmo di samba
by Federico Dezzani
 È torbido il clima in Brasile, teatro in questi mesi di una violenta campagna politico-giudiziaria per spodestare Dilma Rousseff, riconfermata alla presidenza nemmeno due anni fa: il termine “golpe” è entrato ormai nel vocabolario comune della politica. L’operazione è un ibrido tra la nostrana Tangentopoli, dove il gigante petrolifero Petrobas ricopre il ruolo dell’Enimont ed il giudice federale Sergio Moro quello del pm Antonio Di Pietro, e la più recente Euromaidan, dove le Chiese evangeliche hanno assunto la direzione delle proteste di piazza. La posta in gioco per le oligarchie atlantiche è alta: ristabilire, dopo Argentina e Venezuela, la propria egemonia in Brasile, sabotare la Nuova Banca di Sviluppo ideata dai Paese emergenti e “liberare” il Banco Central do Brasil dalla supervisione della politica, per assoggettarlo al controllo alla finanza internazionale.
È torbido il clima in Brasile, teatro in questi mesi di una violenta campagna politico-giudiziaria per spodestare Dilma Rousseff, riconfermata alla presidenza nemmeno due anni fa: il termine “golpe” è entrato ormai nel vocabolario comune della politica. L’operazione è un ibrido tra la nostrana Tangentopoli, dove il gigante petrolifero Petrobas ricopre il ruolo dell’Enimont ed il giudice federale Sergio Moro quello del pm Antonio Di Pietro, e la più recente Euromaidan, dove le Chiese evangeliche hanno assunto la direzione delle proteste di piazza. La posta in gioco per le oligarchie atlantiche è alta: ristabilire, dopo Argentina e Venezuela, la propria egemonia in Brasile, sabotare la Nuova Banca di Sviluppo ideata dai Paese emergenti e “liberare” il Banco Central do Brasil dalla supervisione della politica, per assoggettarlo al controllo alla finanza internazionale.
* * *
Un gigante fuori controllo
Gli anni ’10 del XXI secolo presentano analogie sempre maggiori con quegli ’70 del secolo precedente: la profonda crisi economica, sociale e politica dell’impero angloamericano (vedi l’addio unilaterale degli USA al sistema di Bretton Woods nel 1971), accompagnata ora come allora da sconfitte militari strategiche (ieri il Vietnam, oggi l’Afghanistan e la fallita balcanizzazione di Siria ed Iraq) è accompagnata dal fiorire del terrorismo, dal moltiplicarsi dei colpi di Stato e da un solco sempre più profondo tra la “retorica democratica” e la concretezza quotidiana, connotata dell’esplosione della violenza politica in tutte le sue forme (omicidi mirati, ghettizzazione degli avversari, eliminazioni per via giudiziaria degli oppositori, etc. etc.).
- Details
- Hits: 2058
M€rcati, pubblico/privato e l'esercito europeo
Unica assente, la realtà
di Quarantotto
 1. Proviamo a tornare sul tema dell' "esercito €uropeo"...che garantisce la democrazia.
1. Proviamo a tornare sul tema dell' "esercito €uropeo"...che garantisce la democrazia.
Il problema sostanziale al riguardo non è politico-militare o storico-etno-culturale: porre l'attenzione su tali aspetti, che ostacolerebbero l'operatività futura di un tale "€sercito", equivale tutto sommato a soffermarsi su un problema consequenziale e applicativo che, nello scenario effettivo in cui si svolgono le politiche dell'UE, non è considerato, dagli effettivi "decidenti", così rilevante.
Il problema, o meglio l'essenza di queste politiche ha, invece, più a che fare con le implicazioni e le decisive influenze, tornate in queste ultime ore particolarmente attuali, determinate dall'ideologia, propria dei trattati UE, della assoluta prevalenza dei mercati, e quindi della prevalenza di alcune persone fisiche, che siano esponenti dei gruppi industriali e finanziari, sulle istituzioni (ormai teoricamente) democratiche.
Che questo sia il nodo della questione, che è dunque quello di una politica della "difesa" orientato a favorire i "mercati", più che le effettive e praticabili esigenze operative di protezione dei cittadini assoggettati a tali politiche sovranazionali TINA, ce lo aveva ben illustrato la serie dei 4 post "Fortezza Europa" di Riccardo Seremedi.
- Details
- Hits: 4549
L’Ungheria e l’oblio di Lukàcs
Ferdinando Gueli intervista Janos Kelemen
Un rapporto da sempre tormentato quello tra il grande pensatore marxista ed il suo Paese natale, tanto che pochi giorni fa le autorità accademiche ungheresi hanno annunciato la revoca dei finanziamenti all’archivio Lukàcs di Budapest, che rischia pertanto la chiusura. Ne parliamo con Janos Kelemen, professore emerito di filosofia e linguistica dell’Università di Budapest, nonché direttore dell’Accademia d’Ungheria a Roma dal 1990 al 1995, e conoscitore del pensiero di Lukàcs
 Quello tra Gyorgy Lukàcs ed il suo paese natale, l’Ungheria, è sempre stato un rapporto tormentato, per lui vale sicuramente l’antico detto latino nemo propheta in patria. Dalla rivoluzione bolscevica del 1919 guidata da Bela Kun e che lo vide giovane protagonista, all’esilio in Unione Sovietica negli anni tra le due guerre, durante il regime autoritario dell’Ammiraglio Horthy, dal periodo stalinista di Ràkosi al governo Nagy e alla rivoluzione del 1956, e infine negli anni successivi fino alla sua morte, avvenuta nel 1971. Ma anche dopo la morte di Lukàcs le classi dirigenti ungheresi, politiche ed accademiche, non hanno mai visto di buon occhio questo intellettuale che, invece, a livello internazionale, è riconosciuto come uno dei più grandi e brillanti filosofi marxisti del XX secolo. Nell’ultimo ventennio, dopo la caduta del socialismo reale ed il ritorno dell’Ungheria nel sistema capitalistico, si è assistito ad una vera e propria opera di rimozione sistematica della presenza e del lascito culturale di Lukàcs, potremmo definirla “operazione oblio”.
Quello tra Gyorgy Lukàcs ed il suo paese natale, l’Ungheria, è sempre stato un rapporto tormentato, per lui vale sicuramente l’antico detto latino nemo propheta in patria. Dalla rivoluzione bolscevica del 1919 guidata da Bela Kun e che lo vide giovane protagonista, all’esilio in Unione Sovietica negli anni tra le due guerre, durante il regime autoritario dell’Ammiraglio Horthy, dal periodo stalinista di Ràkosi al governo Nagy e alla rivoluzione del 1956, e infine negli anni successivi fino alla sua morte, avvenuta nel 1971. Ma anche dopo la morte di Lukàcs le classi dirigenti ungheresi, politiche ed accademiche, non hanno mai visto di buon occhio questo intellettuale che, invece, a livello internazionale, è riconosciuto come uno dei più grandi e brillanti filosofi marxisti del XX secolo. Nell’ultimo ventennio, dopo la caduta del socialismo reale ed il ritorno dell’Ungheria nel sistema capitalistico, si è assistito ad una vera e propria opera di rimozione sistematica della presenza e del lascito culturale di Lukàcs, potremmo definirla “operazione oblio”.
L’ultimo recente episodio è particolarmente significativo: si è avuta notizia che l’Accademia Ungherese delle Scienze sta revocando, per addotti motivi di bilancio, il finanziamento dell’archivio Lukàcs, l’unica piccola struttura rimasta, quasi ai margini, che raccoglie documentazione di fondamentale interesse scientifico per lo studio del pensiero lukacsiano, e che rischia così la definitiva chiusura.
Abbiamo intervistato, nella sua Budapest, a poche centinaia di metri dall’archivio Lukàcs, Janos Kelemen, filosofo e linguista, professore emerito dell’Università di Budapest, già direttore dell’Accademia d’Ungheria a Roma dal 1990 al 1995, nonché studioso del pensiero di Lukàcs, per comprendere cosa stia accadendo in questo momento in Ungheria e cosa rimanga del passaggio di Lukàcs nella memoria culturale del popolo magiaro.
* * *
DOMANDA: Janos, o meglio Jimmy, come ti fai chiamare da compagni e amici, in questi giorni si e' avuta la notizia della possibile chiusura dell'archivio Lukàcs a Budapest. Cosa sta succedendo e qual'e' l'importanza scientifica di questo archivio?
RISPOSTA: Circolavano già da anni notizie sulla possibile soppressione dell’Archivio Lukacs.
- Details
- Hits: 2101
Che altro può fare Mario?
Biagio Bossone e Stefano Sylos Labini
Pubblichiamo un post di Biagio Bossone e Stefano Sylos Labini. Biagio Bossone presiede il Group of Lecce on global governance ed è membro del Comitato di sorveglianza del Centre d’Études pour le Financement du Développement Local. Stefano Sylos Labini, ricercatore ENEA, geologo, esperto di energia, dal 2004 al 2014 ha collaborato con Giorgio Ruffolo, con il quale (2012-2014) è stato editorialista di Repubblica su temi di economia e politica. Dal 2014 ha iniziato a lavorare sul Progetto della Moneta Fiscale
 Costi quel che costi…
Costi quel che costi…
Fermo sul suo ormai arcinoto pronunciamento di esser disposto a fare qualunque cosa (whatever it takes) pur di riuscire a ravvivare le economie della zona euro, il presidente della BCE Mario Draghi dal 10 marzo scorso ha impegnato il suo istituto ad acquistare obbligazioni emesse da società non bancarie localizzate nella zona euro nell’ambito del programma di acquisto di obbligazioni aziendali (CSPP) (1). In aggiunta agli interventi non convenzionali già in atto, la nuova misura dovrebbe fornire un’ulteriore opzione di politica monetaria espansiva nel tentativo di rafforzare le condizioni di finanziamento dell’economia reale e di riportare l’inflazione dell’area in linea con l’obiettivo ufficiale del 2%.
La novità assoluta del CSPP è quella di attivare un nuovo canale di trasmissione della politica monetaria attraverso cui il denaro appena stampato affluirebbe direttamente all’economia reale piuttosto che essere risucchiato da un sistema bancario inceppato. Il CSPP promette quindi di conseguire un maggiore impatto rispetto alle altre misure tentate dalla BCE finora. Non c’è dubbio che il coraggio e la determinazione del Presidente della BCE meritino riconoscimento.
Eppure, prima di scommettere sull’efficacia del CSPP, occorre dare risposta ad alcuni interrogativi importanti che esso pone, dal quadro applicativo indefinito alla questione fondamentale se la politica monetaria sia sufficiente da sola a trascinare l’Eurozona fuori dalla stagnazione secolare, senza che la BCE debba assumere su di sé responsabilità di natura quasi fiscale, come, ad esempio, quella di mettere denaro direttamente nelle tasche della gente (2).
- Details
- Hits: 2587
Caro Yanis, ti scrivo...
Lettera aperta a Varoufakis dopo il lancio di DiEM 25
di George Souvlis e Samuele Mazzolini
 "Democratizzazione o Barbarie” è l’alternativa posta in questo incisivo intervento, che appare in inglese su LeftEast. George Souvlis studia per il PhD in Storia presso l’Istituto Universitario Europeo di Firenze e scrive per varie testate di sinistra (Jacobin, ROAR, Enthemata Avgis); Samuele Mazzolini (MA in Latin American Studies ad Oxford) ha lavorato come consulente per il governo dell’Ecuador, scrive tuttora per il quotidiano di quel paese El Telégrafo e studia Ideology and Discourse Analysis presso la University of Essex.
"Democratizzazione o Barbarie” è l’alternativa posta in questo incisivo intervento, che appare in inglese su LeftEast. George Souvlis studia per il PhD in Storia presso l’Istituto Universitario Europeo di Firenze e scrive per varie testate di sinistra (Jacobin, ROAR, Enthemata Avgis); Samuele Mazzolini (MA in Latin American Studies ad Oxford) ha lavorato come consulente per il governo dell’Ecuador, scrive tuttora per il quotidiano di quel paese El Telégrafo e studia Ideology and Discourse Analysis presso la University of Essex.
* * *
Caro Yanis,
abbiamo deciso di scriverti dopo aver seguito attentamente il lancio di DiEM 25 a Roma, il 23 marzo. Questa nostra lettera si propone di discutere una serie di aspetti della tua iniziativa che abbiamo trovato poco convincenti, facendone una critica costruttiva. Chiariamo subito perciò che il nostro obiettivo non è né di bocciare a priori il progetto né di fare i saputelli che sanno meglio di chiunque altro com’è che vanno fatte le cose (atteggiamento non del tutto sconosciuto all'universo della sinistra). Desideriamo piuttosto formulare pubblicamente alcune domande che - sospettiamo – sono già venute in mente a molti e intorno alle quali si è già discusso in modo informale: domande che possano fungere da scintille per una correzione in meglio dell'iniziativa in oggetto.
- Details
- Hits: 6295
La partita del referendum
di Annalisa Corrado
«La vittoria del SÌ al referendum del 17 aprile potrebbe dare una spallata ad un castello di bugie e mostrare che la strada verso la democrazia energetica, verso una promozione sostenibile dei talenti sani dei nostri territori è segnata e che non si torna più indietro», Sbilanciamoci.info, newsletter 467, 31 marzo 2016
 Pensavo fosse incompetenza o mancanza di visione. Fresca di laurea, folgorata sulla via dell’energia come “madre di tutte le battaglie” da combattere (contro le crisi internazionali, i ricatti dei potenti detentori delle risorse, contro le crisi sociale, ambientale e poi anche economica), ero ingegneristicamente innamorata dell’idea che sole, vento, biomassa, maree e calore della Terra, assieme alle intelligenti evoluzioni della tecnologia, avrebbero mostrato di lì a poco la via per costruire una nuova “democrazia energetica” e, ingenuamente, pensavo il freno fosse causato “solo” dalla manifesta incapacità strategica di un apparato politico/burocratico stanco, cinico e clientelare.
Pensavo fosse incompetenza o mancanza di visione. Fresca di laurea, folgorata sulla via dell’energia come “madre di tutte le battaglie” da combattere (contro le crisi internazionali, i ricatti dei potenti detentori delle risorse, contro le crisi sociale, ambientale e poi anche economica), ero ingegneristicamente innamorata dell’idea che sole, vento, biomassa, maree e calore della Terra, assieme alle intelligenti evoluzioni della tecnologia, avrebbero mostrato di lì a poco la via per costruire una nuova “democrazia energetica” e, ingenuamente, pensavo il freno fosse causato “solo” dalla manifesta incapacità strategica di un apparato politico/burocratico stanco, cinico e clientelare.
E invece sbagliavo di grosso. La strategia esiste. Esiste e appare dettata da un potere apartitico (evidente se si analizza l’assoluta continuità nelle scelte fossili degli ultimi 4 governi, dalla destra di Berlusconi/Romani, ai tecnici Monti/Passera, passando per la “sinistra” di Letta/Zanonato, fino al governo del partito della “nazione” di Renzi/Guidi, il più fossile di tutti) gestito attraverso schiere di azzeccagarbugli che usano la normativa contro i cittadini, contro la partecipazione, contro le migliori idee ed energie del Paese.
L’ascolto è riservato esclusivamente ai soliti noti, per i quali un varco nel ginepraio della burocrazia si riesce sempre ad aprire (le autostrade, gli inceneritori, il cemento, le trivelle dello “sbloccaItalia” ne sono la manifestazione plastica).
- Details
- Hits: 3793
La fine dell’Eternità
by Jehu
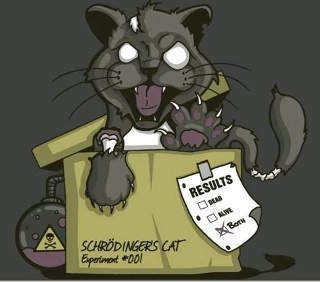 Nel suo libro, "Dall'Eternità a qui" (edizioni Adelphi), Sean M. Carroll discute sulla peculiare natura dell'universo così come viene vista secondo la prospettiva della Scuola di Copenaghen. Tale peculiare natura, può esere descritta per mezzo di quattro caratteristiche della materia, su scala quantica:
Nel suo libro, "Dall'Eternità a qui" (edizioni Adelphi), Sean M. Carroll discute sulla peculiare natura dell'universo così come viene vista secondo la prospettiva della Scuola di Copenaghen. Tale peculiare natura, può esere descritta per mezzo di quattro caratteristiche della materia, su scala quantica:
1 - La materia si comporta sia come una particella discreta che come un'onda meno discreta.
2 - La materia, ogni volta che si cerca di osservarla, vale a dire quando si interagisce con essa, cambia improvvisamente dal comportamento di onda a quello di particella
3 - Il passaggio istantaneo dal comportamento di onda a quello di particella è:
a) irriducibilmente casuale: vale a dire, possiamo prevedere il suo risultato finale, in anticipo, solo approssimativamente
b) irreversibile: vale a dire, non possiamo conoscere lo stato precedente della particella; la nostra interazione con una particella distrugge in maniera irrimediabile le informazioni relative al suo stato precedente.
4 - Nel momento in cui proviamo a misurare il processo, c'è un livello irriducibile di incertezza
Nella fisica classica, lo sviluppo di un processo può essere spiegato per mezzo di un insieme di regole basate sulle leggi fisiche di Newton; ma nel mondo naturale descritto dalla meccanica quantistica lo sviluppo di un processo appare essere governato da due insiemi di leggi fisiche del tutto differenti, che Carroll spiega così:
Page 405 of 613