A Gaza Trump tenta di porre un argine a Israele, ma il futuro è fosco
di Roberto Iannuzzi
Per contenere l’unilateralismo israeliano, la Casa Bianca dovrebbe esercitare una costante pressione sul governo Netanyahu. Ma in ogni caso il piano Trump non offre nulla ai palestinesi
 Cosa attende Gaza dopo il fragile cessate il fuoco imposto dal presidente americano Donald Trump con un vertice pomposo quanto privo di contenuti a Sharm el-Sheikh in Egitto, e con un discorso smaccatamente filo-israeliano pronunciato alla Knesset?
Cosa attende Gaza dopo il fragile cessate il fuoco imposto dal presidente americano Donald Trump con un vertice pomposo quanto privo di contenuti a Sharm el-Sheikh in Egitto, e con un discorso smaccatamente filo-israeliano pronunciato alla Knesset?
Se tutto andrà secondo i piani, “la vita per gli abitanti di Gaza passerà dall’essere un completo inferno a un semplice incubo”, hanno scritto sulle pagine del Guardian Hussein Agha e Robert Malley, entrambi per anni coinvolti nel fallimentare processo di pace israelo-palestinese.
Il piano Trump per Gaza è profondamente sbilanciato, sostengono i due esperti. Esso
“esige dai palestinesi l’espiazione per gli orribili atti del 7 ottobre, ma non da Israele per la barbarie che ne è seguita. Chiede la deradicalizzazione di Gaza, ma non la fine del messianismo israeliano. Detta in ogni aspetto il futuro del governo palestinese, senza dire nulla sul futuro dell’occupazione israeliana”.
Il piano è “pieno di ambiguità, privo di un calendario definito, di giudici o di conseguenze per le inevitabili future violazioni”, e “se la sua nebulosità non verrà sfruttata per silurarlo”, scrivono Agha e Malley, i palestinesi di Gaza passeranno “dall’essere vittime indifese a rifugiati due volte espropriati nella loro stessa terra”.
Le ragioni del cessate il fuoco
Il cessate il fuoco imposto da Trump ha fatto leva sul momento di grande difficoltà attraversato, per ragioni diverse, sia da Hamas che da Israele.
Il primo, alle prese con la drammatica situazione di una popolazione ridotta alla fame dalle restrizioni israeliane, con la devastante offensiva militare israeliana su Gaza City, e sotto l’enorme pressione dei mediatori arabi e della Turchia, ha deciso di scommettere sulle deboli garanzie offerte da Trump.
Il gruppo palestinese ha accettato di consegnare tutti gli ostaggi israeliani ancora in vita in una sola tranche, anche in assenza di un completo ritiro israeliano dalla Striscia, e senza certezze sulla ricostruzione e sulla futura gestione dell’enclave palestinese.
Dal canto suo, Israele, ormai “sull’orlo dell’abisso” dal punto di vista economico e della propria immagine internazionale – come ha riconosciuto uno dei principali think tank israeliani – ha apparentemente rinunciato (almeno per il momento) a sconfiggere Hamas sul campo, ed a realizzare il proprio progetto di pulizia etnica.
La stessa amministrazione Trump è stata per certi versi obbligata ad imporre il proprio piano al governo Netanyahu sotto le pressioni derivanti dal contesto internazionale sempre più ostile a Israele, dalla crescente insubordinazione della propria base in patria, e dai forti malumori dei propri alleati arabi dopo il bombardamento israeliano del Qatar.
L’amministrazione ha sapientemente utilizzato queste molteplici pressioni per mettere Netanyahu di fronte a una sorta di fatto compiuto durante la sua visita alla Casa Bianca a fine settembre.
Tentativo di riprendere il controllo
Il punto di svolta è stato un incontro a margine dell’Assemblea generale dell’ONU, durante il quale Trump ha esposto il suo piano di pace in 20 punti ad un gruppo di paesi arabi e musulmani che avrebbero potuto fornire il nocciolo di una forza di stabilizzazione incaricata di gestire la sicurezza a Gaza nel caso di un cessate il fuoco.
Il 29 settembre, il presidente americano ha emesso un ordine esecutivo con il quale si impegnava a difendere la sicurezza del Qatar. Sebbene il valore vincolante di un simile gesto sia dubbio, visto che gli accordi di sicurezza devono essere approvati dal Congresso, esso era essenzialmente un messaggio di dissuasione rivolto a Israele.
Trump ha poi obbligato Netanyahu, nel corso della sua visita alla Casa Bianca, a telefonare all’emiro del Qatar per leggergli un testo scritto di scuse per il raid israeliano sulla capitale Doha.
Le immagini diffuse dalla Casa Bianca, che ritraggono un Trump accigliato mentre tiene il telefono a un Netanyahu rassegnato che legge il testo sottopostogli, intendevano simboleggiare una sorta di ripresa delle redini delle vicende mediorientali da parte dell’amministrazione.
Tali immagini erano probabilmente anche un messaggio indirizzato alla base trumpiana, volto a indicare che il presidente americano aveva ripreso il controllo della politica estera degli Stati Uniti.
Ad influire sulle decisioni di Trump hanno probabilmente contribuito anche i suoi interessi privati. Dopo la sua elezione, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti avevano investito 1,5 miliardi di dollari in Affinity Partners, una società di investimento controllata dal genero di Trump, Jared Kushner.
In passato il Qatar aveva anche salvato Kushner da un fallito investimento immobiliare a Manhattan. Doha ha a sua volta giocato un ruolo chiave nello spingere Hamas ad accettare il piano Trump.
Un piano a favore di Israele
Come già in altri casi, tuttavia, le mosse del presidente americano hanno un impatto mediatico superiore alla loro reale sostanza.
Che l’azione nei confronti del leader israeliano non fosse così incisiva è confermato dal fatto che, prima di presentare il piano di pace insieme a Netanyahu, Trump gli ha permesso di emendarlo nei suoi punti più critici.
Il piano è fortemente sbilanciato a favore di Israele. Esso non pone fine all’occupazione militare israeliana né garantisce l’avvio di un processo che porti alla creazione di uno stato palestinese. Non riconosce il diritto palestinese all’autodeterminazione sancito dall’ONU.
Non tiene conto del giudizio della Corte Internazionale di Giustizia che ha definito illegale l’occupazione israeliana. Sovraimpone ai palestinesi di Gaza una tutela straniera incarnata dal “Consiglio di Pace” che dovrebbe essere guidato da Trump stesso e dall’ex premier britannico Tony Blair.
Decreta il dispiegamento nella Striscia di una “forza internazionale di stabilizzazione” che al momento non ha alcun legittimazione da parte dell’ONU (Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti stanno lavorando per procurargliene una).
Il piano in 20 punti del presidente americano è sostanzialmente un’evoluzione della “Riviera del Medio Oriente” da lui proposta a febbraio, e poi sviluppatasi dapprima nel prospetto GREAT (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation) rivelato dal Washington Post, il quale aveva come eloquente sottotitolo la frase “Da proxy iraniano demolito a prospero alleato abramitico”; ed infine perfezionatasi nella Gaza International Transitional Authority (GITA), un piano che delineava la specifica struttura istituzionale che avrebbe dovuto governare Gaza.
L’unico elemento che ufficialmente viene a cadere rispetto all’originale piano della “Riviera” è la pulizia etnica dei palestinesi, sebbene sia probabile che la pressione nei confronti di questi ultimi affinché emigrino dal loro territorio devastato rimarrà forte.
Gli obiettivi di Washington
Fin dall’incontro a margine dell’Assemblea generale dell’ONU con un manipolo di paesi arabi e musulmani, il piano Trump ha in effetti puntato ad emarginare le Nazioni Unite ed a scavalcare il diritto internazionale attraverso un progetto arbitrario che di fatto impone a Gaza un protettorato con la collaborazione di un gruppo di paesi “volenterosi”.
Tale piano rappresenta inoltre un tentativo di porre un argine al disastroso unilateralismo israeliano, rivelatosi catastrofico in termini di immagine sia per Israele che per gli Stati Uniti, e di cooptare nuovamente gli alleati regionali degli USA (Egitto, Turchia, Qatar, Emirati, Arabia Saudita) nelle vicende palestinesi.
Sopire il conflitto a Gaza servirebbe dunque a far perdere slancio all’ondata di protesta nelle piazze occidentali, a riabilitare l’immagine di Israele, ed a rilanciare l’agognata integrazione regionale fra Israele e paesi arabi (attraverso l’espansione degli accordi di Abramo) che a sua volta serve a riaffermare la traballante egemonia americana nella regione.
Come hanno osservato Joost Hiltermann e Natasha Hall dalle pagine di Foreign Affairs, nulla garantisce però che l’unilateralismo israeliano non riprenda il sopravvento nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, sia in Palestina che a livello regionale.
Per contenere tale unilateralismo in maniera duratura, la Casa Bianca dovrebbe esercitare una costante pressione sul governo Netanyahu. Che l’amministrazione Trump abbia la coesione interna e il coraggio di perseverare in una simile direzione è tutt’altro che scontato.
Trump alla Knesset
Il discorso pronunciato da Trump alla Knesset israeliana, in occasione del suo viaggio in Medio Oriente per presenziare alla firma della “Trump Declaration for Enduring Peace and Prosperity” a Sharm el-Sheikh in Egitto, lascia presagire uno scenario probabilmente diverso.
Durante il discorso, il presidente americano ha candidamente ammesso che gran parte delle sue politiche mediorientali nel corso del suo primo e secondo mandato sono state al servizio di Israele.
Rivolgendosi a Miriam Adelson, miliardaria israelo-americana che ha finanziato, insieme al defunto marito Sheldon, ciascuna delle sue campagne presidenziali con oltre 100 di milioni di dollari, Trump ha dichiarato: “Ho mantenuto la mia promessa ed ho ufficialmente riconosciuto la capitale di Israele, e ho spostato l’ambasciata americana a Gerusalemme”.
Indicando la Adelson nel pubblico, ha aggiunto: “Non è vero, Miriam?”.
Egli ha poi accennato al fatto che gli Adelson lo hanno anche spinto a riconoscere l’annessione israeliana delle alture del Golan: “Sono stati responsabili di così tante cose, incluso l’avermi fatto pensare alle alture del Golan, che è stata una delle cose più belle che siano mai accadute”.
In un’intervista rilasciata a settembre, Trump aveva affermato che “nessuno ha fatto più di me per Israele, compresi i recenti attacchi all’Iran” (riferendosi alla “guerra dei 12 giorni” che ha avuto luogo lo scorso giugno fra Israele e Iran, nel corso della quale gli USA hanno bombardato le installazioni nucleari iraniane).
Trump si è anche vantato di aver dato a Israele “le migliori armi nella storia”, aggiungendo che lo stato ebraico “le ha usate bene” a Gaza, dunque praticamente riconoscendo che le armi americane sono state impiegate per sterminare i civili della Striscia.
Egli ha anche rivelato che un obiettivo chiave del suo piano era quello di riabilitare Israele: “Siete tornati forti perché la situazione stava diventando un po’ difficile là fuori, e alla fine il mondo ha vinto”, ha detto, aggiungendo che ora “il mondo sta di nuovo amando Israele”.
Ambizioni israeliane solo rimandate
Certamente, il successo di cui parla Trump rappresenta una temporanea sconfitta – sebbene “necessaria e benedetta”, ha scritto Shira Efron della RAND Corporation, uno dei più influenti think tank statunitensi – della visione messianica del governo Netanyahu.
L’accordo raggiunto contraddice infatti ciò che tale governo ha promesso per due anni: una vittoria totale e la distruzione di Hamas.
E Trump ha tenuto a sottolineare la dimensione regionale dell’accordo, affermando che la cosa va “al di là di Gaza”, e riguarda “la pace in Medio Oriente” – un probabile riferimento al suo progetto di espandere gli Accordi di Abramo.
Hamas ha dimostrato di essere in grado di sopravvivere a una campagna genocidaria che ha praticamente raso al suolo l’intera Striscia di Gaza. Il gruppo è rimasto in piedi come forza politica e militare. La stessa rete dei tunnel è ritenuta ancora operativa.
I leader del movimento hanno smentito di essere disposti a deporre le armi. E ciò fa comprendere quanto si annunci problematica la seconda fase dell’accordo, successiva al completo rilascio degli ostaggi.
Perfino se Israele non dovesse riprendere l’operazione militare, quella che si preannuncia è una progressiva frammentazione della Striscia che obbligherà i palestinesi ad ammassarsi in aree via via più ristrette, lasciando porzioni sempre più ampie del loro territorio alle forze armate israeliane.
Potrebbe verificarsi uno scenario di tipo “libanese”, con continue violazioni del cessate il fuoco da parte israeliana pur in assenza di un’azione bellica su vasta scala, e con una mancata ricostruzione e nessun miglioramento delle condizioni di vita dei palestinesi.
Gli stessi rappresentanti dell’amministrazione Trump hanno dichiarato che la ricostruzione avverrà “solo nelle zone liberate” da Hamas.
In altre parole, gli obiettivi del governo Netanyahu appaiono al più rimandati, ma di certo non archiviati.
Nessun futuro per i palestinesi a Gaza
Attualmente, l’esercito israeliano mantiene il controllo su oltre il 50% di Gaza. Nella seconda fase, Israele dovrebbe ritirarsi ulteriormente (continuando però a controllare il 40% della Striscia) allorché la forza di stabilizzazione a guida araba farà il suo ingresso nell’enclave palestinese.
Tale forza al momento è tutta da costruire. E’ previsto che 200 soldati americani la coordineranno dall’esterno, senza entrare a Gaza. Le truppe sul terreno saranno fornite da paesi ancora da definire, sebbene siano stati fatti i nomi di Qatar, Egitto, Turchia e Indonesia.
E’ tuttavia improbabile che la forza di stabilizzazione proceda a un disarmo forzato di Hamas qualora quest’ultimo (come appare verosimile) rifiuti di deporre le armi.
Anche in un’eventuale fase finale, gli israeliani manterranno il controllo sul 15% del territorio di Gaza. Ma tale ulteriore ritiro sarà subordinato al disarmo di Hamas e alla smilitarizzazione della Striscia.
In assenza del disarmo, Israele continuerà dunque a controllare almeno il 40% dell’enclave palestinese. In questa parte di territorio rimarranno sostanzialmente solo i clan palestinesi che il governo Netanyahu ha finanziato e armato contro Hamas.
Non è da escludere che gli scontri fra Hamas e tali clan, i quali usufruiscono di rifugi sicuri in queste retrovie, proseguano. Così come è possibile che i coloni israeliani finiranno per costruire nuovi insediamenti nelle zone controllate dallo stato ebraico.
Il 60% della Striscia che, al più, rimarrà fuori dal diretto controllo di Israele sarà un territorio completamente devastato e ai limiti della sopravvivenza umana: le forze armate di Tel Aviv hanno distrutto il 90% delle abitazioni e l’80% delle terre coltivabili.
Secondo Amit Segal, analista israeliano molto vicino a Netanyahu, “la ricostruzione avverrà solo in cambio della smilitarizzazione”. Essendo improbabile la seconda, lo è anche la prima.
E’ dunque verosimile che i palestinesi di Gaza saranno costretti a sopravvivere non solo su una terra ridotta in macerie, ma dimezzata rispetto alla sua estensione iniziale. “Il messaggio che proviene sia da Washington che da Gerusalemme è chiaro”, scrive il commentatore ebreo americano Peter Beinart. “Non c’è futuro per i palestinesi a Gaza”.
Rischi di ripresa del conflitto, e allarme per la Cisgiordania
Ma non si può neanche escludere che Israele riprenda la sua campagna di sterminio. Secondo il Washington Post, i dirigenti di Hamas avevano chiesto all’amministrazione Trump una garanzia scritta che il governo Netanyahu non avrebbe ripreso la guerra. Ma quest’ultima si sarebbe rifiutata, limitandosi a fornire garanzie verbali ai mediatori di Egitto, Qatar e Turchia.
Nella fase postbellica le prospettive di Netanyahu, alla guida di un governo impopolare e con tre procedimenti giudiziari per frode e corruzione a suo carico, appaiono fosche. Perfino se il cessate il fuoco dovesse reggere per qualche mese, con l’avvicinarsi delle elezioni del 2026 il premier israeliano potrebbe considerare preferibile riprendere il conflitto.
Del resto, lo stesso Trump ha affermato che il disarmo di Hamas avverrà anche con mezzi violenti se quest’ultimo rifiuterà di deporre volontariamente le armi.
In ultimo, va sottolineato che la Cisgiordania non figura affatto nel piano Trump. L’estrema destra del governo Netanyahu, costretta a ingoiare un boccone amaro con l’attuale cessate il fuoco a Gaza, sarà determinata a rifarsi su quella che definisce “Giudea e Samaria”.
Sebbene ufficialmente “in sospeso”, l’annessione della Cisgiordania è un processo in atto da tempo sul terreno. Lo scorso anno, il governo Netanyahu ha espropriato più terra palestinese in Cisgiordania di quanto aveva fatto qualsiasi altro governo israeliano dal 1967.
Con un’amministrazione Trump che rimane schiacciata su posizioni di sproporzionato sostegno a Israele, e in assenza di qualsiasi altra forza in grado di contenere le azioni israeliane, le prospettive per i palestinesi restano catastrofiche.


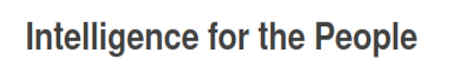




































Add comment