Il liberismo è una fantasia
di Riccardo Bellofiore
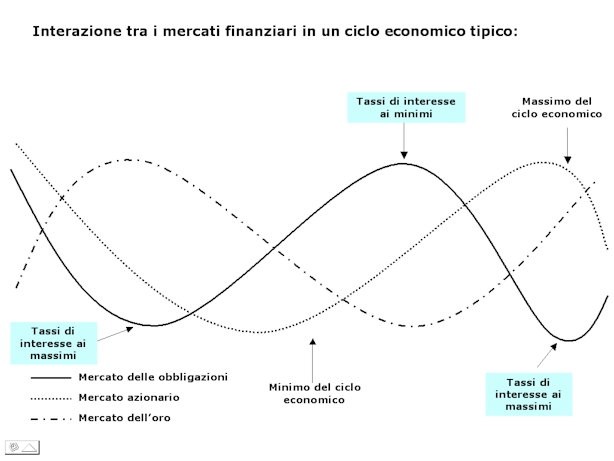 Dopo il fallimento di tutte le strategie messe in campo nell'ultimo decennio, oggi la sinistra, in specie in quella "comunista", ha bisogno di andare a fondo nell'analisi. Cosa non scontata né semplice, perché significa rimettere in discussione letture del capitalismo contemporaneo e dei rapporti di classe politicamente inefficaci, oltre che rozze e ripetitive in molti casi. E rimettersi in discussione fa paura, come evidenzia lo stato desolante della discussione politica dentro e fuori Rifondazione Comunista dopo le elezioni, in cui ci si divide sull'inessenziale e non si affrontano i nodi di fondo.
Dopo il fallimento di tutte le strategie messe in campo nell'ultimo decennio, oggi la sinistra, in specie in quella "comunista", ha bisogno di andare a fondo nell'analisi. Cosa non scontata né semplice, perché significa rimettere in discussione letture del capitalismo contemporaneo e dei rapporti di classe politicamente inefficaci, oltre che rozze e ripetitive in molti casi. E rimettersi in discussione fa paura, come evidenzia lo stato desolante della discussione politica dentro e fuori Rifondazione Comunista dopo le elezioni, in cui ci si divide sull'inessenziale e non si affrontano i nodi di fondo.
In un recente articolo (Liberazione, 29 ottobre 2008) Luigi Cavallaro utilizzando la visione del capitalismo di Hyman P. Minsky - un autore, scrive, "il cui nome si ode nuovamente in questi giorni" - ci mette in guardia da chi riduce la crisi recente a conseguenza di una euforia irrazionale e non della "furia liberalizzatrice" degli ultimi due decenni. Le citazioni di Minsky ormai sono una valanga. Dal marzo 2007 si è tornato a parlare dell'approssimarsi di un "momento Minsky", e poi del rischio di un "collasso Minsky" del capitalismo. Questo sorprendente interesse alla riflessione dell'economista statunitense è venuta da subito da opinionisti tanto neoliberisti quanto social-liberisti, e non solo da circoli eterodossi.
Per Minsky, il capitalismo tende a far degenerare la stabilità in instabilità. Quando la prosperità va avanti da un po', le posizioni degli operatori da "coperte" (con entrate di cassa nette attese che eccedono le uscite di cassa contrattuali sul debito) si fanno più coraggiose, e divengono "speculative" (almeno in alcuni periodi i "profitti" sperati sono inferiori ai pagamenti per interesse e per restituzione del capitale, e ci si deve rifinanziare).
Al rischio "economico" si affianca così il rischio "finanziario", che può concretizzarsi all'aumento dei tassi di interesse (ad esempio perché la Banca centrale vuol combattere l'inflazione) o alla riduzione dei prezzi delle attività. Quando il boom degenera in bolla e l'euforia diviene irrazionale, si intrattengono posizioni "ultraspeculative" o Ponzi: ci si indebita nella speranza di guadagni "eccezionali" (aumento del corso delle azioni, rivalutazioni degli immobili, ecc.) che soli possono giustificare l'investimento. Quando la crisi scoppia, l'alternativa è secca: o deflazione da debiti e una Grande Crisi come nel 1929-1933 o intervento della Banca centrale come prestatore di ultima istanza, affiancato da un intervento di spesa in disavanzo che sostiene i profitti monetari.Il punto è che la brillante "ipotesi di instabilità finanziaria" di Minsky, che sembra calarsi perfettamente nella nostra realtà, ha bisogno di una sua attualizzazione. Altrimenti, anche nella forma in cui ce la ricorda Cavallaro, rischierebbe di restare muta rispetto ad alcuni degli aspetti più rilevanti del capitalismo che abbiamo di fronte. Finiremmo così con il non comprendere né le origini della crisi né la sua natura. Sul merito ho scritto molto, con Joseph Halevi e da solo (in lingua italiana su Alternative per il socialismo n. 2, settembre 2007, il manifesto 23 settembre 2007 e 5 ottobre 2008, e Liberazione 30 marzo 2008). E spero che Luigi Cavallaro accetti questa mia "incursione" nella sua analisi per provare ad approfondirne alcuni elementi fondamentali.
Nel ragionamento di Minsky le variabili chiave sono la domanda di investimenti privati in capitale fisso e il suo finanziamento da parte di banche e intermediari finanziari. Qui iniziano i problemi per la tesi minskyana (esposta nel libro John Maynard Keynes del 1975 e nella raccolta Potrebbe ripetersi? del 1982, i due testi che Cavallaro ci ricorda) secondo cui la "leva finanziaria" sarebbe inesorabilmente crescente nel percorso che conduce alla instabilità finanziaria e poi allo scoppio della "bolla". Mi limiterò a rilevare che, ammesso che dal punto di vista della singola impresa l'investimento richieda un indebitamento crescente, si deve però tenere conto che, visto che l'investimento dà luogo a profitti corrispondenti, non è affatto detto che a livello di sistema l'indebitamento si impenni davvero. E' questo un punto che discende dall'insegnamento di Kalecki, autore che lo stesso Minsky include nelle sue riflessioni nel corso degli anni '70, quando il suo schema di ragionamento è ormai definito. Detto altrimenti: l'ipotesi dell'instabilità finanziaria pare reggere bene microeconomicamente, ma questo non garantisce il suo verificarsi al livello macroeconomico, perché "il tutto è più della somma delle parti". Possiamo uscirne rilevando che, pur senza il carattere della necessità, l'esplosione del debito a breve rispetto ai fondi propri su cui insisteva l'economista americano si è comunque verificato nel periodo che ci interessa. E' inoltre indubitabile che, dalla svolta "monetarista" del 1979-82 in poi, le crisi finanziarie e/o valutarie alla Minsky si sono susseguite una dopo l'altra e che da un decennio investono sempre più gli stessi Stati Uniti e il "centro" capitalistico.
Un secondo problema, più significativo, riguarda il carattere originale e irriducibile del "nuovo capitalismo" dalla metà degli anni '90. La bolla delle dot.com come quella immobiliare (e in essa l'episodio dei subprime) sono state legate soprattutto all'indebitamento crescente delle famiglie, non delle imprese. Negli Stati Uniti gli investimenti fissi privati sono sì cresciuti negli anni della new economy (1995-1999), ma non sono stati certo la componente più significativa della domanda aggregata. Lo sono stati invece, mentre il bilancio statale andava in attivo e la bilancia commerciale aggravava il suo passivo, i consumi delle famiglie in eccesso al loro reddito. Si tratta di consumi "autonomi", finanziati col debito, grazie ad un "effetto ricchezza" trainato dalla bolla speculativa in borsa. La stessa vicenda si è non solo ripetuta ma radicalizzata dalla metà del 2003, con la ripresa trascinata dalla bolla immobiliare, a sua volta suscitata dai bassi tassi d'interesse e dalla inondazione di liquidità con cui la Federal Reserve aveva risposto alla crisi 2000-2001. Qui con tutta chiarezza, mentre torna il disavanzo dello Stato, gli investimenti sono stati sostanzialmente piatti, e la variabile trainante sono stati di nuovo, ancor più di prima, i consumi "autonomi". Questo modello è stato retto da politiche monetarie (e non solo) che tutto sono state meno che "liberiste". Non dovremmo, proprio noi, rimanere intrappolati dalla ideologia dissimulante dell'avversario di classe. La "mano visibile" e lo Stato non si sono affatto ritirati, hanno solo mutato forma nel loro interagire con i mercati e i soggetti sociali, e questo è vero per tutto l'arco del cosiddetto "neoliberismo".
In estrema sintesi, riprendendo una mia analisi che data almeno dalla fine degli anni '90 a partire dai miei scritti sulla rivista de il manifesto, i processi con cui la finanza determina la produzione (il lavoratore "traumatizzato" e la "sussunzione reale del lavoro alla finanza", cioè il risparmiatore "maniacale-depressivo" e il consumatore "indebitato") si trasferiscono alla distribuzione e alla domanda (compressione della quota dei salari e dei consumi dipendenti dal reddito). Bisogna partire dai primi (la finanza e la produzione) e non dai secondi (la distribuzione e la domanda), per non mettere il carro davanti ai buoi. Certo, la caduta del salario relativo avrebbe dovuto produrre la crisi da domanda (un tema tipicamente luxemburghiano, a me caro). Si darebbe però una rappresentazione distorta e sbagliata di questa realtà se non si tenesse conto che le politiche di questo "nuovo capitalismo" hanno risolto, temporaneamente ma efficacemente, il problema della realizzazione (monetaria) del plusvalore proprio grazie a quella inflazione dei prezzi delle "attività" che ha potentemente sostenuto i consumi privati, aggirando la debolezza dei salari. Il processo capitalistico che si è costituito - innovativo e dinamico sul piano non solo finanziario ma anche reale (è futile separare finanza "cattiva" e produzione "buona", così come la rendita dal profitto) - è stato caratterizzato da una potenziale accentuata instabilità che è stata inizialmente contenuta grazie alla resilienza della nuova finanza. Ciò poteva però ritardare ma non cancellare la intrinseca insostenibilità del meccanismo, che si è comunque inverata in ripetuti "crolli". Si è così dovuti passare di bolla in bolla (da quella del mercato azionario, a quella immobiliare, a quella abortita delle commodities come il petrolio e i beni primari), sino a che si è arrivati al capolinea.
Il materializzarsi della crisi reale, quando finalmente avviene, fa emergere la fase "depressiva" del risparmiatore, e quindi si ha un crollo del consumo per la necessità che tutti hanno di rientrare dal debito (un fenomeno che si sta recentemente verificando con grande violenza). Insomma: quando questo asset-bubble driven Keynesianism - questo paradossale keynesismo finanziario e "privatizzato", trainato dalle bolle ultra-speculative - entra in una crisi che pare configurarsi come "finale", il problema della domanda riemerge drammatico. Si entra contemporaneamente in una fase di (probabile) grande innovazione istituzionale: superata la fase di (presumibilmente prolungata) recessione che ci attende, il capitale dovrà trovare una nuova soluzione a queste contraddizioni. Tutte queste dinamiche si sono per l'intanto tradotte, e si tradurranno, in ulteriore pressione nei processi capitalistici di lavoro.
Se le cose stanno così, l'ipotesi dell'instabilità finanziaria di Minsky regge ancora, eccome: ma bisogna darle nuove vesti. E non ci si può limitare a ricordare il discorso originale di Minsky se si vuole sostenerne una qualche rilevanza al giorno d'oggi. Per spiegare tanto lo sviluppo (instabile) quanto la crisi (sistemica) del "nuovo capitalismo" si deve integrare Minsky in una rinnovata lettura marxiana dei processi capitalistici centrata sulla produzione di plusvalore. E si deve anche avere il coraggio di guardare alle "novità" autentiche dell'ultima fase capitalistica. Altrimenti ci si riduce a uno strano miscuglio di sottoconsumismo e neoricardismo, che imputa tutto ai bassi salari e ai bassi consumi prodotti dal "liberismo" degli ultimi trent'anni - un altro di quei corto-circuiti attraenti ma di breve respiro - e dipinge il quadro di un capitalismo "asfittico", senza la dinamicità delle trasformazioni del recente passato. Il "liberismo" è una fantasia, i bassi salari e i bassi consumi ci sono da un bel po'. Così non si spiega nulla e non si comprendono le metamorfosi capitalistiche dell'ultimo trentennio. E dunque non ci si attrezza a contrastare la ristrutturazione e la "rivoluzione dall'alto" che ci attende.
L'errore di questa posizione è simmetrico a quello di chi ha scommesso su una capacità della new economy di estrarre plusvalore stabilmente o è stato affascinato dal "capitalismo dei derivati", sicché, si è sostenuto e ancora si propone, sarebbe possibile strappare un "salario di esistenza". La prima visione, stagnazionistica, fronteggia la seconda, che è nella sostanza apologetica di quel capitale che "parassitariamente" sarebbe mosso da una spontanea produttività di valore delle moltitudini. L'alternativa di fronte a noi sarebbe il ritorno al keynesismo e all'intervento dello Stato nelle forme tradizionali, da un lato, o un social-liberismo radicalizzato, dall'altro.
Minsky può esserci molto utile nel capire questo "nuovo capitalismo" abbandonando queste letture troppo semplici, ampiamente falsificate negli ultimi due decenni. La sua analisi deve però essere aggiornata: cosa che farebbe lui per primo, attento com'era all'innovazione istituzionale e finanziaria. Qui i riferimenti altrettanto essenziali rispetto ai volumi citati da Cavallaro sono il volume Governare la crisi del 1986, e ancor di più alcuni scritti successivi come quelli dedicati alla transizione (allora in corso, e oggi compiuta) al money-manager capitalism - il capitalismo dei fondi pensione e patrimoniale, dove il "piccolo risparmio" nei fondi istituzionali è manovrato da gestori professionali, e si traduce in particolari criteri di corporate governance imposti alle imprese.
Ma quali sono le vie di uscita dalla deflazione da debiti e dalla instabilità finanziaria secondo Minsky? Cavallaro sembra sottovalutare la capacità di risposta della Federal Reserve e del Tesoro statunitensi. L'uno e l'altro hanno fatto all'apparenza tutte le mosse "minskyanamente" giuste, sia pure in ritardo. Non stupisce. Il neoliberismo, come ho detto, tutto è stato (ed è) meno che inattivo. Bernanke la Grande Crisi la conosce bene. Nel mezzo delle settimane di fuoco di settembre ha ricordato come "nessuno è ateo nella tana del lupo, nessuno è ideologo in una crisi finanziaria". E' stato semmai ben più spiazzato il social-liberismo, la cui risposta alla crisi si limita a una più stretta regolamentazione della finanza. Da questo punto di vista vale ancora lo scetticismo di Minsky rispetto al ripetersi della Grande Crisi. Il punto semmai è che non abbiamo a che fare, in questo caso, con una classica crisi di liquidità ma con una crisi di insolvenza. La politica monetaria espansiva si rivela qui necessaria ma doppiamente insufficiente: perché si finisce in una trappola della liquidità; e perché sono gli "investimenti" finanziari (la scommessa "moneta oggi - moneta domani") sottostanti a non essere sostenibili fuori dal riprodursi artificioso di una persistente spinta ultraspeculativa.
Per questo la politica fiscale non può essere limitata a una politica di disavanzi di bilancio sic et simpliciter. Si richiede, come ormai è chiaro anche ai ciechi, non una generica politica di sostegno della domanda, ma un intervento massiccio e mirato (e lo si doveva capire da tempo). Non basta una stabilizzazione del rapporto debito pubblico/Pil, occorre un (temporaneo) innalzamento compensato da capacità di espandere il denominatore, non solo per l'effetto domanda aggregata, ma per i contenuti strutturali della spesa (sta arrivando, ma "da destra"). La sfida è insomma di nuovo quella su cui si incagliò il New Deal: nazionalizzazione della banca e della finanza, spesa diretta dello Stato in grado di attivare nuovi processi di lavoro. Un New Deal che non è stato certo keynesiano secondo la vulgata. La sfida è quella che si ripropose negli anni '70: sul "cosa" e "come" produrre.
Ora, non tanto paradossalmente, proprio questo Minsky pensava. E ne parla non solo nel suo libro del 1986 ma anche in critiche dure, contenute in scritti editi e inediti, alla "guerra alla povertà" di Kennedy e Johnson e dei loro consiglieri keynesiani. Minsky riteneva che proprio lo strumentario keynesiano ricordato da Cavallaro, utile per impedire il ripetersi di una Grande Crisi, aveva prodotto un male nuovo, la stagflazione. E la controrivoluzione monetarista avrebbe dato vita ad un succedersi di episodi di instabilità finanziaria sempre più ravvicinati. La seconda parte della profezia si è verificata appieno, anche se in un quadro parzialmente diverso da quello disegnato da Minsky. La stagflazione, ora compressa dalla recessione in arrivo, non si produce più per una successione di aumenti dei salari e dei prezzi seguiti da politiche monetarie restrittive: qualcosa che non è stato più vero nel contesto del ‘nuovo capitalismo' con piena sotto-occupazione precaria e con inondazione di finanziamenti all'economia, dove le banche centrali intervengono non solo in ultima istanza ma anche (come scrive De Cecco) in prima istanza per promuovere il nuovo meccanismo del paradossale "keynesismo" finanziario.
Non stupisce di conseguenza che le proposte di politica economica di Minsky per "stabilizzare una economia instabile" siano ben lontane dal keynesismo standard, quello anche dei disavanzi di bilancio e del prestatore di ultima istanza: misure di risposta immediata alla crisi, ma del tutto inadeguate a definire un modello alternativo di economia più equa e meno instabile. Occorre una "socializzazione degli investimenti" che, intesa alla Minsky, va ben oltre Keynes. Potrebbe oggi essere riletta e "tradotta" così. Si impone un piano del lavoro con lo Stato che direttamente si fa garante di una piena occupazione, stabile e di qualità. Si richiedono investimenti pubblici che migliorino la produttività del sistema, nel lungo orizzonte temporale che solo lo Stato può intrattenere. Quando scriveva queste cose Minsky aveva appunto in mente gli interventi strutturali del New Deal "non keynesiano" e niente affatto il "keynesismo realizzato", che detestava alquanto. Forse bisognerebbe ricordarlo. Non a caso un appunto di Minsky sulla "cartolarizzazione" pubblicato da poco dal Levy Institute si apre con la frase di Eraclito secondo cui non ci può bagnare due volte nello stesso fiume. Tra le lezioni di Minsky c'è anche questa, e la sinistra farebbe bene a rammentarsela.









































Add comment