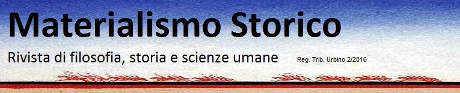Fai una donazione
Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________
- Details
- Hits: 1198
Marx e la cartina di tornasole dell’autoemancipazione
di Fabio Ciabatti
Dan Swain, None So Fit to Break the Chains. Marx’s Ethics of Self-Emancipation, Haymarket Books, Chicago 2020. pp. 224, 33,00 euro
 “L’emancipazione della classe operaia deve essere opera dei lavoratori stessi”. Questa famosa affermazione di Marx appare inequivocabile. Basta però, per alimentare qualche dubbio, accostare questa citazione a un altro famoso passaggio in cui il Moro di Treviri parla dell’“organizzazione dei proletari in classe e quindi in partito politico”. Si può così concludere che l’emancipazione della classe operaia è sostanzialmente opera del Partito comunista. Peccato che, come si evince dall’intero corpus marxiano e come è stato chiarito esplicitamente in una lettera dal diretto interessato, Marx quando parla di partito si riferisce generalmente al partito della classe in senso eminentemente storico, non a una qualche specifica organizzazione politica.
“L’emancipazione della classe operaia deve essere opera dei lavoratori stessi”. Questa famosa affermazione di Marx appare inequivocabile. Basta però, per alimentare qualche dubbio, accostare questa citazione a un altro famoso passaggio in cui il Moro di Treviri parla dell’“organizzazione dei proletari in classe e quindi in partito politico”. Si può così concludere che l’emancipazione della classe operaia è sostanzialmente opera del Partito comunista. Peccato che, come si evince dall’intero corpus marxiano e come è stato chiarito esplicitamente in una lettera dal diretto interessato, Marx quando parla di partito si riferisce generalmente al partito della classe in senso eminentemente storico, non a una qualche specifica organizzazione politica.
In altri termini, il concetto di partito, almeno nella sua accezione dominante nell’opera marxiana, coincide con il “movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti”.1 Un movimento che si costituisce come parte, la parte proletaria in lotta con quella borghese, ponendosi l’obiettivo politico di abbattere il modo di produzione dominante e per fare ciò si cristallizza temporaneamente in specifiche organizzazioni. Saremmo però dei materialisti assai bizzarri se pensassimo che importanti sviluppi storici, come la centralità assunta dal partito nelle vicende novecentesche, siano dipesi dalla cattiva interpretazione di alcuni testi, fossero anche quelli di Marx.
La citazione con cui abbiamo aperto testimonia che l’intera opera marxiana è pervasa da un impegno etico-politico nei confronti della rivoluzione intesa come autoemancipazione del proletariato.2
- Details
- Hits: 1471
Una contraddizione tra materia e forma
di Claus Peter Ortlieb
Sull'importanza della produzione di plusvalore relativo ai fini della dinamica della crisi
 Mentre l'economia politica in carica ritiene di stare osservando solo il lato materiale del modo di produzione capitalistico, e si interessa di magnitudini quali la crescita "reale" del prodotto interno lordo, oppure del reddito "effettivo" - tutte cose che, tuttavia, sono mediate dai loro valori in denaro - la maggioranza dei testi che si legano alla teoria del valore lavoro analizza il medesimo processo di produzione in relazione alla massa di valore e di plusvalore che viene realizzata in quel processo. Entrambe la parti, sembrano partire implicitamente dal principio secondo cui si tratti solo di differenti unità di misura della ricchezza. Viceversa, questo testo parte, con Marx, dal duplice concetto di ricchezza nel capitalismo, storicamente specifico, che viene rappresentato nel duplice carattere della merce e del lavoro. Il valore, come forma dominante di ricchezza nel capitalismo, si contrappone alla ricchezza materiale, alla cui forma specifica il capitale è di fatto indifferente, ma alla quale continua ad essere indispensabile in quanto portatore del valore. Ora, con l'aumentare della produttività, queste due forme di ricchezza entrano necessariamente a far parte di un'evoluzione divergente; ed era a partire da questo che Marx poteva parlare del capitale come «contraddizione in processo». Ed è tale contraddizione che vado qui ad esaminare. L'obiettivo è quello di mettere alla prova le argomentazioni del saggio di Robert Kurz (del 1986), che ha fondato la teoria della crisi dell'ex Krisis, contro quanto meno alle argomentazioni più serie contrarie a quelle formulate da Kurz.
Mentre l'economia politica in carica ritiene di stare osservando solo il lato materiale del modo di produzione capitalistico, e si interessa di magnitudini quali la crescita "reale" del prodotto interno lordo, oppure del reddito "effettivo" - tutte cose che, tuttavia, sono mediate dai loro valori in denaro - la maggioranza dei testi che si legano alla teoria del valore lavoro analizza il medesimo processo di produzione in relazione alla massa di valore e di plusvalore che viene realizzata in quel processo. Entrambe la parti, sembrano partire implicitamente dal principio secondo cui si tratti solo di differenti unità di misura della ricchezza. Viceversa, questo testo parte, con Marx, dal duplice concetto di ricchezza nel capitalismo, storicamente specifico, che viene rappresentato nel duplice carattere della merce e del lavoro. Il valore, come forma dominante di ricchezza nel capitalismo, si contrappone alla ricchezza materiale, alla cui forma specifica il capitale è di fatto indifferente, ma alla quale continua ad essere indispensabile in quanto portatore del valore. Ora, con l'aumentare della produttività, queste due forme di ricchezza entrano necessariamente a far parte di un'evoluzione divergente; ed era a partire da questo che Marx poteva parlare del capitale come «contraddizione in processo». Ed è tale contraddizione che vado qui ad esaminare. L'obiettivo è quello di mettere alla prova le argomentazioni del saggio di Robert Kurz (del 1986), che ha fondato la teoria della crisi dell'ex Krisis, contro quanto meno alle argomentazioni più serie contrarie a quelle formulate da Kurz.
- Details
- Hits: 1683
Questo presepe non ci piace
di Geminello Preterossi
 I dpcm sono ormai armi di distrazione di massa: per distogliere l’attenzione dai problemi veri, cioè dai fallimenti di governo e regioni, si fa propaganda, scaricando sui cittadini le colpe e creando falsi miti. Ad esempio, quello del Ferragosto devastante. Peccato che l’impennata dei positivi sia cominciata un mese e mezzo dopo, a seguito della riapertura delle scuole. L’inadeguata gestione di tale riapertura e il crack dei trasporti pubblici super-affollati sono, in tutta evidenza, le cause principali del ritorno del coronavirus, insieme all’arrivo della stagione autunnale. Cosi come davanti ai nostri occhi è la vergogna della totale disorganizzazione della sanità territoriale, che causa l’ospedalizzazione della malattia. È incredibile che le persone siano abbandonate a se stesse a casa, che non vi siano certezze diagnostiche celeri né protocolli terapeutici chiari, che non si sia provveduto a mobilitare i medici di famiglia (dotandoli degli opportuni presidi di sicurezza). Non sarà che l’alto numero dei decessi, in Italia, è anche l’effetto del fallimento radicale della sanità, in particolare di quella territoriale, che impedisce di curare adeguatamente le persone a casa, facendole affollare in ospedale, magari quando è tardi?
I dpcm sono ormai armi di distrazione di massa: per distogliere l’attenzione dai problemi veri, cioè dai fallimenti di governo e regioni, si fa propaganda, scaricando sui cittadini le colpe e creando falsi miti. Ad esempio, quello del Ferragosto devastante. Peccato che l’impennata dei positivi sia cominciata un mese e mezzo dopo, a seguito della riapertura delle scuole. L’inadeguata gestione di tale riapertura e il crack dei trasporti pubblici super-affollati sono, in tutta evidenza, le cause principali del ritorno del coronavirus, insieme all’arrivo della stagione autunnale. Cosi come davanti ai nostri occhi è la vergogna della totale disorganizzazione della sanità territoriale, che causa l’ospedalizzazione della malattia. È incredibile che le persone siano abbandonate a se stesse a casa, che non vi siano certezze diagnostiche celeri né protocolli terapeutici chiari, che non si sia provveduto a mobilitare i medici di famiglia (dotandoli degli opportuni presidi di sicurezza). Non sarà che l’alto numero dei decessi, in Italia, è anche l’effetto del fallimento radicale della sanità, in particolare di quella territoriale, che impedisce di curare adeguatamente le persone a casa, facendole affollare in ospedale, magari quando è tardi?
Tutto ciò viene rimosso, e l’attenzione spostata, fin dalla primavera scorsa, via via su obiettivi fittizi: sui riders (anche se solitari), la movida, i giovani, il Natale con i parenti (persino quelli stretti, se abitano in un’altra regione, pur gialla), la Messa di Mezzanotte (notoriamente, il virus si sveglia a quell’ora).
- Details
- Hits: 3906
Centomila miliardi di asset finanziano 18.500 miliardi di Pil
Il rischio americano è tutto qui
di Maurizio Novelli, Lemanik
Lo stock di azioni e titoli di debito che finanziano l’economia Usa ha raggiunto questa cifra stratosferica. E circa 10-12.000 miliardi di dollari di risparmio estero di Cina, Giappone ed Europa contribuiscono a quel sostegno, sottraendo risorse alle loro economie. Un circolo vizioso da cui si esce con ricette che Wall Street certo non gradisce
 Mentre si avvia il cambio di amministrazione negli Stati Uniti, i mercati finanziari sono impegnati nella costruzione della piu’ grande bolla speculativa di sempre, in un contesto economico particolarmente disastrato. I postumi della crisi economica non saranno così facili da superare per le economie occidentali e il danno richiederà molto tempo per essere riparato, anche se la frenesia speculativa dei mercati cerca di far credere che non sarà così.
Mentre si avvia il cambio di amministrazione negli Stati Uniti, i mercati finanziari sono impegnati nella costruzione della piu’ grande bolla speculativa di sempre, in un contesto economico particolarmente disastrato. I postumi della crisi economica non saranno così facili da superare per le economie occidentali e il danno richiederà molto tempo per essere riparato, anche se la frenesia speculativa dei mercati cerca di far credere che non sarà così.
Le azioni dei policy makers stanno creando due economie tra loro contrapposte, quella della finanza e quella reale, con il rischio che si possano separare pericolosamente tra loro in modo irreversibile, producendo una ripresa economica a forma di K: il 10% più ricco della popolazione si trova sulla linea superiore della K e il rimanente 90% in quella inferiore, fino a creare in prospettiva l’instabilità sociale prodotta dalla disuguaglianza.
Il livello raggiunto dallo stock di asset finanziari detenuti dagli investitori e circolanti nell’economia americana a fine 2019 era pari a 5,6 volte il Pil Usa, ma in considerazione del recente aumento del debito interno per fronteggiare la crisi economica, dovrebbe essere salito a ben oltre 6 volte il PIL (in UE tale livello è inferiore a 3 volte). In sostanza, il Pil USA vale oggi circa 18.500 miliardi di dollari ma le attività finanziarie (azioni, obbligazioni e titoli cartolarizzati di ogni tipo) che lo rappresentano e servono a finanziarlo hanno raggiunto la cifra astronomica di oltre 100.000 miliardi di dollari (derivati esclusi!).
- Details
- Hits: 1533
Guerra commerciale USA-Cina: il vero ladro finalmente smascherato
di Rémy Herrera, Zhiming Long, Zhixuan Feng e Bangxi Li*
Pubblicato su “Materialismo Storico. Rivista di filosofia, storia e scienze umane", n° 1/2020, a cura di Stefano G. Azzarà, pp. 177-190, licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0

- Details
- Hits: 1618
La Dialettica della Natura di Engels nell'antropocene
di John Bellamy Foster
 Nel capitolo «Parte avuta dal lavoro nel processo di umanizzazione della scimmia» del suo Dialettica della natura, Friedrich Engels affermava: «Ogni cosa influenza ed è influenzata da ogni altra cosa» [1]. Oggi, a duecento anni dalla sua nascita, Engels si può considerare uno dei fondatori del pensiero ecologico moderno. Se la teoria della frattura metabolica di Karl Marx è alla base dell'ecologia odierna ispirata al materialismo storico, resta pur vero che il contributo di Engels alla nostra comprensione del problema ecologico nel suo insieme rimane indispensabile - un contributo basato sulle sue approfondite ricerche sul metabolismo universale della natura, che rafforzarono e ampliarono l'analisi di Marx. Come afferma Paul Blackledge in un recente studio del pensiero di Engels, «La concezione di Engels di una dialettica della natura apre uno spazio attraverso il quale le crisi ecologiche» possono essere ricondotte alla «natura alienata delle relazioni sociali capitaliste» [2]. È proprio in virtù della completezza del suo approccio alla dialettica della natura e della società che l'opera di Engels può contribuire a chiarire le sfide epocali che l'umanità deve fronteggiare nell'antropocene, e la crisi ecologica planetaria che caratterizza l'epoca attuale.
Nel capitolo «Parte avuta dal lavoro nel processo di umanizzazione della scimmia» del suo Dialettica della natura, Friedrich Engels affermava: «Ogni cosa influenza ed è influenzata da ogni altra cosa» [1]. Oggi, a duecento anni dalla sua nascita, Engels si può considerare uno dei fondatori del pensiero ecologico moderno. Se la teoria della frattura metabolica di Karl Marx è alla base dell'ecologia odierna ispirata al materialismo storico, resta pur vero che il contributo di Engels alla nostra comprensione del problema ecologico nel suo insieme rimane indispensabile - un contributo basato sulle sue approfondite ricerche sul metabolismo universale della natura, che rafforzarono e ampliarono l'analisi di Marx. Come afferma Paul Blackledge in un recente studio del pensiero di Engels, «La concezione di Engels di una dialettica della natura apre uno spazio attraverso il quale le crisi ecologiche» possono essere ricondotte alla «natura alienata delle relazioni sociali capitaliste» [2]. È proprio in virtù della completezza del suo approccio alla dialettica della natura e della società che l'opera di Engels può contribuire a chiarire le sfide epocali che l'umanità deve fronteggiare nell'antropocene, e la crisi ecologica planetaria che caratterizza l'epoca attuale.
In corsa verso la rovina
La rilevanza contemporanea della critica ecologica di Engels può essere colta a partire da un celebre commento del 1940 di Walter Benjamin, citato sovente dagli ecosocialisti, tratto dai «Paralipomeni» (o note a margine) delle sue «Tesi sul concetto di storia».
- Details
- Hits: 1179
Pandemia e medicina del territorio
di Visconte Grisi
 Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo testo del compagno Visconte Grisi, che nasce anche dalla sua lunga esperienza di medico di base e medico scolastico. Tra i suoi molti spunti che andrebbero ripresi e discussi a fondo, ne sottolineiamo in particolare due, sui quali già ci siamo espressi e su cui non sarà mai inutile ritornare: 1) lo smantellamento pressoché completo delle attività strutturate di medicina preventiva e di medicina del territorio va considerato un vero e proprio crimine sociale compiuto dalla classe dominante, in combutta tra la sua componente economica e quella politica – complici il sistema universitario e il baraccone massmediatico che l’hanno messa in pratica e difesa; 2) un’inversione di tendenza è possibile soltanto se i lavoratori e le lavoratrici riprenderanno con determinazione nelle proprie mani la difesa della propria salute ispirandosi alle importanti tradizioni di lotta del passato – tradizioni che invitiamo i più giovani a studiare, perché c’è tanto da imparare.
Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo testo del compagno Visconte Grisi, che nasce anche dalla sua lunga esperienza di medico di base e medico scolastico. Tra i suoi molti spunti che andrebbero ripresi e discussi a fondo, ne sottolineiamo in particolare due, sui quali già ci siamo espressi e su cui non sarà mai inutile ritornare: 1) lo smantellamento pressoché completo delle attività strutturate di medicina preventiva e di medicina del territorio va considerato un vero e proprio crimine sociale compiuto dalla classe dominante, in combutta tra la sua componente economica e quella politica – complici il sistema universitario e il baraccone massmediatico che l’hanno messa in pratica e difesa; 2) un’inversione di tendenza è possibile soltanto se i lavoratori e le lavoratrici riprenderanno con determinazione nelle proprie mani la difesa della propria salute ispirandosi alle importanti tradizioni di lotta del passato – tradizioni che invitiamo i più giovani a studiare, perché c’è tanto da imparare.
* * * *
La diffusione della pandemia di Covid-19 ha messo in luce, nel nostro come in altri paesi, le carenze disastrose di una medicina pubblica sottoposta da decenni a tagli nei finanziamenti e a processi sempre più accelerati di privatizzazione.
In questo intervento vogliamo mettere però in evidenza i danni clamorosi provocati dallo smantellamento, ormai quasi completo, operato nei confronti della medicina del territorio.
- Details
- Hits: 2356
La crisi del populismo di sinistra e il socialismo possibile
di Carlo Formenti
Pubblichiamo una sintesi dell’ultimo paragrafo del capitolo conclusivo de “Il capitale vede rosso” di Carlo Formenti, un pamphlet appena uscito per i tipi di Meltemi. Nel volume l’autore chiarisce il proprio pensiero sui temi del populismo e della sovranità nazionale, propone il concetto di “socialismo possibile” allo scopo di ridefinire un’idea di socialismo del secolo XXI emancipata dai dogmatismi della tradizione marxista e ragiona sulla possibilità di rivitalizzare il progetto socialista nei Paesi occidentali e sul blocco sociale su cui lo si potrebbe fondare
 Prendo le mosse da una considerazione: le sinistre populiste occidentali, pur avendo contribuito a riesumare la parola socialismo che il crollo del Muro e quarant’anni di controrivoluzione liberista avevano rimosso dal lessico della politica, avanzano proposte simili alle politiche socialdemocratiche del trentennio glorioso. Nel secolare dibattito su riforme e rivoluzione costoro sembrano dunque collocarsi nel campo riformista. È pur vero che il dibattito interno alla socialdemocrazia tedesca di fine 800/primo 900 su riforme e rivoluzione – oggi ripreso in ambito latinoamericano in relazione alle esperienze bolivariane – ha stemperato questa opposizione assoluta: sia Engels che Luxemburg avevano ribadito che la vera differenza è fra coloro che considerano le riforme come un fine in sé e chi le concepisce come uno strumento per preparare la rivoluzione. Resta il fatto che parliamo di programmi politici che, almeno a un primo esame, appaiono compatibili sia con il modo di produzione capitalista che con i suoi assetti istituzionali. Ma è davvero così?
Prendo le mosse da una considerazione: le sinistre populiste occidentali, pur avendo contribuito a riesumare la parola socialismo che il crollo del Muro e quarant’anni di controrivoluzione liberista avevano rimosso dal lessico della politica, avanzano proposte simili alle politiche socialdemocratiche del trentennio glorioso. Nel secolare dibattito su riforme e rivoluzione costoro sembrano dunque collocarsi nel campo riformista. È pur vero che il dibattito interno alla socialdemocrazia tedesca di fine 800/primo 900 su riforme e rivoluzione – oggi ripreso in ambito latinoamericano in relazione alle esperienze bolivariane – ha stemperato questa opposizione assoluta: sia Engels che Luxemburg avevano ribadito che la vera differenza è fra coloro che considerano le riforme come un fine in sé e chi le concepisce come uno strumento per preparare la rivoluzione. Resta il fatto che parliamo di programmi politici che, almeno a un primo esame, appaiono compatibili sia con il modo di produzione capitalista che con i suoi assetti istituzionali. Ma è davvero così?
La verità è che, mentre il modo di produzione fordista poteva permettersi il compromesso keynesiano fra capitale e lavoro, il capitalismo contemporaneo non intende in alcun modo rinunciare ai frutti delle vittorie ottenute dagli anni Ottanta a oggi.
- Details
- Hits: 1426
Riflessioni pandemiche
di Nico Maccentelli
 Trovo le polemiche interne alla sinistra di classe sul lockdown del tutto fuorvianti. Le accuse reciproche di negazionismo da una parte e dall’altra di sudditanza ai dettami imposti dal regime in materia di salute pubblica non colgono la questione essenziale che è un passaggio epocale, direi antropologico e non solo economico di crisi del capitalismo.
Trovo le polemiche interne alla sinistra di classe sul lockdown del tutto fuorvianti. Le accuse reciproche di negazionismo da una parte e dall’altra di sudditanza ai dettami imposti dal regime in materia di salute pubblica non colgono la questione essenziale che è un passaggio epocale, direi antropologico e non solo economico di crisi del capitalismo.
Un passaggio nel quale la democrazia borghese, ma più profondamente le relazioni sociali, sta subendo un mutamento non certo temporaneo e in cui si evidenzia l’incapacità del capitalismo (ma direi anche la volontà delle classi dirigenti) di affrontare la pandemia e la crisi del capitale che si accresce in questo frangente. Un sistema che cade definitivamente nella barbarie darwiniana del più forte che sopprime i più deboli, che fa la guerra, che si impone con una violenza organizzata di cui la democrazia è ormai solo un vuoto involucro.
Che siamo al crepuscolo di questo modo di produzione e di consumo lo dicono tanti segnali e di certo non occorreva la pandemia per confermarlo. Ma noi comunisti siamo sempre stati della cassandre inascoltate…
Vediamo allora di mettere alcuni punti fermi, in modo sintetico.
1. Ho scritto poc’anzi dell’incapacità del capitalismo di far fronte a questa ecatombe e aggiungo la sola volontà demenziale e direi suicida di riproporre la legge del più forte al netto di tutta la demagogia spicciola tra balconi, bandierine e Mattarella.
Laddove occorrerebbe una spinta rivoluzionaria della politica nel non farsi tirare la giacchetta da chicchessia e nel non guadare in faccia a nessuno, la classe politica sceglie ancora una volta l’egemonia delle oligarchie economiche.
- Details
- Hits: 1673
200 anni di Engels: per una nuova lettura della “Dialettica della natura”
di Gabriele Schimmenti
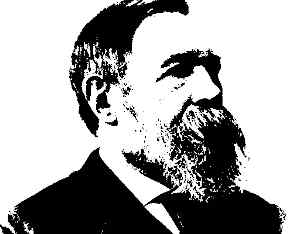 Nell’anno del bicentenario di Engels, vale ancora la pena di tornare a discutere del Generale e di tenere a mente come la sua attività teorica, nelle ultime fasi della sua produzione, si fosse concentrata sul progetto incompleto di una “Dialettica della natura”. Il libro di Kaan Kangal, “Friedrich Engels and the Dialectics of Nature” (Palgrave Macmillan 2020), affronta le intenzioni, i fini, le procedure, le tesi e la storia degli effetti dell’“opera” in questione, invitandoci a ritornare ad Engels senza cadere vittima delle stratificate maldicenze sul suo conto. Solo in questo modo, da una nuova lettura di Engels, sarà possibile osservare i meriti e i limiti del progetto di una “Dialettica della natura”, del suo discorso e delle sue intenzioni.
Nell’anno del bicentenario di Engels, vale ancora la pena di tornare a discutere del Generale e di tenere a mente come la sua attività teorica, nelle ultime fasi della sua produzione, si fosse concentrata sul progetto incompleto di una “Dialettica della natura”. Il libro di Kaan Kangal, “Friedrich Engels and the Dialectics of Nature” (Palgrave Macmillan 2020), affronta le intenzioni, i fini, le procedure, le tesi e la storia degli effetti dell’“opera” in questione, invitandoci a ritornare ad Engels senza cadere vittima delle stratificate maldicenze sul suo conto. Solo in questo modo, da una nuova lettura di Engels, sarà possibile osservare i meriti e i limiti del progetto di una “Dialettica della natura”, del suo discorso e delle sue intenzioni.
Nei manoscritti de L’ideologia tedesca, Marx ed Engels scrissero che
conosciamo una sola scienza, quella della storia. La storia può essere considerata sotto due aspetti, ed essere suddivisa in storia della natura e storia degli uomini. Tuttavia, questi aspetti sono inseparabili: finché esistono uomini, la storia della natura e la storia degli uomini si condizionano reciprocamente.[1]
Sebbene la ricerca più recente ci mostri come entrambi i sodali fossero versati nella storia naturale (come mostrato ad esempio di recente, relativamente a Marx, dai lavori John Bellamy Forster o di Kohei Saito), è stato Engels che ha dedicato la maggior parte della sua ad un progetto in cui la natura assumeva un ruolo centrale, ovvero la cosiddetta Dialettica della natura.
- Details
- Hits: 1672

Osservazioni e critiche a “Catastrofe o rivoluzione” di Emiliano Brancaccio
di Gianni De Bellis e Mario Fragnito
 Cerchiamo di fare alcune osservazioni e alcune critiche al lavoro di Emiliano Brancaccio “Catastrofe o rivoluzione”, tenendo conto che, essendo il compagno un accademico, il lavoro è stato scritto, appunto, con “linguaggio accademico”. Ci scusiamo in anticipo della nostra ripetitività, ma è dovuta alle osservazioni da noi fatte punto per punto, e al ribattere di certi concetti da parte di Brancaccio.
Cerchiamo di fare alcune osservazioni e alcune critiche al lavoro di Emiliano Brancaccio “Catastrofe o rivoluzione”, tenendo conto che, essendo il compagno un accademico, il lavoro è stato scritto, appunto, con “linguaggio accademico”. Ci scusiamo in anticipo della nostra ripetitività, ma è dovuta alle osservazioni da noi fatte punto per punto, e al ribattere di certi concetti da parte di Brancaccio.
Iniziamo dal prologo, in cui Brancaccio, anticipando una sua tesi, dice:
<< la libertà del capitale e la sua tendenza a centralizzarsi in sempre meno mani costituiscono una minaccia per le altre libertà e per le istituzioni liberaldemocratiche del nostro tempo. Dinanzi a una simile prospettiva Keynes non basta, come non basta invocare un reddito. L’unica rivoluzione in grado di scongiurare una catastrofe dei diritti risiede nel recupero e nel rilancio della più forte leva nella storia delle lotte politiche: la pianificazione collettiva >>.
Ora, punto primo:
Marx, in relazione al modo di produzione capitalistico, ha sempre parlato, per quanto ne sappiamo, di “libertà per il borghese (innanzitutto libertà di sfruttare i proletari)” e di “schiavitù del lavoro salariato” per il proletario. Più estesamente: la libertà in ambito borghese è in ultima istanza libertà per il capitale; tutte le altre libertà devono, all’occorrenza, essere ad essa sacrificate, manifestando così la loro falsità, la loro apparenza soltanto, di verità.
- Details
- Hits: 1263
La tempesta perfetta
di Il Pedante
Leggi qui la prima parte dell'articolo
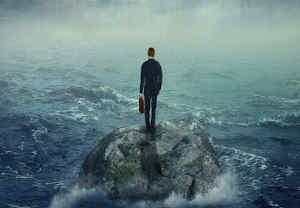 Perché allestire una pandemia di legge che rende pandemica una lunga serie di malattie altrimenti contenibili? E perché un'idea così pericolosa raccoglie i consensi di una parte importante della popolazione, specialmente ai suoi vertici? E ancora, perché una civiltà che si dichiara fedele al metodo e ai risultati delle scienze sceglie di ignorare i danni scientificamente misurabili (come le sindromi da «lockdown») e misurati (come la dubbia utilità dei «lockdown») delle sue condotte, e nel fare ciò pretende persino di agire secondo i «dettami» di una scienza che dice, impone e prescrive? Non è purtroppo possibile fornire una sola risposta a questi interrogativi, perché la contraddizione di oggi amplifica e porta a un livello (finora) mai visto una lunga serie di condizioni che già da prima agivano sull'esercizio e sulla rappresentazione della vita sociale. Essa è nuova nell'intensità, ma non nelle premesse e nei modi. La sua critica dovrebbe perciò strutturarsi nell'alveo di una più ampia critica delle contraddizioni e dei paradossi moderni nel loro sviluppo prima secolare e poi sempre più rapido, degli ultimi pochi decenni. È una critica che qui possiamo affrontare solo disordinatamente e in antologia, offrendo spunti di analisi che convergono da livelli diversi per indovinare le radici lontane del fenomeno esaminando i suoi frutti.
Perché allestire una pandemia di legge che rende pandemica una lunga serie di malattie altrimenti contenibili? E perché un'idea così pericolosa raccoglie i consensi di una parte importante della popolazione, specialmente ai suoi vertici? E ancora, perché una civiltà che si dichiara fedele al metodo e ai risultati delle scienze sceglie di ignorare i danni scientificamente misurabili (come le sindromi da «lockdown») e misurati (come la dubbia utilità dei «lockdown») delle sue condotte, e nel fare ciò pretende persino di agire secondo i «dettami» di una scienza che dice, impone e prescrive? Non è purtroppo possibile fornire una sola risposta a questi interrogativi, perché la contraddizione di oggi amplifica e porta a un livello (finora) mai visto una lunga serie di condizioni che già da prima agivano sull'esercizio e sulla rappresentazione della vita sociale. Essa è nuova nell'intensità, ma non nelle premesse e nei modi. La sua critica dovrebbe perciò strutturarsi nell'alveo di una più ampia critica delle contraddizioni e dei paradossi moderni nel loro sviluppo prima secolare e poi sempre più rapido, degli ultimi pochi decenni. È una critica che qui possiamo affrontare solo disordinatamente e in antologia, offrendo spunti di analisi che convergono da livelli diversi per indovinare le radici lontane del fenomeno esaminando i suoi frutti.
Nel citato articolo di maggio mi concentravo sulle suggestioni religiose di un altrimenti assurdo olocausto di sé con cui la civiltà contemporanea sembra voler propiziare la propria risurrezione scrollandosi di dosso le delusioni, le paure e i problemi irrisolti di un modello spiritualmente esausto e materialmente insostenibile.
- Details
- Hits: 1392
La religione del debito
Dario Gentili, Elettra Stimilli, Antonio Montefusco, Paolo Napoli
Solitamente capitalismo e cristianesimo sono considerati due ambiti opposti, ma in questo dialogo intorno al libro di Elettra Stimilli emergono le fonti cristiane del modo di produzione capitalista, a partire dal concetto di «colpa»
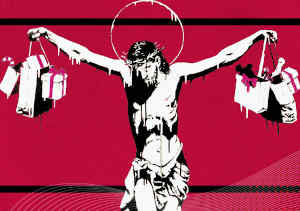 Il saggio di Elettra Stimilli, Il debito del vivente. Ascesi e capitalismo, ripubblicato da poco, ha un obiettivo allo stesso tempo radicale e ambizioso: da che cosa deriva, da un punto di vista filosofico e culturale, il sentimento onnipresente, così tipico del nostro tempo, per il quale ci sentiamo in difetto e in colpa? Il nome che diamo a questo sentimento – debito – si riallaccia a concetti culturalmente stratificati (in tedesco, per esempio, la parola Schuld indica insieme sia la colpa sia il debito, in una confusione che è comune a diverse lingue). Il debito è stato in verità anche uno strumento di governo della vita dei singoli e della costruzione di rapporti geopolitici (sappiamo bene, ormai, come quello «sovrano» e quello «privato» siano intrecciati). Soprattutto, esso si rivela uno strumento che induce a sottrarre agli uomini il controllo del loro destino. L’analisi di Stimilli riesce a individuare in questo elemento un punto cruciale che permette di comprendere le concrete modalità con le quali il capitalismo ha innestato la sua totale presa sul mondo, e sugli esseri umani: porre l’accento sulla condotta di vita individuale, che è considerata di per sé, quasi naturalmente, mancante e in difetto, permette di articolare una forma di fede nel capitalismo, che lo rende, sotto molti aspetti, indiscutibile. Consumare non è più uno obiettivo godibile. Quel deficit originario comporta soprattutto che la nostra vita sia vissuta naturalmente come una rinuncia. Rinuncia che caratterizza la nostra compartecipazione al consumo e all’ordine neoliberale, mascherando sotto l’aspetto dell’imprenditore di sé stesso un’autodisciplina feroce, priva di scopi, che permette al capitalismo di metterci a valore come esseri viventi, come, infine, «capitale umano».
Il saggio di Elettra Stimilli, Il debito del vivente. Ascesi e capitalismo, ripubblicato da poco, ha un obiettivo allo stesso tempo radicale e ambizioso: da che cosa deriva, da un punto di vista filosofico e culturale, il sentimento onnipresente, così tipico del nostro tempo, per il quale ci sentiamo in difetto e in colpa? Il nome che diamo a questo sentimento – debito – si riallaccia a concetti culturalmente stratificati (in tedesco, per esempio, la parola Schuld indica insieme sia la colpa sia il debito, in una confusione che è comune a diverse lingue). Il debito è stato in verità anche uno strumento di governo della vita dei singoli e della costruzione di rapporti geopolitici (sappiamo bene, ormai, come quello «sovrano» e quello «privato» siano intrecciati). Soprattutto, esso si rivela uno strumento che induce a sottrarre agli uomini il controllo del loro destino. L’analisi di Stimilli riesce a individuare in questo elemento un punto cruciale che permette di comprendere le concrete modalità con le quali il capitalismo ha innestato la sua totale presa sul mondo, e sugli esseri umani: porre l’accento sulla condotta di vita individuale, che è considerata di per sé, quasi naturalmente, mancante e in difetto, permette di articolare una forma di fede nel capitalismo, che lo rende, sotto molti aspetti, indiscutibile. Consumare non è più uno obiettivo godibile. Quel deficit originario comporta soprattutto che la nostra vita sia vissuta naturalmente come una rinuncia. Rinuncia che caratterizza la nostra compartecipazione al consumo e all’ordine neoliberale, mascherando sotto l’aspetto dell’imprenditore di sé stesso un’autodisciplina feroce, priva di scopi, che permette al capitalismo di metterci a valore come esseri viventi, come, infine, «capitale umano».
- Details
- Hits: 1313
Competizione per sopravvivere, il nero destino della UE
di Claudio Conti
In calce un articolo di Guido Salerno Aletta
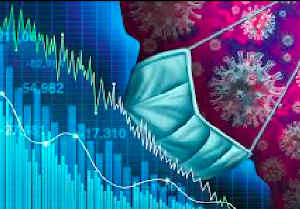 Sepolta sotto la coltre mediatica delle notizie sulla pandemia, la crisi economica marcia trionfale. Esaltata dalla stessa architettura dell’Unione Europea, fissata in trattati pensati in un’epoca di “vacche grasse”, quando la parola crisi era immediatamente associata alla “colpa” di qualcuno.
Sepolta sotto la coltre mediatica delle notizie sulla pandemia, la crisi economica marcia trionfale. Esaltata dalla stessa architettura dell’Unione Europea, fissata in trattati pensati in un’epoca di “vacche grasse”, quando la parola crisi era immediatamente associata alla “colpa” di qualcuno.
Perché si viveva “nel migliore dei mondi possibili”, e dunque se qualcosa andava storto doveva esserci per forza qualcuno che aveva “vissuto al di sopra delle proprie possibilità”, accumulando debiti invece che produrre ricchezza.
Quel mondo perfetto, del capitalismo neoliberista, non è mai esistito, se non nella retorica (qualcuno lo spieghi ai Giannini e ai Mario Monti, che non continuino ignari di tutto!). Ma adesso è la realtà a prendere a martellate in testa chiunque provi a immaginare “misure correttive” per un sistema che non sta in piedi.
L’Unione Europea, dopo dieci mesi di pandemia, non è ancora riuscita a prendere alcuna decisione sensata o comunque pratica. L’unica mezza cosetta è il fondo Sure, garantito dalla Ue, per finanziare – molto parzialmente – la cassa integrazione straordinaria decisa da tutti gli Stati membri.
Per il resto, ognun per sé, come vuole la logica mercantilista dei trattati. Tranne che per quanto riguarda la politica di bilancio, ovviamente improntata all’austerità.
Anche questa è stata presa a martellate dalla pandemia, visto che tutti i Paesi membri hanno dovuto ingigantire i rispettivi debiti pubblici per far fronte all’emergenza. Ma la “sospensione” del Patto di Stabilità non significa affatto revisione delle strategie adottate fin qui.
- Details
- Hits: 1442
Il cittadino criminale e il “grande internamento” del lockdown
Adesso più che mai è necessario rileggere Foucault
di Guy Van Stratten
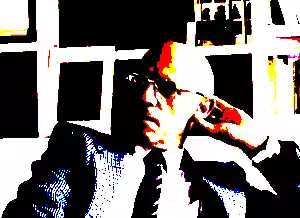 Per descrivere i più svariati fenomeni di tipo sociale e politico che avvengono nella società è utile, in alcuni casi, rivolgersi al pensiero di studiosi e filosofi, che funziona come una vera e propria lente di ingrandimento, come un filtro attraverso il quale possiamo leggere la realtà che ci circonda. Michel Foucault è sicuramente uno di questi: egli stesso considerava le sue opere come una vera e propria “cassetta degli attrezzi” che metteva a disposizione per chi volesse avviarsi sulle piste di ricerca da lui iniziate. I suoi studi sulle dinamiche attraverso le quali il potere si insinua negli interstizi della società moderna e contemporanea rappresentano un importante strumento che non dovremmo mai dimenticare. Adesso più che mai è necessario riprenderlo in mano per tentare di analizzare, in modo lucido e disincantato, i fenomeni sociali e politici scaturiti dall’emergenza della pandemia da Covid-19.
Per descrivere i più svariati fenomeni di tipo sociale e politico che avvengono nella società è utile, in alcuni casi, rivolgersi al pensiero di studiosi e filosofi, che funziona come una vera e propria lente di ingrandimento, come un filtro attraverso il quale possiamo leggere la realtà che ci circonda. Michel Foucault è sicuramente uno di questi: egli stesso considerava le sue opere come una vera e propria “cassetta degli attrezzi” che metteva a disposizione per chi volesse avviarsi sulle piste di ricerca da lui iniziate. I suoi studi sulle dinamiche attraverso le quali il potere si insinua negli interstizi della società moderna e contemporanea rappresentano un importante strumento che non dovremmo mai dimenticare. Adesso più che mai è necessario riprenderlo in mano per tentare di analizzare, in modo lucido e disincantato, i fenomeni sociali e politici scaturiti dall’emergenza della pandemia da Covid-19.
Da più parti, durante il lockdown di marzo-aprile, è stato richiamato il concetto di “criminalizzazione del cittadino”. Adesso, che vengono nuovamente messe in atto pratiche più o meno restrittive della libertà individuale sull’intero territorio nazionale, è interessante recuperare questo concetto. Perché criminalizzazione o, detto altrimenti, colpevolizzazione? Perché – si diceva – gli organi di governo, invece di mettere il dito sulla piaga di un sistema sanitario inefficiente e ridotto al collasso da una cattiva gestione nel corso di lunghi anni, colpevolizzavano diffusamente i cittadini indisciplinati che ‘si assembravano’ e assumevano dei comportamenti sbagliati.
- Details
- Hits: 1081
Infanzia e capitalismo
di Laura Pigozzi
 Il nostro capitalismo, che è indubitabilmente aggressivo, è anche un capitalismo bambino. Uno dei passaggi dall’età infantile a quella adulta consiste nel legare la pulsione aggressiva in una formazione che abbia carattere di sublimazione, che possa, cioè, costruire un ponte simbolico tra gli esseri umani, come il pensiero, l’invenzione. Possiamo chiamare il nostro capitalismo infantile anche “capitalismo pulsionale”, dato che la sua pulsionalità appare slegata, indisciplinata e disinvolta nel gioco del libero mercato. Le parole non sono mai innocenti: definire “gioco” il sistema che regge economicamente il mondo è rivelatore. Eppure, persino il gioco dei bambini ha bisogno di regole imposte da un terzo, esterno alla partita. Al contrario, per quanto riguarda gli scambi economici del nostro mondo industrializzato, si è creduto di poterli lasciare senza una disciplina, senza la guida di un terzo che, estraneo al gioco, dettasse le regole. Si è creduto che un gioco auto-amministrato potesse “dar vita di per sé a una società funzionante ed efficiente [dato che] la teoria neoclassica è stata ampiamente collaudata e ha mostrato il suo valore”, come recita uno dei testi di Peter Ferdinand Drucker, ritenuto l’inventore della scienza del management. Drucker è considerato uno dei pensatori di economia sociale e organizzazione aziendale tra i più illuminati e, mentre scriveva “credo fermamente nei liberi mercati”, sosteneva anche che le attività economiche sono il mezzo “per il raggiungimento di fini non economici (cioè umani o sociali), anziché essere fini in quanto tali”.
Il nostro capitalismo, che è indubitabilmente aggressivo, è anche un capitalismo bambino. Uno dei passaggi dall’età infantile a quella adulta consiste nel legare la pulsione aggressiva in una formazione che abbia carattere di sublimazione, che possa, cioè, costruire un ponte simbolico tra gli esseri umani, come il pensiero, l’invenzione. Possiamo chiamare il nostro capitalismo infantile anche “capitalismo pulsionale”, dato che la sua pulsionalità appare slegata, indisciplinata e disinvolta nel gioco del libero mercato. Le parole non sono mai innocenti: definire “gioco” il sistema che regge economicamente il mondo è rivelatore. Eppure, persino il gioco dei bambini ha bisogno di regole imposte da un terzo, esterno alla partita. Al contrario, per quanto riguarda gli scambi economici del nostro mondo industrializzato, si è creduto di poterli lasciare senza una disciplina, senza la guida di un terzo che, estraneo al gioco, dettasse le regole. Si è creduto che un gioco auto-amministrato potesse “dar vita di per sé a una società funzionante ed efficiente [dato che] la teoria neoclassica è stata ampiamente collaudata e ha mostrato il suo valore”, come recita uno dei testi di Peter Ferdinand Drucker, ritenuto l’inventore della scienza del management. Drucker è considerato uno dei pensatori di economia sociale e organizzazione aziendale tra i più illuminati e, mentre scriveva “credo fermamente nei liberi mercati”, sosteneva anche che le attività economiche sono il mezzo “per il raggiungimento di fini non economici (cioè umani o sociali), anziché essere fini in quanto tali”.
- Details
- Hits: 1788
Bozze per un'analisi della teoria dello Stato in Marx (breve risposta a Riccardo Dal Ferro)
di Bollettino Culturale
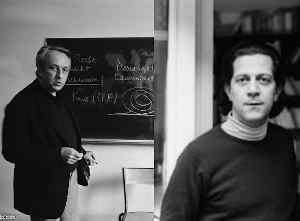 Riflettere su un argomento così complesso come lo Stato in Marx comporta diversi tipi di problemi. Un primo problema è la vastità dell'opera di Marx, un altro la complessità del suo pensiero e l'erudizione delle sue esemplificazioni. Tuttavia, questi problemi possono diventare secondari o minori rispetto ad altri di dimensioni maggiori: cosa intendiamo cercare e trovare quando parliamo di "Stato in Marx"? Un problema teorico della massima importanza, poiché riguarda la definizione dell'oggetto da indagare.
Riflettere su un argomento così complesso come lo Stato in Marx comporta diversi tipi di problemi. Un primo problema è la vastità dell'opera di Marx, un altro la complessità del suo pensiero e l'erudizione delle sue esemplificazioni. Tuttavia, questi problemi possono diventare secondari o minori rispetto ad altri di dimensioni maggiori: cosa intendiamo cercare e trovare quando parliamo di "Stato in Marx"? Un problema teorico della massima importanza, poiché riguarda la definizione dell'oggetto da indagare.
Partendo da una prima approssimazione potremmo, ad esempio, dire: l'oggetto di questa indagine è il concetto di Stato che esiste nell'opera di K. Marx. Ma poi, poco dopo, ci imbattiamo in un problema: se c'è un “concetto” è chiaro che si tratta necessariamente di una teoria. Quindi l'"oggetto" della nostra ricerca non è semplice. È complesso e potrebbe essere una "cosa" diversa da come pensavamo che fosse. Appaiono una serie di domande sollevate anche da Riccardo Dal Ferro nella sua riflessione critica sul pensiero di Marx, a cui proverò a rispondere, e che grosso modo sono: esiste una teoria dello Stato in Marx? E se sì, di quale "tipo" di teoria stiamo parlando? Qual è il suo grado di sviluppo? Implica un "concetto" di Stato?
Le preoccupazioni per il problema dello Stato in Marx avevano forse raggiunto il loro culmine negli anni Sessanta con l'affermazione di Bobbio che non solo Marx non aveva elaborato una teoria dello Stato capitalista, ma non l'aveva nemmeno fatto in relazione al futuro Stato socialista, questo perché il suo interesse centrale era stato il problema del partito.
- Details
- Hits: 1729
L’importanza del comando capitalistico sulla riproduzione sociale
di Federico Chicchi
Note a margine sullo sfruttamento a partire da alcune preziose suggestioni di Christian Marazzi
 I feel so extraordinary
I feel so extraordinary
Something’s got a hold on me
I get this feeling I'm in motion
A sudden sense of liberty
The chances are we’ve gone too far
You took my time and you took my money
Now I fear you've left me standing
True Faith, New Order, 1987
Sporgenze inesauribili della teoria militante
Ci sono luoghi della produzione militante, siano questi teorici o pratici, che non si lasciano assorbire dal crepaccio che lo scorrere del tempo cronologico genera dietro di sé. Tale dimostrazione di vitalità, ad esempio, è quella che illumina il sapere dei cosiddetti insegnamenti classici, quel sapere che continua a interpellarci nonostante tutto, quel sapere resistente ai cambiamenti, ancora necessario a pensare il presente nelle e con le sue contraddizioni. Ma non solo. Esistono a mio avviso frammenti, contributi, lamelle, schegge più difficili da scovare e levigare ma che per questo non sono meno preziosi (quando non indispensabili) per tentare di costruire un bagaglio di sapere militante all’altezza delle sfide del presente. Questo mi porta anche ad affermare che il valore teorico e politico di un sapere militante non è mai definito una volta per tutte e che per questo non può neanche essere approcciato da un fare meramente archeologico. Tra le svariate e possibili motivazioni a sostegno di questa affermazione, ce n’è una credo fondamentale, che voglio provare, molto brevemente, a proporvi di seguito.
- Details
- Hits: 1231

Assassinio Kakhrizadeh, un'altra guerra?
di Fulvio Grimaldi
Nagorno Karabakh – Iran: obiettivo Mosca. Chi, come, perché
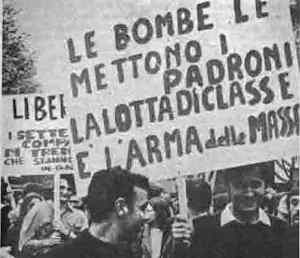 Il Mossad è un’organizzazione criminale con la licenza”
Il Mossad è un’organizzazione criminale con la licenza”
(Tamir Pardo, ex-capo del Mossad)
Attentato, com’è andata davvero
Tra le tante versioni che circolano, quello più attendibile in base a fonti non interessate è esemplificata nella mappa. Per certo non è credibile la fesseria di una mitragliatrice automatica, su un mezzo poi fatto saltare in aria. Operazione in grande stile, invece, con la partecipazione di 62 persone delle quali 12 in azione armata. 1) Il convoglio dello scienziato di tre vetture blindate entra nella rotonda da cui si arriva alla cittadina di Asbard. 2) Salta per aria un’autobomba che abbatte un traliccio, provoca un blackout nell’area e colpisce la vettura di coda. 3) Un’auto Hyundai Santa Fè con 4 passeggeri, quattro motociclette e due cecchini, è appostata al lato opposto. Da qui si apre il fuoco dopo l’esplosione che ha bloccato le macchine.4) Uno del commando trascina Fakhrizadeh dalla macchina e lo finisce sulla strada, dove, infatti, resta una larga pozza di sangue.
Perché il governo di Ahmed Rouhani parla di un’operazione assai meno complessa? Perché si tratta di occultare l’inefficienza dei servizi di sicurezza a protezione dello scienziato, denunciata anche dagli ambienti militari, e l’impressionante grado di infiltrazione di elementi nemici e di collaborazionismo interno. Una debolezza che contrassegna l’intero mandato dell’attuale presidente, espressione, dopo gli anni di Ahmadinejad e nonostante i tentativi di contrasto dei cosiddetti “radicali”, o “conservatori”, di quelli che in Occidente vengono magnificati come “”moderati”. Come spesso succede, la divisione di classe si traduce in divisione geopolitica: da una parte il popolo, antimperialista e per la sua sovranità, dall’altra l’élite, propensa alla consociazione nel segno del mercato senza confini.
- Details
- Hits: 1800
I vizi e le virtù del determinismo marxiano
di Alessandro Barile*
Pubblicato su “Materialismo Storico. Rivista di filosofia, storia e scienze umane", n° 1/2020, a cura di Stefano G. Azzarà, pp. 58-69, licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0
 «Il diciottesimo secolo ha messo in discussione ogni cosa, il diciannovesimo ha il compito di concludere; e conclude con delle realtà; ma realtà che vivono e camminano»
«Il diciottesimo secolo ha messo in discussione ogni cosa, il diciannovesimo ha il compito di concludere; e conclude con delle realtà; ma realtà che vivono e camminano»
(Balzac, Illusioni perdute, 1837-1843)
Attorno al grande problema dell’oggettività, tanto della realtà quanto dei suoi processi sociali, si è istituito un confronto che ha attraversato tutto il marxismo. Oggi il problema ha perso di rilevanza: il campo del marxismo, di per sé residuale, è profondamente venato di soggettivismo nelle sue proposizioni teoriche, e la militanza pensata tutta all’interno di una prassi politica contingente. Un recente volume di Luigi Vinci1 ci ricorda che così non fu per una lunga epoca del movimento operaio. Da Marx fino (almeno) allo scoppio della Grande guerra — e soprattutto lungo tutta l’esperienza della II Internazionale — la teoria politica della socialdemocrazia costruiva la propria forza organizzativa e narrativa pienamente dentro il campo del determinismo storico. Il famigerato “crollismo” altro non era che la fiducia in processi sociali teleologici: il capitalismo era destinato ad essere superato, a prescindere dall’azione del movimento operaio. È quanto asseriva candidamente un marxista rivoluzionario come Plechanov, laddove indicava come «la sociologia non diventa scienza che nella misura in cui perviene a comprendere la comparsa di fini nell’uomo sociale (“teleologia” sociale) come una conseguenza necessaria del processo sociale, condizionato in ultima istanza dal corso dello sviluppo economico»2.
- Details
- Hits: 1619
Ritorna la critica dell'economia politica
di Carlo Magnani
Emiliano Brancaccio, “Non sarà un pranzo di gala. Crisi, catastrofe, rivoluzione”, Meltemi 2020
 Ci sono molte ragioni, specie per chi intende ancora oggi perseguire la via del pensiero critico, per trovare assai utile la lettura dell’ultimo libro dell’economista Emiliano Brancaccio. Il testo è costruito in modo tale da potere essere apprezzato anche da chi non possiede specifiche conoscenze di economia: non si tratta del solito “papers”, come sfotte la categoria Giulio Sapelli, infarcito di inglese e di tabelle micragnose. Siamo convinti che Brancaccio sia anche un ottimo analista economico ma fortunatamente qui non ce lo dimostra, preferendo concentrarsi sui principali nodi di politica economica che attanagliano il presente. Dopo la chiara introduzione del curatore, Giacomo Russo Spena, il lettore incontra tre parti: in primo luogo, una serie di interviste che datano dal 2007 al 2020; poi, i resoconti di confronti che Brancaccio ha intrattenuto in occasioni pubbliche con alcuni autorevoli economisti (spicca su tutti per valore quello con Olivier Blanchard, ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale, ma figurano anche dialoghi con Mario Monti e Romano Prodi); ed infine, un terzo momento è costituito da un recente saggio che costituisce una ideale chiusura teorica di tutto il lavoro.
Ci sono molte ragioni, specie per chi intende ancora oggi perseguire la via del pensiero critico, per trovare assai utile la lettura dell’ultimo libro dell’economista Emiliano Brancaccio. Il testo è costruito in modo tale da potere essere apprezzato anche da chi non possiede specifiche conoscenze di economia: non si tratta del solito “papers”, come sfotte la categoria Giulio Sapelli, infarcito di inglese e di tabelle micragnose. Siamo convinti che Brancaccio sia anche un ottimo analista economico ma fortunatamente qui non ce lo dimostra, preferendo concentrarsi sui principali nodi di politica economica che attanagliano il presente. Dopo la chiara introduzione del curatore, Giacomo Russo Spena, il lettore incontra tre parti: in primo luogo, una serie di interviste che datano dal 2007 al 2020; poi, i resoconti di confronti che Brancaccio ha intrattenuto in occasioni pubbliche con alcuni autorevoli economisti (spicca su tutti per valore quello con Olivier Blanchard, ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale, ma figurano anche dialoghi con Mario Monti e Romano Prodi); ed infine, un terzo momento è costituito da un recente saggio che costituisce una ideale chiusura teorica di tutto il lavoro.
Dovendo sintetizzare in una sola battuta l’intero libro verrebbe da dire: “finalmente ritorna la critica dell’economia politica”, intendendola proprio nel senso più genuinamente marxiano del termine. Si ha l’impressione, ascoltando e leggendo Brancaccio, di ritornare in quei luoghi dove tutto cominciò, di riascoltare quel gergo al contempo scientifico e politico che produsse la critica di classe al capitalismo; di riconnettersi cioè con la consapevolezza teorica che fu alla base di quel vasto mondo che si chiamava movimento operaio.
- Details
- Hits: 2680
Il debito italiano è sostenibile? Facciamo un po’ di chiarezza
di Serena Ionta
 1. Introduzione
1. Introduzione
La crisi sanitaria innescata dal coronavirus è divenuta velocemente una crisi economica, facendo sì che molti Stati avessero la necessità di erogare ingenti risorse per finanziare la spesa pubblica e indirizzare la liquidità necessaria al sistema sanitario e agli operatori economici colpiti.
Come già evidenziato in un articolo precedente, la spesa pubblica può essere finanziata in due modi:
(1) Imposte, tendendo quindi verso un pareggio di bilancio.
(2) Deficit, finanziato da un aumento di debito pubblico o della base monetaria, operazione quest’ultima che rappresenterebbe la cosiddetta monetizzazione.
In questa sede ci si concentrerà principalmente sulla sostenibilità del debito pubblico italiano, attraverso un’analisi basata sui dati sino ad oggi disponibili. L’intento finale è quello di demistificare alcuni luoghi comuni poco fondati.
2. La situazione italiana pre-crisi
Nel caso in cui perdurino deficit non finanziati da moneta appositamente emessa è molto probabile che si presenti nel tempo un’accumulazione di debito: questo è quanto avvenuto in Italia e in altri paesi europei.
- Details
- Hits: 2179

2001-2016: Centralizzazione del capitale e crisi finanziaria, oppure Crisi, da cui centralizzazione del capitale?
di Gianni De Bellis e Mario Fragnito
Osservazioni e critiche sull’omonimo lavoro di Emiliano Brancaccio, docente dell’Università del Sannio, ed altri (Centralization of capital and financial crisis: a global network analysisof corporate control).
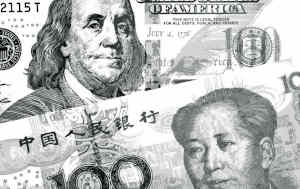
Certo, ricchezza e capitale non si identificano perfettamente; capitale è quella “ricchezza” che è in grado di produrne altra: una villa o uno yacht di lusso sono ricchezza ma non capitale. Però la ricchezza è sempre legata al capitale. Quindi l’idea che il capitale vada sempre concentrandosi nelle mani di chi è già ricco, mentre la maggior parte della popolazione del mondo impoverisce (al di la delle illusioni dei ludopatici e di quanti vengono influenzati fortemente dalle illusioni che il capitalismo potentemente semina ad ogni piè sospinto) soprattutto dopo la crisi di un decennio e mezzo fa, ormai appartiene non solo agli ambienti marxisti, ma va abbastanza oltre. E ciò anche nelle ricche nazioni imperialiste, dove ormai la povertà colpisce strati sempre più ampi della popolazione. Il fenomeno sembra così evidente che sembrano strane le prime parole con cui Emiliano Brancaccio e gli altri ricercatori aprono il loro scritto:
- Details
- Hits: 1292
Il ritorno di Engels
di John Bellamy Foster
Friedrich Engels spesso viene accusato di aver dirottato il marxismo su un terreno troppo deterministico. Ma le sue analisi su rapporto tra evoluzione, lotta di classe e ambiente ne hanno fatto un anticipatore dell'eco-socialismo
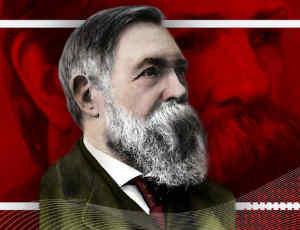 Pochi sodalizi politici e intellettuali possono competere con quello di Karl Marx e Friedrich Engels. Divennero famosi come co-autori del Manifesto del Partito comunista nel 1848, entrambi prendendo parte alle rivoluzioni sociali di quell’anno, ma anche di due opere precedenti: La Sacra Famiglia nel 1845 e L’ideologia tedesca nel 1846.
Pochi sodalizi politici e intellettuali possono competere con quello di Karl Marx e Friedrich Engels. Divennero famosi come co-autori del Manifesto del Partito comunista nel 1848, entrambi prendendo parte alle rivoluzioni sociali di quell’anno, ma anche di due opere precedenti: La Sacra Famiglia nel 1845 e L’ideologia tedesca nel 1846.
Verso la fine degli anni Settanta dell’Ottocento, quando i due socialisti scientifici finalmente poterono vivere in stretta vicinanza e discutere tra loro ogni giorno, spesso camminavano avanti e indietro nello studio di Marx, ciascuno dalla propria parte della stanza, solcando ripetutamente il pavimento mentre giravano sui tacchi e discutevano di idee, piani e progetti.
Spesso leggevano insieme brani dai loro lavori in corso. Engels lesse a Marx l’intero manoscritto del suo Anti-Dühring (al quale Marx contribuì con un capitolo) prima della sua pubblicazione. Marx scrisse un’introduzione a L’evoluzione del socialismo dall’utopia alla scienza di Engels. Dopo la morte di Marx nel 1883, Engels preparò i volumi due e tre del Capitale per la pubblicazione dalle bozze che il suo amico aveva lasciato. Se Engels, come riconobbe per primo, si trovava all’ombra di Marx, era nondimeno un gigante intellettuale e politico a pieno titolo.
Eppure per decenni gli accademici hanno suggerito che Engels avesse declassato e distorto il pensiero di Marx. Come ha osservato criticamente lo scienziato politico John L. Stanley nel suo postumo Mainlining Marx nel 2002, i tentativi di separare Marx da Engels – al di là del fatto ovvio che erano due individui diversi con interessi e talenti differenti – hanno teso sempre più a dissociare Engels, visto come la fonte di tutto ciò che è riprovevole nel marxismo, da Marx, visto come l’epitome dell’uomo di lettere civilizzato, e lui stesso un non-marxista.
- Details
- Hits: 1691
Sulla metafora del nemico invisibile
di Flavio Luzi
 Nel chiasso mediatico generatosi negli ultimi mesi, è difficile non accorgersi della diffusa tendenza della classe dirigente e dell’opinione pubblica a ricorrere al lessico militare in riferimento alla situazione scaturita dalla diffusione del Covid-19: l’epidemia – o, meglio, la pandemia – non sarebbe altro che una “guerra” nella quale si trova coinvolto l’intero pianeta (la “terza o quarta guerra mondiale” o la “prima guerra globale”); le zone ad alto potenziale di rischio, sottoposte a limitazioni, non sarebbero altro che delle “zone rosse” e i reparti di terapia intensiva, a loro volta, delle “trincee”. Si è addirittura arrivati a concepire gli operatori sanitari come degli “eserciti” con i loro feriti e il loro caduti. È una vecchia abitudine: già Susan Sontag l’aveva messa in evidenza tra la fine degli anni Settanta e la conclusione degli anni Ottanta, nei testi Illness as Metaphor e Aids and its Metaphors, datando l’esordio delle metafore belliche in ambito bio-medico alla seconda metà dell’Ottocento. L’inizio del pensiero bio-medico moderno andrebbe ricondotto proprio al focalizzarsi di queste metafore non più, genericamente, sulla malattia in quanto tale, bensì su determinati organismi patogeni visibili all’occhio umano solo con l’ausilio di particolari strumenti, per esempio un microscopio.
Nel chiasso mediatico generatosi negli ultimi mesi, è difficile non accorgersi della diffusa tendenza della classe dirigente e dell’opinione pubblica a ricorrere al lessico militare in riferimento alla situazione scaturita dalla diffusione del Covid-19: l’epidemia – o, meglio, la pandemia – non sarebbe altro che una “guerra” nella quale si trova coinvolto l’intero pianeta (la “terza o quarta guerra mondiale” o la “prima guerra globale”); le zone ad alto potenziale di rischio, sottoposte a limitazioni, non sarebbero altro che delle “zone rosse” e i reparti di terapia intensiva, a loro volta, delle “trincee”. Si è addirittura arrivati a concepire gli operatori sanitari come degli “eserciti” con i loro feriti e il loro caduti. È una vecchia abitudine: già Susan Sontag l’aveva messa in evidenza tra la fine degli anni Settanta e la conclusione degli anni Ottanta, nei testi Illness as Metaphor e Aids and its Metaphors, datando l’esordio delle metafore belliche in ambito bio-medico alla seconda metà dell’Ottocento. L’inizio del pensiero bio-medico moderno andrebbe ricondotto proprio al focalizzarsi di queste metafore non più, genericamente, sulla malattia in quanto tale, bensì su determinati organismi patogeni visibili all’occhio umano solo con l’ausilio di particolari strumenti, per esempio un microscopio.
Ma che tipo di guerra potrà mai essere una guerra condotta contro un virus? Come si nota leggendo Carl Schmitt, la guerra si trova all’interno di una relazione circolare, di presupposizione reciproca, con l’inimicizia.
Page 210 of 612