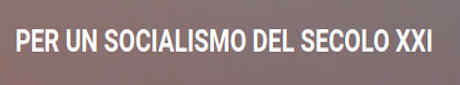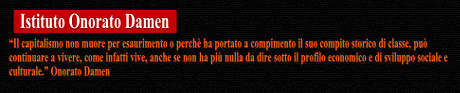Fai una donazione
Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________
- Details
- Hits: 2084
Il concetto di nazione. Ovvero, una patata bollente per il marxismo
di Carlo Formenti
 Spulciando il catalogo online di El Viejo Topo https://www.elviejotopo.com/ editore storico della sinistra iberica (al quale devo due edizioni di altrettanti miei saggi e la conoscenza di importanti materiali teorici in lingua spagnola), mi sono imbattuto in un titolo che ha catturato la mia attenzione: La base material de la nación. El concepto de nación en Marx y Engels, di Carlos Barros (dal profilo biografico dell’autore ho appurato che si tratta di uno storico medievista, fra i fondatori del partito comunista galiziano e membro del comitato centrale del PCE).
Spulciando il catalogo online di El Viejo Topo https://www.elviejotopo.com/ editore storico della sinistra iberica (al quale devo due edizioni di altrettanti miei saggi e la conoscenza di importanti materiali teorici in lingua spagnola), mi sono imbattuto in un titolo che ha catturato la mia attenzione: La base material de la nación. El concepto de nación en Marx y Engels, di Carlos Barros (dal profilo biografico dell’autore ho appurato che si tratta di uno storico medievista, fra i fondatori del partito comunista galiziano e membro del comitato centrale del PCE).
A intrigarmi, ancor più dell’argomento scottante (la questione nazionale è sempre stata fonte di problemi irrisolti e di conflitti teorici e ideologici in campo marxista), è stato il sottotitolo, il quale, come mi è stato confermato da un breve video di presentazione del libro registrato dall’autore, allude all’esistenza di un discorso sistematico e coerente, se non di una vera e propria teoria, dei due fondatori del materialismo storico sull’argomento in questione. La cosa mi è parsa sorprendente, non essendo a conoscenza di scritti di Marx ed Engels dedicati alla questione nazionale di peso e dimensioni paragonabili a quelli di altri mostri sacri del pensiero socialcomunista, Lenin su tutti (1).
Tuttavia, dopo avere acquistato e letto l’e.book di Barros, ho avuto conferma che il mio difetto di informazione non è frutto di disattenzione o ignoranza: effettivamente Marx ed Engels non hanno scritto nulla di sistematico sul concetto di nazione.
- Details
- Hits: 1104
Le Lezioni di Napoleoni sul capitolo sesto inedito di Marx
di Leo Essen
 Nella primavera del 1971 Claudio Napoleoni tiene alcune lezioni sul Capitolo sesto inedito di Marx. L’anno successivo le Lezioni vengono pubblicate da Boringhieri. Riscuotono quasi immediatamente un grande successo, tanto che nel 74, 75 e 79 vengono ristampate. Poi cala il sipario. L’edizione del 79 si trova ancora in vendita nel 1990.
Nella primavera del 1971 Claudio Napoleoni tiene alcune lezioni sul Capitolo sesto inedito di Marx. L’anno successivo le Lezioni vengono pubblicate da Boringhieri. Riscuotono quasi immediatamente un grande successo, tanto che nel 74, 75 e 79 vengono ristampate. Poi cala il sipario. L’edizione del 79 si trova ancora in vendita nel 1990.
Il testo pubblicato, che riproduce la trascrizione delle lezioni tenute all’UniTo, è sorprendente, sia per la chiarezza, sia per il rigore filologico. Una vera rarità nel panorama della ricerca universitaria italiana. Leggerlo rende la sensazione di partecipare a un seminario. La sua influenza, meritata, si è estesa a tutta la galassia della sinistra radicale – marxista e non marxista. L’andamento ripetitivo, tipico delle lezioni universitaria, invece di appesantire la lettura, ha quasi un effetto ipnotico. Di più, suscita quella sensazione di stupore che solo le grandi opere riescono a suscitare.
Il tema del libro è riassunto in poche righe nella Lezione settima, dove Napoleoni dice che uno dei modi attraverso i quali Marx stabilisce la differenza tra la produzione capitalistica e altri modi di produzione è questo: che mentre altri modi di produzione sono indirizzati al consumo di qualcuno, viceversa la produzione capitalistica è produzione di ricchezza astratta, ossia ricchezza destinata a riconvertirsi in ricchezza addizionale; con la conseguenza che, mentre nel primo caso il valore-uso ha una rilevanza decisiva – proprio perché il processo è finalizzato al consumo -, nel secondo caso, il valore-uso diventa irrilevante, non in quanto scompare, perché questo naturalmente è impossibile, ma in quanto il valore-uso diventa un semplice supporto materiale per la ricchezza come tale. Ricchezza come tale, la cui espressione formale è il valore, che ha poi nel valore-scambio la sua necessaria rappresentazione o espressione fenomenica.
- Details
- Hits: 2674
Quando finirà il Kali Yuga? Apocalisse e catastrofe dal Novecento a oggi
di Adriano Ercolani
 Il Novecento è stato un secolo attraversato da una profonda inquietudine apocalittica. In filosofia da Heidegger a Deleuze e Derrida, da Kojève a Fukuyama, passando per l’esistenzialismo, nella riflessione politica e sociologica da Pasolini a Baudrillard, in poesia da T.S.Eliot agli Ermetici e ai New Apocaliptycs inglesi, nell’arte da Munch a Bacon, nella letteratura attraverso le distopie antiutopistiche di Orwell, Huxley, Dick, Ballard, nella musica popolare di canzoni come A Hard Rain’s a-Gonna Fall di Bob Dylan o Eve of Destruction di Barry McGuire, nel cinema di massa con opere d’autore quali Il Dottor Stranamore di Kubrick, Melancholia di Lars Von Trier, I figli degli uomini di Cuarón, ma anche l’intero filone di film post-apocalittici dominante nel mercato americano. Soprattutto questo sentimento si manifesta più che mai nella ricerca spirituale, riferendosi non solo alla prospettiva escatologica di maestri orientali dal grande seguito come Shri Mataji Nirmala Devi e Ramana Maharshi, ma anche al pensiero di figure considerate fuori dagli schemi del calibro di Quinzio e Ceronetti. In queste e moltissime altre opere, in tutti i campi del sapere e della sfera creativa, si respira il senso di una fine ineluttabile, di una necessaria catastofe palingenetica.
Il Novecento è stato un secolo attraversato da una profonda inquietudine apocalittica. In filosofia da Heidegger a Deleuze e Derrida, da Kojève a Fukuyama, passando per l’esistenzialismo, nella riflessione politica e sociologica da Pasolini a Baudrillard, in poesia da T.S.Eliot agli Ermetici e ai New Apocaliptycs inglesi, nell’arte da Munch a Bacon, nella letteratura attraverso le distopie antiutopistiche di Orwell, Huxley, Dick, Ballard, nella musica popolare di canzoni come A Hard Rain’s a-Gonna Fall di Bob Dylan o Eve of Destruction di Barry McGuire, nel cinema di massa con opere d’autore quali Il Dottor Stranamore di Kubrick, Melancholia di Lars Von Trier, I figli degli uomini di Cuarón, ma anche l’intero filone di film post-apocalittici dominante nel mercato americano. Soprattutto questo sentimento si manifesta più che mai nella ricerca spirituale, riferendosi non solo alla prospettiva escatologica di maestri orientali dal grande seguito come Shri Mataji Nirmala Devi e Ramana Maharshi, ma anche al pensiero di figure considerate fuori dagli schemi del calibro di Quinzio e Ceronetti. In queste e moltissime altre opere, in tutti i campi del sapere e della sfera creativa, si respira il senso di una fine ineluttabile, di una necessaria catastofe palingenetica.
Ciò si è manifestato talvolta come anticipazione profetica, l’anelito al potere sacro della violenza che animava le avanguardie storiche in mezzo ai due conflitti bellici, in altri casi invece si è tradotta nella contemplazione delle macerie dopo il disastro, esemplificata dall’arte giapponese del Dopoguerra.
- Details
- Hits: 7154
L’affare Covid. Tra Emergenza spettacolare ed epidemia dolosa
di Un amico di Winston Smith
 Un anno di emergenza. Stato e tecnocrati sono riusciti finora a creare una sorta di “cerchio perfetto”: se la curva dei contagi cala, è merito del governo; se cresce, è per l’allentamento delle restrizioni e lo scarso senso di responsabilità della gente (e vai con i servizi mediatici sempre-uguali sui Navigli, sullo shopping, sulla movida…). Nel caso in cui fossero minimamente organizzate le cure domiciliari per i malati di Covid, il merito verrebbe probabilmente attribuito alle vaccinazioni; se queste ultime risultassero ampiamente inefficaci, la colpa sarebbe comunque del virus con le sue “diaboliche” e imprevedibili mutazioni. Anche la denuncia delle inefficienze della Sanità e la rivendicazione di misure governative sganciate dalla logica del profitto rientrano perfettamente nel cerchio.
Un anno di emergenza. Stato e tecnocrati sono riusciti finora a creare una sorta di “cerchio perfetto”: se la curva dei contagi cala, è merito del governo; se cresce, è per l’allentamento delle restrizioni e lo scarso senso di responsabilità della gente (e vai con i servizi mediatici sempre-uguali sui Navigli, sullo shopping, sulla movida…). Nel caso in cui fossero minimamente organizzate le cure domiciliari per i malati di Covid, il merito verrebbe probabilmente attribuito alle vaccinazioni; se queste ultime risultassero ampiamente inefficaci, la colpa sarebbe comunque del virus con le sue “diaboliche” e imprevedibili mutazioni. Anche la denuncia delle inefficienze della Sanità e la rivendicazione di misure governative sganciate dalla logica del profitto rientrano perfettamente nel cerchio.
Se tanti aspetti di ciò che è successo e che segnerà a lungo le nostre vite sono stati affrontati – cause strutturali del “salto di specie” dei virus, incompatibilità tra tecno-industria e salute, accelerazione verso una società digitalizzata, militarizzazione, sperimentazione biomedica di massa …– non avevamo ancora preso di petto l’“affare Covid”. Si è analizzato, cioè, ciò che Stato e tecnocrati hanno realizzato a partire dall’epidemia come dato di fatto, non le scelte politico-sanitarie ben precise che hanno fatto di quel dato una Emergenza.
È ciò che si propone questa piccola, ma densa e approfondita, “contro-inchiesta arrabbiata” realizzata da un compagno. Si tratta di un testo “mostruoso”. L’idea di una Emergenza “costruita ad arte” è un pensiero che facciamo fatica a far nostro, ma che non possiamo evitare di prendere in considerazione. Una tesi che potrebbe scandalizzare persone a noi vicine e risultare fin troppo familiare a persone che vogliamo invece tenere lontane.
- Details
- Hits: 1121
“Agitando i pugni contro Cina e Russia, l’America va verso la catastrofe”
di Fabrizio Poggi
 Putin è “un killer” e Xi “un tagliagole” ha stabilito Joe-Burisma-Biden; Mosca «destabilizza la situazione nei paesi vicini», evoca il segretario NATO Jens Stoltenberg; e il capo della diplomazia UE Josep Borrell e il suo superiore, il segretario di stato yankee Antony Blinken tuonano contro l’atteggiamento «di sfida della Russia, inclusa la persistente aggressione contro Ucraina e Georgia», ecc. ecc.
Putin è “un killer” e Xi “un tagliagole” ha stabilito Joe-Burisma-Biden; Mosca «destabilizza la situazione nei paesi vicini», evoca il segretario NATO Jens Stoltenberg; e il capo della diplomazia UE Josep Borrell e il suo superiore, il segretario di stato yankee Antony Blinken tuonano contro l’atteggiamento «di sfida della Russia, inclusa la persistente aggressione contro Ucraina e Georgia», ecc. ecc.
La dichiarazione di guerra di USA e vassalli è consegnata: una guerra energetica alla Russia, soprattutto per il “North stream 2”, e una guerra commerciale alla Cina. Mosca ha risposto per ora (annunciate contromisure anche alle sanzioni imposte dal Canada) in maniera non particolarmente dura; più tempestiva e determinata Pechino.
Il confronto tra USA e Russia ha dunque raggiunto una nuova fase. La prima fase, di “accumulazione della tensione”, scrive Aleksandr Khaldej su Svobodnaja pressa, ha coperto il periodo tra il 2000 e il 2007; dal 2007 al 2014, la seconda fase, di “contrapposizione”; quindi, la terza, avviata con gli eventi in Siria e Ucraina, è già quella della guerra, quando il «desiderio di danneggiare il nemico non è più commisurato al danno verso se stessi. Niente trattative in questa fase; ora parlano i cannoni: non importa se di ferro o mediatici».
Poi, di incidente in incidente, si arriva alla quarta fase, quella del “equilibrio di posizione” e della “stanchezza di guerra“, dopo di che sarà forse possibile tornare alle trattative.
- Details
- Hits: 1270
Marx e il socialismo del XXI secolo, a partire dallo spazio dello sfruttamento
Giulia Rustichelli intervista Luciano Vasapollo
Vasapollo: “non dal tempo ma dallo spazio dei Sud il riscatto degli esclusi”. Marx e il socialismo nel XXI secolo, con Bolívar e Martí, Gramsci e Che, Fidel e Chavez. Importante conferenza ieri di Luciano Vasapollo promossa dalla Rete dei Comunisti con le testimonianze di compagni tunisini del Comitè de défense du peuple de Tunisie e compagni marocchini de La Voie Démocratique. L’economista ritiene che l’incontro tra i popoli del Mediterraneo può rappresentare il momento storico per un rilancio dell’ideologia marxista nella concretezza di una situazione di evidente e forte ingiustizia che aspetta un riscatto
 La situazione che vivono i giovani nell’altra sponda del Mediterraneo, con le dovute differenze, non appare troppo lontana dalla situazione di precarietà che esperiscono i giovani nelle periferie dell’Unione Europea: migliaia di questi salpano dal Nord Africa per giungere sulla costa Nord del Mediterraneo al fine di migliorare le proprie condizioni salvo poi ritrovarsi emarginati e sfruttati, mentre numerosi loro coeatanei italiani, spagnoli e greci emigrano verso i paesi del centro Europa. Sono le Periferie che vengono derubate dei propri beni, delle ricchezze e dei giovani, il cui futuro viene devastato.
La situazione che vivono i giovani nell’altra sponda del Mediterraneo, con le dovute differenze, non appare troppo lontana dalla situazione di precarietà che esperiscono i giovani nelle periferie dell’Unione Europea: migliaia di questi salpano dal Nord Africa per giungere sulla costa Nord del Mediterraneo al fine di migliorare le proprie condizioni salvo poi ritrovarsi emarginati e sfruttati, mentre numerosi loro coeatanei italiani, spagnoli e greci emigrano verso i paesi del centro Europa. Sono le Periferie che vengono derubate dei propri beni, delle ricchezze e dei giovani, il cui futuro viene devastato.
Luciano Vasapollo, professore di politica economica alla Università La Sapienza di Roma e membro della segreteria nazionale della Rete dei Comunisti, amico oltre che firma autorevole di questo giornale online, ritiene che l’incontro di solidarietà e complementarietà tra i popoli del Mediterraneo possa rappresentare una rottura di classe storica per l‘attualizzazione dell’ideologia marxista nella sua espressione gramsciana e per il socialismo nel XXI secolo dando l’occasione concreta per un riscatto da condizioni di grave ingiustizia proprio mentre in questo inizio 2021 la situazione della sponda sud del Mediterraneo torna ad essere infuocata.
- Details
- Hits: 1546
Lavoro e tempo di lavoro in Marx
di Franco Piperno
Pubblichiamo per gentile concessione dell'autore
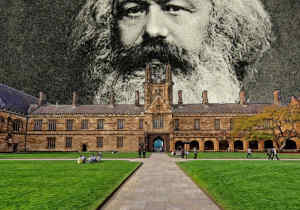 I) Cento anni dopo.
I) Cento anni dopo.
A più di un secolo dalla morte, Marx viene trattato, tanto nell’opinione quanto nell’accademia, come ”un cane morto”. La situazione è quindi ottima per riprendere lo studio dei suoi testi, per rifare i conti con lui. Procedere su questa strada, comporta, in primo luogo, sgombrare il terreno dall’ovvio, rifiutare la relazione di causalità tra l’attuale discredito di cui gode il Nostro ed il crollo del socialismo di stato nell’Europa dell’Est. L’inconsistenza logica della dottrina marxista, così come la cattiva astrazione sulla quale si fondava la legittimità dei regimi socialistici, erano nascoste solo agli occhi di chi non voleva vedere. Tutto era chiaro già da prima, da molto prima.
A testimonianza che il senso comune non ha atteso il crollo del muro di Berlino per formulare un giudizio– sulla teoria del socialismo scientifico e sulla natura del socialismo di stato– riproponiamo, qui di seguito, un breve commento a riguardo, scritto nel 1983, in occasione del centenario della morte di Marx, quando il Paese dei Soviet esisteva ancora (1).
“La celebrazione di K.Marx, nel centenario della morte, costituisce quel piccolo dettaglio più illuminante che un intero discorso. Innanzi, tutto chi celebra chi? Giacche’ bisognerà bene augurarsi che esista qualche differenza tra il Marx celebrato dal compagno Andropov, attuale primo ministro sovietico ed ex-capo del K.G.B.; e quello di cui si ricorda il militante dell’Autonomia nelle prigioni italiane.
- Details
- Hits: 1654
Byung-Chul-Han. La società senza dolore
di Davide Sisto
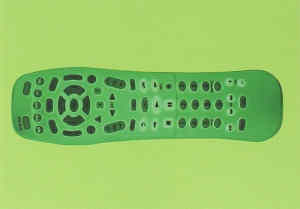 “Il filosofo tedesco più letto nel mondo” (El Pais), “La punta di diamante di una nuova, accessibile filosofia tedesca” (The Guardian), “Uno dei più importanti filosofi contemporanei” (Avvenire). Byung-Chul Han è, senza dubbio, uno dei pensatori attualmente più apprezzati a livello internazionale. I suoi libri sono letti e studiati non solo dagli addetti ai lavori nel campo della filosofia, ma in ogni settore disciplinare intento a decifrare con lucidità le caratteristiche del presente. Addirittura, Der Spiegel usa il termine “gratitudine” per l’audacia con cui il filosofo sudcoreano cerca di interpretare quella complessità del reale che, quotidianamente, rischia di sopraffarci e di soffocarci.
“Il filosofo tedesco più letto nel mondo” (El Pais), “La punta di diamante di una nuova, accessibile filosofia tedesca” (The Guardian), “Uno dei più importanti filosofi contemporanei” (Avvenire). Byung-Chul Han è, senza dubbio, uno dei pensatori attualmente più apprezzati a livello internazionale. I suoi libri sono letti e studiati non solo dagli addetti ai lavori nel campo della filosofia, ma in ogni settore disciplinare intento a decifrare con lucidità le caratteristiche del presente. Addirittura, Der Spiegel usa il termine “gratitudine” per l’audacia con cui il filosofo sudcoreano cerca di interpretare quella complessità del reale che, quotidianamente, rischia di sopraffarci e di soffocarci.
Il segreto dell’universale entusiasmo nei confronti di Han è riconducibile, soprattutto, alla sua capacità di vestire plausibilmente i panni di un Günther Anders del XXI secolo, quindi di un critico radicale, pessimista e apocalittico delle principali tendenze politiche, sociali, culturali e tecnologiche odierne, adottando però uno stile di scrittura tanto cristallino quanto fascinoso e attraente. Le proposizioni perlopiù stringate, che connotano la forma dei suoi brevi pamphlet polemici, celano una scrupolosa ricerca dell’immagine perfetta per togliere il fiato al lettore, nonché del gioco di parole più seducente che, facendoci progressivamente aumentare lo stato d’ansia, stimoli in noi il lato maggiormente critico e censore del presente. Non fa eccezione il nuovo pamphlet, intitolato in modo enfatico Una società senza dolore, il quale addirittura estremizza la forma stilistica adottata nei libri precedenti. Ne è senza dubbio complice la particolare delicatezza del tema scelto da Han: il rapporto assai problematico tra il mondo contemporaneo e il dolore.
- Details
- Hits: 3350
Klaus Schawb e Thierry Malleret, “Covid 19: The great reset”
di Alessandro Visalli
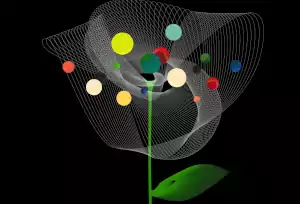 Il prof Schwab è un ingegnere che ha anche un dottorato in economia alla famosa Università di Friburgo, in pratica la patria dell’ordoliberalesimo, con un master in Public Administration ad Harvard, fondatore del Word Economic Forum[1] ed autore di un libro di grande successo come “The Fourth Industrial Revolution” nel 2016. Si tratta, insomma, di una persona con un curriculum accademico indiscutibile, apprezzabilmente interdisciplinare, e di certissima derivazione ideologica-culturale. Uno dei papi del capitalismo contemporaneo, insomma.
Il prof Schwab è un ingegnere che ha anche un dottorato in economia alla famosa Università di Friburgo, in pratica la patria dell’ordoliberalesimo, con un master in Public Administration ad Harvard, fondatore del Word Economic Forum[1] ed autore di un libro di grande successo come “The Fourth Industrial Revolution” nel 2016. Si tratta, insomma, di una persona con un curriculum accademico indiscutibile, apprezzabilmente interdisciplinare, e di certissima derivazione ideologica-culturale. Uno dei papi del capitalismo contemporaneo, insomma.
Thierri Malleret è più giovane, sulle sue spalle sarà caduta la redazione di gran parte del libro. Si occupa di analisi predittiva (una remunerante specializzazione) e di Global Risk al Forum. Educato alla Sorbona in scienze sociali e specializzato ad Oxford in storia dell’economia (master) ed economia (dottorato). Si è mosso tra banche d’affari, think thank, impegni accademici e servizio presso il primo ministro francese.
Questo libro fa parte di una proliferante letteratura. Un tipo di letteratura divulgativa ed esortativa, molto generica e contemporaneamente molto larga nella visione, fatta per tradursi in presentazioni da convegno attraenti e stimolanti, dirette ad un pubblico di manager e imprenditori che hanno bisogno di sentirsi consapevoli, aggiornati e progressisti con poco sforzo. Una lettura da weekend sul bordo della piscina.
- Details
- Hits: 1589
L’urbanesimo rivoluzionario e la critica della vita quotidiana della Comune di Parigi
di Francesco Biagi
[La redazione di Thomas Project pubblica in forma estesa l’intervento orale di Francesco Biagi intervenuto nel convegno online “La Comune di Parigi 150 anni dopo” (qui il video completo del convegno organizzato dal Partito della Rifondazione Comunista). Una versione più breve di questo testo sarà pubblicata la prossima settimana, in un volume che raccoglie gli atti per le edizioni della rivista settimanale “Left”]
 Ogni politica di emancipazione deve puntare a distruggere l’apparenza “dell’ordine naturale”, deve rivelare che quello che ci viene presentato come necessario e inevitabile altro non è che una contingenza, deve insomma dimostrare che quanto abbiamo finora reputato impossibile è, al contrario, a portata di mano. (Mark Fisher, Realismo Capitalista, p. 53)
Ogni politica di emancipazione deve puntare a distruggere l’apparenza “dell’ordine naturale”, deve rivelare che quello che ci viene presentato come necessario e inevitabile altro non è che una contingenza, deve insomma dimostrare che quanto abbiamo finora reputato impossibile è, al contrario, a portata di mano. (Mark Fisher, Realismo Capitalista, p. 53)
In questo intervento cercherò di esporre brevemente l’innovativa interpretazione che Henri Lefebvre ha dato della Comune di Parigi. Non c’è qui lo spazio per raccontare l’importanza dell’autore ancora troppo ignorato nel dibattito marxista italiano, ma ci basti pensare che nella sua vita si occupò di riattualizzare il contributo di Marx ed Engels alla luce dei problemi posti dalla modernità capitalistica lungo il XX secolo. Mi concentrerò in modo particolare sull’evento della Comune in quanto (1) “rivoluzione urbana” capace di sovvertire l’oppressione di classe imposta a livello spaziale e urbanistico e in quanto (2) possibilità realizzata di trasformazione concreta della vita quotidiana grazie all’agire politico del movimento operaio. È necessaria tuttavia un’altra piccola postilla: le riflessioni di Lefebvre che qui espongo, come vedremo, sono fortemente debitrici delle discussioni che l’autore ha intrattenuto con Guy Debord e l’Internazionale Situazionista.
- Details
- Hits: 1188

Le differenze del capitale. Razza, genere, antagonismo, compatibilità
di Anna Curcio
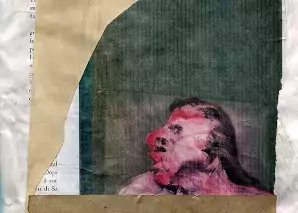 L’ordine del discorso femminista e antirazzista ha ormai conquistato il mainstream, dal livello mediatico a quello politico-istituzionale. L’elezione di Kamala Harris, o il passaggio di Angela Davis da ricercata dall’Fbi a una delle cento donne più influenti secondo il «Time», ci parlano di qualcosa più specifico e profondo del semplice pinkwashing: qualcosa che chiama in causa le forme del comando capitalistico, che adesso invoca le attitudini del lavoro femminile (mai naturali e sempre storicamente determinate), dalla cura alle relazioni. In questo ricco e denso contributo, Anna Curcio propone una riflessione per ripercorre il rapporto storico che lega razza e genere al processo del capitale e interrogare, tra antagonismo e compatibilità capitalistica, la lotta femminista e antirazzista oggi.
L’ordine del discorso femminista e antirazzista ha ormai conquistato il mainstream, dal livello mediatico a quello politico-istituzionale. L’elezione di Kamala Harris, o il passaggio di Angela Davis da ricercata dall’Fbi a una delle cento donne più influenti secondo il «Time», ci parlano di qualcosa più specifico e profondo del semplice pinkwashing: qualcosa che chiama in causa le forme del comando capitalistico, che adesso invoca le attitudini del lavoro femminile (mai naturali e sempre storicamente determinate), dalla cura alle relazioni. In questo ricco e denso contributo, Anna Curcio propone una riflessione per ripercorre il rapporto storico che lega razza e genere al processo del capitale e interrogare, tra antagonismo e compatibilità capitalistica, la lotta femminista e antirazzista oggi.
* * * *
Negli ultimi tempi, la nostra attenzione è stata con insistenza sollecitata da questioni che qui per sintesi chiamerò di razza e genere, riservandomi di ritornare sui due termini nel corso del testo. Si tratta di sollecitazioni di segno diverso e finanche opposto, che interrogano inequivocabilmente la pratica teorica dell’antirazzismo e della lotta femminista e pongono, mi pare, l’urgenza di una riflessione.
La razza e il razzismo continuano a produrre violenza e morte, non solo negli Stati Uniti e lungo i confini nazionali, la violenza di genere ha assunto tale ricorsività che è stato coniato il termine «femminicidio». La pandemia ha seminato morte, paura e impoverimento in maniera disproporzionale lungo le gerarchie della razza e le donne sono state le più colpite dall’ondata di licenziamenti innescati dalla crisi sanitaria, quelle su cui maggiormente si è riversata la violenta riorganizzazione della riproduzione.
- Details
- Hits: 1312
La questione sindacale e il sindacalismo alternativo in questa fase
di Michele Castaldo
 Senza girarci troppo intorno cerchiamo di andare al cuore del problema: la questione sindacale non è una fra le tante, ma è la questione delle questioni inerente il rapporto del proletariato, cioè il produttore di valore, col capitale. Detto rapporto non si presenta sempre allo stesso modo ma segue l’andamento dell’accumulazione capitalistica, l’estensione del modo di produzione, le trasformazioni tecnologiche dei mezzi di produzione, il rapporto della concorrenza fra le merci comprese le merci operaie e la concorrenza al loro interno. Su tale questione l’insieme della sinistra si è rotta parecchi denti senza mai riuscire a venirne a capo per un vizio d’origine mai superato, quello di non mettere al centro il soggetto-agente, che è il proletariato, e la sua azione dipendente dall’andamento del modo di produzione.
Senza girarci troppo intorno cerchiamo di andare al cuore del problema: la questione sindacale non è una fra le tante, ma è la questione delle questioni inerente il rapporto del proletariato, cioè il produttore di valore, col capitale. Detto rapporto non si presenta sempre allo stesso modo ma segue l’andamento dell’accumulazione capitalistica, l’estensione del modo di produzione, le trasformazioni tecnologiche dei mezzi di produzione, il rapporto della concorrenza fra le merci comprese le merci operaie e la concorrenza al loro interno. Su tale questione l’insieme della sinistra si è rotta parecchi denti senza mai riuscire a venirne a capo per un vizio d’origine mai superato, quello di non mettere al centro il soggetto-agente, che è il proletariato, e la sua azione dipendente dall’andamento del modo di produzione.
Queste note sono motivate da alcuni fatti che stanno accadendo in Italia e nel settore specifico della Logistica, ovvero il trasferimento delle merci attraverso colossi del settore come Amazon, ad esempio, ma che rivestono caratteri generali della contrattazione tra la merce proletaria e il capitalista, ovverossia quella che storicamente si è definita come la questione sindacale.
Dal momento che in Italia, all’interno di questo settore, è emersa la necessità di organizzarsi dei lavoratori per lo più immigrati e di colore, trovando in alcuni militanti dell’estrema sinistra residuale degli anni ’70 del secolo scorso, la disponibilità a farlo, si è costituito una decina d’anni fa un piccolo sindacato, il SI Cobas, che è balzato sulla scena perché per tutto questo periodo ha saputo tenere testa al padronato del settore e alla più brutale repressione da parte delle istituzioni dello Stato democratico italiano.
- Details
- Hits: 1175
Inside Marx. Viaggio al fondo del pianeta. Cronache marXZiane n. 3
di Giorgio Gattei
 Sono stato trasportato sul pianeta Marx dall’astronave marxziana “La Grundrisse” nel 1968 e laggiù ho vissuto per più di mezzo secolo, interessandomi soprattutto alla sua composizione geologica costituita da una “crosta” di Prezzi di mercato, da un “mantello” di Prezzi naturali/Prezzi di produzione e da un “nucleo” di Valore, come ho raccontato nella Cronaca precedente. Però sulla sostanza del Valore le congetture teoriche, nell’impossibilità di arrivare fino al nucleo, si erano nel tempo così ingarbugliate che il governo marxziano ha deciso di organizzare una spedizione scientifica apposita per verificare come andassero le cose laggiù. La spedizione è stata affidata ad un esploratore di qualità come Piero Sraffa (che peraltro non era nemmeno un marxziano: era chiamato l’“Uomo dalla luna” per il ritratto che una volta aveva dato di sè scrivendo che, «se un uomo caduto dalla luna sulla terra registrasse l’ammontare delle cose consumate in ogni impresa e le quantità prodotte da ogni impresa durante un anno, ne potrebbe dedurre a quali valori le merci devono essere vendute, se il tasso di profitto deve essere uniforme e il processo di produzione ripetuto: le equazioni mostrerebbero così che le condizioni dello scambio sono interamente determinate dalle condizioni della produzione»).
Sono stato trasportato sul pianeta Marx dall’astronave marxziana “La Grundrisse” nel 1968 e laggiù ho vissuto per più di mezzo secolo, interessandomi soprattutto alla sua composizione geologica costituita da una “crosta” di Prezzi di mercato, da un “mantello” di Prezzi naturali/Prezzi di produzione e da un “nucleo” di Valore, come ho raccontato nella Cronaca precedente. Però sulla sostanza del Valore le congetture teoriche, nell’impossibilità di arrivare fino al nucleo, si erano nel tempo così ingarbugliate che il governo marxziano ha deciso di organizzare una spedizione scientifica apposita per verificare come andassero le cose laggiù. La spedizione è stata affidata ad un esploratore di qualità come Piero Sraffa (che peraltro non era nemmeno un marxziano: era chiamato l’“Uomo dalla luna” per il ritratto che una volta aveva dato di sè scrivendo che, «se un uomo caduto dalla luna sulla terra registrasse l’ammontare delle cose consumate in ogni impresa e le quantità prodotte da ogni impresa durante un anno, ne potrebbe dedurre a quali valori le merci devono essere vendute, se il tasso di profitto deve essere uniforme e il processo di produzione ripetuto: le equazioni mostrerebbero così che le condizioni dello scambio sono interamente determinate dalle condizioni della produzione»).
- Details
- Hits: 1296
Come insegnare la teoria economica?
A proposito di un recente libro di Mauro Gallegati
di Stefano Lucarelli
Questo scritto riporta l’intervento di Stefano Lucarelli alla presentazione del libro “Il mercato rende liberi” di Mauro Gallegati organizzata da Kritica Economica
 1. Il mercato rende liberi?
1. Il mercato rende liberi?
Che il mercato non renda liberi lo si può leggere anche nelle principali opere dei pensatori liberali. Adam Smith ben sapeva che le dinamiche competitive potevano tradursi in una centralizzazione dei capitali e che la divisione del lavoro poteva condurre all’alienazione dei lavoratori (a meno che lo Stato non si fosse preoccupato di intervenire anzitutto organizzando la pubblica istruzione). Luigi Einaudi nelle Lezioni di Politica Sociale parlava di mercati che potevano funzionare grazie al cappello a doppia punta dei gendarmi e al ruolo necessario di altri pubblici poteri.
Ciò che rende interessante il libro di Mauro Gallegati è che dietro al titolo accattivante si nasconde un viaggio ben narrato e comprensibile ai non addetti ai lavori nei piani alti della teoria economica.
2. Una critica ai modelli neoclassici
Il libro comincia con un attacco ai modelli DSGE, le nuove vesti dei modelli EEG (equilibrio economico generale) utilizzati da molti decisori nel mondo economico nonostante debolezze analitiche e conferme empiriche insoddisfacenti. Vediamo come vengono descritti da Banca d’Italia:
- Details
- Hits: 1430
Glosse a "Ontologia dell'essere sociale" di Lukàcs (II)
di Carlo Formenti
La pubblicazione delle mie Glosse alla "Ontologia" di Gyorgy Lukacs prosegue con questa seconda puntata (qui la prima) che raggruppa la seconda e la terza sezione tematica
 2. Critica del materialismo meccanicista
2. Critica del materialismo meccanicista
La critica delle interpretazioni meccaniciste e deterministe del pensiero di Marx è un filo rosso che attraversa tutta l’Ontologia, per cui lo ritroveremo in tutte le sezioni in cui sono articolate queste Glosse. In questa seconda sezione, tuttavia, intendo concentrare l’attenzione soprattutto su due aspetti: 1) il modo in cui, nel pensiero di Lukacs, il principio della determinazione (in ultima istanza!) della coscienza da parte del fattore economico si associa all’affermazione della (relativa!) libertà del fattore soggettivo; 2) la critica della feticizzazione oggettivistica della tecnica.
Parto da un passaggio particolarmente illuminante per quanto riguarda il primo punto: il metodo dialettico, scrive Lukacs, riposa sul già accennato convincimento di Marx che nell’essere sociale l’economico e l’extraeconomico di continuo si convertono l’uno nell’altro, stanno in una insopprimibile interazione reciproca, da cui però non deriva (…) né uno sviluppo storico privo di leggi (…) né un dominio meccanico <<per legge>> dell’economico astratto e puro. Ne deriva invece quella organica unità dell’essere sociale in cui alle rigide leggi dell’economia spetta per l’appunto e solo la funzione di momento soverchiante (vol. II, pp. 290/91). Il passaggio è denso e ricco di aspetti degni di rilievo. In primo luogo, l’affermazione secondo cui economico ed extraeconomico si convertono di continuo l’uno nell’altro, fa eco alla concezione dell’essere sociale come complesso di complessi descritta nella prima sezione: nessuna dimensione dell’essere sociale è separata dalle altre da un confine rigido, per cui il gioco dialettico delle interazioni reciproche è continuo, e soprattutto non è mai unidirezionale, nel senso che nessuna dimensione condiziona le altre senza venirne a sua volta condizionata.
- Details
- Hits: 1775
Sul declino degli Usa e l’inasprirsi della guerra imperialista permanente
di Giorgio Paolucci
 Nel nostro vocabolario esiste una parola che più di tutte
Nel nostro vocabolario esiste una parola che più di tutte
rappresenta una speranza per il futuro; questa parola è: Comunismo
(G. Greco)
Le ha davvero provate tutte Donald Trump pur di ribaltare il risultato delle elezioni presidenziali. Ha perfino spinto i suoi sostenitori più accaniti a occupare e a mettere a soqquadro la sede del Congresso convocato -come previsto dalla costituzione - per certificare la vittoria di Joe Biden. Un’irruzione con armi alla mano e che pare mirasse a bloccare i lavori dei deputati e a sequestrare la speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi e a dare una lezione, in stile Klu Klux Klan, al vicepresidente Pence per non essersi opposto alla procedura parlamentare per la ratifica della vittoria di Biden da Trump ritenuta illegittima perché, a suo dire, conseguita per mezzo di gravi brogli elettorali. Accusa mai ritirata nonostante tutte le corti statali e quella federale ne abbiano certificata l’infondatezza.
Definirlo un tentativo di golpe, nell’accezione classica del termine, forse è eccessivo, benché -stando alle ultime indagini dell’Fbi - non sia mancata una qualche complicità da parte di qualche dirigente e agente della polizia locale e di alcuni parlamentari del partito repubblicano.
In ogni caso, sarebbe fuorviante considerarlo un episodio isolato, frutto della personalità disturbata di Trump come si trattasse di un aspirante dittatorello di una qualsiasi repubblica delle banane e non il presidente della prima potenza imperialistica mondiale.
- Details
- Hits: 1695
Evento e struttura in Marx
Note su La guerra civile in Francia
di Franco Berardi Bifo
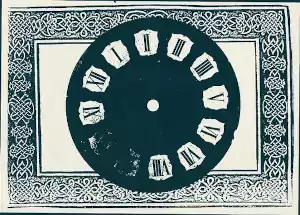 Il concetto di rivoluzione non viene elaborato in modo specifico nelle opere di Marx: si potrebbe dire, sostiene Franco Berardi Bifo, che quello di rivoluzione non è neppure un concetto, per lui: è un evento difficilmente concettualizzabile in termini strutturali. Ne parla negli scritti storici, nel Manifesto del partito comunista e ne La guerra civile in Francia. Questo breve documento, pubblicato a Londra nel 1871, raccoglie tre discorsi tenuti al Consiglio generale dell’Internazionale. Le pagine centrali del pamphlet sono dedicate alla Comune di Parigi, di cui in questi giorni ricorrono i 150 anni: in presa diretta Marx ne coglie la straordinaria novità, come manifestazione autonoma della classe operaia in quanto soggetto politico. La Comune durò meno di cento giorni, eppure marcò in modo profondo l’immaginazione politica del secolo successivo, fino ad arrivare ai giorni nostri. Quell’esperimento, «forma politica finalmente scoperta», non è la manifestazione di una tendenza implicita ma un evento imprevedibile, in quanto la struttura non implica necessariamente ogni evento. Marx lo capisce, perché non era un determinista e neppure un dottrinario bisbetico, un dogmatico credente nella necessità storica. Centocinquant’anni dopo, ripercorriamo con Bifo quel viaggio incantato alla scoperta di qualcosa che non ci aspettiamo.
Il concetto di rivoluzione non viene elaborato in modo specifico nelle opere di Marx: si potrebbe dire, sostiene Franco Berardi Bifo, che quello di rivoluzione non è neppure un concetto, per lui: è un evento difficilmente concettualizzabile in termini strutturali. Ne parla negli scritti storici, nel Manifesto del partito comunista e ne La guerra civile in Francia. Questo breve documento, pubblicato a Londra nel 1871, raccoglie tre discorsi tenuti al Consiglio generale dell’Internazionale. Le pagine centrali del pamphlet sono dedicate alla Comune di Parigi, di cui in questi giorni ricorrono i 150 anni: in presa diretta Marx ne coglie la straordinaria novità, come manifestazione autonoma della classe operaia in quanto soggetto politico. La Comune durò meno di cento giorni, eppure marcò in modo profondo l’immaginazione politica del secolo successivo, fino ad arrivare ai giorni nostri. Quell’esperimento, «forma politica finalmente scoperta», non è la manifestazione di una tendenza implicita ma un evento imprevedibile, in quanto la struttura non implica necessariamente ogni evento. Marx lo capisce, perché non era un determinista e neppure un dottrinario bisbetico, un dogmatico credente nella necessità storica. Centocinquant’anni dopo, ripercorriamo con Bifo quel viaggio incantato alla scoperta di qualcosa che non ci aspettiamo.
* * * *
Marx non ha parlato molto di rivoluzione. Il concetto di rivoluzione non viene elaborato in modo specifico nelle sue opere. Oserei dire che quello di rivoluzione non è neppure un concetto, per lui: è un evento che difficilmente si può concettualizzare in termini strutturali.
- Details
- Hits: 1514
Il discorso dominante del virus
di Edmond Dantès
 La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l’ignoranza è forza.
La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l’ignoranza è forza.
George Orwell, 1984
L’emergenza del virus ha portato con sé anche un discorso dominante, creato dal potere e diffuso dai suoi più svariati servitori mediatici: i telegiornali, i giornali e tutte le diramazioni create dalla Rete. Tale discorso dominante parla della verità o, meglio, di ciò che è giusto, di ciò che è bene. Una caratteristica di questo discorso è infatti quella di essere contrapposto, quasi in forma manichea, a ciò che viene definito come male, come sbagliato. Da una parte c’è il bene, dall’altra c’è il male. Anche un bambino di quattro anni capirebbe che non può funzionare così, non deve funzionare così. Il discorso dominante funziona invece come un blocco monolitico al quale non ci si può contrapporre se non si vuole cadere vittima della pratica dell’interdetto e del divieto.
Come nota Michel Foucault ne L’ordine del discorso, pressoché in tutte le società esistono “narrazioni salienti che si raccontano, si ripetono, si fanno variare; formule, testi, insiemi ritualizzati di discorsi che si recitano, secondo circostanze ben determinate; cose dette una volta e che si conservano, perché vi si presagisce qualcosa come un segreto o una ricchezza”.1 Tali narrazioni possono benissimo essere rappresentate, nelle società antiche, dai racconti mitici e dai miti in generale. Nella società contemporanea, in cui la parola mitica in senso proprio è stata completamente rimossa, quegli stessi racconti mitici del passato hanno assunto le vesti di una vera e propria nuova ‘mitologia’, quella della società dei consumi.
- Details
- Hits: 2204
Considerazioni sulla relazione tra la televisione e la società
di Anselm Jappe
 Può essere utile cominciare precisando alcune idee di Guy Debord, autore del libro La società dello spettacolo [*1]. La critica radicale dello spettacolo formulata da Debord va ben oltre una semplice critica della televisione e dei mass media. Egli stesso ha detto: «Lo spettacolo non può essere inteso come un abuso del mondo visibile, come un prodotto delle tecniche della diffusione di massa delle immagini» [*2]. Riconoscere, oggi, un valore "profetico" al libro di Debord pubblicato nel 1967 è, pertanto, facile, ma è anche riduttivo qualora la perspicacia di Debord venga vista solo nel fatto che egli prevedeva una società dominata da una dozzina o da un centinaio di canali televisivi di intrattenimento o notizie-spettacolo. Al giorno d'oggi, negli ambienti che si ritengono più intelligenti è di moda storcere il naso di fronte allo "spettacolo", ed esistono registi televisivi e ideatori di programmi per la tv, in Italia, e ministri francesi che amano citare Debord ed elogiarlo. Tuttavia, però Debord ha già detto nel suo libro che: «Lo spettacolo non è un insieme di immagini, ma un rapporto sociale tra le persone, mediato dalle immagini.» [*3]. Ha detto anche che lo spettacolo, inteso nella sua totalità, è allo stesso tempo sia il risultato che il progetto del modo di produzione esistente. Di fatto, egli parla della società dello spettacolo, vale a dire, di una società che funziona come uno spettacolo.
Può essere utile cominciare precisando alcune idee di Guy Debord, autore del libro La società dello spettacolo [*1]. La critica radicale dello spettacolo formulata da Debord va ben oltre una semplice critica della televisione e dei mass media. Egli stesso ha detto: «Lo spettacolo non può essere inteso come un abuso del mondo visibile, come un prodotto delle tecniche della diffusione di massa delle immagini» [*2]. Riconoscere, oggi, un valore "profetico" al libro di Debord pubblicato nel 1967 è, pertanto, facile, ma è anche riduttivo qualora la perspicacia di Debord venga vista solo nel fatto che egli prevedeva una società dominata da una dozzina o da un centinaio di canali televisivi di intrattenimento o notizie-spettacolo. Al giorno d'oggi, negli ambienti che si ritengono più intelligenti è di moda storcere il naso di fronte allo "spettacolo", ed esistono registi televisivi e ideatori di programmi per la tv, in Italia, e ministri francesi che amano citare Debord ed elogiarlo. Tuttavia, però Debord ha già detto nel suo libro che: «Lo spettacolo non è un insieme di immagini, ma un rapporto sociale tra le persone, mediato dalle immagini.» [*3]. Ha detto anche che lo spettacolo, inteso nella sua totalità, è allo stesso tempo sia il risultato che il progetto del modo di produzione esistente. Di fatto, egli parla della società dello spettacolo, vale a dire, di una società che funziona come uno spettacolo.
Dal momento che Debord non è più un autore "marginale" o "maledetto", ritengo che il concetto di società spettacolare da lui sviluppato sia già noto: si traccia di una società basata sulla contemplazione passiva, in cui gli individui, anziché vivere in prima persona, guardano le azioni degli altri.
- Details
- Hits: 1949
Elia Pupil intervista Alain Badiou
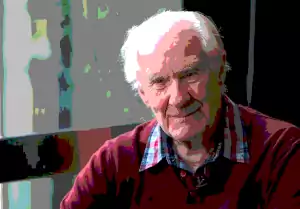 Alain Badiou, nato a Rabat, in Marocco, il 17 gennaio 1937, è stato insegnante presso l’Università di Paris VIII Saint-Denis Vincennes. Attualmente è professore all’École normale supérieure di Parigi.
Alain Badiou, nato a Rabat, in Marocco, il 17 gennaio 1937, è stato insegnante presso l’Università di Paris VIII Saint-Denis Vincennes. Attualmente è professore all’École normale supérieure di Parigi.
Tra i membri fondatori del Parti socialiste unifié, nel 1967 si unì ad un gruppo di studio intitolato a Baruch Spinoza, organizzato da Louis Althusser alla Scuola Normale e nello stesso anno partecipò alla fondazione dell’Union des communistes de France marxiste-léniniste, partito di ispirazione maoista di cui fu dirigente fino agli anni ’80. Partecipò al ’68. Influenzato dal pensiero di Althusser e Lacan, nel 1969 divenne membro dell’Università di Parigi VIII dove ebbe l’opportunità di confrontarsi con pensatori del calibro di Gilles Deleuze e Lyotard. Nel 1999 passa all’École normale supérieure. Badiou è anche un famoso drammaturgo.
Tra le sue opere principali troviamo: La République de Platon, Théorie du sujet, Saint Paul. La fondation de l’universalisme, L’Être et l’Événement, L’Hypothèse communiste e Métaphysique du bonheur réel.
* * * *
1. Nel contesto dell’ipotesi comunista, come pensa che possa rinascere un nuovo polo rivoluzionario in Occidente, dopo il crollo delle socialdemocrazie e l’avvento della demagogia dell’eterogeneità nei movimenti? Come, e quale evento occorre attendere per sviluppare una situazione storica che sia favorevole a una rottura degli equilibri?
- Details
- Hits: 1330
Pandemia, economia e crimini della guerra sociale
Stagione 2, episodio 3: disciplinamento dell’immaginario e del lavoro
di Sandro Moiso
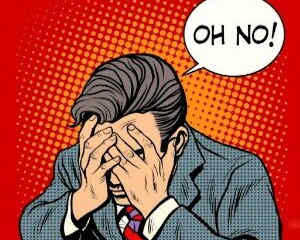 Ho scritto recentemente, a proposito del pensiero di Carl Schmitt, che il concetto di “eccezione” è fondativo della sovranità ovvero del potere dello Stato, qualsiasi sia la forma politico-istituzionale che questo assume: «Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione»1.
Ho scritto recentemente, a proposito del pensiero di Carl Schmitt, che il concetto di “eccezione” è fondativo della sovranità ovvero del potere dello Stato, qualsiasi sia la forma politico-istituzionale che questo assume: «Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione»1.
Da questa affermazione è possibile far derivare che l’eccezionalità, o stato di eccezione, e la facoltà/forza di deciderne gli aspetti formali e strutturali costituiscono le condizioni che devono sostanziare ogni governo poiché, se nelle fasi “normali” la normativa vigente è sufficiente a governare l’esistente e a dirimerne le contraddizioni, è proprio nella gestione di una fase inaspettata, e dunque potenzialmente pericolosa, che si esprime la vera autorità, riconosciuta come tale.
Se questo risulta essere piuttosto significativo dal punto di vista meramente politico, soprattutto in una fase come quella che stiamo attraversando e che abbiamo precedentemente definito come “epidemia delle emergenze”2, assume un’ulteriore importanza una volta che lo si associ alle riflessioni di Michel Foucault sul “potere di disciplina”.
In che consiste un simile potere? L’ipotesi che vorrei avanzare è che esiste, nella nostra società, qualcosa che potremmo definire un potere disciplinare. Con tale espressione mi riferisco, semplicemente, a una certa forma, in qualche modo terminale, capillare, del potere, un ultimo snodo, una determinata modalità attraverso la quale il potere politico – i poteri in generale – arrivano, come ultima soglia della loro azione, a toccare i corpi, a far presa su di essi, a registrare i gesti, i comportamenti, le abitudini, le parole; mi riferisco al modo in cui tutti questi poteri, concentrandosi verso il basso fino ad investire gli stessi corpi individuali, lavorano, plasmano, modificano, dirigono, quel che Servan chiamava “le fibre molli del cervello”3.
- Details
- Hits: 1322
L’alternativa possibile della Comune di Parigi
di Marcello Musto
Il 18 marzo del 1871 scoppiò in Francia una nuova rivoluzione che mise in pratica la democrazia diretta e l'autogoverno dei produttori. Quell'esperienza indica ancora come si può costruire una società radicalmente diversa da quella capitalista
 I borghesi avevano sempre ottenuto tutto. Sin dalla rivoluzione del 1789, erano stati i soli ad arricchirsi nei periodi di prosperità, mentre la classe lavoratrice aveva dovuto regolarmente sopportare il costo delle crisi. La proclamazione della Terza Repubblica aprì nuovi scenari e offrì l’occasione per ribaltare questo corso. Napoleone III era stato sconfitto e catturato dai tedeschi, a Sedan, il 4 settembre 1870. Nel gennaio dell’anno seguente, la resa di Parigi, che era stata assediata per oltre quattro mesi, aveva costretto i francesi ad accettare le condizioni imposte da Otto von Bismarck. Ne seguì un armistizio che permise lo svolgimento di elezioni e la successiva nomina di Adolphe Thiers a capo del potere esecutivo, con il sostegno di una vasta maggioranza legittimista e orleanista. Nella capitale, però, in controtendenza con il resto del paese, lo schieramento progressista-repubblicano era risultato vincente con una schiacciante maggioranza e il malcontento popolare era più esteso che altrove. La prospettiva di un esecutivo che avrebbe lasciato immutate tutte le ingiustizie sociali, che voleva disarmare la città ed era intenzionato a far ricadere il prezzo della guerra sulle fasce meno abbienti, scatenò la ribellione. Il 18 marzo scoppiò una nuova rivoluzione; Thiers e la sua armata dovettero riparare a Versailles.
I borghesi avevano sempre ottenuto tutto. Sin dalla rivoluzione del 1789, erano stati i soli ad arricchirsi nei periodi di prosperità, mentre la classe lavoratrice aveva dovuto regolarmente sopportare il costo delle crisi. La proclamazione della Terza Repubblica aprì nuovi scenari e offrì l’occasione per ribaltare questo corso. Napoleone III era stato sconfitto e catturato dai tedeschi, a Sedan, il 4 settembre 1870. Nel gennaio dell’anno seguente, la resa di Parigi, che era stata assediata per oltre quattro mesi, aveva costretto i francesi ad accettare le condizioni imposte da Otto von Bismarck. Ne seguì un armistizio che permise lo svolgimento di elezioni e la successiva nomina di Adolphe Thiers a capo del potere esecutivo, con il sostegno di una vasta maggioranza legittimista e orleanista. Nella capitale, però, in controtendenza con il resto del paese, lo schieramento progressista-repubblicano era risultato vincente con una schiacciante maggioranza e il malcontento popolare era più esteso che altrove. La prospettiva di un esecutivo che avrebbe lasciato immutate tutte le ingiustizie sociali, che voleva disarmare la città ed era intenzionato a far ricadere il prezzo della guerra sulle fasce meno abbienti, scatenò la ribellione. Il 18 marzo scoppiò una nuova rivoluzione; Thiers e la sua armata dovettero riparare a Versailles.
Di lotta e di governo
Gli insorti decisero di indire subito libere elezioni, per assicurare all’insurrezione la legittimità democratica. Il 26 marzo, una schiacciante maggioranza (190.000 voti contro 40.000) approvò le ragioni della rivolta e 70 degli 85 eletti si dichiararono a favore della rivoluzione.
- Details
- Hits: 1222
Fantasia nella stiva
Logistica dello schiavismo e fantasie di fuga
di Stefano Harney e Fred Moten
Un estratto di Undercommons. Pianificazione fuggitiva e studio nero di Stefano Harney e Fred Moten, recentemente pubblicato da Tamu Edizioni e Archive Books, nella traduzione a cura di Emanuela Maltese. Ringraziamo l’editore per la disponibilità
 Logistica, o del trasporto marittimo
Logistica, o del trasporto marittimo
Lavorare oggi significa che ci viene chiesto sempre più di fare senza pensare, sentire senza emozioni, muoverci senza attrito, adattarci senza discutere, tradurre senza pausa, desiderare senza scopo, connettere senza interruzione. Solo poco tempo fa, molti di noi dicevano che il lavoro fosse passato attraverso il soggetto al fine di sfruttare le nostre capacità sociali, per spremere più forza lavoro dal nostro lavoro. L’anima discendeva nell’officina, come scriveva Franco «Bifo» Berardi o, come suggeriva Paolo Virno, ascendeva come nel virtuosismo di un oratore senza spartito. Più prosaicamente, abbiamo sentito proporre l’imprenditore, l’artista e l’investitore tutti come nuovi modelli di soggettività in grado di favorire l’incanalamento dell’intelletto generale. Ma oggi ci viene da chiederci: perché preoccuparsi proprio del soggetto, perché passare in rassegna degli esseri del genere per raggiungere l’intelletto generale? E perché limitare la produzione ai soggetti i quali, dopotutto, sono una così piccola parte della popolazione, una storia così piccola dell’intellettualità di massa? Ci sono sempre stati altri modi per mettere i corpi al lavoro, persino per mantenere il capitale fisso di tali corpi, come direbbe Christian Marazzi. E ad ogni modo, per il capitale il soggetto è diventato troppo ingombrante, troppo lento, troppo incline all’errore, un soggetto che controlla troppo, per non parlare di una forma di vita troppo rarefatta, troppo specializzata. Eppure, non siamo noi a porre questa domanda. Questa è la domanda automatica, insistente e determinante del campo della logistica.
- Details
- Hits: 3360
Fine partita. Ha vinto la barbarie
Lettere al futuro IV
di Marino Badiale
 1. Introduzione
1. Introduzione
“Socialismo o barbarie” è un notissimo slogan dovuto a Rosa Luxemburg, contenuto in un testo scritto durante la Prima Guerra Mondiale [1]. È stato usato molte volte nel Novecento, a indicare il pericolo di una degenerazione regressiva e barbarica delle società occidentali (regressione la cui analisi specifica si differenziava fra i vari autori), e la necessità di una evoluzione socialista per prevenire tale degenerazione. Un critico potrebbe obbiettare che, nel Novecento, il socialismo non ha vinto ma la barbarie tanto temuta non è in definitiva arrivata: il nazifascismo è senz’altro l’evento storico più simile alla temuta regressione, ma esso è stato sconfitto da forze interne alle stesse società capitalistiche (assieme, ovviamente, all’URSS), che hanno così dimostrato di essere capaci di esprimere efficaci controtendenze rispetto agli elementi di barbarie sorti al proprio interno. Può dunque sembrare arrischiato riproporre oggi lo slogan “socialismo o barbarie”, perché si potrebbe venire smentiti, come è successo per tutto il Novecento. Sono però convinto, e l’ho argomentato in altri interventi [2], che il capitalismo abbia ormai esaurito la sua capacità di rappresentare una potenzialità contraddittoria di progresso, e sia entrato in una fase univocamente regressiva, che porterà in tempi non troppo lunghi ad una sua crisi irreversibile. Purtroppo tale crisi non sarà quella che speravano i movimenti comunisti e socialisti degli ultimi due secoli: non si tratterà di una fase turbolenta, magari drammatica, che porterà a sostituire il capitalismo morente con un socialismo ecologico, pacifico, in grado di conservare le conquiste spirituali della modernità e metterle al servizio del libero sviluppo di ogni individuo.
- Details
- Hits: 1794
Il rasoio di Occam
Tra marxismi e post-marxismi: una mappatura globale
di Emanuele Lepore
È appena uscito il “Routledge Handbook of Marxism and Post-Marxism”, curato da Alex Callinicos, Stathis Kouvelakis e Lucia Pradella (Routledge, 2021). Si tratta di un importante contributo agli studi marxiani contemporanei, ricco di numerose estensioni storico-geografiche e teoriche
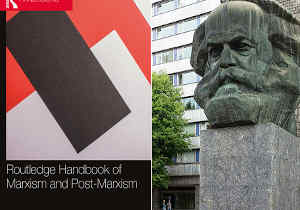 È stato dato da poco alle stampe il Routledge Handbook of Marxism and Post-Marxism, a cura di Alex Callinicos, Stathis Kouvelakis e Lucia Pradella. Ne offriremo qui una presentazione generale, in cui proveremo a individuare alcuni fili che di questo handbook costituiscono la fitta trama.
È stato dato da poco alle stampe il Routledge Handbook of Marxism and Post-Marxism, a cura di Alex Callinicos, Stathis Kouvelakis e Lucia Pradella. Ne offriremo qui una presentazione generale, in cui proveremo a individuare alcuni fili che di questo handbook costituiscono la fitta trama.
Il volume si caratterizza anzitutto come una ricognizione puntuale dell’ampio e variegato spettro di esperienze teoriche del marxismo e del post-marxismo, secondo una scansione abbastanza netta, che ripercorriamo brevemente: la prima parte è dedicata al momento fondativo del marxismo, alle figure di Karl Marx e Friedrich Engels. Se è vero che il marxismo è costitutivamente “teoria della crisi” (Kouvelakis 2005), allora il ritorno alla fondazione si presenta come una necessità storica, rispondendo alla quale è possibile guadagnare una nuova prospettiva tanto sulle fonti a cui si fa ritorno, quanto sugli eventi determinati che si vuole comprendere. In questo caso, si può dire che il ritorno sia riuscito, poiché nel saggio dedicato specificamente a Karl Marx, Lucia Pradella – tenendo fede ad uno degli impegni teorici stabiliti in L’attualità del Capitale (2010) – imposta un confronto ravvicinato con chi ha inteso scorgere nell’opera marxiana assenze tematiche e vicoli ciechi, dalla questione di genere al presunto eurocentrismo della critica di Marx all’economia politica.
Page 197 of 612