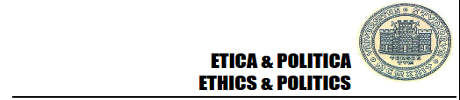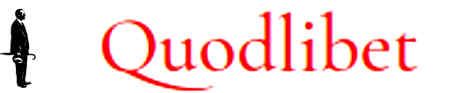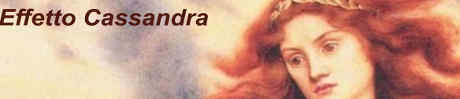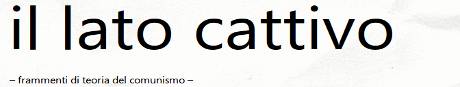Fai una donazione
Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________
- Details
- Hits: 1192
Ecco a voi il Super-MES
di Leonardo Mazzei
 Il super-Mes
Il super-Mes
Bruxelles, ore 5:32 del 21 luglio, per l’Italia il disastro è compiuto. Non si chiama Mes, anche se ci sarà spazio pure per questo, ma Recovery Fund, il super-Mes pensato dall’asse carolingio, ripreso dalla Commissione, ed infine modificato (in peggio, ovviamente) dal Consiglio europeo con la firma di stamattina.
Lo abbiamo sostenuto per mesi. Non è mai esistito un Mes cattivo, opposto ad un Recovery Fund buono. Esiste invece il sistema dell’euro, che di questi meccanismi abbisogna come il pane. E’ da quel sistema che bisogna liberarsi. Il resto è solo chiacchiera per l’interminabile teatrino della politica. Quel teatrino tenuto in piedi affinché ogni ragionamento serio sia bandito dal discorso pubblico.
Oggi gli euroinomani festeggiano. Lo fanno per l’accordo raggiunto, per la novità di un pacchetto economico a loro dire eccezionale, perfino per l’idea che si sia aperta la strada alla condivisione del debito, aprendo così pure quella della mitica Europa federale. Hanno torto su tutto, ed i fatti lo dimostreranno.
L’accordo è stato uno dei più pasticciati dell’intera storia dell’Unione, che in quanto a pasticci proprio non ha rivali. Non il frutto di un’intesa di fondo, ma di un’estenuante mediazione sul più piccolo dettaglio degli interessi di ognuno.
Lo dimostra il consistente aumento degli sconti dei contributi al bilancio comunitario, ottenuto dai 4 “frugali” (Olanda, Svezia, Danimarca, Austria) più la Germania, per il periodo 2021-2027. Molti segnalano come i quattro portino a casa 26 miliardi, “dimenticandosi” però di dire che altri 25,6 verranno incamerati dalla Germania.
- Details
- Hits: 1187
Neoliberismo, tecnoscienza e democrazia nell’era Covid
di Riccardo Emilio Chesta
Al contrario di quanto fa intendere il senso comune neoliberista, scienza e tecnologia non sono autonome dai rapporti di potere che informano la società. Per evitare derive tecnocratiche o populiste nella gestione della crisi Covid, occorre democratizzare entrambe
 “La fede nel valore della verità scientifica è il prodotto di determinate civiltà, non già qualcosa di dato per natura”[1]. Questa frase di Max Weber, pensatore di cui ricorre quest’anno il centenario dalla morte, offre spunti di riflessione che dovrebbero aiutare il dibattito pubblico italiano a superare concezioni monolitiche del modo di operare della scienza. Negli sconvolgimenti che attraversano società, politica ed economia investite dal Covid-19, queste parole di Weber possono aiutare a superare i cortocircuiti cognitivi che caratterizzano scienza e politica così come vengono concepite in un senso comune definito dall’egemonia neoliberista e da forme di populismo che a quest’ultima dicono di opporsi.
“La fede nel valore della verità scientifica è il prodotto di determinate civiltà, non già qualcosa di dato per natura”[1]. Questa frase di Max Weber, pensatore di cui ricorre quest’anno il centenario dalla morte, offre spunti di riflessione che dovrebbero aiutare il dibattito pubblico italiano a superare concezioni monolitiche del modo di operare della scienza. Negli sconvolgimenti che attraversano società, politica ed economia investite dal Covid-19, queste parole di Weber possono aiutare a superare i cortocircuiti cognitivi che caratterizzano scienza e politica così come vengono concepite in un senso comune definito dall’egemonia neoliberista e da forme di populismo che a quest’ultima dicono di opporsi.
Nell’odierno dibattito pubblico italiano, professionisti della politica e del giornalismo sembrano rivolgersi agli esperti con quell’approccio tipico che in psicologia cognitiva si definisce come “realismo ingenuo”. Si può dire che questo senso comune con cui si guarda agli esperti poggi sinteticamente su due presupposti fondamentali. Il primo è che esista una modalità immediata di vedere la realtà – sia essa riferita alla natura o alla società – ovvero che ci siano modelli e metodi di conoscenza scientifica che prescindono dalle scelte cognitive dell’attore scientifico o politico. Questo aspetto fa del realismo ingenuo nel senso comune la vera epistemologia sui cui poggia il celeberrimo motto neoliberale del “There is no alternative” nella vita politica ed economica.
- Details
- Hits: 1031
Osservazioni sulla rifondazione teorica del socialismo
di Pasquale Noschese
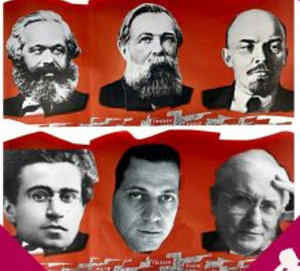 Nel 2012, in una breve intervista[i] tanto utile quanto tristemente passata inosservata, il filosofo sloveno Slavoj Žižek invitava la sinistra anti-capitalista a smettere di agire ed iniziare a pensare. Provocatorio come sempre, Žižek ha però messo a nudo una debolezza fondamentale, che previene ogni possibilità di costruzione di un “movimento reale che abolisce lo stato di cose presente”: l’assenza di un solido apparato teorico.
Nel 2012, in una breve intervista[i] tanto utile quanto tristemente passata inosservata, il filosofo sloveno Slavoj Žižek invitava la sinistra anti-capitalista a smettere di agire ed iniziare a pensare. Provocatorio come sempre, Žižek ha però messo a nudo una debolezza fondamentale, che previene ogni possibilità di costruzione di un “movimento reale che abolisce lo stato di cose presente”: l’assenza di un solido apparato teorico.
Osservazioni su difetti di origine storica
Vista con gli occhi di chi è nato molto dopo l’89 e il ’91, la confusione che le sinistre hanno attraversato in quel periodo è comprensibile ma non giustificabile. Il crollo dell’URSS ha mostrato come ad un certo punto il pensiero socialista fosse stato completamente assorbito dalla legittimazione teorico-storica del modello sovietico. Se le sinistre fossero state saldamente legate ad un’idea più che ad un’esperienza politica, è verosimile che al crollo dell’URSS non sarebbe seguito il tracollo delle sinistre. È probabilmente legittimo pensare che in larga parte il pensiero socialista, già quasi dal ’17, è stato, in larga parte, deformato da un certo “sovietismo”. Questa affermazione potrebbe sembrare in contrasto con le varie tensioni che hanno attraversato i rapporti tra PCUS e gli altri partiti comunisti, e tuttavia pare essere confermata dal collasso a catena di cui sopra. L’impostazione da “partito padre” tenuta dal PCUS, la postura figlia dell’articolo 14 del Komintern[ii] mai realmente corretta, l’eventuale lotta all’eretico ingaggiata da molti militanti, intellettuali e politici di spicco: queste ed altre cose hanno soffocato la libera elaborazione del pensiero socialista, facendone perdere i concetti chiave in un oceano di contingenze storiche elevate a dogmi.
- Details
- Hits: 2174
Da oggi in poi ci governa Berlino
di Dante Barontini
 Come sarebbe andata a finire lo si poteva capire già nella notte di domenica, quando Giusppe Conte, rivolgendosi all’olandese Mark Rutte, ha detto: “Il mio Paese ha una sua dignità. C’è un limite che non va superato”, aggiungendo il dubbio che “si voglia piegare il braccio a un Paese perché non possa usare i fondi”.
Come sarebbe andata a finire lo si poteva capire già nella notte di domenica, quando Giusppe Conte, rivolgendosi all’olandese Mark Rutte, ha detto: “Il mio Paese ha una sua dignità. C’è un limite che non va superato”, aggiungendo il dubbio che “si voglia piegare il braccio a un Paese perché non possa usare i fondi”.
In quel momento è stato inevitabile ripensare ad Alexis Tsipras, in un’altra notte di luglio, quella del 2015, che nella stessa sede (solo qualche faccia diversa) si era alzato togliendosi la giacca per porgerla alla Merkel sbottando: «A questo punto, prendetevi anche questa…»
Poi, com’è noto, la Troika si precipitò rapace su Atene, assumendone il pieno controllo e dando il via al saccheggio di tutto quel che di pubblico poteva essere svenduto (porti, aeroporti, centrali, ecc), tagliato (salari, sanità e pensioni), impegnato.
All’Italia di Conte è andata leggerissimamente meglio, in apparenza, visto il diverso peso economico in Europa – terza economia dell’Unione – che renderebbe il tracollo senza freni di questo Paese un detonatore devastante per tutti, più della pandemia.
Ma per separare con chiarezza la realtà di quanto “concordato” dalla “narrazione” che ne viene fatta già a botta calda, sarà bene vedere i singoli punto del compromesso finale, firmato alle 5.32 del mattino, al quinto giorno di un vertice che doveva durarne due.
Il “successo” della UE sta solo nel fatto che ne sia stato firmato uno, cosa che ad un certo punto sembrava persino improbabile. Ma nessuno dei 27 leaderini spaventati e feroci poteva tornare a casa senza questo risultato. Avrebbe significato la fine di un sistema di trattati e istituzioni, sanzionato pesantemente dai “mercati” e quindi un moltiplicatore degli effetti negativi della pandemia che avrebbe alla fine travolto anche chi si sente meno esposto.
- Details
- Hits: 2039
Gramsci e la rivoluzione contro il Capitale
Riflessione su un famoso articolo
di Antiper
 Antonio Gramsci è pressoché unanimemente considerato il più importante marxista italiano e gli “studi gramsciani” si sono sviluppati in modo vastissimo, soprattutto a livello internazionale.
Antonio Gramsci è pressoché unanimemente considerato il più importante marxista italiano e gli “studi gramsciani” si sono sviluppati in modo vastissimo, soprattutto a livello internazionale.
Gramsci è stato anche una vittima del fascismo, un uomo che ha pagato con 10 anni di carcere e con la morte la sua lotta contro la dittatura mussoliniana; è dunque comprensibile che gli siano stati tributati tanti meritati omaggi, soprattutto nel passato.
Il testo che ha dato maggior fama a Gramsci è senza dubbio la raccolta dei Quaderni del carcere pubblicati dalla casa editrice Einaudi dopo la fine della guerra. Ma come ha giustamente osservato Alberto Burgio per capire davvero quest’opera è necessario collocarla nel quadro dell’intera vita di Gramsci che comprende anche gli anni prima del carcere [1]. Senza tenere conto di questi anni di impegno politico la lettura dei Quaderni può condurre a numerosi fraintendimenti.
Negli anni precedenti al carcere Gramsci scrisse molti articoli e tra i tanti ce n’è uno che merita particolare attenzione, sia per la grande risonanza che ha avuto nel tempo, sia perché mostra come anche le migliori intenzioni possano dare origine a esiti problematici. Questo articolo si intitola La rivoluzione contro il Capitale ed è stato pubblicato sul quotidiano del Partito Socialista Italiano Avanti! il 24 novembre 1917 e sul settimanale di area socialista Il Grido del Popolo il 5 gennaio 1918.
Possiamo quindi già fissare un primo punto cronologico: mentre in Russia i bolscevichi stanno conquistando il potere politico in Italia i rivoluzionari stanno dibattendo nel PSI su cosa fare (come si sa, si dovrà attendere il 21 gennaio 1921 per avere la nascita del Partito Comunista d’Italia).
- Details
- Hits: 1073
Alle radici della teoria marginalista. Una nota teorica
di Andrea Galeotti
Parte I
 Il recente attacco della Corte Costituzionale Tedesca alla BCE può far “cadere dal pero” solo i più o meno consapevoli sostenitori della neutralità della politica monetaria. Sarebbe precisamente questa neutralità che le recenti misure (PEPP – Pandemic Emergency Purchase Programme) metterebbero, secondo l’accusa, fortemente a rischio. Come recentemente osservato da Brancaccio, il vero problema è che questa neutralità non esiste.
Il recente attacco della Corte Costituzionale Tedesca alla BCE può far “cadere dal pero” solo i più o meno consapevoli sostenitori della neutralità della politica monetaria. Sarebbe precisamente questa neutralità che le recenti misure (PEPP – Pandemic Emergency Purchase Programme) metterebbero, secondo l’accusa, fortemente a rischio. Come recentemente osservato da Brancaccio, il vero problema è che questa neutralità non esiste.
Tale neutralità è esclusivamente e rigorosamente difendibile se – e solo se – si è pronti ad accettare le fondamenta teoriche della macroeconomia neoclassica. Ovvero, la teoria marginalista del valore e della distribuzione.
Lo scopo di questa prima nota è quello di mettere a scrutinio le premesse teoriche necessarie per poter sostenere che esista una naturale tendenza a un equilibrio di piena occupazione. In una seconda nota, mostreremo come queste premesse siano necessarie anche per poter sostenere la stessa neutralità della politica monetaria. Come vedremo, in entrambi i casi, una condizione necessaria è la specificazione del capitale come un fattore di produzione omogeneo espresso in termini di valore. Ovvero, precisamente quella concezione del capitale che le controversie degli anni ’60 e ’70 hanno dimostrato essere teoricamente indifendibile.
- Details
- Hits: 999
Filosofia e postmarxismo nella ricognizione critica di Giorgio Cesarale
di Mario Reale*
Da Etica & Politica / Ethics & Politics, XXII, 2020, 2, pp. 611-621, ISSN: 1825-5167
 I
I
Il lettore che si trovi in mano il libro di Giorgio Cesarale (=GC) A Sinistra. Il pensiero critico dopo il 1989 (=AS), Laterza Bari-Roma 2019 ha più che mai, per le ragioni che dirò, il diritto di chiedersi: ma val la pena di leggere e anzi studiare un simile testo? La mia risposta a un tal quesito, cui sono giunto in realtà per gradi, è senz’altro positiva, quand’anche la lettura riuscisse contesta di riserve riguardo ad alcuni o molti degli autori interpretati o allo stesso interpretante, che, non al modo di un’estrinseca rassegna ma in forma piuttosto unitaria, presenta i suoi diversi «pensatori critici». La lettura del testo è infatti compensata, risarcita, da molte acquisizioni capaci di avvicinarci, in varie guise, a modi di pensare che si rivelano importanti e utili, se non indispensabili, al bagaglio di chi voglia oggi capire le punte «avanzate» degli studi filosofico-sociali. Già una ricognizione dei pensatori critico-radicali degli ultimi trent’anni non può che essere vista in ogni caso con interesse. In un mondo così lacerato e scisso a parte obiecti e a parte subiecti, privo di una sicura egemonia e anzi di un’egemonia tout court, di stabili connessioni qual è quello in cui oggi viviamo, è di grande importanza, credo, sapere se vi sia un pensiero più profondo e radicale, quasi una guida sicura nella lettura delle carte del nostro tempo, capace di spingersi lontano, di ritrovare nuovi legami e una qualche forma di «unità». Un pensiero in grado, nell’atto stesso, di guardare oltre i significati e le forze dati per intravedere almeno qualche segno del futuro – sebbene senza residui di filosofia della storia, senza forzature identitarie né esiti di irrelato atomismo: con un procedere «dialettico» sì, ma non risolto subito in una grande sintesi conciliativa, calata dall’esterno e passepartout.
- Details
- Hits: 2008
ASPI, niente nazionalizzazione ma salvataggio statale del capitale transnazionale
di Domenico Moro
 La decisione del Consiglio dei ministri di non procedere alla revoca della concessione ad autostrade per l’Italia (Aspi) non è soltanto un salvataggio in extremis dei Benetton, ma rappresenta, nel nuovo modello di azienda che si configura, una modalità di salvataggio del capitale transnazionale e di interessi europei da parte dello Stato italiano.
La decisione del Consiglio dei ministri di non procedere alla revoca della concessione ad autostrade per l’Italia (Aspi) non è soltanto un salvataggio in extremis dei Benetton, ma rappresenta, nel nuovo modello di azienda che si configura, una modalità di salvataggio del capitale transnazionale e di interessi europei da parte dello Stato italiano.
La revoca della concessione avrebbe portato al fallimento di Aspi, che avrebbe coinvolto non solo la Atlantia dei Benetton, che la controlla all’88%, ma anche multinazionali straniere, che sono presenti nel capitale di Aspi, e alcune istituzioni europee. Un eventuale default avrebbe reso insolventi 9 bond di Aspi comprati dalla Bce e sarebbe finito in crisi il finanziamento da 1,3 miliardi erogato dalla Bei. Soprattutto avrebbe comportato grosse perdite per gli altri azionisti di peso di Aspi. Si tratta di Appia, che detiene il 6,94% di Aspi, e del fondo governativo cinese Silk Road, che ne detiene il 5%. Non è un caso che la Merkel, nell’incontro con Conte prima del vertice dei capi di governo della Ue sul Recovery Fund, si fosse detta curiosa di sapere come sarebbe andato il Consiglio dei ministri che doveva decidere in merito alla sorte di Aspi. Infatti, in Appia è presente la tedesca Allianz, che è il primo gruppo assicurativo mondiale, Edf, che è la maggiore società produttrice e distributrice di energia della Francia, e Dif, che è un fondo olandese di investimento. Tutte aziende di Paesi importanti, che, guarda caso, giocano un ruolo decisivo anche nelle trattative in corso sul fondo di ricostruzione europeo. Ma il capitale multinazionale è presente anche in Atlantia, dove le minoranze contano il 40% dell’azionariato e vedono la presenza di colossi come la statunitense Blackrock e il fondo di investimento di Singapore. In Edizione, la holding dei Benetton, che controlla a sua volta Atlantia, è presente anche la statunitense Goldman Sachs, una delle più grandi banche d’affari del mondo.
- Details
- Hits: 1208
Il primato dei rapporti di produzione e la lotta di classe nella fase di transizione
di Bollettino Culturale
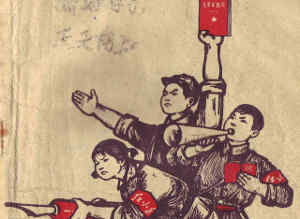 Il problema della transizione è stato mal sviluppato da Marx e da Engels a causa della limitazione di un fenomeno di cui avevano poca conoscenza, dato che l'unica esperienza che videro in vita fu la Comune di Parigi del 1871.
Il problema della transizione è stato mal sviluppato da Marx e da Engels a causa della limitazione di un fenomeno di cui avevano poca conoscenza, dato che l'unica esperienza che videro in vita fu la Comune di Parigi del 1871.
Anche in queste condizioni, Marx ha dato un notevole contributo nei suoi scritti sulla Comune, concentrandosi sulla questione della rottura degli apparati statali come scuole e forze armate, oltre a ridefinire il ruolo della burocrazia, della rappresentanza politica e della giustizia in questa fase di transizione.
La dittatura del proletariato nella sua descrizione dell'esperienza della Comune di Parigi è quella del non-Stato, dato il grado di decentralizzazione, partecipazione e controllo delle masse sull'apparato statale.
Il problema teorico (e con effetti politici) in Marx si trova nella prefazione del 1859, in cui l'enfasi data alle forze produttive è strettamente delimitata in questo passaggio: “A un dato punto del loro sviluppo, le forze produttive materiali della società entrano in contraddizione con i rapporti di produzione esistenti, cioè con i rapporti di proprietà (che ne sono soltanto l'espressione giuridica) dentro i quali tali forze per l'innanzi s'erano mosse. Questi rapporti, da forme di sviluppo delle forze produttive, si convertono in loro catene.”
Questo passaggio dal lavoro di Marx ha consentito un'interpretazione con un forte contenuto meccanicistico ed economicista della sua teoria. Non è un caso che questo testo sia diventato il riferimento centrale nella concezione stalinista, fortemente segnata dal suo riduzionismo. Come afferma lo stesso Stalin: “le forze produttive non sono solo l'elemento più mobile e rivoluzionario della produzione. Sono anche il fattore determinante nello sviluppo della produzione.”
- Details
- Hits: 1396
Forse non la stiamo prendendo per il verso giusto
di Pierluigi Fagan
 L’altro ieri, la missione di analisti dell’IMF, di ritorno dal suo soggiorno americano, ha pubblicato questo rapporto su stato e prospettive dell’economia americana che da sola vale un quarto di quella planetaria.
L’altro ieri, la missione di analisti dell’IMF, di ritorno dal suo soggiorno americano, ha pubblicato questo rapporto su stato e prospettive dell’economia americana che da sola vale un quarto di quella planetaria.
Nel secondo trimestre (A-M-G), il Pil USA ha fatto -37% (lo ripeto per i distratti e coloro che saltano i dati di quantità a priori perché preferiscono le parole: “meno trentasette per cento”). Si prevede che l’economia USA tornerà ai livelli di Pil fine 2019, solo a metà 2022, forse. IMF segnala che gli USA erano già un sistema con una forte componente di povertà interna, la crisi è destinata ad allargare e sprofondare questa parte addensata nelle etnie afro-americana ed ispanica. Al momento sono 15 milioni i disoccupati ed è appena iniziata la catena di fallimenti di esercizi commerciali ed imprese che accompagnerà la lenta ma costante caduta. Ed aggiunge: “il rischio che ci attende è che una grande parte della popolazione americana dovrà affrontare un importante deterioramento degli standard di vita e significative difficoltà economiche per molti anni a venire.”.
“Molti anni a venire” , come riportato in post precedenti, viene da Nouriel Roubini e dai "miliardari invocanti tasse", quotato sulla prospettiva del decennio, magari non saranno proprio dieci anni, ma al momento le prospettive sono di crisi profonda e lunga. “Larga parte della popolazione” significa più che la maggioranza.
- Details
- Hits: 1576
Il contributo di Nancy Fraser al dibattito su un nuovo socialismo democratico
Per un inquadramento critico
di Giorgio Fazio
Nancy Fraser: Cosa vuol dire socialismo nel XXI secolo, Castelvecchi. 2020
 Non sembra esserci tempo più propizio di quello che stiamo vivendo in questo passaggio storico eccezionale, per tornare a riflettere – con serietà, realismo e alla luce di prospettive teoriche e politiche rinnovate – sul tema che dà il titolo all’intervento di Nancy Fraser: che cosa può significare socialismo nel XXI secolo.
Non sembra esserci tempo più propizio di quello che stiamo vivendo in questo passaggio storico eccezionale, per tornare a riflettere – con serietà, realismo e alla luce di prospettive teoriche e politiche rinnovate – sul tema che dà il titolo all’intervento di Nancy Fraser: che cosa può significare socialismo nel XXI secolo.
Più volte è stato osservato in questi ultimi mesi: come tutte le emergenze che interrompono bruscamente lo svolgimento delle nostre routine sociali, economiche e politiche, la pandemia da Covid-19, investendo inesorabilmente per ondate successive i quattro angoli del pianeta, ha avuto il potente effetto rivelatorio di riportare alla luce, senza più diaframmi, le soglie critiche su cui è sospesa la nostra contemporaneità globalizzata. Soglie critiche di varia natura – sanitaria, ecologica, economica, democratica, sociale, razziale, etc. – eppure tra loro strettamente intrecciate, poichè tutte in qualche modo riconducibili al modello di capitalismo finanziarizzato e deregolamentato che si è imposto su scala globale negli ultimi decenni. Crisi che, tuttavia, la normalità sospesa nei mesi di emergenza epidemica tendeva a rimuovere dal centro dell’agenda politica, mentre ora, dopo e dentro questa emergenza, si ha l’impressione che quel rimosso ripresenti il conto e non possa essere più facilmente relegato sullo sfondo.
L’approccio di Fraser alla questione del socialismo si presenta come una pista di riflessione particolarmente idonea ad aiutarci a leggere “contropelo” questo passaggio storico e ad offrirci strumenti di orientamento politico. E questo per due ragioni fondamentali.
La prima di queste ragioni è che la sua riflessione su una rinnovata idea di socialismo democratico ruota fin dall’inizio attorno al tema della crisi.
- Details
- Hits: 2975
Che cos’è la paura?
di Giorgio Agamben
 Che cos’è la paura, nella quale oggi gli uomini sembrano a tal punto caduti, da dimenticare le proprie convinzioni etiche, politiche e religiose? Qualcosa di familiare, certo – eppure, se cerchiamo di definirla, sembra ostinatamente sottrarsi alla comprensione.
Che cos’è la paura, nella quale oggi gli uomini sembrano a tal punto caduti, da dimenticare le proprie convinzioni etiche, politiche e religiose? Qualcosa di familiare, certo – eppure, se cerchiamo di definirla, sembra ostinatamente sottrarsi alla comprensione.
Della paura come tonalità emotiva, Heidegger ha dato una trattazione esemplare nel par. 30 di Essere e tempo. Essa può esser compresa solo se non si dimentica che l’Esserci (questo è il termine che designa la struttura esistenziale dell’uomo) è sempre già disposto in una tonalità emotiva, che costituisce la sua originaria apertura al mondo. Proprio perché nella situazione emotiva è in questione la scoperta originaria del mondo, la coscienza è sempre già anticipata da essa e non può pertanto disporne né credere di poterla padroneggiare a suo piacimento. La tonalità emotiva non va infatti in alcun modo confusa con uno stato psicologico, ma ha il significato ontologico di un’apertura che ha sempre già dischiuso l’uomo nel suo essere al mondo e a partire dalla quale soltanto sono possibili esperienze, affezioni e conoscenze. «La riflessione può incontrare esperienze solo perché la tonalità emotiva ha già aperto l’Esserci». Essa ci assale, ma «non viene né dal di fuori né dal di dentro: sorge nell’essere-al-mondo stesso come una sua modalità». D’altra parte questa apertura non implica che ciò a cui essa apre sia riconosciuto come tale. Al contrario, essa manifesta soltanto una nuda fatticità: «il puro “che c’è” si manifesta; il da dove e il dove restano nascosti». Per questo Heidegger può dire che la situazione emotiva apre l’Esserci nel «essere-gettato» e «consegnato» al suo stesso «ci». L’apertura che ha luogo nella tonalità emotiva ha, cioè, la forma di un essere rimesso a qualcosa che non può essere assunto e da cui si cerca – senza riuscirci – di evadere.
- Details
- Hits: 1960
Usciamo dall’euro per tornare a essere un paese normale
di Thomas Fazi
 Ormai, di fronte al fallimento sempre più conclamato dell’UE e della moneta unica e all’insofferenza sempre più diffusa nei confronti di quella che viene (giustamente) percepita come una camicia di forza che da troppo tempo sta soffocando l’economia italiana, l’unica argomentazione rimasta ai difensori dello status quo sembrerebbe essere quella per cui «le cose vanno male, è vero» – ormai neanche loro hanno più il coraggio di negarlo – «ma fidatevi, senza l’euro andrebbero anche peggio».
Ormai, di fronte al fallimento sempre più conclamato dell’UE e della moneta unica e all’insofferenza sempre più diffusa nei confronti di quella che viene (giustamente) percepita come una camicia di forza che da troppo tempo sta soffocando l’economia italiana, l’unica argomentazione rimasta ai difensori dello status quo sembrerebbe essere quella per cui «le cose vanno male, è vero» – ormai neanche loro hanno più il coraggio di negarlo – «ma fidatevi, senza l’euro andrebbero anche peggio».
Un esempio da manuale di questa strategia sempre più disperata è un articoletto uscito l’altro giorno sul Sole 24 Ore a firma di Innocenzo Cipolletta, economista e dirigente d’azienda italiano, ex presidente delle Ferrovie dello Stato (2006-2010). Già dal titolo si intuisce che l’obiettivo dell’autore è uno solo, inculcare il terrore in chi legge: “COVID+lira = molta inflazione (e zero crescita)”. L’argomentazione di Cipolletta è semplice quanto prevedibile: se avessimo dovuto affrontare questa pandemia fuori dall’euro, cioè con la vecchia/nuova lira, «avremmo dovuto aumentare il nostro disavanzo pubblico per sostenere l’economia, come tutti gli altri paesi». A tal fine, continua Cipolletta, «la Banca d’Italia sarebbe stata indotta a comprare il debito italiano, ciò che avrebbe probabilmente tenuto bassi i tassi di interesse per un po’ di tempo, ma la lira si sarebbe immediatamente svalutata come sempre è avvenuto in passato». A quel punto «l’aumento dell’inflazione interna sarebbe stato automatico, visto che la svalutazione aumenta i costi di rimpiazzo delle nostre importazioni […]. Gli italiani avrebbero così perso, assieme al lavoro falcidiato dalla pandemia, anche potere d’acquisto e sarebbero stati più poveri». Insomma, conclude Cipolletta, «molto (ma molto) meglio abbiamo fatto noi ad aderire all’euro» e ad evitare così questo scenario da incubo.
- Details
- Hits: 1155
Nota su Da Marx al post-operaismo
di Salvatore Tiné
Da Marx al post-operaismo, Giovanni Sgro’ e Irene Viparelli (a cura di), Napoli, La Città del Sole, 2019
 1. Tanti i temi e tanti gli autori marxisti e non solo affrontati in questo piccolo ma densissimo libro. E tuttavia mi pare che alcuni temi li leghino tra loro in profondità. Uno tra questi, forse il più importante, e non caso vi si rimanda esplicitamente nel sottotitolo, è quello della soggettività, delle sue figure e forme insieme sociali e politiche, teoriche e insieme pratiche. Un tema che ha attraversato l’intera storia del movimento operaio e del marxismo e che ha acquistato in questi ultimi decenni, quelli per l’appunto successivi alla fine dell’Urss e alla tragica sconfitta del movimento operaio che l’ha insieme preceduta e accompagnata, una straordinaria attualità nel dibattito teorico e politico.
1. Tanti i temi e tanti gli autori marxisti e non solo affrontati in questo piccolo ma densissimo libro. E tuttavia mi pare che alcuni temi li leghino tra loro in profondità. Uno tra questi, forse il più importante, e non caso vi si rimanda esplicitamente nel sottotitolo, è quello della soggettività, delle sue figure e forme insieme sociali e politiche, teoriche e insieme pratiche. Un tema che ha attraversato l’intera storia del movimento operaio e del marxismo e che ha acquistato in questi ultimi decenni, quelli per l’appunto successivi alla fine dell’Urss e alla tragica sconfitta del movimento operaio che l’ha insieme preceduta e accompagnata, una straordinaria attualità nel dibattito teorico e politico.
2. I saggi del volume affrontano il tema della soggettività a partire da Marx, e soprattutto dal Marx in cui la nozione di soggetto e di soggettività è ancora esplicita e evidentemente centrale, il Marx giovane dei Manoscritti del ’44 e quello meno giovane della Ideologia tedesca, ma già approdato al materialismo storico, ebbene ancora nettamente al di qua della critica dell’economia politica e della teoria del modo di produzione capitalistico cui il pensatore di Treviri approderà compiutamente nei Grundrisse e poi nel Capitale.
3. Particolarmente nel saggio sui Manoscritti parigini di Luca Mandara, mi pare interessante il tentativo di una lettura insieme politica e materialistica del tema della soggettività che percorre tutta l’analisi marxiana del lavoro alienato e il suo sforzo di definire il carattere insieme attivo e passivo, ovvero al contempo soggettivo e oggettivo del lavoro, al di là della impostazione ancora troppo astrattamente e genericamente “umanistica” che caratterizza questa fase del pensiero di Marx, ovvero come dice bene Mandara la sua “ontologia umanista”: in tal senso egli individua nella storicizzazione del bisogno innescata dalla trasformazione o umanizzazione della natura attraverso il lavoro una delle premesse fondamentali della critica dell’economia politica del Marx maturo e anche della stessa teoria politica che egli comincerà ad elaborare dopo l’esperienza delle rivoluzioni del ’48.
- Details
- Hits: 2413
Covid-19: Cosa Rischiano i Bambini e i Ragazzi a Scuola?
di Alessandra Basso (TINT, Università di Helsinki), Valentina Flamini (Biologa molecolare), Eleonora Franchini (docente di scuola secondaria di secondo grado), Sara Gandini (IEO, SEMM)
 Vi passo qui di seguito un testo scritto da un gruppo di ricercatrici italiane che è veramente una boccata di ossigeno nello tsunami di fesserie e di bugie che ci sta sommergendo. Non un testo facile, non un testo annacquato. Un esame approfondito della letteratura scientifica. Non è un testo di opinioni, è un testo di dati e di fatti. E che arriva alla conclusione che il rischio di un ritorno a scuola per i nostri bambini è minimo o inesistente, e che -- soprattutto -- è trascurabile rispetto ai danni psicologici che i bambini ricevono standosene isolati a casa.
Vi passo qui di seguito un testo scritto da un gruppo di ricercatrici italiane che è veramente una boccata di ossigeno nello tsunami di fesserie e di bugie che ci sta sommergendo. Non un testo facile, non un testo annacquato. Un esame approfondito della letteratura scientifica. Non è un testo di opinioni, è un testo di dati e di fatti. E che arriva alla conclusione che il rischio di un ritorno a scuola per i nostri bambini è minimo o inesistente, e che -- soprattutto -- è trascurabile rispetto ai danni psicologici che i bambini ricevono standosene isolati a casa.
La cosa più bella è il successo che questo testo ha avuto. Pubblicato sul sito Facebook "Pillole di Ottimismo" è stato condiviso oltre 2500 volte in 24 ore. E' un risultato eccellente considerato il marasma che è Facebook al momento attuale. Dei circa 500 commenti, praticamente tutti sono favorevoli, molti ringraziano per la spiegazione. Soprattutto, sono genitori e mamme preoccupate per i loro bambini costretti in una situazione innaturale di isolamento e segregazione.
Come sappiamo, l'informazione pubblica in Italia è dominata da sorgenti di informazione completamente inaffidabili e di solito impegnate nel raccontarci bugie. Ma quest storia ci fa vedere come c'è ancora spazio per raccontare le cose come stanno. C'è ancora gente in grado di recepire un messaggio anche complesso quando capiscono che gli autori (le autrici, in questo caso) hanno lavorato seriamente per fare un servizio di informazione pubblica. (UB)
* * * *
“I bambini non sono i più colpiti da questa pandemia, ma rischiano di essere le sue più grandi vittime”. Così apre il report delle nazioni unite dedicato all’impatto del Covid-19 sui bambini (1).
- Details
- Hits: 1841
Filosofia del ritiro, ritiro della filosofia. Sulle derive del post-marxismo
di Yuri Di Liberto
 1. Sulla fobia del potere
1. Sulla fobia del potere
Rivolgendo uno sguardo ricognitivo al lessico della filosofia dopo la fine del socialismo reale, dopo la caduta del muro di Berlino, ma - in realtà - già a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale, non si può fare a meno di notare come le parole d’ordine della vecchia filosofia (rivoluzione, partito, contraddizione, lotta di classe ecc.) siano state lentamente sostituite da un lessico ad esse complementare, ma talvolta con esse incompatibile. Una certa insofferenza per il fantasma di Stalin, nonché un certo imbarazzo per l’adesione di tanta intellighenzia mitteleuropea al progetto comunista, hanno fatto sì che lo scibbolet, la parola d’ordine, del pensiero filosofico-politico post-Unione Sovietica diventasse - e lo è tuttora - quella del ritiro.
Se il progetto emancipatorio della rivoluzione si trasforma in totalitarismo, l’unica prescrizione che vale è quella di ritirarsi dall’ordine dato, rifuggire qualsiasi mira di potere, ripulirsi del fascismo che ciascuno di noi ha dentro di sé, non credere più ad alcuna guida partitica. Si tratta di una tendenza post-marxista che, agitando lo spauracchio di Stalin, ha prodotto vari elogi del ritiro, immanentismi pigri, apologie dell’inoperosità ecc.
Le «rivelazioni sul gulag», nota Jameson, hanno innescato «un’ossessione distopica, una paura quasi paranoica, di qualsiasi forma di organizzazione politica o sociale» (Jameson 2016:2), fobie che di volta in volta prendono di mira la forma-partito o la semplice speculazione su progetti che riguardano la società del futuro.
- Details
- Hits: 1371
Mes o Recovery, comunque al guinzaglio
di Claudio Conti
Con un articolo in calce di Guido Salerno Aletta da Milano Finanza
 La settimana che si apre dovrebbe essere quella decisiva per quanto riguarda la strategia europea per il post-pandemia (ammesso e non concesso che ci si trovi in un “post” anziché in una pausa stagionale). Gli iniziali atteggiamenti ritardatari dei “paesi frugali” (“l’importante è fare bene”) sono stati improvvisamente accantonati su indicazione della cancelliera Angela Merkel, per sei mesi presidente di turno di tutta l’Unione Europea, che intende sfruttare anche questa occasione – e la crisi ne sta offrendo a decine – per imporre l’imprinting sull’Unione 2.0.
La settimana che si apre dovrebbe essere quella decisiva per quanto riguarda la strategia europea per il post-pandemia (ammesso e non concesso che ci si trovi in un “post” anziché in una pausa stagionale). Gli iniziali atteggiamenti ritardatari dei “paesi frugali” (“l’importante è fare bene”) sono stati improvvisamente accantonati su indicazione della cancelliera Angela Merkel, per sei mesi presidente di turno di tutta l’Unione Europea, che intende sfruttare anche questa occasione – e la crisi ne sta offrendo a decine – per imporre l’imprinting sull’Unione 2.0.
Cuore della discussione continentale è il Recovery Fund, ossia il fondo straordinario “per la ricostruzione” da aggiungere al normale bilancio europeo. 500 miliardi, come nella proposta iniziale di Merkel e Macron, e non 750 come poi proposto dalla Commissione guidata da Von der Leyen. Tanto per far capire chi è che comanda (nonostante anche la presidente della Commissione sia tedesca, ma con una composizione ovviamente più “pluralista”).
500 miliardi di “trasferimenti a fondo perduto”, vincolati a investimenti per effettuare precise “riforme strutturali” che l’Unione Europea pretende da ogni Paese non le abbia ancora compiute o completate. I dettagli non sono ancora stati resi noti, ci si è limitati ad evocare “svolte green”, rivoluzioni digitali, ecc. Ma sono pià che intuibili…
Per esempio, l’incontro tra Giuseppe Conte e il suo omologo olandese Mark Rutte ha provveduto a sgomberare il campo da ogni equivoco, visto che il boero ha consigliato all’”avvocato del popolo” di eliminare “quota 100”. Una battuta informale, certo – “quota 100” vale pochissimo, in termini di bilancio, e comunque doveva scadere nel 2021 – ma che indica con nettezza la direzione da prendere: i Paesi con alto debito pubblico, quelli euromediterranei, insomma, devono tagliare ancora di più la spesa sociale, a cominciare da quella pensionistica.
- Details
- Hits: 2121
Democrazia a un bivio: ripensare la Rivoluzione al di là delle “riforme”
di Luca Cimichella
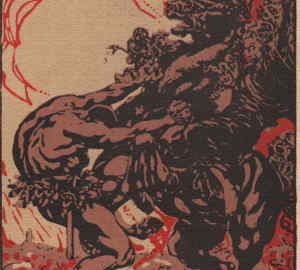 Lo scorso 20 giugno Michele Salvati, voce storica del PD e della sinistra riformista, scriveva sul Corriere della Sera: «Gli storici hanno da tempo messo in rilievo l’antica dannazione italica dei partiti “antisistema”, partiti che non potevano far parte delle coalizioni di governo anche se erano rappresentati in Parlamento. Non potevano farlo perché il loro programma politico contrastava con i principi in base ai quali una democrazia liberale e\o un’economia di mercato si erano di fatto assestate nel nostro Paese. (…) Finito questo conflitto per il collasso dell’Unione sovietica, ci si poteva attendere che fossero esaurite anche in Italia le ragioni per escludere come “antisistema” partiti che accettassero i criteri di una democrazia liberale, di un’economia capitalistica e fossero legittimamente rappresentati in Parlamento. E di fatto si instaurò per alcuni anni, tra il 1994 e il 2018, una alternanza destra\sinistra che includeva tutti (…). Poi, con le elezioni del 2013 e del 2018, arrivarono in Parlamento partiti populisti-sovranisti (…). Che si collochino a destra o a sinistra, la concezione di democrazia da essi condivisa è in conflitto con quella liberale, parlamentare e rappresentativa».
Lo scorso 20 giugno Michele Salvati, voce storica del PD e della sinistra riformista, scriveva sul Corriere della Sera: «Gli storici hanno da tempo messo in rilievo l’antica dannazione italica dei partiti “antisistema”, partiti che non potevano far parte delle coalizioni di governo anche se erano rappresentati in Parlamento. Non potevano farlo perché il loro programma politico contrastava con i principi in base ai quali una democrazia liberale e\o un’economia di mercato si erano di fatto assestate nel nostro Paese. (…) Finito questo conflitto per il collasso dell’Unione sovietica, ci si poteva attendere che fossero esaurite anche in Italia le ragioni per escludere come “antisistema” partiti che accettassero i criteri di una democrazia liberale, di un’economia capitalistica e fossero legittimamente rappresentati in Parlamento. E di fatto si instaurò per alcuni anni, tra il 1994 e il 2018, una alternanza destra\sinistra che includeva tutti (…). Poi, con le elezioni del 2013 e del 2018, arrivarono in Parlamento partiti populisti-sovranisti (…). Che si collochino a destra o a sinistra, la concezione di democrazia da essi condivisa è in conflitto con quella liberale, parlamentare e rappresentativa».
Un tono candido e lineare, un’argomentazione che non sembra fare una piega. Se non fosse per un solo dettaglio: il misterioso ritorno di questo spettro, i “dannati” partiti “antisistema”, che vengono periodicamente a turbare l’innocente rotta della democrazia liberale sugli intrascendibili, universali orizzonti del sistema vigente. Si tratta di una narrazione rassicurante quanto falsa e cieca, che dopo aver sedotto per circa trent’anni i cuori e le menti di quella sinistra “illuminata”, “moderata”, che esce dalle rovine di Pci, Psi e Dc – passando per i vari D’Alema, Amato e Prodi – risulta ormai indigeribile per le nostre coscienze disincantate, che in un contesto economico-politico sempre più insensato, soffocante e indistricabile, anelano disperatamente (spesso senza saperlo) ad una alternativa di mondo e di società.
- Details
- Hits: 1634
L'insostenibile impalpabilità del ceto dirigente
di Alberto Bradanini
 Nell’Italia del XXI secolo chiunque può diventare capo del governo, persino un ignoto avvocato di provincia, sia detto con rispetto, privo fino al giorno prima di qualsiasi ombra di familiarità con politica, affari di Stato e relazioni internazionali. Egualmente, sia detto anche qui con rispetto, chiunque può diventare ministro degli esteri, delle finanze, dell’economia e via dicendo.
Nell’Italia del XXI secolo chiunque può diventare capo del governo, persino un ignoto avvocato di provincia, sia detto con rispetto, privo fino al giorno prima di qualsiasi ombra di familiarità con politica, affari di Stato e relazioni internazionali. Egualmente, sia detto anche qui con rispetto, chiunque può diventare ministro degli esteri, delle finanze, dell’economia e via dicendo.
Si tratta di un’evidenza, solo in apparenza sorprendente, che va posta in termini strutturali, non personali. Sui futuri libri di storia questi dirigenti saranno menzionati in un riquadro a fondo pagina, raccolti in un freddo elenco di nomi e anni di riferimento: è improbabile che di essi si parli per lo spessore delle gesta, la tensione etica o le lotte combattute a favore della popolazione, a dispetto del pur oscillante frasario elogiativo destinato a evaporare a ogni tramontar del sole.
Nei paesi a democrazia liberale – Stati Uniti ed Europa, in primis - la selezione del ceto dirigente non è fortuita. E quando talvolta i meccanismi selettivi sfuggono di mano (Trump...), la sottostante struttura statuale supplisce alle insufficienze del livello politico. Anche in paesi lontani dalle tradizioni istituzionali occidentali, i processi selettivi non sono lasciati al caso. In Cina, ad esempio, sapere e potere vanno da sempre a braccetto. Nella millenaria storia cinese, l’imperatore, suprema espressione del potere assoluto, poneva massima attenzione a circondarsi di persone selezionate: a partire dall’epoca Tang, in particolare, i mandarini (rappresentanti dell’autorità imperiale) erano tenuti a superare esami pubblici faticosi, forse non sempre trasparenti, eppure sufficienti a evitare che giungessero a responsabilità elevate anonimi figli del vento, originati dal caso, dalla corruzione o dal nepotismo.
- Details
- Hits: 2398
Lo scientismo come nuova religione
di Ilaria Bifarini
 Cos’è la scienza?
Cos’è la scienza?
“La scienza non è democratica” è il nuovo mantra utilizzato come scudo per allontanare chiunque provi a manifestare un pensiero divergente da quello accreditato dalla vulgata dominante e per questo inconfutabile, non passibile a critiche di alcun tipo. Il monito è molto efficace, ed emana quell’autorevolezza che ci si aspetta dal rigore e dall’inaccessibilità della scienza, intesa come campo esclusivo di un élite di esperti, la cui competenza e preparazione implicano qualità tali da giustificare un certo distacco dal popolo, il demos appunto. Mai come in questo periodo di diffusione della paura collettiva legata al Covid-19 la scienza, o come meglio vedremo la sua degenerazione scientista, ha avocato a sé il ruolo di padre primigenio, che sorveglia i propri figli e impone loro la propria indiscussa autorità.
Ma cosa è la scienza?
Sciens, participio presente del verbo latino scire, sapere, essa comprende quel sistema di cognizioni acquisito con lo studio e la riflessione.
Ricostruire la genesi della scienza richiederebbe un trattato a sé, ed esula dall’obiettivo della nostra esposizione; peraltro esiste già una vasta e importante letteratura in merito da poter esaminare.
Già nella cultura classica i filosofi greci distinguevano due diverse forme di conoscenza, l’opinione (doxa), fondata sull’esperienza sensibile e perciò ingannevole e incerta, e la scienza (epistème), basata sulla ragione e dunque fonte di conoscenza sicura e incorruttibile.
- Details
- Hits: 2726
Quale comunismo? Un invito a rileggere il “Manifesto del Partito Comunista”
di Michele Martelli
Il “Manifesto” non è la sacra Bibbia, né il Catechismo dei comunisti, ma un’opera aperta, laica, profana, imperfetta, incompiuta, in fieri, con luci e ombre, intuizioni geniali e difetti innegabili. Un’opera che va letta e studiata senza estrapolarla dall’epoca in cui fu scritta e senza pregiudizi fideistici, al pari di ogni altro classico della politica

Comunismo si dice in molti modi
«Il Manifesto del Partito comunista è uno dei più grandi scritti politici di tutti i tempi»[1]. Così un filosofo e stu
dioso liberale italiano ultracritico di Marx, allacciandosi a un giudizio analogo del giovane Max Weber, poi divenuto il grande sociologo, denominato l’Anti-Marx, o «il Marx della borghesia»: «il Manifesto è una realizzazione scientifica di prim’ordine. Questo è innegabile»[2].
Ma perché, chiediamoci in via preliminare, Marx ed Engels l’hanno intitolato Manifesto del Partito comunista, e non «socialista»? In primo luogo, per ragioni politiche contingenti: a) perché il compito di scriverlo gli era stato affidato nel dicembre del 1947 dal Congresso londinese della Lega dei Comunisti (ex-Lega dei Giusti)[3], in cui militavano da qualche tempo: b) perché – lo spiegò poi Engels nella Prefazione del 1890 al Manifesto – «socialisti» si definivano in quel tempo i seguaci di «vari sistemi utopistici» (Owen e Fourier), e molti «ciarlatani sociali» e riformatori borghesi (tra cui Proudhon), mentre invece con «comunismo» si intendeva il «movimento» reale, le agitazioni e le lotte concrete degli operai[4]. In secondo luogo, per ragioni filosofiche e teoriche: la loro idea di comunismo era stata già da loro elaborata nelle sue linee fondamentali dal 1844 al 1847 in diversi scritti di critica e confutazione del socialismo utopistico e del riformismo borghese. Il loro comunismo, lungi dall’essere «un ideale al quale la realtà dovrà conformarsi», coincideva col «movimento reale che abolisce lo stato di cose presente»[5].
- Details
- Hits: 1775
Pedagogia hacker trasgredire la norma tecnocratica
Intervista al Collettivo Ippolita
 Questi mesi di distanziamento sociale hanno reso evidenti e aggravato molte delle contraddizioni relative alle grandi corporation del web e all’uso e agli effetti delle tecnologie digitali nelle nostre esistenze quotidiane, su cui voi avete scritto in maniera molto lucida negli ultimi anni. Un primo tema su cui vi chiediamo un commento riguarda il ruolo politico, economico, sociale, che hanno giocato e stanno giocando corporation come Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Apple, nel periodo del distanziamento sociale e nella gestione sanitaria e sociale della pandemia.
Questi mesi di distanziamento sociale hanno reso evidenti e aggravato molte delle contraddizioni relative alle grandi corporation del web e all’uso e agli effetti delle tecnologie digitali nelle nostre esistenze quotidiane, su cui voi avete scritto in maniera molto lucida negli ultimi anni. Un primo tema su cui vi chiediamo un commento riguarda il ruolo politico, economico, sociale, che hanno giocato e stanno giocando corporation come Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Apple, nel periodo del distanziamento sociale e nella gestione sanitaria e sociale della pandemia.
Mentre scriviamo i quotidiani ci dicono che circa 500mila persone hanno scaricato la app Immuni. Interessante notare che a distribuire questa app non sia un sito del Governo che ha finanziato l’operazione, ma gli store di Apple e Google, che sono società private con un fatturato che supera il Pil di molti stati nazione e che hanno delle regole interne spesso in conflitto con quelle delle democrazie occidentali presso le quali nella maggior parte dei casi non pagano le tasse.
Apple e Google, due Big tech, collaborano per la prima volta imponendo delle scelte di decentralizzazione privata sulla distribuzione di un software di Stato dedicato alla salute pubblica. Cosa diranno di ciò i fedayn della decentralizzazione? Per noi questa è la dimostrazione che la decentralizzazione di per sé non è un valore, cioè non è una garanzia di orizzontalità democratica e si sposa benissimo con il liberismo senza regole delle corporation tecnologiche.
- Details
- Hits: 1039
"Venezuela e guerra in Siria sono fondamentali per individuare i pacifinti"
Geraldina Colotti intervista Massimo Zucchetti
 Massimo Zucchetti è un ingegnere nucleare italiano che ha al suo attivo una impressionante quantità di pubblicazioni specialistiche, ma anche militanti. Infatti, quando firma i suoi articoli che coniugano la precisione dei dati con una visione radicale e controcorrente rispetto alla subalternità culturale che di solito abita il mondo accademico italiano, si definisce “scienziato, comunista, disordinatore delle narrazioni tossiche del potere”.
Massimo Zucchetti è un ingegnere nucleare italiano che ha al suo attivo una impressionante quantità di pubblicazioni specialistiche, ma anche militanti. Infatti, quando firma i suoi articoli che coniugano la precisione dei dati con una visione radicale e controcorrente rispetto alla subalternità culturale che di solito abita il mondo accademico italiano, si definisce “scienziato, comunista, disordinatore delle narrazioni tossiche del potere”.
* * * *
Che significa, Massimo, questa definizione? Qual è stato il tuo percorso professionale e come si è intrecciato con l’impegno politico?
Mi sono laureato in ingegneria nucleare magna cum laude nel 1986, ma, un mese dopo: ecco il disastro di Chernobyl! Un decennio prima, al liceo, divenni anarchico leggendo “In his own write” di John Lennon: niente Bakunin o Kropotkin, niente laurea in scienze politiche su Marcuse, purtroppo non tutti hanno nobili origini come i Grandi Padri Fondatori della Sinistra Intellettuale. L’abitudine alle discipline tecniche mi ha lasciato il colpo d’occhio e l’intuizione per capire quando dietro una bella narrazione si nasconda il nulla montato a neve, come d’uso nella sinistra, oppure si celino depositi ideali di liquami tossici e fecali, come di norma nel centro-destra-sinistra di governo. Questa specie di talento è un dono di natura e, sebbene io sia ateo, ritengo sarebbe un peccato non metterlo a frutto, un po’ come nella parabola dei talenti, appunto. Da qui discende il mio impegno come anarco-comunista, scienziato contro la guerra, ambientalista. Sono un professore universitario da ormai un trentennio, ma non sono democristiano.
Tu insegni anche in una prestigiosa università statunitense. Come valuti le due esperienze, come funziona negli USA?
- Details
- Hits: 1328
Il popolo in seno alle contraddizioni. Una risposta ad alcune critiche
di Diego Melegari e Fabrizio Capoccetti
 A partire dalla pubblicazione dell’articolo scritto per la fionda I «bottegai», l’ultimo argine? Spunti per una politica oltre purismo e subalternità, diverse sono state le reazioni e le letture che hanno dato luogo a un proficuo dibattito, che ci auguriamo possa proseguire e continuare ad avvalersi degli importanti spunti analitici mossi da più parti. Due sono i fronti della critica su cui ci concentreremo, non potendo ritenere validi i rilievi secondo i quali indicheremmo nella piccola borghesia una “nuova classe rivoluzionaria”[i], essendo piuttosto evidente che una tale intenzione non emerge in alcun punto del nostro contributo. Da una parte, abbiamo il fronte costituito da chi ravvisa nella nostra analisi una lettura della fase che non prenderebbe in sufficiente considerazione i rischi insiti nella costruzione di un’alleanza con la piccola e media borghesia, la quale nella futura e imminente gestione della crisi (Recovery fund, Mes, etc.) sarà ancora una volta portata ad ascoltare il “richiamo della foresta” di arricchirsi e distinguersi dai proletari, dal momento che uscire dalla condizione di immiserimento è sempre stata, resta e sarà la sua sola parola d’ordine. Per semplificare e rendere più chiara la nostra esposizione, chiameremo questo fronte il “fronte A”[ii]. Dall’altra, c’è chi osserva nel nostro punto di vista un certo indeterminismo, insito nell’uso della teoria di Ernesto Laclau, che finirebbe per «gettare nel cesso» il materialismo storico e, che pur nella giusta decisione di puntare sulla piccola e media borghesia per la costruzione di un «blocco storico nazional-popolare», vedrebbe nella nostra rivendicazione della sovranità nazionale contro l’UE, non tanto un secondo momento (la teoria dei due tempi), quanto piuttosto un momento secondario rispetto alla centralità assunta dalla conquista socialista dello stato. Chiameremo questo fronte, il “fronte B”[iii].
A partire dalla pubblicazione dell’articolo scritto per la fionda I «bottegai», l’ultimo argine? Spunti per una politica oltre purismo e subalternità, diverse sono state le reazioni e le letture che hanno dato luogo a un proficuo dibattito, che ci auguriamo possa proseguire e continuare ad avvalersi degli importanti spunti analitici mossi da più parti. Due sono i fronti della critica su cui ci concentreremo, non potendo ritenere validi i rilievi secondo i quali indicheremmo nella piccola borghesia una “nuova classe rivoluzionaria”[i], essendo piuttosto evidente che una tale intenzione non emerge in alcun punto del nostro contributo. Da una parte, abbiamo il fronte costituito da chi ravvisa nella nostra analisi una lettura della fase che non prenderebbe in sufficiente considerazione i rischi insiti nella costruzione di un’alleanza con la piccola e media borghesia, la quale nella futura e imminente gestione della crisi (Recovery fund, Mes, etc.) sarà ancora una volta portata ad ascoltare il “richiamo della foresta” di arricchirsi e distinguersi dai proletari, dal momento che uscire dalla condizione di immiserimento è sempre stata, resta e sarà la sua sola parola d’ordine. Per semplificare e rendere più chiara la nostra esposizione, chiameremo questo fronte il “fronte A”[ii]. Dall’altra, c’è chi osserva nel nostro punto di vista un certo indeterminismo, insito nell’uso della teoria di Ernesto Laclau, che finirebbe per «gettare nel cesso» il materialismo storico e, che pur nella giusta decisione di puntare sulla piccola e media borghesia per la costruzione di un «blocco storico nazional-popolare», vedrebbe nella nostra rivendicazione della sovranità nazionale contro l’UE, non tanto un secondo momento (la teoria dei due tempi), quanto piuttosto un momento secondario rispetto alla centralità assunta dalla conquista socialista dello stato. Chiameremo questo fronte, il “fronte B”[iii].
- Details
- Hits: 1730
Lotte interclassiste: obiettivi ed esiti
Estratti da Le ménage à trois de la lutte des classes
di Bruno Astarian e Robert Ferro
A margine del sostanziale riflusso del movimento sociale negli Stati Uniti, pubblichiamo un altro breve estratto da Le Ménage à trois de la lutte des classes, uscito in Francia nel dicembre 2019, e in fase di traduzione in italiano. Degli Stati Uniti, avremo modo di riparlare in maniera più circostanziata prossimamente. Nel frattempo, per chi volesse procurarsi il volume di cui sopra, ricordiamo che è ormai possibile ordinarlo direttamente sul sito della casa editrice: https://editionsasymetrie.org/ouvrage/le-menage-a-trois-de-la-lutte-des-classes/.
 Obiettivi delle lotte interclassiste
Obiettivi delle lotte interclassiste
Fatta eccezione per i Gilets Jaunes nel momento più alto della loro mobilitazione, nei movimenti interclassisti attuali – tali quali si manifestano attraverso scioperi, manifestazioni e sommosse – la presenza del proletariato è meno evidente di quella della classe media. Lo si è visto in Francia nel 20161 e in molte altre occasioni, che dimostrano come all’interno della lotta interclassista sia la classe media a parlare più forte. Questo vuol dire forse che è essa a menare le danze? No, vuol semplicemente dire che è essa ad avere i mezzi per esprimere il discorso più appropriato al terreno sul quale si colloca la lotta interclassista: quello politico, in cui ci si rivolge allo Stato perché difenda il posto che le due classi occupavano precedentemente nella società capitalistica. Quella interclassista non è una lotta in cui il proletariato giochi un ruolo secondario sottomettendosi agli imperativi della CMS [classe media salariata, NdT]. Il proletariato non rinuncia alla sua posizione specifica. Semplicemente, è impegnato in una lotta rivendicativa e/o riformista. Fino a un certo punto, le sue rivendicazioni sono le stesse della classe media, reclama le stesse riforme. Fin quando si rimane al di qua di questa soglia, la classe media è il portavoce meglio capace di formulare gli obiettivi congiunti delle due classi. Ma quali sono questi obiettivi? Li si può analizzare secondo il ventaglio seguente.
1) Standard generali di riproduzione. Si tratta dei fattori che determinano le condizioni di vita delle due classi in generale (disoccupazione, inflazione etc.). Il problema non riguarda solo il proletariato. Abbiamo visto quale sia stata l’importanza della questione dei disoccupati diplomati durante le Primavere arabe.
Page 223 of 610